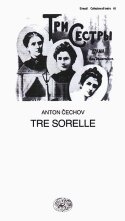La vita è sogno

Saggistica
Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
Le metamorfosi del reale
Calderón de La Barca è tra i maggiori autori teatrali, insieme a Lope de Vega, del secolo d’oro spagnolo, periodo fiorente dell’arte iberica, erede del nuovo spazio del mondo dopo la scoperta dell’America, un mondo orizzontale, partattico, modernissimo e non più quello verticale, di subordinate, del medioevo, cristallizzato nella distanza incolmabile fra uomo e Dio. Un mondo che si scopre labirintico e ariostesco e non a caso Calderón apre la sua opera più celebre con un “ippogrifo volante”, cosicché fin dalla prima battuta il libro si pone su un piano irreale, illusorio, che non è metafisico, quanto piuttosto un giochi d’ombre dove la veridicità è sospesa e tutto è possibile. Fin da qui Calderón pone il gioco di riflessi e specchi su cui tutta l’opera è costruita, a voler rimarcare nella struttura, prima ancora che nelle parole, il tema dell’opera, ovvero la vita che è puro sogno, un agitarsi di burattini ai quali nemmeno la datità del corpo permette di certificare la verità dell’esistenza. Considerato l’Edipo Re del teatro Barocco spagnolo, in realtà l’opera sembra avere più affinità con una altra grande opera dell’età classica, le Metamorfosi di Ovidio. Nell’autore latino la Metamorfosi, intesa come passaggio di stato, come immagine dinamica del divenire, di una realtà che continuamente si trasforma, lo spazio è un dedalo di inganni, illusioni, in cui la verità continuamente passa e nega se stessa. Non a caso l’opera di Ovidio è piena di specchi, il lago in cui si riflette narciso, o Pigmalione, lo scultore che plasma, a sua immagine, la realtà, venendone continuamente sopraffatto.
Nelle pieghe barocche e scivolose di questo mondo, un mondo di continue trasformazioni (e per questo di implacabili agnizioni), Calderón mette in scena le sue illusioni: Sigismondo, principe su cui grava una profezia nefasta, è fatto rinchiudere dalla nascita in una cella, per evitare che possa aspirare al trono; parallelamente Rosaura arriva in Polonia, travestita da uomo, per vendicare l’affronto subito da Astolfio, erede, in assenza di Sigismondo, al regno. Da qui Sigismondo sarà liberato (significativamente sotto sedativi, in modo tale che la realtà gli sfugga di mente) e Rosaura tornerà donna e ancora Sigismondo tornerà in cella e Rosaura assommerà le fattezze della donna e le armi dell’uomo. Nel mentre la scoperta dell’uno come principe e dell’altra come figlia del carceriere di Sigismondo. Tutto questo per dire dell’estrema mobilità della trama, dei giochi di disvelamento e delle storie che vengono a galla tanto ché ad un certo punto Rosaura (come Troilo prima di lei), ci vede doppio. Agnizioni esplicite che diventano anche l’occasione per i personaggi di scoprire ulteriormente se stessi. E così Calderón, pur riconoscendo l’illusorio e futile gioco della vita, sogno e poco più, non cede ad una possibile deriva nichilistica, ma anzi fa dire a Sigismondo che, pure fosse un sogno, non per questo l’uomo non dovrebbe comportarsi bene. E, parallelamente, sviluppa una riflessione di cruciale importanza, che già in Dante aveva creato accese diatribe teologiche: il libero arbitro di fronte alla predestinazione. In età di Controriforma, l’opera rasenta quasi la blasfemia. Sigismondo, rinchiuso per una profezia degli astri (e l’astrologia ha molto spazio nell’opera), tenta di essere salvato dal padre dalla saggezza dell’uomo, che può opporsi al destino, ma, proprio in questo tentativo, finisce per manifestare le più turpi azioni. Può allora l’uomo opporsi al volere del fato? Calderón risponde affermativamente e lo fa riconoscendo alle azioni positive, alla conoscenza, alla verità la capacitò di determinare il corso degli eventi.
Nonostante le riflessioni importanti che l’opera racchiude, siamo lontani dalla tempra filosofico-esistenziale di Amleto (che pure ha punti in comune con Sigismondo) o dalle invenzioni linguistiche di Shakespeare, e siamo anche distanti da quella tensione spirituale che l’arte spagnola coeva ha dimostrato nelle tele di El Greco, Zurbaràn o De Ribera. Calderón è più conciliante, meno ostinato, meno problematico e il tono favolistico dell’opera, complice anche uno stile che procede in versi e troppe rime baciate, rischia davvero di ridurre l’opera ad una favola. Detta in breve, lo stile non sostiene il peso dei contenuti e alla fine lascia un vago senso di insoddisfazione. Non perché non ci sia materia, ma perché qui la sostanza è tutta nell’interpretazione del lettore.