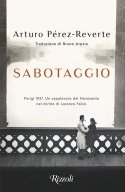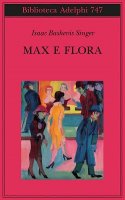Dettagli Recensione
Top 1000 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Coraggio e determinazione
Nella pubblicazione di questo memoir in Italia, così come nella sua riedizione in Inghilterra (l’originale è del 1968), non si manca di ricordare che ad esso si ispira la fortunata serie televisiva "Downton Abbey", cui non a caso rinvia l’immagine della magione ritratta sulla copertina del libro.
In realtà le fonti ispiratrici della serie TV – e di altre assai meno fortunate – non si limitano a quest’opera della Powell. Ciò che è più importante, tuttavia, è di non lasciarsi fuorviare dal lancio pubblicitario. In "Ai piani bassi" - il titolo originale è "Below Stairs" – non si trova certamente, né dovrebbe esservi ricercata, la ricchezza di intrecci caratteristica della serie TV e neppure, tanto meno, una narrazione pariteticamente divisa tra vicende, passioni e punti di vista degli abitanti dei “piani alti” e di quelli dei “piani bassi” (per non parlare di improbabili commistioni).
Il memoir narra specificamente la dura storia della Powell – allora Margaret Langley - che, avendo rinunciato a una borsa di studio per le condizioni di indigenza della famiglia, comincia a lavorare poco più che tredicenne: prima domestica-badante, quindi lavorante nella lavanderia e stireria d’un albergo, e infine a servizio. Un pesante apprendistato di sguattera, dal quale la protagonista riesce a saltare, audacemente, al rango di cuoca, presso famiglie della ricca borghesia di campagna dapprima e, in seguito, di famiglie abbienti, ma talvolta in declino, di Londra.
La narrazione rispecchia rigorosamente il punto di vista della protagonista, in cui non di rado l’identità individuale si espande a comprendere una coscienza di classe, e illustra con crudo realismo l’indigenza d’origine che spinge lei, come tanti altri, a cercare di sopravvivere e di emanciparsi attraverso le dure condizioni di lavoro e di vita della servitù dei redditieri. Nessuna inclinazione a sentimentalismi e autocommiserazione, ma la lucida consapevolezza delle barriere esistenti tra “noi”, poveri, e “loro”, i ricchi; del fatto che i padroni, persino nel momento in cui propendono ad atteggiamenti appena più aperti (o forse ancor più in queste circostanze), non riconoscono al personale di servizio la condizione piena di esseri umani. Non di rado, per converso, emerge l’orgoglioso riconoscimento di autenticità essenziali del proprio vissuto a fronte delle sfarzose superfluità delle classi privilegiate.
“Ai figli dei ricchi non era mai permesso giocare con bambini di basso ceto come noi. […] Non andavano mai in nessun posto senza tata. […] Noi, comunque, provavamo per loro un sorta di disprezzo. Non potevano fare le cose che facevamo noi […] Non potevano fare niente di emozionante. Non era colpa loro.”
Gli episodi di umiliazione assumono spesso connotati cocenti. Per aver osato di porgere dei giornali, che stava per posare su di un tavolo, al padrone di casa, nell’intento di fargli una cortesia, Margaret si guadagna un pesante, altezzoso rimbrotto: “Langley, non deve mai, in nessuna occasione, porgermi qualcosa a mani nude; usi sempre un vassoio d’argento. Dovrebbe avere un po’ più di giudizio. Sua madre è stata a servizio, non le ha insegnato niente?”
Indifferenti alle condizioni di lavoro dei sottoposti, i datori di lavoro erano invece estremamente solleciti per quanto ne riguardava i buoni costumi: “Del benessere fisico gli importava meno di niente: fintanto che eri in grado di lavorare, pazienza se avevi mal di schiena, mal di stomaco o mal di chissà che, ma si preoccupavano della tua moralità sotto tutti gli aspetti.”
La scrittura di Margaret Langley, nonostante i temi trattati, non è affatto pesante o cupa. Al contrario, essa è estremamente scorrevole e piacevole, certo anche per l’umorismo, non di rado salace, che ne è una costante permanente, e perché risulta avvincente la determinazione della protagonista a non farsi sommergere dalle condizioni avverse. Non siamo, però, nemmeno di fronte ai toni recriminatori e didascalici di un pamphlet politico. La Langley vede chiaramente come e quanto le condizioni di lavoro e di vita si siano evolute rispetto a quelle dominanti ai tempi della sua infanzia e giovinezza; non ha remore nel riconoscere, apprezzare, talora rimpiangere, senza alcun sentimento di invidia deteriore, la raffinatezza di oggetti, consuetudini, belle maniere consentiti dalla ricchezza; non è animata da spirito revanscista nei confronti dei ricchi, ma dalla volontà di riuscire nella sua lotta individuale sulla via dell’emancipazione, della conquista del benessere, dell’arricchimento culturale.
“Non sono particolarmente invidiosa dei ricchi, ma non li biasimo: cercano di tenersi stretti i loro soldi e lo farei anch’io, se ne avessi. L’idea che i ricchi dovrebbero condividere ciò che hanno è una corbelleria: solo chi non ha un soldo può pensarla così. A me, di condividere i miei a destra e a manca non passerebbe nemmeno per la testa.”
Una lettura, in conclusione, senz’altro consigliabile (e sicuramente istruttiva per tutti i negazionisti dei progressi conseguiti rispetto a tempi relativamente recenti dalle classi più indigenti).
Unico appunto che mi sembra si possa muovere all’autobiografia è che nelle ultime parti della narrazione fa capolino una certa ripetitività di vicende e considerazioni, mentre – per converso – le ultime tappe della scalata dell’autrice-protagonista appaiono riferite piuttosto frettolosamente, in termini privi dello spessore e della vivezza che caratterizza la parte antecedente della storia.