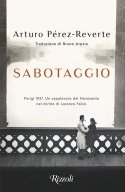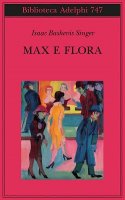Dettagli Recensione
Quale ostinazione?
Hammerstein. In un testo che non parla affatto di Hammerstein. Né della sua ostinazione.
Si direbbe, pertanto, un testo fuori tema. O forse no.
Il generale Kurt von Hammerstein, quell’ uomo complesso, duplex, in grado di
“…cogliere il nocciolo della questione, faceva durare un istante anche la più profonda delle conversazioni. Bisognava avere l’orecchio fine per riconoscere la portata di cose dette quasi en passant”.
Così nel suo sotto-testo, dove l’autore sfila tra le parole ed i gesti del generale di Weimar, del generale di quell’esercito tedesco che rappresenta la base costituzionale del sistema della democrazia contrattata, sfila, dicevamo, quell’identificazione tra legalità e legittimità propria della burocrazia tedesca.
Ai non giuristi: l’ asse costituzionale di Weimar deve considerarsi non tanto il testo costituzionale (che è di per sé un mero documento) quanto il patto Ebert-Groner (9 novembre 1918), ossia l’accordo (strutturalmente un patto costituzionale), tra la classe politica socialdemocratica e l’esercito tedesco, secondo il quale le forze armate avrebbero appoggiato la Repubblica a condizione di fissare il concetto di legalità, inteso nella sua vuota versione positivistica e burocratica come forza normativa del dato di fatto (C. Schmitt), come il grund della nuova unità politica.
Non ci fu nessuna rivoluzione costituente a Weimar (Troeltsch giustamente si stupiva: “Una rivoluzione che conservi con cura il corpo dei funzionari precedenti è un caso unico al mondo”). Vi fu piuttosto un accordo costituzionale cristallizzato sulla legalità.
È del tutto significativo, in questo senso, il discorso del ministro dell’ Interno David, socialdemocratico, che ai partiti di destra disse che la Costituzione “(…) vi dà la possibilità di realizzare per vie legali la trasformazione nel significato che voi le attribuite, con l’ovvia premessa che guadagnate alle vostre idee la necessaria maggioranza del popolo. Cade perciò ogni necessità di metodi violenti di lotta politica… La strada è aperta per ogni pacifico sviluppo legislativo. Questo è il valore supremo di ogni genuina democrazia”.
Mi pare piuttosto significativo allora il senso che questo giuspositivismo aveva del principio della legalità (Gesetzmassigkeit).
Tale, il punto di vista di Hammerstein, quando scrive “Se i nazionalsocialisti prenderanno il potere legalmente, dovrò farmene una ragione. In caso contrario, imbraccerò le armi” (p.73).
Ma, dicevo in precedenza, questo testo non parla di quel generale che nel 1933 abbandonò il suo ruolo, ritirandosi a quella vita quasi-privata, nell’ambigua posizione della emigrazione interna.
Dell’ asse weimariano, infatti, dopo poche pagine si tace: tutto viene sospeso. Il nazismo diventa sfondo astratto.
È invece la Germania post-bellica e divisa tra RFT e RDT quella con cui l’autore dialoga: tutta la tensione narrativa si coglie non tanto nell’attentato a Hitler, nel problema tedesco del “dittatore”, quanto nella confusione e nell’ambiguità tra i tedeschi in esilio, i tedeschi nascosti e la Russia, il comunismo, lo stalinismo.
Non si respira mai Weimar, dopo pagina 80. Direi che in tutto il testo, se mi è consentita questa tesi paradossale – trattandosi, apparentemente, di un protagonista dell’epoca hitleriana -, non si respira mai il Terzo Reich. Soprattutto quando se ne parla direttamente.
È una narrazione, invece, della divisione di Berlino, è un libro in cui si vede che l’autore non ha che ricordi di una Germania da guerra fredda.
È come se proiettasse la cortina di ferro già nel momento in cui parla di Hammerstein.
Credo che, terminata la lettura del testo, l’ impressione del lettore sarà proprio questa: non si parla mai di nazismo.
Si ha in mente la Germania lacerata, divisa, la Germania dei figli miseri di Hammerstein, delle loro carriere inutili, delle loro ideologie di basso livello. Non c’è mai Hammerstein, in questo libro, il suo spirito: c’è quello della Germania tra il 1946 ed il 1989.
È un libro tutto teso al crollo del Muro.
Non è un caso che la frase che l’autore pone come chiave del suo libro, “La paura non è un’ideologia”, è tratta da un discorso in cui Hammerstein non parla del nazismo, ma del comunismo russo (p.93: “Le relazioni con Mosca sono un patto col diavolo. Ma non abbiamo scelta. La paura non è un’ideologia”).
Ma allora quale è questa ostinazione? Di chi è?
Io dico che non è certo l’ostinazione di Hammerstein a resistere al nazismo.
Certo, questo è quel che l’autore vuol farci pensare. Ma non ci si impegna neppure troppo, a dire il vero.
L’ostinazione vera è quella dei suoi sette figli: nascondersi, confondersi.
Gente che è in a-simmetria con la storia, mentre il padre, comunque, fu un uomo storicamente saldo.
Il clima di questa ostinazione, ancora una volta, è allora quello da guerra fredda, non quello del nazismo.
Io penso che la miglior descrizione sia quella (riportata a pag. 149 del libro) che la Arendt riferisce a proposito dell’atmosfera della Mosca delle purghe staliniane (ancora, non a caso, la Russia, e non la Germania di Hitler) – ma che è il clima di tutto il libro, in realtà- : “un’atmosfera in cui, consapevolmente o inconsapevolmente, tutti spiano tutti, tutti possono rivelarsi degli agenti, tutti sono costretti a sentirsi sotto costante minaccia”.
È la profonda fuga dalla propria patria e dalla propria storia l’ostinazione che questo romanzo racconta: Hammerstein, ovvero la famiglia di Hammerstein.
È la storia dell’ostinazione a negare la storia stessa. A negarla nella sua nuova astrazione, l’astrazione in cui la storia diventa solo un’atmosfera, diventa solo un sospetto, diventa soltanto una minaccia: tale storia, non è quella del nazismo – che di astratto non ebbe nulla -, ma della nuova Germania, dopo la sua distruzione.
È la storia di figli e figlie che non ricordano o non vogliono ricordare il passato tedesco, e che vivono tra le due Repubbliche, tra gli Stati Uniti e la Russia.
Io penso che sia essenzialmente un libro sul passaggio all’astrazione della storia.
La Russia ed il comunismo sono le linee guida di questo sentiero.
I figli di Hammerstein pensano per categorie contrapposte rispetto al padre. Si pensi all’atteggiamento di Hammerstein verso la Russia, che tradisce la mentalità propria della borghesia ottocentesca, che pensa il diritto internazionale in termini di rapporti tra Stati, che è impreparato a considerare l’elemento del politico: è ancora un rappresentante di quegli eserciti europei che pensano ancora l’avversario come justus hostis, in quanto Stato, unità statale belligerante, e mai come nemico (“Per quanto rifiutiamo e combattiamo le idee rivoluzionarie, la Germania non deve dimenticare che a Mosca non c’è solo l’Internazionale comunista, ma in primo luogo il governo dello Stato russo”, p. 57).
Ora tutto cambia: figli e figlie di Hammerstein invertono la prospettiva.
La Russia è ora il solo comunismo, intorno al quale tutti i figli del generale ora si trovano a ruotare, chi con la pistola, chi non il semplice spiare: nessuno, però, con lo sguardo fermo del padre.
La lotta adesso, l’ostinazione, è il parto del nuovo processo giuridico di criminalizzazione del nemico, di guerra discriminatoria, del nuovo “partito della guerra civile mondiale” . Combattono anche loro, ma sulle ceneri degli Stati, sulle ceneri dell’unità politica interna.
E senza pensare che, in fondo, sono loro stessi il nemico criminalizzato.
Sono loro stessi i tedeschi la cui patria è stata negata, una patria occupata e divisa in due e che ha perduto il proprio status giuridico .
Hammerstein è, in fondo, un romanzo su quello specchio per le allodole che sta tra la colpa metafisica dei tedeschi di cui parla Jaspers ed il senso di innocenza collettiva (kollektive Unschuld) di quegli stessi tedeschi .
Questo specchio si chiama forse “anno zero”. O forse si chiama, come la chiama Enzensberger, ostinazione: è lo specchio in cui si nega se stessi, in cui si fugge dalla propria terra concreta, e verso l’astrazione.
L’autore lo sa: si trova costretto così, non vedendo che l’astratto nelle vite di questi personaggi, a chiedere la parola ai loro spiriti.
Ma questi non gli risponderanno. Non ne vorranno più sapere alcunché.
T.Gazzolo
(da http://www.moscasulcappello.com)
NOTE:
i- Così a proposito dell’Internazionale comunista E. NOLTE, Nazionalsocialismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945, Milano, Rizzoli, 1996, p. 4
ii - Mi limito a chiarire la situazione giuridica della Germania nel momento della sua distruzione definitiva, ossia della “resa incondizionata” firmata dal governo del Reich di Dönitz. Esprime con chiarezza e brevità il punto E. TRAVERSO, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 111-112: “Nel 1945, la Germania non è sottoposta a uno stato d’ «occupazione belligerante», secondo la definizione della convenzione dell’Aia del 1907. Detto altrimenti, non è una nazione sconfitta e temporaneamente occupata da forze vincitrici che ne riconoscono il carattere di stato belligerante. (…) La Germania ha perduto la propria sovranità, che è stata trasferita, de facto, alle quattro potente occupanti. Molto semplicemente, non esiste più uno stato tedesco. L’URSS, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia non vogliono firmare un trattato di pace con il nemico vinto, ma decidere del suo avvenire. «Dopo la resa incondizionata – spiega Hans Kelsen nel 1945 -, la Germania ha cessato di esistere come stato dal punto di vista del diritto internazionale». Il suo statuto, aggiunge lo studioso, corrisponde piuttosto a quello della debellatio”.
iii - Rimando ancora al testo di Traverso, p.121, per la concisione con cui l’autore riesce ad esporre concetti piuttosto complessi, che qui non possono essere trattati.