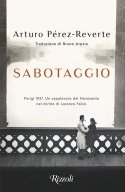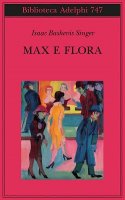Dettagli Recensione
L’ussaro sul tetto
Angelo Pardi è un miracolato. A cavallo o a piedi, alla luce del sole o sfuggendo le insidie, attraversa cinque mesi e quasi cinquecento pagine di colera accusando al più un principio di mal di pancia (sconfitto con due bottiglie di borgogna): eppure non si tira indietro, anzi si danna a soccorrere moribondi e lavare morti senza neppure badare a evitare il contatto con i fluidi corporei. Bisogna dire che, nella prima metà del romanzo, il vero protagonista non è lui, bensì la malattia che fa strage in una Provenza strozzata da una calura implacabile: un’afa innaturale che fa squadra con le innumerevoli descrizioni di morti colerosi e di uccelli più feroci di quelli di Hitchcock, il tutto a testimonianza della scelta iperrealista dell’autore. In sintonia con il clima, il ritmo è lentissimo e Angelo è quasi solo testimone sullo sfondo di un’immobilità assoluta. La ripetizione immerge il sud della Francia in una sorta di bolla o di incantesimo, ma non sempre la misura è quella giusta e la lettura si fa irritante, tra corpi blu, riso nel latte, cieli di gesso e foglie rigide: fastidio che però viene dimenticato grazie alle pagine migliori, come quelle che raccontano la sopravvivenza di Angelo sui tetti e per la strade della natìa (per l’autore) Manosque. In questi capitoli non si conosce il nome del protagonista e si hanno solo pochi accenni sul suo passato: solo dopo il definitivo incontro con Pauline scopriamo chi è e che ci fa lì (è in fuga dai moti carbonari in Piemonte). E’ il momento in cui il racconto prende la forma del romanzo di avventura, con un apice nella fuga dalla quarantena di Vaumeilh, mentre il nostro accompagna la bella fuori dai territori del contagio. Cambia anche il clima – ci si inoltra nell’autunno tra piogge e freddo – ma, a differenza della peste manzoniana, il colera (in gran parte immaginario) di Giono non demorde e anche il passo del romanzo resta grave sullo sfondo di una natura quasi sempre matrigna, dove ai paesaggi calcinati dal sole si sostituiscono aspre colline tra le quali ci si può perdere per mancanza di punti di riferimento. La tendenza a calcare la mano rimane sempre – come nell’episodio dei contadini che hanno appena ucciso il maiale – mentre Angelo rivela sempre più un animo nobile, da vero erede dei cavalieri senza macchia e senza paura, che risalta nei confronti della pusillanimità borghese: motivo che ritorna spesso, sia nelle considerazioni del protagonista, sia nei dialoghi con i numerosi personaggi, fra i quali risultano migliori quelli provenienti dalle classi più umili. La gestione delle figure secondarie è, d’altra parte, a volte insoddisfacente, con abbandoni improvvisi non appena se ne esaurisce l’utilità: il dottore ebreo e l’ufficiale medico che compaiono all’inizio, la suora di Manosque, l’amico Giuseppe sono solo alcuni esempi mentre si prende anche troppo spazio l’altro dottore, il logorroico e solitario ospite sulla strada per Gap. Così, sia durante la lettura sia alla fine, resta una sensazione ambivalente, sospesa tra l’ammirazione per i moltissimi passaggi convolgenti in un libro di certo non banale, pur se costruito su di una storia lineare, e la pazienza che a volte scappa quando all’improvviso il motore dà l’impressione di girare a vuoto, non aiutato certo una tradizione ricca di termini desueti.