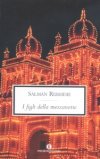Dettagli Recensione
UN'EPOPEA STORICA E FANTASTICA
Ricordate Forrest Gump, il protagonista dell’omonimo film di Robert Zemeckis del 1994 che attraversava involontariamente e con la sua candida ingenuità gli avvenimenti più importanti del dopoguerra americano, dalla guerra in Vietnam allo scandalo Watergate, uscendone miracolosamente e paradossalmente trionfante? Ebbene, Saleem Sinai, la voce narrante de I figli della mezzanotte, è una sorta di Forrest Gump alla rovescia: anche lui si trova presente in prima persona a tutti gli eventi cruciali della travagliata storia indiana degli ultimi trent’anni, ma, a differenza del suo omologo americano, egli non ne esce affatto indenne, subendo fino in fondo tutti i rovesci e le umiliazioni inflitti dalle guerre, dagli odi religiosi, dai colpi di stato e dalle persecuzioni politiche in cui si trova suo malgrado coinvolto. I figli della mezzanotte è infatti un romanzo in cui le esistenze dei personaggi procedono parallelamente alle date importanti della Storia (a partire dalla nascita di Saleem avvenuta nel giorno, anzi nell’ora precisa – la mezzanotte - dell’indipendenza della nazione indiana), l’individuale si mescola al collettivo, il privato al pubblico, sino a tracciare con questa ininterrotta sovrapposizione un quadro acuto e nient’affatto convenzionale (per non dire polemico) della recente storia dell’India (più o meno dal primo dopoguerra al governo di Indira Gandhi). Ci troviamo quindi di fronte a un romanzo simbolico? Certamente, anche se non in un’accezione propriamente tradizionale. Il Saleem che influenza direttamente la storia indiana (ad esempio, con il suo improvvido incidente in bicicletta egli scatena una serie di eventi che porta ai sanguinosi scontri di piazza tra manifestanti di fazioni contrapposte e alla spartizione dello Stato di Bombay), e la cui faccia (come sarcasticamente gli fa notare il perfido insegnante di storia) sembra la carta geografica dell’India, è fuor di ogni dubbio una metafora in cui si possono leggere in controluce le tare di una nazione ambiziosa ma imperfetta, alla ricerca di un ruolo di primo piano sullo scacchiere mondiale ma tristemente destinata a rimanere relegata ai margini del mondo sviluppato, e inoltre i sensi di colpa per i conflitti armati, le violenze occulte e le sopraffazioni di cui si è nutrita una democrazia troppo simile al regime coloniale che l’ha preceduta, l’oblio e l’amnesia come rimozione della vergogna per le molteplici mutilazioni (di parti del corpo così come di stati) subite dai potenti di turno, l’abbandono al fatalismo e all’inevitabilità di una condizione immutabile nonostante le periodiche e immotivate crisi di ottimismo, ecc. C’è però in questo simbolismo a tratti fin troppo esplicito un carattere nuovo e insolito, e cioè la lucida consapevolezza che Saleem ha della propria natura metaforica. Ad un certo punto (pagg. 274-275) egli ad esempio discetta ironicamente sui modi di connessione (le combinazioni attiva-letterale, passiva-metaforica, passiva-letterale e attiva-metaforica) da cui è contrassegnata la sua vita, il che dà al suo diario (una rievocazione scritta, non a caso) una profonda valenza meta-testuale, di riflessione cioè sui modi in cui lo scrittore (“doppio” evidente del narratore) può legare storie individuali e Storia collettiva. Il protagonista attribuisce inoltre al proprio racconto (e alla propria mentalità) caratteristiche più propriamente letterarie, come quelle “descrizioni realistiche del bizzarro, nonché il loro opposto, vale a dire le versioni intensificate, stilizzate del quotidiano” (pag. 253) che sono espressione della scrittura ossimorica di Rushdie.
Ma torniamo a Saleem Sinai, il bambino della mezzanotte. Il suo racconto-diario, un po’ romanzo di formazione, un po’ monologo psicanalitico e un po’ libro picaresco e d’appendice, percorre i territori più svariati, dall’esotismo avventuroso (“Nel Sundarbans”) al fantastico e al parapsicologico (le sue proprietà telepatiche e i prodigiosi talenti degli altri “figli della mezzanotte”), e ha innumerevoli sfumature, non ultima una vena patologica che, pur contraddetta dall’apparente verosimiglianza della narrazione, si fa sotterraneamente largo pagina dopo pagina, man mano che la congiura della Storia contro lui e gli altri coetanei nati nella mezzanotte del 15 agosto 1947 inizia a prendere forme e contenuti fanta-politici. Viene da chiedersi se tutto il romanzo non sia in fondo il frutto malato della mente di un folle con un gigantesco complesso di persecuzione. A pensarci bene, Saleem ha una mentalità un po’ paranoica: è convinto che la guerra indo-pakistana sia scoppiata col solo scopo di sterminare la sua famiglia, un fascicolo intravisto nelle mani di suo zio con la sigla “MCC” gli fa sospettare che lo spionaggio governativo sia sulle tracce della fantomatica Conferenza dei Bambini della Mezzanotte (di cui le tre lettere costituiscono l’acronimo in lingua inglese), si attribuisce persino la responsabilità indiretta della morte di Nehru; in aggiunta a ciò, ci sono intenzionali inesattezze storiche, volute dimenticanze e persino l’ammissione di una falsificazione (la morte dell’alter-ego Shiva). Tutte queste ambiguità, pur senza nulla togliere al carattere metaforico del romanzo, e oltre a creare uno schermo protettivo per l’autore (il quale è estremamente polemico tanto nei confronti dell’establishment politico indiano quanto del fanatismo religioso, sia esso induista o musulmano, e quindi gli può tornare utile celarsi dietro a un personaggio farneticante e psicopatico), creano anche un sorprendente equilibrio tra verità e invenzione, tra fantastico e reale, tra grottesco e naturalistico, per cui non sappiamo mai qual è l’autentico registro del racconto, il quale fino alla fine si fa beffe di qualsiasi classificazione, sgusciando bellamente attraverso le larghe maglie di ogni banale tentativo critico e interpretativo.
Qualcosa su I figli della mezzanotte è comunque possibile dirla, le sue affinità letterarie più prossime, per esempio. I referenti obbligati del romanzo di Rushdie sono Gabriel Garçia Marquez per il modo di narrare vicende surreali con un tono distaccato e impassibile, come se fossero le cose più normali del mondo, e più ancora il Günther Grass de Il tamburo di latta per la prosa ironica, dissacratoria e politicamente scorretta, per non dire iconoclasta. Ma la scrittura di Rushdie è soprattutto fortemente, prepotentemente personale: il suo stile è fluente, immaginifico e barocco. Lo scrittore indiano è straordinario nel tenere una materia narrativa “eccessiva” in un mirabile equilibrio di forma e contenuto per più di cinquecento pagine, tirando alla fine i fili della lunghissima ed elaborata rievocazione del passato di Saleem in una sintesi dal sapore quasi felliniano, con la dissoluzione del protagonista in una miriade di pezzi che rappresentano l’intero popolo indiano. Una vera e propria moltitudine sono i personaggi del romanzo, racchiusi tra i due Adam dagli occhi azzurri come il cielo del Kashmir, il nonno e il figlio di Saleem, e Rushdie è bravissimo a non perderli per strada, a portarseli dietro, a tenerseli stretti (insieme a ricordi, odori e sensazioni, come la sputacchiera d’argento e al chutney di Mary Pereira), convinto come il suo protagonista che “per capire una sola vita dovete inghiottire il mondo”. Un altro accorgimento stilistico di Rushdie è l’uso inusuale dei flashforward: fugaci e impercettibili accenni ad avvenimenti che devono ancora accadere (ad esempio, “e qui, nella solitudine del tempo arrugginito, feci paradossalmente i miei primi passi esitanti verso quel coinvolgimento nei grandi eventi e nelle vite pubbliche da cui non mi sarei mai liberato… se non quando la Vedova…” – pag. 202 – o ancora, “se Evie non fosse venuta a vivere in mezzo a noi… non ci sarebbero stati né un climax nella pensione di una Vedova, né una chiara prova del mio significato, né una coda in una fumante officina,… Ma Evie Burns venne sulla sua bicicletta argentea e mi permise non solo di scoprire i bambini della mezzanotte, ma anche di provocare la spartizione dello Stato di Bombay” – pag. 211), i quali accenni creano, a dispetto del tono del racconto, una sottile curiosità (per non dire addirittura suspense) che tiene avvinto il lettore fino all’ultima riga. Salman Rushdie possiede inoltre la stupefacente abilità di ipostatizzare gli stati d’animo e i sentimenti, in linea con quella vena metaforica che in fin dei conti consiste nell’accostare cose concrete (fatti, personaggi, ecc.) ad entità astratte (il destino, il significato, e così via): così rancori, risentimenti, gelosie, invidie e sensi di colpa si trasferiscono sui cibi cucinati (il chutney del rimorso di Mary Pereira) o sui corredini per bimbo fatti a mano (impregnati del desiderio di vendetta della zia Alia). Infine si può citare una capacità molto più tradizionale, quella di disegnare con raffinata semplicità personaggi splendidi e indimenticabili, che si imprimono - anche quelli secondari - nella memoria del lettore grazie a un intercalare tipico (lo spassoso, e ripetuto a sproposito in ogni discorso, “comesichiama” della Reverenda madre) o un tratto fisico distintivo (la faccia da Pulcinella di Zulfikar). Grazie a questi (e a molti altri) meriti letterari, I figli della mezzanotte è qualcosa di veramente unico nel panorama letterario del ‘900, un romanzo che, non solo perché si propone di essere lo specchio di una nazione nell’arco di molti decenni, si può a buon diritto definire epocale.