Dettagli Recensione
la colpa l'innocenza
TEMPO DI UCCIDERE (1947) romanzo di ENNIO FLAIANO (1910-1972)
le indicazioni di pagina si riferiscono all’ediz. Rizzoli del 1973
PRESENTAZIONE GENERALE. Il titolo e la copertina di certe edizioni possono far pensare ad un romanzo d’avventura, insomma a un libro di intrattenimento o addirittura commerciale, e invece non è affatto così, tuttavia avvince dalla prima all’ultima pagina. Perché? Perché è il protagonista stesso che racconta la sua storia in prima persona, e lo fa in modo non di rado parziale allusivo ed elusivo, quasi raccontasse a se stesso piuttosto che a un ignaro interlocutore. Perché il suo tono apparentemente razionale e oggettivo, persino banale, fa dapprima pensare ad una narrazione realistica di ciò che “realmente” accade, senonché leggendo intuiamo presto che la sua interpretazione dei fatti e la consapevolezza dei suoi sentimenti è sempre contraddittoria, e siamo perciò costretti a capire al di là delle parole che dice. Perchè pagina dopo pagina ci chiediamo se apprenderemo come l’esperienza narrata si riverberi sul suo presente e se alla fine egli pagherà per quel che ha fatto. In estrema sintesi, infatti, è la storia di un delitto nell’Africa coloniale e degli sforzi tortuosi del militare che lo ha perpetrato - colui che racconta - di sfuggire alle temute conseguenze del suo atto, e Flaiano rende conto magistralmente degli auto-inganni di chi in fondo, ma appunto in fondo, si sa colpevole. Il delitto resterà impunito anche quando il protagonista deciderà infine di costituirsi: “Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri” (p. 273). Esattamente il contrario di quanto ha espresso Sartre pochi anni prima in “Processo a porte chiuse” (1944): per Sartre la colpa non si estingue mai perché eternamente gli altri la vedranno (“l’inferno sono gli altri”). Tuttavia le ultime righe del romanzo, come si vedrà, fanno pensare che nel proprio foro interiore il colpevole non si assolverà mai.
1. IL TITOLO è desunto dall’Ecclesiaste, e “… tempo di uccidere e tempo di sanare; tempo di … Eccl. III, 3” sono le parole in esergo al libro. Inizialmente però il titolo doveva essere “Il coccodrillo” e in effetti il coccodrillo è un elemento ricorrente nell’opera, prendendo anche la forma del drago infilzato dall’Arcangelo Gabriele nella pittura che il tenente scopre sulla porta della capanna che non a caso sceglie di abitare. Esso rappresenta certo il Male contrapposto al Bene, ma questo Male si configura come il pericolo che non vediamo ma temiamo incomba su di noi, come il coccodrillo acquattato nei fiumi africani, la paura dell’ignoto insomma, e l’uomo “civilizzato” non è capace di governare questa paura, e anzi la civiltà lo ha reso arrogante e ha indebolito la sua forza morale, irretendolo con sofismi.
2. L’AFRICA DI “TEMPO DI UCCIDERE”. Flaiano conosce l’Etiopia per esserci stato come soldato, e della sua esperienza militare io so solo quanto ne traspare in questo romanzo, e cioè che la guerra vi ha portato morte corruzione umiliazione. Su questo piano un passaggio significativo la testimonianza di un commilitone di colui che racconta, su quanto accadde una volta presumibilmente in un ospedale: “Erano briganti, disse, e il colonnello voleva ammazzarli tutti, anche i feriti. Occhio per occhio, diceva. E dove trovava un ferito, sparava. (…) Venne il dottore e disse: Ma se lei non gli spara alla testa, non conclude nulla con questa gente. Allora il colonnello cominciò a sparare al primo ferito che vide. Il cranio scoppiò e il colonnello si trovò imbrattato. Se l’avesse visto! Era su tutte le furie. Investì il dottore di insulti: Bei consigli mi dà, lei! urlava. Dovette andare a cambiarsi” (p. 81).
Tuttavia l’Africa di “Tempo di uccidere” non è soprattutto un luogo geografico né il teatro di eventi bellici, bensì la foresta delle fiabe e delle narrazioni mitiche, quel luogo in cui tutto è possibile, che con la sua alienità, mette alla prova l’uomo che vi si avventura. E qui l’alienità è data non solo e non tanto dalla selvatichezza della natura, ma dal fatto che vi abita un’umanità primigenia, che non conosce il peccato, i cui abitanti sono “antichi” come gli uomini dei tempi della Bibbia. E gli unici personaggi che hanno un nome si chiamano Mariam, Johannes ed Elias.
3. IL CAPITOLO I (il libro è articolato in 7 capitoli suddivisi in sottocapitoli) si intitola “LA SCORCIATOIA”, altro titolo cui Flaiano aveva pensato per questo suo romanzo. Il protagonista comincia qui a raccontare cosa gli occorse nell’ultimo mese e mezzo della sua permanenza in Africa,. Racconta ai tempi del passato, senza nulla dirci del suo presente né quanto questo presente sia lontano dalle vicende narrate.
All’epoca dei fatti egli è un giovane tenente dell’esercito italiano e da diciotto mesi (p. 12) si trova in Etiopia: siamo dunque fra il ‘35 e il ‘36. Ha ottenuto quattro giorni di licenza per raggiungere una città in cui gli potranno curare un dente malato, ma il suo camion si rovescia e poiché il successivo non passa prima del giorno dopo, si avventura per una scorciatoia che gli segnala un uomo dalla “singolare bellezza” (p. 11): “Il Cielo mi guardi dall’insinuare il sospetto che egli sia più di una semplice comparsa e che al suo intervento si debba quanto seguì” (p. 11). Di fatto l’ufficiale si smarrisce in una boscaglia dove anche marciscono i cadaveri di tre abissini scarnificati dai corvi: “non c’era più sentiero” (p.15) e “l’orologio s’era fermato” (p. 17) (il riferimento a Dante mi pare lecito).
Cápita in un “folto d’alberi verdi” dove ritrova la lettera della moglie (“Lei”) che non si era accorto di aver perduto quando evidentemente già era passato da lì : “Tra quei cari alberi ricominciava la vita e ogni cosa ripigliava la sua vera proporzione, anche la mia paura. Ripresi la corsa e lasciavo che le gambe si muovessero automaticamente, ma ancora dovetti fermarmi. Tra gli alberi c’era una donna che stava lavandosi” (p. 19). La bellezza (anche questa “singolare”) della giovane etiope evoca in lui un mondo primigenio di bellezza e di innocenza, intatto come ai tempi della creazione. La donna è nuda: “La guardavo e la purezza del suo sguardo rimaneva intatta” (p. 24); quando si riveste, gli appare “vestita ancora come le donne romane arrivate laggiù, o alle soglie del Sudan, al seguito dei cacciatori di leoni e dei proconsoli” (p. 24). Ed ecco il pensiero fatale: “Io cercavo la sapienza nei libri e lei la possedeva negli occhi, che mi guardavano da duemila anni (…) Fu questo pensiero, credo, che mi trattenne”(p. 25). Preso dalla febbre del desiderio, l’uomo costringe la donna a sedersi: “Mi respinse, quando la toccai, e fece il gesto di levarsi. S’era rabbuiata. La rimisi a sedere bruscamente (…) e lei mi respingeva con fermezza, ma il mio desiderio, così male espresso, non l’offendeva: non ne faceva una questione di belle maniere e di opportunità. Respingeva le mie mani perché così Eva aveva respinto le mani di Adamo, in una boscaglia simile a questa” (p. 25). Lui non capisce perché la giovane lo rifiuti benché lui le abbia offerto due monete d’argento e non sia sposata: “cominciavo a non capirci più (…) Forse, come tutti i soldati conquistatori di questo mondo, presumevo di conoscere la psicologia dei conquistati. Mi sentivo troppo diverso da loro, per ammettere che avessero altri pensieri oltre quelli suggeriti dalla più elementare natura. (…) Potevano vivere conoscendo solo cento parole. Da una parte il Bello e il Buono, dall’altra il Brutto e il cattivo. (…) Nei miei occhi c’erano duemila anni di più e lei lo sentiva. (…) La lotta continuò ancora, e avrebbe potuto continuare (…) e invece, com’era cominciata, così bruscamente finì: ma evitava di guardarmi”.
Dopo questa litote, il racconto prosegue così:“Qualcosa era nato in me che non sarebbe più morto. (…) Oppure avevo ritrovato qualcosa?”(p. 26-27). L’uomo si addormenta brevemente e nel sogno si dice, come fosse finalmente pacificato: “Esisteva qualcosa di diverso? Scendevo alla riva dell’affluente e il coccodrillo aveva l’aria di darmi il benvenuto, e scompariva come un tronco d’albero, lasciandomi felice di quell’accoglienza che mi assolveva” (p. 28). Al risveglio però il suo stato d’animo è mutato: “Dovevo andarmene (…) La donna si era fatta misera e il mio peccato insignificante” (p. 29); di nuovo le offre le due monete: “Non voleva nulla e, purtroppo, ne fui fiero” (p. 29), è però attratta dal suo orologio e lui glielo regala : “Era un orologio da quattro soldi … Quale migliore occasione per abbandonarlo?” (p.30). Dice, ripensando a quel desiderio infantile: “credo di essere arrivato a capire il perché di quella donna. Quel giorno, anzi in quelle ore, stava varcando la soglia della giovinezza, lasciandosi alle spalle l’adolescenza, e i suoi gesti prendevano dell’una e dell’altra età” (p. 30). Nell’affibbiarle l’orologio al polso, lui ha “la sgradevole sensazione di infilarle l’anello nuziale” (p. 31), e forse anche per lei quel dono è stato una sorta di promessa: “Quando vide che me ne andavo davvero, lanciò un grido che mi ferì le viscere” (p. 31), e allora “Ritornai verso gli alberi - continua -, lasciandomi condurre, e la cosa ricominciò. Di nuovo lo sgomento di cadere in quel fiume secolare, di nuovo la gioia di caderci e la certezza che era inutile uscirne” (p. 31). Si addormenta e al risveglio lei non c’è: “Il mio primo moto fu meschino, frugai lo zaino per vedere se avesse tolto qualcosa, e c’era tutto” (p. 31), però l’incapacità di sottrarsi al desiderio che prova per la giovane indigena suscita in lui quel sospetto, che lo accompagna in realtà in ogni sua relazione con gli altri, di essere oggetto di “un odioso disegno (…) Ma quale disegno?” (p. 32). Mentre lui esita, la giovane torna e gli porge “uova e un pane azimo (…) ancora caldo” (p. 32). Mentre mangia, lui la osserva, e ancora non si capacita di tanta bellezza, così diversa da quella tipica delle donne indigene, e volendo toccarle i capelli, cerca di toglierle il turbante che li copre, ma lei “respinse la mano bruscamente” (p. 33). Nel frattempo è calato il buio, impossibile rimettersi in cammino: “Ero in trappola”, dice (p. 34). Alla sua profferta di passare la notte nel suo villaggio lui pensa che “si fa presto a nascondere il cadavere di un ufficiale” (p. 35); davanti al suo rifiuto, la donna gli mostra allora un anfratto: “Era una proposta sciocca e mi ribellai: “Il ponte” ripetei più volte e ancora la spinsi, ma lei si liberò sorridendo” (p. 36). La giovane accende un piccolo fuoco che crea un’atmosfera di “intimità domestica” (p. 36); “Ormai dovevo rassegnarmi - dice - e aggiungerò che questa rassegnazione cominciava a piacermi troppo: dai modi della donna capivo infatti che sarebbe restata a tenermi compagnia” (p. 36). Si amano dunque nuovamente; dopo l’amore, però, il giovane cede alla paura dell’ignoto - qui è un rumore nella boscaglia notturna popolata di animali selvatici o forse di nemici - e spara nel buio: anche qua il caso (caso o destino?) vuole che la pallottola colpisca gravemente la donna e - questo è l’atto indicibile, irreparabile -, temendo che l’assassinio sia scoperto, lui la “finisce” per poterne nascondere il cadavere e con esso la propria colpa, anche a se stesso: “in fondo non l’avevo uccisa, le avevo impedito di soffrire più a lungo” (p.52). Cancella le tracce del delitto, in un crepaccio nasconde il cadavere, avendo avuto cura di togliere l’orologio dal polso, ricopre tutto di pietre; “recitai - dice - una breve preghiera” (p. 53) e infine si allontana, ritrovando quella scorciatoia che, per non averla lui vista, l’aveva condotto alla giovane indigena, che probabilmente si chiamava Mariam, poiché “tutte le Etiopi si chiamano così”.
Da questo momento il senso di una colpa sempre oscuramente sentita e mai pienamente assunta, simboleggiata dalla lebbra che teme di aver contratto dalla donna, che portava il turbante bianco dei malati di lebbra in quelle contrade, lo imprigiona in una spirale di azioni e pensieri contraddittori anche criminosi - il progetto di uccidere il dottore, il furto al maggiore, la pianificazione dell’uccisione di questi, il desiderio di uccidere il vecchio - finalizzati a sfuggire alle conseguenze delle sue azioni, però ... Però, per quanto ripetutamente egli si dica deciso a partire, a lasciare il luogo che è diventato la tomba di lei, sempre inesorabilmente vi ritorna per ragioni che in realtà sono pretesti.
4. CAPITOLO VI (il penultimo). Molto lentamente, senza che la coscienza e la volontà vi giochino un ruolo forse perché non si danno scorciatoie nella vita, qualcosa di simile ad una liberazione e ad una rinascita ha inizio quando infine egli smette i suoi tentativi sempre rinviati di partenza per stabilirsi vicino a quella tomba, nel villaggio distrutto (non è chiaro da chi) dove vivono ormai solo un mulo dimenticato dall’Esercito e il vecchio ascari Johannes, occupato a custodire il tumulo sotto il quale giacciono i suoi morti e a fabbricare dei pali (si saprà alla fine del capitolo a cosa devono servire). Tra i due uomini c’è un non detto che genera una segreta tensione, la quale sfocerà infine in uno scontro fisico: un giorno che la sua abituale compostezza è alterata dall’alcool, il vecchio colpisce l’ufficiale con violenza insospettata, come se cedesse ad un’esigenza a lungo trattenuta, e l’ufficiale lo colpisce a sua volta, acquisendo in quel momento la certezza improvvisa che Johannes è il padre di Mariam e del giovanissimo Elias, datosi a piccoli traffici con gli occupanti. Ferisce il vecchio, ma non lo uccide, nonostante ne sia tentato: “Dopo un’ora di simili snervanti meditazioni arrivai a un compromesso. Non l’avrei ucciso, ma minacciato soltanto”. “Restai - dice - e Johannes guarì in tre giorni, e in quei tre giorni si può dire che diventammo amici, o almeno questa fu la mia illusione” (p. 251). Il quarto giorno, “molto agitato (...) per l’attesa di Elias”, il tenente scende al fiume e qui ha l’impressione che un coccodrillo lo minacci, per cui scarica l’arma là dove vede il sommovimento dell’acqua, dopodiché si riavvia alla capanna, ora quasi sicuro di non voler partire: “Troppi processi mi attendevano, troppi processi e l’ospedale. E verrebbe Lei a visitarmi? (…) Oppure non verrebbe affatto? Una solitudine vale l’altra, insomma” (p. 253). Dal sentiero intravede però dei carabinieri preceduti da Elia, e subito, come sempre, pensa ad un tradimento e fugge. “Giunto sulla riva - racconta - saltai in groppa al mulo e lo spinsi in acqua. (…) non voleva saperne di entrare in acqua (…) Ora, sulla riva, non più lungo di cinque palmi c’era un coccodrillo. Era un coccodrillo giovanissimo (…) Ci guardava , lo guardavamo, e nessuno di noi tre si muoveva (…) Devo agire, ma come? Fu il coccodrillo stesso a suggerirmi, sollevando la testa. (…) La bestia ricevette quel terribile calcio sotto la mascella inferiore. (…) Se ne andava.” (p. 257-8). Arriva Elias: i carabinieri sono andati via - erano venuti perché attratti dai suoi spari di qualche ora prima - e lui può dunque tornare al villaggio. Racconta: “La mattina dopo, all’alba, mi accingevo a lasciare il villaggio (…) Quando salutai Johannes ero convinto che sarei partito, ma ...” (p. 259). Come sempre avviene qualcosa che lo trattiene o che orienta le sue azioni in una direzione diversa da quella annunciata: a Johannes offre del denaro (e anche qua le sue intenzioni, in cui sempre entra il calcolo, non sono univoche), ma Johannes gli fa capire che desidera piuttosto l’orologio che lui ha al polso, l’orologio che lui aveva donato a Mariam e tolto dal polso di lei prima di nasconderla nel crepaccio: “Gli occhi di Johannes non si staccavano dai miei e, più del mio pallore, dovette tradirmi il gesto istintivo che feci di nascondere l’orologio: quell’orologio che la donna tornando al villaggio aveva certo mostrato. Quando potei parlare, dissi: “Andiamo”. E lo lasciai solo davanti alla tomba di Mariam. Ed io non partii. Non partii perché aveva ammesso l’esistenza di Mariam (ormai ognuno di loro sa che l’altro sa) e ora avrebbe parlato di Mariam e avrebbe detto se la mia debole speranza era o no infondata. Quando, il giorno dopo (…) gli chiesi ciò che volevo sapere, il vecchio rispose. Gli mostrai le mie piaghe e allora scosse il capo. Le guardò a lungo. La sera stessa mi applicava il primo disgustoso impiastro sul ventre e sulla mano. Io lo ricevetti singhiozzando ma senza crederci, non era possibile, non poteva essere vero che sarei guarito. Singhiozzai al punto da restare stordito nella capanna (…) sino all’alba” (p. 259). Come prima l’ufficiale italiano ha “sanato” il vecchio, per dirla con Flaiano, ora il vecchio ha “sanato” l’ufficiale.
“La mattina del quarantunesimo giorno (sempre scandisce con precisione i tempi della sua “avventura”, quasi rendesse conto di un tempo lungamente meditato) presi la scorciatoia per l’altopiano, andavo a costituirmi. Inutile nascondersi ormai. Le piaghe stavano guarendo. (…) Passando davanti alla tomba di Mariam, vidi che era coperta da una tettoia di paglia. La sorreggevano i pali che il vecchio aveva tagliato con tanta ostinazione” (p. 260). Così finisce questo capitolo, e il lettore crede che qua si sia rivelato il senso della storia: il protagonista ha riconosciuto la sua colpa e desidera espiare, come in “Delitto e castigo” per esempio. E invece segue un ultimo capitolo che si è tentati di considerare del tutto avulso da quanto precede perché strutturalmente diverso, ma come sempre … “in cauda venenum”.
5. L’ULTIMO CAPITOLO. Il tenente scopre che nessuno lo cerca per giudicarlo e che può prepararsi alla partenza per l’Italia coi commilitoni. Ha raccontato la sua storia (quella che nel frattempo abbiamo letto?) ad un sottotenente suo amico e riporta la lunga conversazione con lui, nel corso della quale l’amico, invece di parlargli di colpa ed espiazione come lui si aspettava (p.261) analizza “i punti oscuri” della storia fino a disarticolare i fatti finché tutto svanisce nell’incertezza, e innanzitutto la colpa, anzi le colpe, del giovane tenente. “Come tutte le storie di questo mondo - gli dice l’amico -, anche la tua sfugge a un’indagine. (…) Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia, da quel giovane superficiale che eri (…) Tacemmo. L’aver ucciso Mariam ora mi appariva un delitto indispensabile, ma non per le ragioni che me l’avevano suggerito. Più che un delitto, anzi, mi appariva una crisi, una malattia, che mi avrebbe difeso per sempre, rivelandomi a me stesso. Amavo, ora, la mia vittima, e potevo temere soltanto che mi abbandonasse”. Il “tempo di uccidere” è finito ed è ora “tempo di sanare”, secondo l’esergo al libro. E per guarire, meglio non conoscere con certezza le conseguenze delle proprie azioni: “I dubbi confortano, meglio tenerseli”, ossia, meglio l’incertezza circa moventi e conseguenze di ciò che si fa, dice il nostro all’amico che gli chiede se vuole verificare se il maggiore è morto a causa del dado tolto dalla gomma del camion (p. 272). E d’altra parte, “Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri” (p.273). “Se nessuno mi ha denunciato meglio così. Tuttavia non si ha diritto di essere tanto generosi”, dice il nostro, come se fosse dovere degli altri punire piuttosto che dovere del colpevole esporsi al castigo), e l’amico gli risponde: “ O prendere o lasciare”. Il nostro “prende”. Squilla infatti la tromba che chiama all’adunata in vista della partenza: “È una tromba abbastanza comica per il mio Giudizio, dissi, ma a ciascuno la sua tromba”. “Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste (…) Eppure, dissi, questa valle …” Ma non seguitai (inutile citare un autore, quando di un foglio del suo libro abbiamo fatto cartine per sigarette)” (p. 273). L’allusione è a Dio e alla Bibbia, delle cui pagine il tenente ha fatto cartine per sigarette.
6. MA QUAL È IL SENSO DI QUESTA STORIA? Ha condizionato la vita del protagonista? Poche cose sono certe in questo romanzo sospeso tra realtà percezione soggettiva e non detto, però alcuni elementi fanno pensare ad un suo cambiamento. Dell’uccisione di Mariam il protagonista dice: “ora mi appariva un delitto indispensabile (...) , anzi (...) una crisi, una malattia, che mi avrebbe difeso per sempre, rivelandomi a me stesso”, ma queste parole non sono risolutive perché i tempi verbali sono quelli del passato e non ci sono indizi sicuri che questo sentimento perduri nel presente. Più significativo, per quanto sibillino, mi sembra il passaggio seguente nella parte finale : “Non c’erano denunce. C’era soltanto una lettera di Lei, ma non l’ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare il mio ultimo complice [Lei]. Per quel suo volto dei momenti gravi (sono le stesse parole che usa parlando di “Lei” a p. 48), ho ucciso la donna. (…) Dovrò lasciarla [Lei]. Credevo che la sua malinconia [di Lei] le venisse dall’esperienza del cuore e fosse meditatissima e sentita. Ora dovrò convincermi che in lei (ora con lettera iniziale minuscola ma non può essere che Lei) è soltanto una traspirazione organica, un alito freddo e fetido. Forse lo stesso fiato che mi angustiava un tempo, rammentandomi ciò che più temevo (forse che non c’era amore?). Se lei dovesse entrare in acqua senza spogliarsi (giacché Lei non è donna da entrare in acqua nuda), facendomi cenno di seguirla (come era avvenuto con Mariam), starei fermo sulla riva, incapace di accettare le leggi della sua ipocrita pazzia. (…) Il postino (…) non trovava la lettera. E io sentivo che, la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l’ho ancora aperta” (p. 262-3). In queste parole io leggo che “Lei”, cioè la casa, il luogo delle certezze, si sono rivelati vuoti simulacri di miti in cui in realtà lui non crede più.
Il romanzo si chiude con parole enigmatiche: “Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo (di Mariam, il “gentile effluvio” che già più volte ha sentito senza spiegarsene la causa (...) Una pomata dal profumo delicato, infantile, (...) il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva”. Gli altri non vedranno mai la colpa, ma lui sempre la sentirà?

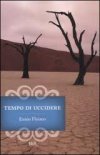
 Opinione inserita da anna rosa di giovanni 14 Febbraio, 2021
Opinione inserita da anna rosa di giovanni 14 Febbraio, 2021



























