Dettagli Recensione
Gli stranieri che sono in noi...
«Capire perché abbia rinunciato a imporre la sua lingua privata non è difficile per me, che ho avuto paura di parlare ad alta voce per tanto tempo: la lingua dei segni è teatrale e visibile, ti espone in continuazione. Ti rende subito disabile. In assenza di gesti, puoi sembrare solo una ragazza un po’ timida e distratta. Leggendo le labbra degli altri per decifrare cosa stavano dicendo fino a consumarsi gli occhi e i nervi, parlando con la sua voce alta e forte e dagli accenti irregolari, sembrava solo un’immigrata sgrammaticata, una straniera.»
Nata a Brooklyn, nipote di emigrati e rientrata in Basilicata, in un paesino sperduto con poche anime e tante voci sconosciute e incomprensibili all’età di sei anni, Claudia Durastanti ha una doppia anima: una prima radicata nei ricordi d’infanzia oltreoceano, una seconda che identifica nella Lucania il luogo della casa. Ma la sua non è una storia che qui si esaurisce perché i personaggi del padre e della madre che conducono le danze laddove il ritmo narrativo diventa più serrato per di poi lasciare il palco alla ballerina principale laddove il tempo si abbassa, la luce si affievolisce, la cadenza muta, hanno la peculiarità di essere affetti entrambi da sordità. Il loro incontro è avvenuto in modo molto particolare, ma mai uguale. Ciascuno con la sua versione, ciascuno ogni volta con qualche dettaglio in più o in meno, uguale o diverso, di fatto sempre in un rinnovamento del riferito. Gli stessi alternano anche la narrazione, avvicendandosi e così ricostruendo. Ricostruendo una storia d’amore, di dolore, di dispersione, una storia di migrazione, una storia di dissoluzione e con anche qualche riferimento alla criminalità. Queste storie che in prima battuta possono apparire quali tra loro distanti e separate da quella della scrittrice, a seguito dei primi capitoli, vi si fondono e uniscono diventando parte di un’unica verità.
Tra tutti i personaggi introdotti, perno delle vicende è la madre, una donna caotica che si sposta tra continenti e che è avvezza anche alla bottiglia. Il suo incontro con il marito è già dal principio burrascoso e confusionario, dalla loro unione nascono due figli di cui Claudia è la secondogenita preceduta da un primogenito. Segue un divorzio, seguono i rapporti famigliari con la loro laboriosità, con la loro problematicità, con la loro confusione e costernazione, con quelle generazioni che si susseguono senza sconti in quei giorni, minuti, ore e anni che si perpetrano.
«Erano persone divertenti e buone, non particolarmente raffinate, eppure sono stati capaci di un’intuizione fondamentale: loro non ci sarebbero stati per sempre, non avrebbero potuto proteggerla in ogni istante. Mia madre doveva diventare indipendente e lo ha fatto.»
Il risultato è quello di un memoir, di una lunga lettera d’amore, senza pretese, senza aspettative ma capace di parlare con voce forte e altisonante in quella folla costante che è la vita. E parla di dolore, di disagio, di situazioni disturbanti, di vissuto, di esistenza, di quotidianità, di attualità, di politica, di Brexit e parla anche di lingue. Lingue che non sono solo e soltanto quelle parlate. Lingue che non solo soltanto quelle dei gesti. Il risultato è ancora quello di un testo che è capace di rievocare l’opera di Camus, per consentire alla mente di ricercare e di osservare la vita da un esterno che tutto costituisce a discapito di un interno in cui tutto sembra disperso. Per individuare, per acuire una nostalgia, per appagare quella vita, anche inventata, che non sia la nostra ma che possa essere migliore, diversa, altro. Per una vita che troppo spesso ci è banale, per una vita che perdiamo la voglia di raccontare, per le azioni che non compiamo, per quelle parole che non abbiamo detto, perché siamo semplicemente quello che quella situazione ci permette di essere. Non siamo quindi sempre e solo noi, ma siamo quel che ci ha formato, quel che ci ha costruito, quel che ci ha strutturato, quei luoghi che abbiamo visitato, quelle cose che ci circondano, quei talenti che spesso nemmeno pensiamo di avere, quella classe sociale a cui apparteniamo, quelle ricchezze che abbiamo ereditato, quei legami che ci legano, quelle sconfitte che ci hanno piegato, quella dignità che abbiamo ricostruito, quella forza che abbiamo avuto per ricominciare.
Un libro complesso, stratificato, ricco di tanti tanti contenuti e tanti tanti spunti di riflessione è “La straniera” di Claudia Durastanti. Un romanzo che non è un diario ma che è come se lo fosse, un testo frammentario che ricostruisce poco alla volta, che come un puzzle assume la sua forma soltanto nella sua conclusione. Tuttavia, nonostante questa grande forza di contenuti affatto semplice ne è la lettura a causa di uno stile narrativo che talvolta sembra perdersi in se stesso e confondere quel lettore che a più riprese si chiede dove l’autrice voglia arrivare, quale sia la sua morale, quale sia il suo obiettivo. Tecnica narrativa, questa, che è una scelta volontaria finalizzata a dare quell’unica impostazione a quel volume che chiede di essere ascoltato e non solo letto ma che ha quale conseguenza quella di non facilitarne la conoscenza, di annoiare, di sfiancare. Perché per quanto si possa aver da dire, il come lo si dice è un qualcosa di imprescindibile che se non ben architettato rischia di far perdere di interesse, di profondità, di volontà.
Indicazioni utili
- sì
- no
no = per lo stile narrativo che non mi ha convinta lasciandomi preda di molteplici perplessità.
Commenti
| 9 risultati - visualizzati 1 - 9 |
Ordina
|
Grazie Maria!
Comunque hai colto, libro moooolto ambizioso ma c'è quel ma.
| 9 risultati - visualizzati 1 - 9 |





















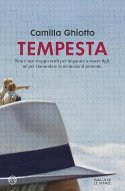








Una bella recensione, Maria, molto equilibrata.