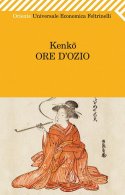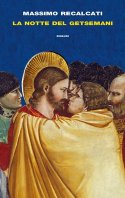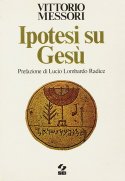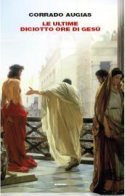Dettagli Recensione
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Ed il resto? Manc(i)a
Pare che esista una antichissimo rituale che viene ripetuto rigorosamente con gli stessi gesti da millenni all'elezione di ogni nuovo pontefice: il rabbino capo di Roma si presenterebbe in Vaticano scortato da una rappresentanza della comunità ebraica romana e, con aria interrogativa, porgerebbe al nuovo Papa una vetusta pergamena sigillata che il Sommo Pontefice sdegnosamente rifiuterebbe facendo accompagnare fuori la delegazione. Solo una volta un Papa, ignoto alle cronache, spinto dalla curiosità, si sarebbe accordato con il Rabbino per sbirciare in gran segreto, terminato il rito, l’antichissima pergamena. Aperti i sigilli, questa si sarebbe rivelata essere… il conto dell’Ultima cena.
Esordisce così con questa specie di witz (storiella umoristica ebraica) questo volumetto di Moni Ovadia dedicato al cibo, come cultura e come espressione stessa di un popolo, segnatamente, quello ebraico.
La struttura è abbastanza insolita, infatti si parte dal commento di un film greco: “Politikì kuzina” (in Italia “Un tocco di zenzero”) che, per chi non l’ha visto, tratta dei difficili rapporti della comunità greco ortodossa nella Turchia moderna tra difficoltà di integrazione e astiosa segregazione ed esilio, tutto visto attraverso il filtro della tradizione culinaria di quel popolo.
Si passa, poi, ad un lunghissimo capitolo intermedio nel quale Ovadia cerca di tratteggiare la psicologia e cultura ebraica in relazione al cibo, attraverso una serie di witz postillati e collegati gli uni agli altri con la tecnica che lo ha reso famoso in teatro.
Il volume prosegue con una ricostruzione delle tradizioni gastronomiche ebraico-sefardite, attraverso una intervista a distanza di una amica dell’autore e si chiude con una sorta di ricettario commentato di piatti della tradizione.
Opera insolita, quindi e solo parzialmente riuscita. La discontinuità della narrazione è il principale pregio del libro, ma anche il difetto sostanziale. Sicuramente, infatti, se Ovadia si fosse limitato ad inanellare una serie interminabile di witz - alcuni dei quali di yiddish, consentitemelo, hanno assai poco, trattandosi niente altro che di vecchissime barzellette rimasticate in innumerevoli salse - ne sarebbe uscito un libro stucchevole da leggere. D’altra parte il cambiare continuamente marcia da un capitolo all'altro, disorienta e non fa capire quale sia lo scopo ultimo dell’autore. Se, cioè, abbia inteso trattare seriamente la questione della civiltà in cucina o se si sia limitato a utilizzare la culinaria come scusante per parlare di tutto un po’ senza approfondire nessun tema.
Ovadia confessa in finale di non sentirsi portato alla scrittura e c’è sicuramente del vero in ciò: il siparietto dei witz, in teatro sarebbe risultato sicuramente più gradevole, condito con l’istrionica abilità dell’autore, ma qui ha soprattutto il sapore di un barzellettiere. Gli altri argomenti, poi, sarebbero più adatti ad una conversazione “colta” da salotto buono, ma forse sono un tema insufficiente per attrarre l’attenzione di un lettore.
Peccato, perché l’argomento in sé aveva una sua attrattiva ed avrebbe potuto/dovuto essere trattato con maggior rigore in ossequio alle tesi che si desiderava sostenere e che sono solo accennate all’inizio del libro: davanti al buon cibo, in fondo, gli uomini si dovrebbero tutti sentirsi fratelli dismettendo ogni forma di rancore reciproco.
Indicazioni utili
- sì
- no