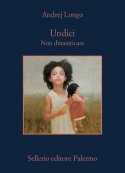Le recensioni della redazione QLibri
| 1719 risultati - visualizzati 201 - 250 | « 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 35 » |
Ordina
|
Jorge e Norama Tripe
«Ma siccome la vita è molto distraente, noi camminiamo in molti luoghi, ci dedichiamo al continuo spostamento. Diciamo pure che benché inclini allo scavo preferiamo che a scavarci la fossa siano gli altri a cose fatte.»
Quando arrivò a Siviglia, il padre di Norama Tripe, il trattore lo abbandonò all’angolo della strada e da allora di questo non ebbe più memoria, quasi come se mai fosse esistito. Trovato lavoro come magazziniere in un antro buio e lungo, fece di quello stesso luogo la sua casa. Qui si chiuse in un magnetico viaggio fatto di libri e letture, appunti e riflessioni sino a che, «dopo aver tirato un sospiro lungo che pareva trapassarlo in chissà quale altro mondo, disse: “E ora scrivo io.” E così cominciò a scrivere un libro sulla tragedia ilare del vivere, e trascorse anni nella affossata scanalatura di un linguaggio che inventava ricordando il meglio del linguaggio altrui». Da qui nacque la sua opera la “Tragica ilarità del mondo” che in quel 1965 lo destinò a riempiere le pagine dei giornali ma anche a lei, sua figlia. Perché Jorge andatosene a bordo di quel trattore lascia alle sue spalle una figlia di appena due anni e una consorte ormai rassegnata a quell’uomo così imprevedibile, sconsiderato ed egoriferito. Eppure quella figlia vuole avere contezza di quel padre mai conosciuto e visto per la prima volta su una rivista e decide allora di partire, per incontrarlo e scoprire delle sue radici.
«Ebbe paura della disparità che l’avrebbe attesa l’indomani. Avrebbe dovuto fronteggiare chi per età non poteva certo aver dimenticato i ricordi. Eppure era lei che lo cercava. Naturale, certo che era lei.»
L’uomo che si trova innanzi è un uomo di una quarantina d’anni, grasso e trasandato che dimostra molto più della sua età e che trasuda vecchiaia e decadimento a ogni sguardo. È un uomo, Jorge Tripe, che ha un’amica, Dolores, con la quale talvolta condivide il letto, un editore che lo foraggia con uno stipendio fisso e un luogo ove vivere ma è anche un uomo che fa delle parole la sua unica ragione di vita. L’allontana, la respinge, rifiuta la presenza di quella giovane donna carne della sua carne quasi come se questa si fosse decisa a incontrarlo esclusivamente per privarlo di quel verbo suo proprio. Riuscirà ella a farsi amare dal padre o comunque a farsi accettare nella sua vita?
Ed ecco che quella furia di cui al titolo ribolle e trasuda in un romanzo metaletterario che con una prosa dai toni carezzevoli quasi una fiaba giunge con tutta la sua imponderabile forza emotiva. Provocatorio ma anche riflessivo è “Cuore di furia” che sin dalle prime battute invita ad andare oltre le apparenze proprio scindendo da quel primo giudizio verso la figura di Jorge che istintivamente sviene da associare a un uomo egoista e irresponsabile.
Da qui una curiosità che è in realtà alle origini perché sotto le mentite spoglie di Jorge Tripe si cela Giorgio Manganelli, padre putativo di Romana Petri che a sua volta si cela dietro l’anagramma di Norama Tripe, figlia invece di sangue del protagonista dell’opera de qua. Una figura centrale attorno alla quale ruotano quella della ragazza ma anche quella di Dolores, la donna che lo ama e che vorrebbe condividere con lui un poco di normalità.
Il tutto è avvalorato da uno stile prezioso e minuzioso, erudito e magnetico che rappresenta il pregio dell’opera attraverso toni sia carezzevoli che forti, dialoghi serrati e distesi, porta alla delineazione di personaggi robusti e corposi, ben tratteggiati e facilmente riconoscibili.
Un buon titolo che non teme di trattare tematiche importanti e attuali, che non teme di solleticare le corde e le curiosità più intime del lettore e che al contempo conferma la maestria narrativa di Romana Petri.
«Come non si sa? È mai possibile che tu debba ogni volta svegliarti in piena notte per andarti a finire il sonno in magazzino?»
«Evidentemente sì» le rispose lui. «Ognuno sa star bene a modo suo.»
Indicazioni utili
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Pace nel mondo
Fresco di stampa, ecco che troviamo nelle librerie "Donne dell'anima mia" di Isabel Allende, edito da Feltrinelli, in una bella edizione e con una copertina deliziosamente rosa con delle spennellate arancioni, forse a emulare le fiamme della bruciante filosofia femminista dell'autrice? "Non esagero quando dico che sono femminista dai tempi dell'asilo" - questo è l'incipit bruciapelo e che mette subito in chiaro l'argomento cardine di questa "chiacchierata informale" come l'autrice stessa definisce il libro. Uno scritto autobiografico quello di Allende, che indaga sull'origine del suo pensiero femminista e osserva come esso si è plasmato nel tempo fino ad arrivare a oggi, e che ha necessitato anche di un certo coraggio esponendosi attraverso confessioni facilmente criticabili, ma del resto nessuno è perfetto, il rischio però è quello di cadere in contraddizioni con ciò che si afferma e perdere la credibilità. E in effetti le contraddizioni non mancano in questo libro, così come non mancano i cliché e la soggettività di certe idee e quindi la loro non condivisione, il che dimostra come il femminismo sia interpretabile in vari modi e di come i suoi confini siano labili.
Ho trovato in questo libro un super-io molto spiccato, a tratti disturbante perché ingombrante, autocompiaciuto e se da un lato riconosce i suoi privilegi dall'altro mostra una falsa modestia ("Se sono riuscita a trovare un fidanzato io, c'è speranza per tutte le donne anziane che desiderano un compagno."). Ho trovato un'autrice che nel periodo della quarantena Covid si mette comoda al suo pulpito e scrive un bel discorso alle sue "fedeli lettrici" su come sarebbe bello, giusto e civile il mondo guidato parimenti da donne e uomini, concludendolo con l'invito alla costruzione di un mondo "gentile, in cui regnino la pace, l'empatia, l'onestà, la verità e la compassione", "un pianeta incontaminato, protetto da qualsiasi forma di aggressione", che non è una fantasticheria ma un progetto e "insieme possiamo realizzarlo". A unicorni o altri animali fantastici non fa riferimento.
Personalmente apprezzo moltissimo l'impegno sociale che Allende intraprende attraverso la sua fondazione per dare assistenza e protezione a donne e bambini, è l'esempio concreto di chi applica la sua teoria e cerca di coinvolgere e sensibilizzare gli altri nei confronti dei più deboli e trovo sia la cosa più umana e difficile che si possa fare: fare del bene. Anche per Tolstoj, fare del bene e aiutare chi è in difficoltà, i mujic in particolare, è diventata la sua ragion di vita, ha sostituito la fede in Dio, e c'è bisogno di persone di questo tipo, che hanno i mezzi economici e la voce alta per coinvolgere la massa. Ben venga. Non mi ha convinto invece il libro sia a livello letterario che ideologico, lo trovo già invecchiato. Probabilmente perché i riferimenti che fa sono ambientati in Cile, in Asia, in Africa. In Europa, grazie a Dio alcune realtà sono superate già da qualche anno, seppur la donna continua ad essere debole in qualsiasi parte del mondo ma a mio avviso bisogna anche restare con i piedi per terra e non trasformare il femminismo in una lotta contro il maschilismo a prescindere. Chi ci dice che un mondo al femminile sia migliore di quello patriarcale che tanto la scrittrice detesta? Chi ci dice che la cattiveria sia lieve e meno frequente tra le donne rispetto a quella insita nel maschio? Fino alla prova contraria, la solidarietà tra donne è minore rispetto a quella tra maschi e la si può ben notare negli ambienti lavorativi.
"Negli Stati Uniti, in questo secondo millennio, si mette ancora in discussione non solo il diritto all'aborto, ma anche gli anticoncezionali femminili. Ovviamente nessuno mette in discussione il diritto dell'uomo alla vasectomia o all'uso dei preservativi"...paragone un po' forzato, la vasectomia non è così facilmente ottenibile ma ancora vincolata e secondo, il preservativo è utile ad entrambi e protegge da malattie sessualmente trasmissibili prima ancora che di una eventuale gravidanza.
"Provo a immaginare l'amante che le mie lettrici eterosessuali desidererebbero, ma questo compendio di virtù maschili non è nelle mie corde. L'uomo ideale dovrebbe essere bello, forte, ricco o potente, per niente stupido, deluso dell'amore ma pronto a lasciarsi sedurre dalla protagonista, insomma, è inutile che prosegua..."...qualcosa non mi quadra, da femminista che promuove la donna come un essere pensante profondo e con pari diritti dell'uomo mi cade in questo pregiudizio sull'amante ideale della donna?! o su quello che una lettrice donna vorrebbe dal protagonista maschio di un libro? Un'altra cosa che ho notato è che lei si rivolge al suo pubblico più volte con l'appellativo di "fedeli lettrici", altra cosa che non ho compreso, perché non "lettori"? Sarà che il genere neutro ha troppe sembianze maschili?
"sono grata a quell'infanzia infelice perché mi ha fornito materiale per i miei romanzi. Non so come se la cavino gli scrittori che hanno avuto un'infanzia serena in un ambiente normale."... altra affermazione molto discutibile a mio avviso. Peccato che non possiamo chiederlo a Proust, a Nabokov, a Tolstoj, come hanno fatto scrivere dei monumenti della letteratura.
E se all'età di due anni, secondo la leggenda era capace di riconoscere Renoir e Monet, non ci sorprende che alla veneranda età di settantotto anni scatta quasi come una gazzella, scrive cinque ore al giorno, e fa l'amore - in effetti pare che sia molto orgogliosa della sua natura passionale e della libido che fortunatamente c'è ancora, in calo ma c'è. Tutto molto bello, è un libro in cui si dichiara felice della sua vita, dei suoi sogni raggiunti e felice di viversi il presente tra scrittura e amore. E noi siamo felici per lei.
Indicazioni utili
- sì
- no
Chiamare è riportare alla luce
“La vita va da quando decidono che nome darti a quando quello stesso nome è solo un graffio su una lapide. Nell’uno e nell’altro caso non hai l’iniziativa, quelle lettere sono tutto ciò che hai per venire alla luce e provare a rimanerci. Forse per questo gli antichi dicevano che il destino è nel nome: che ti piaccia o no, sei chiamato a rispondere all’appello.”
Il nuovo lavoro di Alessandro D’Avenia si ambienta tra i banchi di scuola, tra i turbolenti ragazzi di una quinta “classe sgangherata” da portare alla maturità e ha come protagonista un insegnante divenuto cieco all’improvviso da cinque anni. Come dall’incipit, nel nome è scritto il nostro destino, il professore si chiama Omero (“in greco ‘colui che non vede’...) Romeo, dove il cognome è l’anagramma del nome. Un nome straordinario per quello che da necessità diventa un vero e proprio “progetto” straordinario che rivoluziona il modo di fare scuola. Il professore torna dopo una pausa di cinque anni ad insegnare la sua passione : scienze naturali.
La scienza è la disciplina della vita per eccellenza e lui vuole che a scuola venga insegnata la vera vita e che non ci si limiti soltanto a trasmettere un astruso ed asettico sapere in cui i ragazzi di oggi non trovano senso, se non in parte. Per insegnare la vita bisogna partire da loro, dai ragazzi, uno per uno, chiamandoli all’appello, ogni mattina perché
“siamo fatti per nascere, non certo per morire. E un nome ben detto dà alla luce e dà alla luce ogni angolo dell’anima e del corpo (...) Questo è il potere di un nome proprio (...)”.
Ogni giorno si ripete quello che da semplice operazione di registrazione diventa un vero e proprio rituale che i ragazzi accoglieranno prima con un po’ di titubanza mista a curiosità e che poi pretenderanno anche dagli altri insegnanti della loro classe, con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Il nuovo insegnante nonostante la cecità dimostra di vedere il loro ‘dentro’ molto meglio degli altri insegnanti che si limitano a vederli solo in superficie, senza neppure guardarli. Omero Romeo per conoscere bene i suoi alunni i primi giorni di scuola chiede loro qualcosa che li lascia un po’ perplessi : toccare i loro volti, conoscere le loro fattezze, la tensione dei muscoli facciali per ‘vedere’ le loro ansie, le loro preoccupazioni, la loro personalità.
Per chi è cieco (ma non solo per chi è cieco, potremmo dire), il tatto
“è il senso più importante. Quando ancora non vedevamo niente, noi toccavamo tutto ed eravamo toccati da tutto. Il destino dell’uomo è nelle sue mani. (...) Le mani danno forma al mondo in cui vorremmo vivere. È con l’uso che facciamo delle nostre mani che facciamo la vita.”
La lezione che il professor Romeo /D’Avenia vuole lasciare in questo libro è quasi rivoluzionaria, dal momento che da anni si propugna la necessità di mettere “l’alunno al centro” dell’insegnamento e di lasciare le incombenze dei programmi ministeriali in secondo piano. L’insegnante non deve “ridurre” la classe, numerosa o meno che sia, ma l’insegnante è chiamato ad “ampliare. Nei campi di lavoro si riducono le vite, a scuola le vite si ampliano: siete in tanti, ma voi ed io, insieme, faremo il possibile per arrivare fino in fondo, costi quel che costi”.
Una visione che fa del mestiere di insegnare una vera e propria missione tra mille difficoltà, anzitutto burocratiche e istituzionali e “il progetto Appello” trova favorevole risposta tra tutti gli alunni della scuola, ma anche una serie di atteggiamenti infusi di sospetto tra gli insegnanti arroccati sulla difensiva, resistenze da parte del Dirigente scolastico che teme di perdere il controllo della situazione. Tutto ciò è normale, spiega il professor Romeo, approfittando dei momenti di vita quotidiana per spiegare concetti scientifici:
“È normale trovare resistenza quando qualcosa mette in crisi un sistema: in fisica occorre vincere l’attrito prima di riuscire a mettere in moto qualcosa, figuratevi se quel qualcosa è la scuola come la si fa da più di un secolo a questa parte...”.
Un esperimento straordinario che per essere fattibile e concreto dovrebbe partire da questa considerazione che tutti gli insegnanti dovrebbero far propria : “ i ragazzi non studiano, perché l’autorità non è più riconosciuta sulla base del ruolo. L’unica autorità che i ragazzi riconoscono è quella di chi sa volere bene, oltre che a conoscere la materia”.
LA MIA OPINIONE. È stato il primo libro di D’Avenia che ho letto. Dopo aver ascoltato molte sue lezioni ed interviste su YouTube ero davvero incuriosita. È un libro che si legge velocemente, per nulla impegnativo, molto pop che arriva ad un vasto pubblico e sono sicura che piacerà a molte persone, soprattutto ai giovani e a chi probabilmente non esercita la professione di docente, in quanto chi insegna oggi in Italia con professionalità e passione è talvolta lasciato solo in un mare di confusione burocratica e obblighi e doveri extra non soltanto non retribuiti, ma anche non riconosciuti. Il mestiere di insegnante non si esaurisce certo in un’aula scolastica, cioè nel suo ‘habitat’ riconosciuto istituzionalmente, ma continua anche a casa e non mi riferisco solo all’immane lavoro che c’è dietro la didattica a distanza di cui sentiamo tanto parlare in questo delicato momento di emergenza sanitaria.
Quanto poi alla questione dell’autorità, la mia visione è più galimbertiana: sono cambiate le famiglie. E delle famiglie e dell’educazione ricevuta nel libro non si parla, in quanto le famiglie degli alunni del professor Romeo sono disastrate, si tratta di casi estremi. Ho trovato inoltre poco credibili la maturazione in così poco tempo -solo un mese- dei ragazzi (drogati, ospiti di case famiglia, ladruncoli, ragazze che hanno abortito...) e soprattutto la cultura che avevano alle spalle: citazioni perfette di Rimbaud, della Woolf, del dottor Zivago, una conoscenza indefettibile della fisica quantistica...non mi ha convinta fino in fondo. Certamente il libro è consolatorio, con happy ending, leggero e con belle riflessioni che tanto piacciono a chi fa “centoni” da copiare e incollare sui social network.
Perfetto da regalare, soprattutto per Natale e vi lascio con questo splendido pensiero che condivido in pieno:
“...non è vero che a Natale sono tutti più buoni. A Natale hanno semplicemente più fretta. Ma la fretta è proporzionale alla difficoltà di amare, perché per amare bisogna prendersi tutto il tempo che ci vuole”.
A tutti gli insegnanti che lottano contro il tempo per far quadrare i conti ministeriali e ad esercitare la loro professione con cuore e umanità.
Indicazioni utili
We - a re - fa mi lyyyy
Londra è sotto attacco, colpita dal virus influenzale H5N1 con un indice di mortalità pari all’80%.
Mentre si scavano le fondamenta di un grande padiglione ospedaliero dove isolare i malati, affiora un sacco contenente piccola ossa umane, ossa di bambino.
Lui urla, impreca, mentre i tonfi delle sue scarpe rimbombano sugli scalini verso il piano superiore.
Choy! La chiama e lei si fa sempre più piccola nello sgabuzzino, ma il battito del suo cuore è fragoroso, lui sente, gira la maniglia. E sorride.
Il manoscritto di questo romanzo risale al 2005, quando gli editori britannici lo rifiutarono vista l’idea troppo cupa e assolutamente poco credibile di una Londra in lockdown.
Avevano torto.
Certamente, affrontare oggi una narrativa ambientata durante una pandemia che miete centinaia di migliaia di vittime ha un effetto più suggestivo che nella suggestione scenica stessa. Si è consci, durante la lettura, che quello che era stato inventato per impressionare il lettore oggi non è altro che cronaca, la finzione è diventata quotidianità e tutto questo è spaventoso. Noi, oggi, rinchiusi di nuovo tra le quattro mura di casa, siamo quello che quindici anni fa era fiction.
Fluida e piacevole la scrittura di May, egli ha il pregio di dare un taglio approfondito ai suoi personaggi, che vantano un profilo molto realistico ed umano, è facile raggiungere un contatto empatico con loro che vivono, oltre quelle parole.
Ottimo l’intreccio ed il livello di suspense, il romanzo procede spedito ed accattivante a lungo, non fosse per le ultime pagine che debilitano un risultato eccellente. Forzatura eccessiva di un soggetto chiave ed un rapido finale prevedibile anche per il peggior detective del mondo – che io incarno alla perfezione -, ormai siamo tanto esperti in materia che non c’è intrigo irrisolvibile, quando ci si muove a volto coperto e guanti di lattice.
Non il miglior thriller dell’inglese, certamente il periodo storico che stiamo vivendo gli garantisce una marcia in più, potrebbe essere il momento giusto per trascorrerci qualche ora.
“… affinché noi ci rendiamo conto che le cose potrebbero andare molto, molto peggio.”
Indicazioni utili
Il profumo perduto
Il titolo che ho dato alla recensione può trarre in inganno, non sto parlando di una ricerca nel senso letterario del termine, qui bisogna andare oltre, perché Elena, la profumiera che avevo già trovato e amato nel libro “Il sentiero dei profumi”, non riesce più a sentire il profumo come una volta, non riesce più ad andare oltre, a cogliere quei dettagli che l'hanno resa famosa e conosciuta all'interno del settore.
Elena l'avevamo lasciata appagata, con un compagno eccezionale e una bambina da crescere e soprattutto un rapporto con la madre non proprio ottimo. Ripartiamo proprio da qui.
Ero un po' pensierosa, quando leggo un romanzo che mi è piaciuto e che ho apprezzato, sapere che ne esce il seguito mi ha sempre fatto un po' di paura. La scrittrice può andare a rompere degli equilibri che mi ero creata nella mente oppure a snaturare dei personaggi a cui mi ero affezionata oppure a stravolgere l'ordine delle cose lasciandomi delusa.
Cristina Caboni invece è riuscita nel suo intento, ha creato un seguito all'altezza del precedente, non ha snaturato niente, anzi ha fatto “maturare” i suoi protagonisti ed è andata a completare quello che aveva lasciato incompiuto nel primo libro. Si parla di genitori, di figli, di amori presenti e passati, di decisioni difficili e scelte che solo il cuore può aiutare a fare.
Un romanzo che mi ha fatto sognare, che mi ha portato in quei campi di rose e fiori e mi ha fatto annusare i profumi e la loro purezza. Un romanzo adatto più ad un pubblico femminile che fa sospirare, sperare e credere nel futuro. Uno stile elegante, mai volgare e soprattutto denso di significato. Questa volta l'autrice ha fatto davvero un ottimo lavoro.
Un libro coinvolgente che consiglio a tutte le amanti dei romanzi d'amore scritti bene e non superficiali.
Buona lettura!
Indicazioni utili
A sangue... caldo
Molto spesso la realtà trascende la più cruda immaginazione: questo accade, probabilmente, perché chiunque si ritrovi a produrre un'opera di fantasia non può o non riesce a oltrepassare certi limiti, o magari non vuole ammettere a sé stesso e agli altri d'essere in grado di immaginare efferatezze di un certo tipo. Ma a volte è semplicemente la realtà a essere cruda ogni altra aspettativa, e l'essere umano può rivelarsi capace di mettere in atto crudeltà prima inconcepibili. È questo il caso del racconto contenuto nell'ultima fatica di Nicola Lagioia: “La città dei vivi", che si rivela una specie di ibrido tra reportage e racconto di uno dei più efferati casi di cronaca nera italiana degli ultimi anni e forse di sempre: l'omicidio del ventitreenne Luca Varani da parte di Manuel Foffo e Marco Prato, due giovani scapestrati appartenenti alla borghesia romana.
Impossibile non pensare, durante la lettura, a libri come “A sangue freddo” di Truman Capote e “L’avversario” di Emmanuel Carrère, perché oltre ai contenuti a esser simile è anche il metodo con cui le vicende sono esposte. Lagioia prova a indagare sui motivi, a ricostruire gli eventi che hanno portato all'omicidio facendo uso di informazioni di prima e seconda mano; ma soprattutto prova a scavare nella psicologia degli assassini, a cercare le origini della mostruosità ma anche l’umanità che può celarsi alle sue spalle. Rispetto ai lavori di Capote e Carrère, tuttavia, il romanzo di Lagioia non risparmia dettagli truculenti: il capitolo in cui si descrive l'omicidio citando le testuali parole dei due assassini, infatti, risulta davvero disturbante, e questo è un aspetto che può piacere come anche no. Sebbene ne riconosca la necessità narrativa, personalmente non l'ho gradito moltissimo.
Quel che è interessante è provare a mettere insieme i tasselli di questo macabro mosaico avvalendosi di tutti gli indizi fornitici da Lagioia: trascrizioni di testimonianze, pensieri postati sui social dalle parti coinvolte, articoli di giornale oppure semplici incontri. Quel che emerge è una spaventosa realtà tipica dei giorni nostri, in cui a chiunque è permesso di esprimersi in ogni campo semplicemente accedendo a un dispositivo elettronico: in questo modo, la verità rischia di diventare un'entità sempre più astratta e inafferrabile, inquinata dai punti di vista e dalle opinioni (spesso infondate) delle suggestionabili masse.
Cos'è vero e cosa no? Pare che sarà sempre più difficile, stabilirlo.
Sullo sfondo di questo crimine crudele non manca nulla: questioni di classe, di droga, di omosessualità, di lacune affettive nell'ambito familiare; ma soprattutto emerge un'immagine contraddittoria della città di Roma, vera protagonista di questa storia e detta la città dei vivi: un luogo maledetto, sporco, grottesco, ma che in qualche modo ammalia e una volta lasciato fa sentire la sua mancanza in maniera irresistibile: come un inferno che ci chiami a sé per godere delle sue pene, che paradossalmente ci ritroviamo a bramare.
Forse un po' troppo ripetitivo e riempito di dettagli superflui, “La città dei vivi" lascia sicuramente un segno, ma non saprei davvero dire se questo si rivelerà indelebile, né se sarà piacevole.
“Tutti sanno che la fine del mondo ci sarà. Ma il sapere, nell’uomo, è una risorsa fragile. Gli abitanti di Roma la consapevolezza delle cose ultime ce l’hanno nel sangue, ed è talmente assimilata da non generare più nessun ragionamento. Per chi abita qui la fine del mondo c’è già stata, la pioggia ha solo il fastidioso effetto di rovesciare dal bicchiere un vino che in città si beve di continuo.”
Indicazioni utili
L'avversario di Emmanuel Carrére
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Senza infame e senza lode
"Desideri deviati" rappresenta il secondo romanzo della trilogia "Amore e ragione", inaugurata lo scorso anno con "Cuori fanatici". Ambientato nella Milano "da bere" degli anni ottanta e in cui la moda approda nella ormai ricca città. La trama segue Nico Quell, promettente ma anche raccomandata figura nel campo dell'editoria milanese di quei tempi. Un ragazzo pieno di contraddizioni, che insegue il successo, desidera crearsi una propria identità, ma nello stesso tempo perso in un mondo di incredibili e numerose opportunità, soprattutto sentimentali. La critica lo associa a un "uomo senza qualità", un Ulrich in attesa della occasione giusta, ma a mio avviso non bisogna scomodare il caro Musil per così poco. E non bisogna scomodare nemmeno Proust, che in una frase ha detto tutto ciò che probabilmente l'autore ha voluto dire attraverso questo libro, è cioè che "I nostri desideri interferiscono via via fra di loro, e, nella confusione dell'esistenza, è raro che una felicità giunga a posarsi esattamente sul desiderio che l'aveva invocata.“
Citando l'autore, in un opera ci devono essere molte sciocchezze "attorno quel poco di buono che si combina in essa" perché "se così non fosse l'arte sarebbe ermetica, un bersaglio che la freccia non colpisce mai", solo che quel poco di buono che personalmente ho trovato in questo libro è davvero limitato e poco valorizzato. Per un parere onesto devo assumere la parte del "ragazzo ignorante come una capra" e permettermi di dire che a mio avviso questa opera è un "ammasso di ferraglia". Dopo un inizio promettente con il prologo in cui viene presentata una Milano tutt'ora attuale e che ho molto apprezzato, che ho riconosciuto dato che ci vivo, la mia esperienza di lettura è stata monotona, noiosa e la fine della lettura è stata quasi una liberazione. Ho trovato molto disarmonico e contraddittorio questo libro, che non manca anche di alcuni cliché e scene che sembrano buttate lì per caso come per esempio il capitolo nel quale Irene, la sorella di Quell, si alza alle sette del mattino e va a passeggiare nel parco offrendosi agli sconosciuti che incontra, facendone ritorno in casa alle nove dopo circa tre-quattro rapporti non protetti, descritti in modo spiccio, come per offrire la dose di sesso necessaria in un libro. E tutto questo perché?! perché adesso avrebbe avuto cosa raccontare al fratello nel loro prossimo incontro. E come se non bastasse il capitolo di intitola "Un muto stupore le prese l'anima" (???!). Un titolo altisonante che io non capisco. Probabilmente si riallaccerà alla scena nel terzo volume della trilogia, magari tirando in ballo anche il discorso sull'AIDS che in quei anni esplodeva, altrimenti non mi spiego.
Restando nel campo della trama, l'ho trovata dispersiva. E' anche vero che vengono narrate poche giornate della vita dei personaggi quindi magari scarsa da un punto di vista dei fatti o dei colpi di scena e va benissimo, la cosa che invece non ho gradito è stata la sua poca armonia in quanto i capitoli con le varie scene presentate spesso sembrano racconti indipendenti, foto istantanee- per esempio la scena in cui Nico va in piscina, o a sentire il concerto di musica classica, o quando va a visitare Marta Sesamo. I personaggi invece sono descritti abbastanza bene, seppur pieni di contraddizioni, il mio preferito è Coboldo, il nome non è casuale, significa folletto poco socievole- sembra una specie di Pnin nabokoviano, mi ha fatto molta tenerezza soprattutto nel finale, un rospo baciato dalla pantera nera, Sheila modella di colore che mi ha tanto ricordato la venere nera, Naomi Campell. Insomma la bella e la bestia che forse l'autore unirà in futuro. L'ambientazione invece l'ho trovata abbastanza minimale e con pochi riferimenti descrittivi di quei anni, mi sarei aspettata un tuffo più profondo sotto quest'aspetto.
Ora prendo dalla mia faretra un'altra freccia e provo a tirare nel bersaglio "stile". Personalmente l'ho trovato arzigogolato e disordinato. Io sono la prima ad amare le narrazioni non convenzionali, amo il postmodernismo e l'originalità stilistica, ma il disordine casuale no. I dialoghi vengono presentati sotto tre forme: come una pièce teatrale (vedi il discorso tra Enobaudo e Coboldo), con l'utilizzo di trattini e infine con quello delle virgolette alte. Non ho capito perché, io l'ho visto solo come un disordine che mi ha disturbato da un punto di vista estetico. I dialoghi certe volte mi sembravano sconnessi e artificiosi giusto per tirare in ballo determinati argomenti e mancano di spontaneità. La prosa l'ho trovata forbita, ma arzigogolata. Nonostante sia un libro in lingua, l'ho trovato poco armonioso, poco musicale, ostico da seguire, stancante, criptico, a tratti come se si sforzasse di ostentare cultura. Non ho compreso nemmeno certe sue metafore e nemmeno i suoi lungi elenchi che dicono tutto e dicono niente.
Oltre ai desideri in continuo mutamento, un tema centrale è anche quello dell'editoria e l'autore non fa sconti né all'editoria, che sembra un mondo impenetrabile pieno di raccomandazioni e con scelte dettate più dall'arbitro che dal rigore, lancia freccette verso la scarsa qualità dei libri che attualmente vengono pubblicati, ma anche sulla scarsa e insufficiente preparazione culturale dei critici letterari. Ho quasi l'impressione che ogni autore crede che il suo libro sia imperdibile e quelli dei suoi contemporanei, superficiali. Ci sono molte altre idee che non condivido, come quella sull'inutilità del lavoro intellettuale che in questo libro mi è sembrato più con il fine/ ambizione di cambiare il mondo, anziché come espressione di se stessi, come necessità personale di esprimersi per poter vivere- mi viene in mente Pessoa, per lui scrivere era vivere, respirare, e non cambiare il mondo. Che poi, questo cambiamento avviene ugualmente come conseguenza all'autenticità e profondità di quello che viene espresso.
Nell'insieme è un'opera che mi è mancata di spontaneità e quindi di armonia, che non mi ha colpita su nulla, seppur non nego che mi sono piaciuti alcuni passi ma non sono bastati. Ho percepito lo sforzo intellettuale che ovviamente rispetto ma l'ho trovato troppo artificioso e di conseguenza poco stimolante.
Indicazioni utili
- sì
- no
Capitan Fracassa
Quando Michael Moore ha realizzato il film Farhenheit 11/18 voleva fare riflettere gli americani sull’elezione di un politico come Trump fornendo loro materiale su cui farlo. Invece Eggers ha rinunciato a questo tipo di sforzo, ritenendolo fatica sprecata, e in questo suo libro si rivolge all’americano medio con un testo più alla sua portata. Una favola molto semplice in cui l’uomo con la piuma gialla, un uomo senza grandi qualità né morali né tantomeno intellettuali, decide da un giorno all’altro di voler fare il capitano della nave senza avere nessuna nozione di navigazione né il buon senso di farsi consigliare di chi ha esperienza o da guide di navigazione, né buonsenso in generale. Il capitano si candida alle elezioni navali. E. incredibilmente, il fatto che un personaggio così da poco possa diventare capitano di una grande nave stuzzica il sogno americano che viene così rimaneggiato: un tempo chiunque dopo studio, meriti, preparazione poteva aspirare a fare qualsiasi cosa; ora chiunque, nel senso di qualunque imbecille, può fare qualsiasi cosa, fosse pure il capitano di una nave senza averne le capacità. Questa nuova versione consolatoria del sogno americano appare migliorativa, soprattutto ai più deficienti tra i passeggeri. Ovviamente l’uomo con la piuma gialla ha una certa antipatia per gli amici storici del vecchio capitano, per il vecchio capitano, anzi per tutti i vecchi capitani, mentre ammira sconfinatamente gli altri pericolosi pirati un tempo nemici della nave. Non faccio spoiler sul finale.
La metafora è, diciamo, alla portata degli elettori del capitano, studiata sul loro livello. Oppure Eggers si è rivolto ai figli degli attuali elettori sperando che in futuro stiano alla larga dagli uomini con la piuma gialla.
Quanto a me, da un punto di vista letterario il libro non mi entusiasma. Anche il tipo di satira così vago non mi entusiasma. Apprezzo però lo sforzo di fare riflettere gli elettori dell’uomo con la piuma gialla.
Indicazioni utili
- sì
- no
Fine pena mai
Antonio Manzini torna in libreria sorprendendoci con una storia che non vede tra i protagonisti il suo personaggio più noto, il vicequestore Rocco Schiavone, da tanti ben conosciuto anche per l’ottima resa scenica che ne ha dato sul piccolo schermo l’attore Marco Giallini.
Schiavone nei romanzi cult di Manzini è un investigatore atipico, potremmo definirlo come un poliziotto sui generis che indaga in romanesco, con acume e ironia, nel mentre cerca disperatamente di restituire un senso alla propria esistenza, sconvolta dall’assassinio dell’adorata moglie Marina, avvenuta in tragiche circostanze per mano di un pregiudicato risentito nei confronti del poliziotto.
Una tragedia personale che restituisce sprazzi di intensa ed insolita tenerezza alle sembianze del poliziotto, di per sé persona intelligente, ricco di umanità, di buon senso pratico, positiva, ma che i fatti della vita, la sua crescita esistenziale nelle difficili e tormentate borgate romane, per quanto talora gravide di incredibili fortissimi legami di fratellanza, amicizia e solidarietà, hanno reso cinico, disincantato, irriverente nella distinzione netta tra bene e male, tra lecito o penalmente perseguibile.
Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, a mio parere Manzini non è da meno neanche stavolta, anche senza Schiavone ha scritto un bel libro, ci sorprende piacevolmente con un’ ottima storia, attuale e moderna nei temi e nei personaggi, descritti con semplicità e sapienza, resi alla perfezione nella loro essenza, assistiamo attenti ad un raccontare reale e non di fantasia, sintetico, essenziale ma fluido e intenso, forse vigoroso solo a tratti, ma è così che deve essere.
Perché questo è una storia di vite infrante, un racconto disperato e disperante, e la disperazione, quella vera, se pure sorge d’improvviso, evidenzia appieno i suoi nefasti effetti spalmandosi nel tempo, approfondendo le sue spire gradualmente, avvelenando in profondità l’esistenza delle sue vittime; non è vigorosa al suo insorgere, è più subdola e deflagrante solo nel finale. Come questa storia.
Una storia che senza mezzi termini, da subito, dall’inizio, prende il lettore, lo avvince, lo interessa, lo inchioda alle pagine, neanche tante, che si fanno leggere con un misto di piacevolezza ed amarezza insieme. Un romanzo che si legge con piacere, dunque, anche se parla di dolore, di cordoglio, di afflizione, senza però mai scadere nel patetico o nella mestizia fine a sé stessa, e questo risultato lo raggiunge solo chi sa come scriverne. E bene anche. L’autore ha fatto davvero un ottimo lavoro.
Antonio Manzini ci riporta al meglio una storia dissacrante e dissacratoria, un racconto profanante del senso della giustizia, narra del comune buon senso infranto dalle tragedie personali.
Tratta di un assassinio, e di tutte le sue vittime, non tanto colui che è caduto, ma tutti quanti gli sopravvivono, a partire dal reo fino ai familiari dell’ucciso, quasi che un omicidio fosse un corpo pesante gettato a forza, con rabbia cieca ed impulsiva al centro di uno lurido specchio d’acqua, e il turbinoso moto ondoso con le onde concentriche che ne derivano travolgono inesorabilmente te rovinosamente tutti coloro che ne sono in qualche misura coinvolti, colpevoli ed innocenti, carnefici e vittime, un tsunami disastroso e irrimediabile. Per tutti e per chiunque.
Nora e Pasquale sono una comune coppia di mezz’età, gestiscono con buona fortuna una florida attività imprenditoriale a conduzione familiare, sono titolari di una tabaccheria nel centro città.
La loro esistenza si svolge tranquillamente lieta e felice, come quella di tante famiglie, ruota attorno al nucleo fondante della loro vita di coppia, l’unico adorato figliolo Corrado.
Si svolgeva: un triste giorno, per pura fatalità Corrado è da solo in servizio in tabaccheria, un balordo tenta una rapina, e vuoi per il dilettantismo del rapinatore, vuoi per il coincidere degli eventi, la paura e lo stress del dilettante, l’impulsivo reagire del giovane, il fato avverso e la cattiva congiuntura delle stelle e dei pianeti, fatto sta che Corrado muore accoltellato ed il rapinatore arrestato in flagranza.
Una rapina finita male che è non solo una tragedia, ma il prologo della disperazione annunciata.
L’esistenza terrena di Corrado termina, e con essa il suo sorriso e la sua gioia di vivere; e con lui termina anche la vita dei suoi genitori, gli ultimi giorni di quiete, che da quel momento in poi trascineranno le loro esistenze in un susseguirsi di gesti, movimenti, attività stinte, confuse, dissonanti, niente più che tentativi non di dimenticanza, che sarebbe impossibile, ma di annullarsi nell’oscurità e nel silenzio a celare il dolore.
“Portare i fiori sulla tomba di un figlio è contro natura. Piangere sulla tomba di un figlio è contro natura. Vivere al posto di tuo figlio è anche peggio.”
Al dolore si accompagna il rancore, l’astio, il livore per chi ancora respira, quando invece la persona che amavi più di te stesso ha esalato il suo ultimo.
Una reazione assurda e ingiusta ma quasi normale, del tutto logica, difficile a comprendersi se non si è vissuta sulla propria pelle, al rimpianto per l’affetto perduto si accompagna inevitabilmente l’acredine per chi sopravvive, che si reputa sempre immeritevole.
Questo è quanto accade a Nora e Pasquale, e si accentua al massimo grado allorché del tutto casualmente si imbattono nel balordo assassino, Danilo, scarcerato dopo pochi anni di reclusione per sommatoria di benefici di legge.
Una sensazione comune per un evento ricorrente, chiunque sia stato vittima di atti di delinquenza ritiene inadeguata la pena comminata al colpevole, qualunque sia il reato e il danno causato, nemmeno la massima severità, un fine pena mai, placa il personale sentimento di giustizia della parte offesa, figuriamoci per la perdita dell’unico figlio per la cui morte la giustizia ha ritenuto congruo l’estinzione della pena con pochi anni di reclusione.
In Nora e Pasquale scatta allora il meccanismo della rivalsa del borghese piccolo piccolo, un misto di odio, di rabbia, di ricerca della violenza, della vendetta, del sangue e della sofferenza da infliggere personalmente al colpevole, che anni fa fu magistralmente reso sullo schermo da Alberto Sordi in un film di Monicelli, appunto “Un borghese piccolo piccolo” tratto da un bel libro di Vincenzo Cerami.
Solo che la vita non è un film, serve fare i conti con la realtà: Pasquale vuole procurarsi una pistola, per farsi giustizia da solo, non solo per dare un senso ed un significato concreto alla sua scialba esistenza strascicata tra casa, lavoro e manutenzione continua di una vecchia motocicletta, ma anche per interrare una volta per sempre il complesso di colpa che lo tormenta da allora, in quanto avrebbe dovuto trovarsi lui al posto di Corrado quel fatidico giorno, se per una banale casualità non fosse accaduto diversamente.
“Non sono mai stato a favore della pena di morte. Ma della pena sì.”
Ben diverso il piano di Nora, che agisce in maniera più sottile, anche più semplice ed efficace per la sua rivalsa, oserei dire la più logica ed intensamente femminile.
“Una madre non ha più diritto alla vita se suo figlio quel diritto non ce l’ha più…”
Nora sa che quello che l’ha da sempre tormentata non è l’odio che le ha avvelenato l’esistenza, l’odio è solo una conseguenza, un sintomo; ciò che strazia di continuo senza fine è l’ossessione.
L’ossessione di rivedere continuamente la scena, di immaginarla, di creare con la mente alternative e sviluppi diversi, modalità differenti di svolgimento dei fatti, addirittura scenari futuri idilliaci impossibili a crearsi, l’idea fissa che un’immensa ingiustizia è stata commessa, prima da Dio, dal fato o da chi per lui e poi dalla giustizia degli uomini, e questo assillo, questo tormento, questo chiedersi perché Corrado e non altri assai più inutili e immeritevoli del suo figliolo, questa ossessione Nora intende restituire all’assassinio di suo figlio. Pari pari.
Perché si tormenti, accusi il colpo, reagisca, venga punito.
Perciò Nora si trasforma da placida vecchietta in una nemesi che segue Danilo come un’ombra, al lavoro, al bar, al supermercato, a casa, si pone appresso la sua compagna, dovunque vada lo segue, diventa la sua ossessione, perché sa benissimo che questa fa impazzire, basta poco perché questa si trasformi nell’incubo peggiore.
Antonio Manzini ha raccontato una storia di sentimenti, di sensazioni, di emozioni, tutte dolenti, amare, desolanti. Eppure, sono reazioni comunissime, quelle che chiunque proverebbe, davanti a simili tragedie, perchè le sofferenze tratte da tragedie improvvise e inaspettate come solo la vita sa proporre, oltre ogni realtà romanzata, hanno un solo attributo, sono crudeli.
Così crudele è la vita: serve godersi gli ultimi giorni di quiete.
Indicazioni utili
BEN VENGA MAGGIO!
Un nuovo viaggio di ritorno al paese natale, un nuovo percorso interiore che non può prescindere dai ricordi. L’austriaco Peter Handke è garanzia di qualità, indipendentemente dal lauro del Nobel. La sua penna prolifica ha un elevato peso specifico, la sua voce è quasi “ubiqua”: ora vicino al lettore, la senti quasi sussurrare nell’orecchio e contemporaneamente si allontana a narrare fatti remoti. Proseguendo nella lettura, si ha la sensazione di avere tra le mani un’opera di qualità letteraria straordinaria. Sono queste le sensazioni che suscita, dopo aver fatto esperienza di lettura handkiana con “Infelicità senza desideri” e “La ladra di frutta”.
Il richiamo a quest’ultimo romanzo è innegabile.
La preparazione di un viaggio che si dimostra un percorso interiore: l’incipit de “La ladra di frutta” ha ambientazione esterna, si apre con immagini di primavera, con la puntura di un’ape quale spinta/segnale dell’inizio di un nuovo tempo da vivere, mentre “La seconda spada” si apre in tempo primaverile, a maggio per la precisione, ma in un ambiente chiuso, col protagonista narratore che si guarda allo specchio cercando nel volto qualche indizio che gli riveli una nascosta natura di assassino e di vendicatore. Nonostante ambientazioni più urbane, come stazione, treni, alberghi, la natura torna protagonista qui come ne “La ladra di frutta”, con i suoi alberi, le cui chiome riecheggiano come “voci di bambini”, con le sue “farfalle dei Balcani” tanto care all’autore che turbinano nell’aria infuocata ai piedi della Collina Eterna, con i suoi uccelli che stavolta non sono solo ricco sfondo ornitologico, ma personaggi della stessa storia che coi loro versi diventano gli interlocutori privilegiati del narratore. Il tema del luogo di origine da scoprire/riscoprire attraverso i ricordi, una memoria involontaria di origine proustiana che scatta come una molla ad ogni profumo, ogni sapore, (anche se per captatio benevolentiae Handke sostiene “niente di paragonabile alla madeleine del tempo perduto e ritrovato di Monsier Marcel Proust”) si intreccia sapientemente all’altro tema ricorrente nelle opere di Handke, quello del sentirsi sconosciuto a se stesso, quello di sentirsi straniero in patria e contemporaneamente di appartenere a qualsiasi luogo. “Per me il senso dell’origine è molto profondo: non posso tornare indietro, ma sono sempre là…” diceva l’autore in un’intervista (E.Filippini, ediz.Castelvecchi, 2013).
Prima di partire, l’innegabile ammissione:
“Mi era sempre tornata in mente nella vita la vecchia storia, più o meno biblica, dell’uomo quale era stato afferrato da Dio o da chissà quale altra forza maggiore per una ciocca di capelli, e portato via dal suo luogo natio, da tutt’altra parte – in un altro Paese”. (pag.19)
Nel passo a pag.72 che cito come assaggio della sua scrittura ironica, a volte fredda e cristallina, torna l’immagine dello straniero di Camus, nascosto nell’io più profondo e segreto del protagonista:
“...nell’altro Paese, io, l’estraneo, lo straniero, sentendo i latrati e gli strepiti, spesso infiniti, dei cani oriundi – più oriundi di così non era possibile -nei giardini vicini, non potevo impedirmi di immaginare continuamente, scena peraltro spiacevole, di prendere un bazooka – di cui ignoro nel mondo più assoluto caratteristiche e funzionamento – per far saltare in aria la relativa casa oriunda; di livellarne il terreno, di trasformarlo in un inferno di fiamme, con tanto di lamenti di animali e uomini che ci vivevano. E un giorno o l’altro un atto di violenza lo commetterò davvero (o forse no) …”
La necessità impellente di vendicare sua madre, la sua “santa” madre, più volte ricordata nel libro, così come nell’altro, “Infelicità senza desideri”, è la spinta a percorrere questo viaggio alla ricerca di se stesso per scoprire alla fine che esiste una seconda spada.
SPOILER? Ma no, ma quale spoiler quando siamo di fronte ad un’opera a trama quasi zero, che si fa leggere per la pregevolezza dello stile e la profondità delle osservazioni sul mondo? Però vi anticipo che il libro, nel finale, si allinea a “La ladra di frutta” pur con le sue differenze, in quanto questo libro così breve, poco più di 150 pagine, rispetto al precedente dà una sensazione di compiutezza, è meno “sfuggente”.
La seconda spada, la seconda possibilità, l’alternativa alla prima, che è quella più facile ed ovvia quella della violenza e della giustizia fatta da soli. E’ una storia di rinascita, dopo aver fatto pace col passato, è la storia di una nuova primavera, già preannunciata nel sottotitolo “ una storia di maggio”, dove la natura sua interlocutrice col suo verde ed i suoi suoni, gli sussurra “Fallo”Fallo!compi la tua vendetta”, ma il vero messaggio è tutt’altro, il vero messaggio della letteratura è al limite, affermava qualche anno fa l’autore “Tutto ciò che scrivo è al limite. Solo al limite appare qualche cosa. Al limite del tempo appare l’eternità”.
Indicazioni utili
Infelicità senza desideri
le altre opere di Handke
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il primo giorno
Con questo romanzo Angela Marsons torna indietro nel tempo e ci racconta, se non gli esordi della sua Kim Stone, almeno la nascita della squadra che i suoi appassionati lettori hanno imparato a conoscere. Dopo un certo numero di romanzi e di indagini, che le hanno valso tra l’altro anche il Premio Bancarella, il lettore curioso potrà scoprire in che modo questa squadra Investigativa britannica si sia formata. In un certo senso il primo giorno di scuola di un gruppo disomogeneo per carattere, cultura e formazione, ma con una sua certa omogeneità data dall’essere in qualche modo dei soggetti ai margini. Prima fra tutti lei: Kim Stone il caposquadra tanto brava e precisa nelle sue indagini quanto incapace nel gestire le dinamiche di gruppo e i rapporti con i superiori. Riservata e gelosa della propria vita privata, tende a disinteressarsi anche di quella dei colleghi apparendo più fredda e scostante di quanto in realtà sia. In realtà attenta a quello che succede e con la rara sensibilità di chi è capace di essere generoso senza mettere in condizioni il destinatario del suo gesto di ringraziarla o di sentirsi in imbarazzo. Attorno a lei due sergenti: uno più adulto stanco di superiori che vogliono fargli fare carriera, perché lui se ne sta benissimo dov’è con un lavoro che sa fare bene e senza gli ingombri di responsabilità a cui non vuole pensare. L’altro più giovane, ambizioso e con l’arroganza tipica di chi non ha l’esperienza necessaria a valutare correttamente le proprie capacità e quelle degli altri. Infine una agente investigativa di fresca nomina: desiderosa di dimostrare le sue doti che sono parecchie, ma forse troppo ansiosa di piacere e di compiacere tutti.
Direi che questo libro ci presenta innanzitutto una squadra fatta di personaggi ben amalgamati, credibili e interessanti da conoscere. Mi sono piaciute molto anche le indagini: chiare, serie e con esisti credibili, ma mai scontati. Il primo cadavere a cui fa riferimento il titolo è il primo che la neonata squadra è chiamata a visionare pochi minuti dopo essere stata formata. Il primo di cui si occupa, ma non il primo dello stesso assassino e neppure l’ultimo. A parte la tendenza della Marsons, che secondo me è diventata comune alla maggior parte dei giallisti, a calcare un po’ la mano sui dettagli macabri e a dare motivazioni e schemi mentali piuttosto contorti all’assassino, nel complesso si tratta di un buon thriller. L’esigenza di far inorridire e spaventare il lettore tanto da rendere appetibile il libro è bilanciata da una scrittura gradevole e fluente, dalla cura per i dettagli e da una trama fitta e coinvolgente. Abile l’autrice nel depistare il lettore, o almeno a depistare me che molto prima della fine ho sbuffato quando ho pensato di avere già individuato il colpevole. Abile anche a giustificare in modo logico tutto quanto ci ha raccontato, o solo accennato nel corso del racconto. Come dovrebbe succedere in un buon giallo alla fine, non una pagina prima, tutti i pezzi del puzzle che sono stati sparsi nelle righe precedenti, vanno al loro posto.
Indicazioni utili
Democrazia dittatoriale
Cosa saresti disposto a fare per una banana?
Non una banana qualunque, la banana sudamericana che ha invaso il mondo e si è imposta nell’alimentazione di ogni abitante del globo.
Tutto, direbbe probabilmente il ricco signor Zemurray, magnate delle United Fruit Company.
Siamo nel 1954 e per colpa di un presidente guatemalteco decisamente troppo democratico, si vorrebbe addirittura costringere l’azienda a pagare le tasse. Per non parlare poi di una riforma agraria e del mercato del lavoro, dove si ipotizza la lotta ai soprusi subiti dagli indios e la distribuzione della terra - accumulatasi illegalmente nelle mani di pochi latifondisti- ai piccoli contadini.
Zemurray, appoggiandosi al massimo esperto di pubbliche relazioni, riuscirà ad insinuare la minaccia comunista in un paese in via di democratizzazione fino al colpo di stato che lo condurrà, invece, verso la dittatura militare.
Buona la premessa e pure la penna, i primi capitoli sono accattivanti ed incuriosiscono il lettore con una scrittura di una fluidità sorprendente, devo talvolta riprendere il passo che gli occhi mi scivolano più veloci della mente. Poi, però, aumentano disordinati i personaggi – qualcuno resterà a lungo, qualcuno sparirà chissà dove e chissà perché – e si ingarbuglia così la disinvolta narrativa.
Dimentichi della futura Chiquita, ci addentriamo in un Guatemala dove l’autore dibatte essenzialmente di dittatura ed intrigo politico, attraverso un intreccio caotico. Certo, val la pena proseguire per apprezzare la denuncia verso un sistema corrotto ed usurpatore, verso le dinamiche di un’America che finanzia la guerra per proteggere i suoi interessi economici, ma scema il piacere sotto il passo greve e le pagine hanno un denso “effetto Wikipedia”.
I personaggi sono costruiti per enfatizzare il loro lato oscuro, però sono brutti senz’anima, sterili e piatti.
Poco vestibili gli abiti della narrativa da ricordare, improbabile la precisione della saggistica, il romanzo è un tentativo di miscelare entrambi gli elementi cui non potrei negare una sufficienza per forma e contenuto, anche se, ammetto, mi ha annoiata a morte.
Autopsia di un amore
Questo romanzo è un tavolo autoptico su cui giace un amore finito da più di dieci anni. Le parole, affilate e taglienti come un bisturi, non esitano ad aprire, spietate e implacabili, ma da quella ferita non sgorga più il sangue caldo della passione, della rabbia, della sofferenza. Quell’amore oramai è un corpo inanimato, da osservare e analizzare, non per riviverne le emozioni o per lasciarsi trasportare dalla nostalgia, ma per rispondere a un bisogno freddo e cerebrale, quello di capire cosa si cela dietro la distruzione di un rapporto, e perché distruggere a volte sia l’unica strada per trovare quel porto tranquillo tanto cercato.
Filo conduttore di questo viaggio introspettivo è l’idea che una coppia non sia una bolla abitata da due persone, ma una costruzione che deve fare i conti con tutti coloro che le rispettive storie si portano dietro. Le passioni brucianti, i trascorsi famigliari, il peso degli errori e delle fughe.
Elena, voce narrante, è una giovane contabile innamorata del suo ex professore di economia, Pietro, di trent’anni più vecchio. Lui ha un matrimonio alle spalle, tre figli ormai adulti, un passato complesso e stratificato, ma ad Elena non importa, è qualcosa di lontano, esterno al bozzolo di felicità che hanno costruito, calzando le maschere di giovani e spensierati sposini. Così quando l’ex-moglie Maria la avvicina con uno stratagemma, Elena percepisce per la prima volta che esiste un’altra prospettiva con cui guardare le cose. Chi è la protagonista e chi l’altra donna? Si può davvero costruire senza sapere la storia di quel matrimonio andato in pezzi, senza guardare in faccia le ragioni di quel fallimento, senza fare i conti con i non-detti? Conoscere significa però attraversare una barriera da cui non si torna più indietro, perché nella verità si nascondono debolezze, illusioni, paure, ed è difficile conviverci e accettarle. Ma indispensabile, perché per salvarsi bisogna prima assolvere, gli altri e se stessi.
“Era scesa tra noi l’illusione che tutto si potesse rifare sempre da capo, senza tracce di quello che era accaduto, come fossimo lavagne pronte a essere cancellate, riscritte, cancellate di nuovo”.
Cristina Comencini dà vita a uno scritto psicologico, introspettivo, riflessivo, in cui si percepisce l’urgenza di volere capire, addentrandosi nelle pieghe di stati d’animo e sensazioni, senza sconti e senza abbellimenti. Ottima la capacità dell'autrice di scavare negli angoli bui della famiglia e dell’animo umano, mettendo in scena un confronto femminile e generazionale che molto ha da comunicare. Lo stile asciutto, incalzante e aspro diventa un elemento cardine della narrazione, invogliando a proseguire nonostante una trama scarna, sfumata, che rimane quasi in secondo piano. Una lettura che costringe a riflettere e meditare, da cui mi sarei però aspettata maggiore intensità e trasporto emotivo e che mi ha invece lasciato la sensazione di una potenza inespressa e di un fuoco spento, di cui ho percepito solo qualche scintilla.
“Siamo una catena di storie d’amore, una dentro l’altra, e i fallimenti appartengono a tutti. Ero figlia di una serie di donne che venivano prima di me, come lui lo era degli uomini. Non ci si salva da soli”.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 15 Ottobre, 2020
Opinione inserita da ornella donna 15 Ottobre, 2020
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La giornalista Clara Simon
Francesco Abate è un giornalista professionista per l’Unione Sarda; il suo primo romanzo è del 1998, Mister Dabolina. Nel 2003 pubblica Il cattivo cronista, a cui fa seguito Ultima di campionato. Nel 2006 inizia una collaborazione con Massimo Carlotto, con cui scrive Mi fido di te. Altri romanzi fanno seguito fino all’ultimo appena edito intitolato I delitti della salina, pubblicato da Einaudi. Un libro curioso e nel suo genere innovativo: la protagonista è Clara Simon, una bella donna, dai tratti orientali. Figlia di una donna cinese di umili origini, e di un capitano di marina Francesco Paolo Simon. Purtroppo la madre muore di parto, e il padre risulta disperso in guerra. Clara viene cresciuta dal nonno, Ottavio Simon, un uomo molto importante a Cagliari:
“Il cavalier Ottavio Simon , le spalle larghe, un metro e novanta d’altezza, si pizzicò il baffo canuto con pollice e indice destro. (…) siamo una stirpe bizzarra, una famiglia eccentrica, bislacca. Oserei dire che abbiamo incanalato la nostra pazzia nel genio, abbiamo mitigato gli umori neri che ci sono propri per natura con l’ingegno, vinto ogni angoscia lanciandoci nel vuoto delle avventure più perigliose.”
Quest’ultimo nutre per la nipote un affetto smisurato, e non riesce mai a dirle di no, accettando i suoi comportamenti, spesso al limite. Come quello di voler a tutti i costi esercitare il mestiere di giornalista investigativa, che per il periodo è del tutto fuor luogo ed impensabile. Da ciò infatti derivano i guai della nostra protagonista:
“Erano giornate infuocate, di scioperi e proteste per il carovita. (…) alla manifattura si scatenò un tumulto tra le sigaraie, che volevano far valere le proprie ragioni, e chi era pronto a mettersi al soldo dei padroni per non fermare il lavoro. (…) Clara decise di vederci chiaro e nei suoi articoli non si fermò davanti a nulla, riuscendo a scalfire il muro di omertà e portando alla luce la verità. “
Ora sembra più tranquilla, anche se non desiste dai suoi propositi. Quando una sigaraia le comunica la sparizione di molti “piciocus de crobi”, lei non può far finta di nulla. Chi sono costoro? Sono:
“i facchini del mercato e il loro mondo di miseria. Bestioline per lo più orfane o provenienti da famiglie mischinissime. “
Aiutata dal suo amico di infanzia Ugo Fassberger, redattore del giornale in cui scrive, e del tenebroso tenente Rodolfo Saporito, che ha un debole per lei, Clara riuscirà a scoprire cosa sta succedendo in città? In particolare cosa accade durante la notte con celebri personaggi che si riuniscono lontani da occhi indiscreti per mettere in atto quali strane pratiche? La verità è un lungo cammino irto di ostacoli, e questo Clara lo sa molto bene.
Un libro scritto ed elaborato con un taglio giornalistico netto e preciso, che non concede scampo e non si perde in inutili fronzoli, che si legge con piacere e coinvolgimento emotivo. La protagonista, Clara, è sicuramente il punto forza di grande impatto, che suscita non solo interesse per i suoi comportamenti, per la sua intelligenza e per il suo intuito; ma è anche motivo di riflessione su tempi passati dove ad una donna era impedito di scrivere articoli di cronaca nera e meno che mai investigare. Un altro punto di grande forza è l’ambientazione, data dalla città di Cagliari, colta nella sua bellezza intrinseca delle saline, del Bagno penale, del bordello e del teatro dell’opera, alla spiaggia del Poetto, ma anche nel suo lato più oscuro, più miserevole, dove il male esercita tutta la sua forza. Ne consegue una lettura avvincente, di un tempo passato, resa dall’autore con perizia narrativa e ricerca alle fonti precisa e ricca di dettagli importanti. Da gustare con piacere infinito.
Indicazioni utili
Teatro ellenico, realtà sottesa
Con "Il teatro dei sogni" Andrea De Carlo torna in libreria con un romanzo corposo che muove le sue fila da due personaggi che si incontrano per caso, in una mattina come tante, durante una colazione come tante.
Il nuovo anno ha avuto inizio, è il primo di gennaio e Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta gustandosi il suo cornetto in un bar. È in questo frangente che la suddetta delizia per il palato le va storta rischiando di soffocarla durante una diretta. Nessuno tra i presenti muove un passo per intervenire, nessuno sembra interessato a quanto sta accadendo. Tra tutti soltanto un uomo interviene, un uomo di professione archeologo e di nome Guiscardo Guaidarini, un uomo che ha appena rinvenuto un importante sito e che non ha il minimo interesse a mostrarsi al grande pubblico per ottenere una qualsiasi fama.
A questi due primi personaggi si sommano l'assessora alla cultura Annalisa Sarmani, vicesindaco con deleghe alla Cultura e al Turismo della città di Suverso, esponente del partito sovranista Unione Nazionale, e il sindaco Cosmarate di Sopra e di Sotto, Massimo Bozzolato, del movimento titolato del Rivolgimento.
Le vicende hanno luogo in un Nord Italia nato dalla fantasia, una localizzazione inventata che però non fatica a farsi ravvisare nella realtà. Le circostanze, in particolar modo, raggiungono una evoluzione inattesa quando la giornalista rivela della scoperta dello studioso trasformandolo in un vero e proprio eroe.
Da qui iniziano delle lotte tra partiti, competizioni tra comuni, esponenti delle comunità scientifiche e giornalistiche e chi più ne ha più ne metta.
Il risultato finale è quello di un teatro ellenico in cui si disputano battaglie paradossali e spesso insensate che rappresentano in modo perfetto la realtà e la società che ci circonda. Non mancano, infatti, tra le pagine riflessioni sottese sui sogni perduti, le disillusioni, desideri indotti, speranze dissipate, perdite costanti di valori.
Un testo corposo, ben costruito, ironico e scenico come ogni lavoro di De Carlo ma avvalorato da un contenuto e una riflessione più matura, una serie di considerazioni che emergono tra le righe con naturalezza e già dal primo capitolo (basti pensare alla reazione della reporter innanzi al gesto dello studioso, una reazione che la porta a dover immediatamente immortalare l'attimo per cercare di raggiungere quel numero di follower in più tali da far incrementare il suo profilo social).
Unica pecca che ho ravvisato è una certa ridondanza in alcune parti dello scritto e in particolare proprio a causa dello stile narrativo eclettico ed elaborato che talvolta risulta farraginoso ed eccessivo stante anche la mole del componimento.
Un libro piacevole, interessante, riflessivo, da leggere un poco alla volta.
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Sentieri di vita medievale
A cavallo dell’anno Mille l’Inghilterra non si è ancora sollevata dal degrado in cui era scivolata con la fine dell’impero romano. La gente per lo più si trascina faticosamente in un regime di mera sussistenza e la vita è una continua lotta contro la fame e le incursioni vichinghe o le razzie gallesi e britanne.
In questa età dura e complicata vive Edgar, ultimogenito di un abile costruttore di barche nella città di mare di Combe. Il ragazzo, appena diciottenne, vorrebbe farsi una vita altrove assieme all’adorata Sunni, la moglie maltrattata del lattaio Cyneric, che lui ama teneramente. Ma la notte in cui i due vorrebbero fuggire è funestata da un assalto vichingo. Sunni muore per mano di un predone e pure il padre di Edgar cade sotto i colpi dei razziatori. Ora che il cantiere navale è distrutto, Edgar e la sua famiglia, privati pure della casa, temono di dover affrontare un futuro disperato, forse, addirittura, di schiavitù.
Per rifuggire a questo destino la madre, donna di grande razionalità e pragmatismo, costringe i tre figli ad accettare la proposta del subdolo e corrotto vescovo di Shiring, Wynstan: diventare contadini e trasferirsi nel misero borgo di Dreng’s Ferry, per occuparsi, come fittavoli, di un misero terreno alluvionale di proprietà della locale collegiata religiosa. Il posto è trascurato e dà loro a malapena da vivere, ma Edgar è intelligente, industrioso e tenace. Lentamente, a fatica, e superando innumerevoli dolori e ingiustizie, riuscirà a farsi strada.
La sua storia si intreccia con quella di Ragna, figlia del conte normanno di Cherbourg, andata in sposa (per amore) a Wilwulf, aldremanno di Shiring e fratello del vescovo Wynstan. La ragazza, colta, intelligente e volitiva ama teneramente il marito, il quale pur ricambiando, inizialmente, i sentimenti della sposa, è uomo falso, incostante e amante solo del potere. Così Ragna si trova ben presto costretta a difendersi dagli intrighi di quella piccola corte e dai continui agguati che, in essa, le provengono dalla matrigna del marito, Gytha e dai due fratellastri, Wynstan e Wigelm.
Unico alleato dei due giovani è il monaco Aldred, uomo pio e amante delle lettere, tra i pochi a voler far rispettare la giustizia e il rispetto per il prossimo in una comunità ove la sopraffazione e la lotta per il predominio sembrano essere gli unici stili di vita ammessi. Ma anche lui deve subire la viltà dell’abate Osmond, l’ostilità del vescovo, il nepotismo di Wilwulf e la sostanziale impotenza del re Etelredo e del cardinale di Cantherbury, troppo lontani per poter influire sulla piccola, malsana comunità.
“Fu sera e fu mattina” rappresenta il prologo alla trilogia di Follett dedicata al fittizio paese di Kingsbridge e alla sua comunità, iniziato oltre trent’anni fa, con il grande best seller de “I pilastri della Terra”.
In questo romanzo la storia retroagisce di un secolo e mezzo, rispetto alla narrazione di quel primo libro e ci fa comprendere come sia nata Kingsbridge (qui King’s Bridge) e come si vivesse nell’Inghilterra dell’alto medioevo.
È indubbia l’abilità di Ken Follett di inventarsi storie, anzi di dar proprio vita a personaggi i quali rapidamente assumono consistenza e tridimensionalità e dei quali il lettore può seguire il loro percorso sui sentieri della vita, tra fatti memorabili e piccoli accadimenti quotidiani, con una concretezza tale da renderli credibili e verisimili.
Anche in questo nuovo romanzo le figure di Edgar, Ragna (suppongo da leggersi con la “g” dura), Aldred e tutti gli altri sono ottimamente delineate e si fa presto a entrare in sintonia con essi, a parteggiare per loro, a soffrire, per empatia, delle loro sventure o gioire per i loro successi.
Dunque, sotto il profilo narrativo anche questo nuovo romanzo è da considerarsi un successo e fonte di piacevoli momenti di lettura e distrazione se ciò che si desidera sono soprattutto passioni, azione, intrighi, amore, un po’ di sesso e l’eterna lotta del bene contro il male dove quest’ultimo, alla fine (ma proprio alla fine!), viene sconfitto.
Tuttavia chi ha già avuto modo di apprezzare i romanzi del ciclo di Kingsbridge, non faticherà a notare le evidenti analogie delle trame, il ripetersi dei medesimi schemi già abilmente sfruttati ne “I Pilastri della Terra” e nei volumi che a questo hanno fatto seguito. Come nella commedia dell’arte avveniva che gli attori riproponessero sempre gli stessi caratteri e, pur in canovacci lievemente modificati, alla fine si assistesse sempre alle stesse situazioni, alle medesime contrapposizioni, così anche in questo libro le attinenze sono prevalenti sulle novità e ciò spoglia il racconto di originalità e, in parte, di attrattiva.
Il lettore attento non faticherà a notare le innumerevoli affinità tra i protagonisti. La figura di Edgar il costruttore ricorda, a grandi linee, quelle di Tom e Jack (ne “I Pilastri”) o Merthin (ne “Anni senza fine”) guarda caso anch’essi costruttori. Ragna assomiglia agli altri personaggi femminili volitivi, in primis Aliena, ma anche Caris di “Anni senza fine”. Aldred richiama sin troppo il buon priore Philip. L’arrogante aldermanno Wilfwulf e suo fratello Wigelm risultano essere discreti antesignani del crudele conte William. Il cattivo vescovo Wynstan non si discosta dal carattere del parigrado Waleran Bigod (o dal priore Godwyn di “Anni senza fine”). Le vicende di cui sono protagonisti, ovviamente, sono diverse, ma non così tanto e, alla fine, lo schema generale della trama risulta assai simile, una sorta di “per aspera ad astra” che, in conclusione, conduce al trionfo della tenacia nel perseguire le buone intenzioni contro la perseverante malvagità dei cattivi.
La sensazione finale è di trovarsi di fronte a un abile clone degli altri romanzi, soprattutto se questi sono stati letti molto tempo addietro e il ricordo dei singoli particolari si è annebbiato e stemperato.
Ciò di cui ho sentito maggiormente la mancanza è l’assenza, per contestualizzare le vicende dei protagonisti, di un consistente apporto della grande storia: qui è presente solo come sfumato sottofondo alle vite dei personaggi principali.
È pur vero che, a cavallo tra il X e l’XI secolo, l’Inghilterra era ancora un luogo turbolento, ma, sostanzialmente, una nazione in via di formazione dove non accaddero eventi memorabili sino all’arrivo di William di Normandia, il futuro Guglielmo I il Conquistatore. Tuttavia, proprio perché la narrazione risulta focalizzata soprattutto sui protagonisti, si perde in parte quella essenziale caratteristica che contraddistingue il romanzo storico e lo impreziosisce: la fusione tra eventi reali e invenzioni letterarie. Il medioevo di Follett è curato e rispettoso dello spirito, dei comportamenti e delle condizioni sociali dell’epoca, ma forse non così incisivo e vivido come mi sarei aspettato e avrei gradito.
In conclusione il romanzo è una buona fonte di svago, ma decisamente inferiore a “I Pilastri della Terra”. Poi, magari, duecento, duecentocinquanta pagine in meno non avrebbero guastato, perché il "brodo" alla fine diviene davvero lungo e difficile da sorbire tutto con lo stesso piacere..
Indicazioni utili
Piccole donne
Il rapporto tra due sorelle, in particolare in una famiglia in cui le sorelle sono più di due, è sempre un rapporto un po' speciale, spesso collocato su un gradino più elevato nell'ordine degli affetti familiari.
Un rapporto amorevole, molto più intenso di quello che intercorre normalmente tra i fratelli solo maschi, e tra fratelli e sorelle.
Del tutto diverso dal rapporto che si può avere con l’amica del cuore, spesso è anche più conflittuale, talora polemico e dispettoso, non di rado divergente, ma sempre affezionato, complice, partecipe, quando è davvero forte è energicamente intrigante, coinvolgente come poche relazioni al mondo.
Un po' quanto appare evidente nel celeberrimo “Piccole donne” di Luisa May Alcott, in cui le quattro sorelle March, tutte diversissime tra loro, sono però un’entità unica, indivisa, unite in un rapporto, possibile solo al femminile di amore, amicizia, premura e solidarietà, quasi fossero una sola donna.
Questo è quanto rievoca ne “Il mantello” la scrittrice cilena Marcela Serrano, e l’occasione per parlarne, però, coincide con uno dei momenti più difficili da affrontare nell'esistenza di ognuno, allorché viene meno una persona cara, amatissima, come nello specifico la sorella Margarita.
La perdita di una sorella, in verità, non è mai in un certo senso nell'ordine naturale delle cose. Dopotutto in qualche modo si è inconsapevolmente già preparati alla scomparsa dei propri genitori, avverrà prima o poi, è nella norma, magari anche del partner di vita, sebbene non sia piacevole soffermarsi su questi pensieri, mai però si è veramente preparati alla scomparsa di una sorella, quantunque afflitta da una malattia inesorabile, meno che mai al sopravvivere al proprio figlio.
Tutto quanto la scrittrice lo descrive efficacemente già all’inizio del libro:
“Quando ti muore il marito sei vedova. Quando ti muore il padre sei orfana…Io non sono né l’una né l’altra…Sono qualcosa che non ha nome, perché la mia perdita è orizzontale. Un bel problema: comincio già sapendo che le parole non bastano. Non ne esiste nessuna per definire il mio stato. Non hanno inventato nessuna parola per una sorella rimasta senza sorella. “
Ecco, la scrittrice ha appena enunciato un paradosso importante: ha il cuore a pezzi, è tremendamente affranta per la scomparsa della sorella a cui era legatissima.
È sotto choc, stordita, disorientata, malgrado fosse perfettamente al corrente delle condizioni disperate in cui versava Margarita.
Fin dall'inizio della comparsa del suo male, Marcela Serrano era perfettamente conscia della gravità della malattia contro cui da anni la coraggiosa sorella Margarita combatteva, un tumore al seno.
E però…e però non trova le parole per esplicitare questo dolore, per definirlo e definirsi.
Il che, per una scrittrice, appare il colmo. Mica tanto: l’elaborazione di un lutto prevede la sua metabolizzazione, la sua primaria assimilazione prima della catarsi.
Il dolore va definito per bene prima, vanno rievocati i comuni ricordi, e questo ricordare i momenti condivisi e convissuti, lieti e brutti che siano, avviene anche con irrisoria facilità.
Poi da quei ricordi devi sintetizzare il significato che ti porti a fartene una ragione, e non puoi farlo, non ti riesce, non ti viene perché è il dolore stesso che ti blocca, ti toglie il respiro, inaridisce la fonte dei vocaboli che servono per delineare i motivi di una accettazione.
Marcela Serrano è una delle voci più rappresentative dell’odierna letteratura cilena, e come tutti i buoni scrittori, è stata e continua ad essere una lettrice appassionata.
Ricorre allora alle sue letture, utilizzando brani e scrittori che delineano al meglio il suo stato d’animo attuale, annichilito dal grave lutto, in un certo senso possiamo dire che chiede l’aiuto dei colleghi in questo difficile momento della sua esistenza.
La scrittrice cilena non ci offre qui la lettura di un suo romanzo, meno che mai una autobiografia; in questo bel libro, un piccolo volumetto che si legge con fluidità, malgrado la tristezza di cui è permeato, che però mai ne appesantisce la lettura, si riportano episodi lieti, gentili, teneri, divertenti di un vissuto di una normale famiglia piccola borghese. Di retroterra culturale e di crescita formativa improntata sui principi di antica saggezza di stampo contadino, seguita da studi e appartenenza piena al vivere e alla partecipazione civile di un paese, tanto tipico quanto tormentato politicamente, come il natio Cile. Un libro costituito di tanti paragrafi brevi e brevissimi, talora di una sola pagina e di poche parole: l’autrice preferisce affidarsi più all'immagine suscitata brevemente da qualche riga e captata in misura dipendente dalla sensibilità del lettore, anziché delineare con precisione fatti e persone. Direi perciò che è un libro fortemente evocativo, ma evoca con forza, con energia, è graffiante, pungente, ti inchioda alla lettura certo, ma molto di più alla riflessione ed alla ponderazione.
Questo non è affatto un libro pesante, una raccolta di dolorosi ricordi, è un bel libro, un saggio di tenerezza, è un elogio di sentimenti affettivi, è un viaggio nella memoria per riacquistare il presente, è un giungere ad una inevitabile conclusione: la morte è una costante nell'esistenza di ognuno, non si può negarla. Ma non si vive per i morti e con i morti, il mondo è solo per i vivi.
Quello che ci affratella ai nostri cari scomparsi, molto più dei vincoli di amore e di sangue, è la memoria dei nostri affetti perduti.
I nostri morti sono scomparsi dal numero dei vivi, ma sono sempre ben presenti in noi.
E tanto basta, e ci deve bastare.
Allora, e solo allora, elaboriamo il lutto, e ce ne liberiamo, pur continuando ad avere nei cuori i nostri cari. Così fa Marcela serrano, e riprende a scrivere.
Ma appunto come dicevamo, ripercorre la sua storia con Margarita, scandendone i punti salienti con le sue letture preferite.
La scrittrice trova conforto nella lettura…”la lettura è un’anticipazione della gioia - Jorge Luis Borges”.
Il lutto impigrisce ogni sua azione…”nessuno ha mai parlato della pigrizia del dolore – C.S. Lewis”.
Il dolore della perdita stranamente è un va e vieni di continuo…”Mi fa una paura folle il carattere discontinuo del lutto – Roland Barthes”
Cosa succederà dopo il tempo dal lutto…”Il rispetto della realtà prende il sopravvento – Sigmund Freud”.
La perdita della sorella è una mancanza incredibile…”Un essere solo vi manca, e tutto sembra deserto – Philippe Aries”
L’unico sudario adatto ad una persona estroversa, vitale e sorridente come Margarita? Nessun sudario, qualcosa di più adatto, ecco, un mantello, per esempio, un bel mantello...”Tanti quadrati o rettangoli, uniti tra di loro…scintille di colore…petardi in un giorno di festa, verdi, rossi, bianchi, stampati, marrone, viola, uno nero qui, uno rosa là, stretti gli uni agli altri in un diligente lavoro di patchwork – Il mantello di Clara Sandoval”.
Quello che unisce ancora di più due sorelle, è che inevitabilmente sono state compagne di giochi, hanno condiviso i segreti più intimi dell’infanzia, dell’adolescenza, della giovinezza, compresi gli amori, le infatuazioni, le assurdità tipiche dell’età, non può esistere un legame più forte quando è legato inestricabilmente da emozioni simili, come catene di diamante inscalfibili…”Se la patria è l’infanzia, una sorella è la mia compatriota – Rainer Maria Rilke”.
Si può continuare a scrivere dopo un simile lutto? Non è significativo di un cuore freddo? ...”Nel cuore di ogni scrittore c’è un pezzetto di ghiaccio – Graham Greene”.
Marcela Serrano non è la sola ad aver scritto un libro sulla perdita di un familiare, basti ripensare a Philip Roth ed al suo romanzo “Patrimonio”, in cui ci racconta con certosina diligenza del padre e del declino fisico del genitore fino alla fine, quasi come un’odissea che ogni uomo affronta nel suo divenire adulto.
Tuttavia, l’originalità della Serrano sta nel citare altri scrittori, come detto, per giungere alla conclusione che un lutto, per quanto grave, è un’esperienza comune, ovunque esistono persone che piangono i loro morti. Ma appunto perché è evento comune e condiviso, significa che si supera, si può superare, è uno stato transitorio. Certo, devi transitare.
Se nel transito trovi aiuto e consolazione, meglio ancora, non tutti amano viaggiare da soli.
Se poi viaggi con le tue letture preferite, quelle per te più significative, tanto di guadagnato.
Certo, la perdita rimane. Ma ne hai una qualche consolazione.
Meglio che niente: a qualcuno non è dato neanche quello, talora nemmeno un corpo da piangere.
Piangono i loro figli, vivono tuttora il loro lutto, le piccole donne che mai riusciranno ad elaborare il lutto dei propri figlioli, i desaparecidos cileni. Marcela Serrano lo sa, lo ricorda, lo rievoca:
“Ha ragione Faulkner quando dice che il passato non muore mai. E che non è nemmeno passato.”
Indicazioni utili
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Non si scende da treni in movimento
In una intervista di qualche tempo fa, alla domanda in cosa consistesse il suo attuale lavoro, Peter Cameron rispose che stava lavorando a un romanzo che ha come protagonisti una coppia eterosessuale, che si reca in un lontano paese nordico per adottare un bambino. E questa è in effetti la trama di "Cose che succedono di notte", riassunta un poche parole.
Sette capitoli contenenti sette giorni della vita di un uomo. Dico un uomo, perché al lettore non è dato conoscere il suo nome così come non si conosce il nome di sua moglie. Una settimana che sembra scorrere come una notte, in effetti rappresenta una settimana di buio, una notte interminabile, perché ci troviamo in un paese ai confini del mondo in cui per sei mesi è notte e per gli altri sei è giorno. Un buio perenne accompagna il lettore dalla prima riga fino all'ultima in una bellissima struttura narrativa in cui le atmosfere che l'autore crea sembrano gareggiare con i personaggi, sembrano voler attrarre l'attenzione del lettore su di esse, vanitose e ammaglianti. A lettura ultimata ciò che più mi è rimasto impresso sono loro, queste magnifiche "creature" rarefatte composte di buio, neve, freddo ma anche eleganza, fascino e mistero. Una struttura circolare, dall'incipit poetico e che nel finale l'autore riprende nello stesso punto, e anche un po' oltre, dove finalmente il sole compare, assieme a una nuova vita ma anche a una mancanza.
La tematica base è il desiderio di avere un figlio da parte di una coppia eterosessuale che farò di tutto pur di averlo. Però mano a mano che si procede nella lettura, gli eventi precipitano e prenderanno una piega diversa e la vera tematica, a mio avviso, diventa la paternità per un uomo omosessuale, che non potrà offrire una mamma al proprio figlio. Onestamente conoscevo poco della biografia di questo autore ma già dopo le prime pagine un dubbio mi si era istillato e sono andata a controllare in rete: in effetti l'autore è omosessuale, e sotto questa luce il tutto diventa più digeribile per un lettore e il libro lo si legge sotto una nuova luce. Dico digeribile perché ci sono alcune scene che potrebbero urtare, potrebbero essere incolpate di misogina, di superficialità o di una scarsa abilità nel descrivere un atto sessuale. Questo perché l'autore non ne parla direttamente di questo suo intimo desiderio, ma lo fa appunto al buio, nascondendosi, camuffandolo attraverso un desiderio di una coppia eterosessuale ma che inevitabilmente spicca fuori per quel che è. All'enorme desiderio di paternità si sovrappone però anche una terribile paura ma anche moltissima sensibilità. Oltre a questo tema se ne parla anche della solitudine, del radicamento delle persone alla propria terra per quanto essa possa essere ostile, si parla di figli, ma anche della malattia.
Un libro che complessivamente mi è piaciuto, soprattutto per le atmosfere e per la forma narrativa, scritto con una prosa scorrevole e nello stesso tempo ricercata, in cui non mancano gli affondi introspettivi. Mi ci sono affezionata meno ai personaggi con i quali si fatica a entrare in empatia perché bizzarri, egoisti, strani, quasi irreali. Concludo con questo delizioso frammento:
"Qualche istante dopo la donna disse: Resto sbigottita davanti a una tale profondità di sentimento. Sentimento d'amore, immagino. O forse non sarà amore, ma commuoversi fino alle lacrime... Quando si smette di provarli, ci si dimentica che i sentimenti esistono, che le altre persone effettivamente li provano. L'amore, per esempio. Forse sarà una cosa dovuta alla vecchiaia o forse i sentimenti, come i muscoli, si atrofizzano. Penso proprio di sì, almeno nel mio caso. Ecco perché continuo a esibirmi, anche se è difficile che venga a sentirmi qualcuno. Per guadagnarmi da vivere suono il pianoforte e canto laggiù nella hall, cinque sere alla settimana e la domenica pomeriggio. E' l'unico modo in cui di questi tempi riesco a provare qualcosa, per quanto non siano sentimenti veri ma il facsimile del facsimile del facsimile. E poi arriva lei, proprio qui accanto a me, con i suoi sentimenti veri. Mi vergogno. E lo ritengo un onore."
Indicazioni utili
Edward Cullen
«I chicchi della melagrana e il mio mondo infernale. Non ero appena stato testimone di un brutale esempio di quanto il mio mondo potesse essere sbagliato per lei? E lei giaceva lì, spezzata, per colpa di questo. Di certo, il più grande male possibile sarebbe stato tenerla con me.»
Sono trascorsi già quindici anni da quando “Twilight” ha fatto il suo ingresso nelle nostre librerie. In quegli anni Stephenie Meyer riuscì a portare tutti i lettori in un universo fatto di vampiri ma anche di amore e amicizia, destò l’interesse anche dei meno avvezzi alla lettura e si distinse nel panorama del fantasy grazie a una serie ben costruita che fece sognare e battere i cuori.
In questo 2020 torna tra gli scaffali con “Midnight Sun”, opera che non deve essere considerata uno spin-off del titolo che ha dato avvio alla saga ma che è al contrario un testo che torna a narrarne le vicende ma dal punto di vista del travagliato Edward Cullen. È lui, infatti, la voce narrante di questo componimento e noi ne ripercorriamo le tappe osservando da una diversa prospettiva.
La prima cosa che colpisce sin dalle prime battute è lo stile narrativo che si distingue per la grande eleganza della penna. Ciò consente a chi legge di immedesimarsi nei panni di un uomo che apparentemente ha solo diciassette anni ma che in realtà ha diversi decenni in più alle sue spalle, ciò permette di avvicinarsi con più facilità a quella realtà scolastica in cui egli conosce Isabella Swan insieme alle due sorelle e ai due fratelli nella grigia e piovosa Forks. Edward non solo è un vampiro ma legge anche nella mente di chi lo circonda. Di tutti, credeva. Perché l’incontro con Bella, la ragazza scoordinata, timida e minuta, suscita in lui sentimenti contrastanti di amore, odio, attrazione e desiderio di fuga e cambia quella che è sempre stata la consuetudine: può leggere i pensieri di tutti ma non i suoi. Per quale motivo? Cos’ha quella ragazza di diverso dalle altre? Perché la sua mente è inaccessibile?
«Bella Swan camminò nel flusso d’aria calda che soffiava verso di me dal condotto di aerazione. Il suo profumo mi colpì come un ariete, non c’era un’immagine abbastanza violenta per esprimere la forza di ciò che mi accadde in quel momento. Istantaneamente, mi trasformai […]
Io ero un predatore. Lei la mia preda. Non esisteva più niente in tutto il mondo, tranne quella verità.»
Brevi assunti, questi, che rappresenteranno soltanto l’inizio di quel che “Midnight Sun” è. L’effetto sul conoscitore sarà quello di sentirsi a casa, di sentirsi coccolato e cullato, di tornare indietro nel tempo, alla propria età della prima lettura. Il conoscitore sarà travolto dalle emozioni che si susseguiranno passando dalla gioia, al dolore, all’arrabbiatura, al cuore che batte. A differenza però del passato lo farà con una diversa maturità, la propria essendo trascorso un quindicennio, ma anche quella di Edward che proporrà un punto di vista che lo renderà più umano e tangibile. Arriveranno il suo tormento sia fisico che mentale, la sua indecisione, il suo combattere contro se stesso, il suo arrendersi all’evidenza.
Unica pecca che ho riscontrato è stata in un eccessivo dilungarsi su alcuni elementi secondari che tendono a rallentare a tratti un poco la lettura. Interessante il confronto naturale che scaturisce con “Twilight” e al tempo stesso con la trasposizione cinematografica. Alcune incongruenze non sfuggono all’occhio del lettore in relazione alla pellicola ma certamente sono dettate dall’esigenza della narrazione.
In ogni caso “Midnight Sun” è un libro che coinvolge e fa evadere, che conquista e regala ore liete. Non può mancare nella libreria di chi ha amato la serie.
Indicazioni utili
Né carne né pesce
"Jane va a nord”, voglio precisarlo dal principio, è un libro senza troppe pretese se non quella di intrattenere un certo tipo di pubblico. Riguardo a questo pubblico è difficile anche definirlo: direi probabilmente una platea di lettori che cercano qualcosa di leggero, piuttosto ironico, che abbia qualche rimando ai romanzi di viaggio di giovani americani, un po' sullo stile di “Sulla strada" di Kerouac, pur non presentando molte delle sue caratteristiche peculiari. In effetti, è proprio la difficoltà di collocazione la pecca principale di questo libro: è un racconto di viaggio ma non troppo, ironico ma non troppo, d’azione ma non troppo. Né carne né pesce e si rimane dunque spaesati seppur consapevoli, alla fine. che la lettura verrà presto dimenticata. Non che avessi altissime aspettative, ma sono ancora alla ricerca d'una nuova perla in mezzo al mare di pubblicazioni recenti dell' autore, che ormai sforna romanzi come fossero panini: in quantità e fondamentalmente tutti uguali, nella norma.
La trama di "Jane va a nord "è piuttosto semplice: una ragazza disoccupata del Texas riceve l'invito al matrimonio dell' odiata sorella. I suoi sentimenti verso di lei e le altre sorelle la spingono, all’inizio, a non prendere molto in considerazione l'invito, ma poi, solo per il gusto di fare un dispetto con la propria presenza, Jane decide di trovare il modo di “andare al Nord" e assistere alla cerimonia. Un viaggio che non parte dunque con le migliori premesse psicologiche e nemmeno pratiche: la sua auto è un catorcio che non arriverebbe al nord neanche portandolo sulle spalle; non ha abbastanza soldi per acquistare un biglietto per l'autobus, né un regalo per le nozze che sia granché. Come soluzione al primo problema, Jane decide di cercare un passaggio e lo trova con l'irriverente Henry, ragazza che fin dal principio dimostra una personalità e un modo di fare spiccatamente maschili, che deve andare al Nord per sottoporsi a un intervento oculistico; almeno ufficialmente.
Le due ragazze si imbarcheranno in questo viaggio carico di eventi avventurosi… ma non troppo.
“Non credo di conoscere bene la tua personalità. Ma penso che tutti crediamo a qualche stronzata. Il vero amore. I numeri magici, i segni zodiacali. Forse ci serve. O serve a qualcuno di noi. Ho conosciuto un uomo che non valeva la carta igienica con cui si puliva, e io insistevo a credere che fosse migliore di come appariva, e che la persona che vedeva non era il vero lui, come se il vero lui si nascondesse in bagno.”
SENZA INFAMIA SENZA LODE
"Troppi di loro non erano felici, tutti persi dietro qualche sogno impossibile... e poi... Dio santo, quello che ho visto è stato terribile..."
Inizio così la mia recensione con una frase che a mio avviso è molto significativa, al suo interno racchiude alcuni dei punti più importanti del libro: l'infelicità, il raggiungimento di un sogno e il soprannaturale e il leggere il futuro nelle carte.
Partiamo però dall'inizio, la famiglia è il punto cardine della storia, i Casadio sono particolari, stravaganti, bizzarri e a volte talmente strani da sembrare quasi irreali.
Il libro ripercorre le vicende di questa famiglia dal 1800 al 1970 circa, quasi duecento anni di vita condensati in un piccolo volume; la storia si svolge a Stellata un paese che incrocia il Veneto, la Lombardia e l'Emilia, nel cuore della Pianura Padana e vicino al Po.
Sì, probabilmente le pagine sono troppo poche per descrivere al meglio tutti i personaggi che l'autrice ci presenta, alcune storie si esauriscono in poche pagine mentre altre prendono più spazio. Non c'è una vera e propria trama principale ma una serie di subplots, dove ci viene raccontata la vita di alcuni dei discendenti di Giacomo Casadio e Viollca Toska.
Tutto parte da loro, dall'incontro del solitario e taciturno Giacomo con la zingara Viollca, il loro matrimonio farà partire la storia di questo libro e divideranno i Casadio in due categorie: i sognatori quelli con gli occhi e i capelli chiari e i sensitivi quelli con dei tratti del viso più scuri.
Viollca è molto diversa da Giacomo, ha delle tradizioni e una cultura molto lontana da quella del marito, radicata in anni di storia del suo popolo che oggi chiamiamo semplicemente Rom. La donna, va contro la sua famiglia per aver sposato un gagè ( in lingua romanì sta a indicare "gli altri") però, durante il matrimonio, non cambia se stessa o le proprie convinzioni. Lei prepara degli intrugli con erbe e radici e si dedica ad alcuni rituali per togliere il contaminato marhime; come se l'ordine e la pulizia della casa fossero responsabili dei problemi o dell'infelicità del matrimonio con Giacomo. Pertanto, tutto doveva essere pulito con accuratezza, come se ci fosse una netta divisione tra l'interno puro e simbolo di unione famigliare e l'esterno contaminato, sporco e pieno di insidie. Viollca aveva una vera e propria paura dell'impurità e per questo non toccava i rifiuti o non lavorava nei campi. La donna leggeva i tarocchi e vedeva delle cose spaventose nel futuro dei Casadio. Su questo ultimo punto, non sono del tutto sicura che i rom leggessero il futuro, sono andata ad approfondire e ho trovato degli articoli contrastanti a riguardo; quindi rimango perplessa su questo punto.
In realtà l'elemento del realismo magico è presente in questa storia, la stessa autrice lo dice, lei stessa ammette di essere stata influenzata dagli autori latino-americani che conosce bene, anche se sinceramente nel nord Italia non ne avevo mai sentito parlare. Io sono veneta e non mi sono riconosciuta, se non in parte, nelle storie di questa famiglia, tutto quello che mi è stato raccontato dai parenti più anziani mi ha dato una visione differente del passato. Posso trovarmi d'accordo con la parte in cui l'autrice ci parla delle travagliate storie d'amore, di matrimoni infelici, di amanti e di tradimenti anche tra persone insospettabili, molti segreti sono rimasti sepolti per anni, per evitare uno scandalo. Nei piccoli paesi si parla molto e le malelingue sono sempre in agguato e possono anche raccontare delle dicerie che alla fine non si rivelano veritiere. Ma era lavoratori umili e instancabili, dove non c'era possibilità di studiare, dove si viveva di quello che la terra riusciva a donare, dove lo spazio per i sogni era impossibile.
Per rendere l'idea dell'epoca e delle tradizioni trovo che sia stata vincente l'idea di inserire delle frasi in dialetto, che oggi in famiglia si parla ancora, almeno in Veneto è di uso comune.
Ho apprezzato l'enorme lavoro di ricerca che l'autrice ha fatto per inserire questi personaggi in un contesto storico credibile, attraverso le storie di alcuni componenti della famiglia ripercorriamo anche una parte della storia italiana. Sono andata a verificare alcuni fatti e date per capire se effettivamente corrispondevano. Inoltre, la Raimondi introduce alcuni argomenti importanti che non vengono sempre approfonditi: l'istruzione infantile, l'emigrazione verso le Americhe, la fede religiosa e l'aborto.
La cosa che più mi ha colpito e per la quale sono arrivata a dare una valutazione media è stata l'ambientazione, Stellata, un piccolo borgo situato a ridosso del fiume Po, fin dal Medioevo punto strategico di difesa contro i tentativi di conquista di Venezia e di Milano. Stellata non è un paese di fantasia ma esiste veramente ed è situato in provincia di Ferrara. Questo luogo viene descritto in maniera vivida e verosimile, è il posto dove vediamo e leggiamo la storia di tutti i Casadio fino ai giorni nostri.
Posso dire che sia la famiglia, che Stellata sono i due punti cardine della narrazione.
Il punto debole del romanzo sono i moltissimi personaggi, vuoi per i quasi duecento anni che ci vengono raccontati, vuoi perché è impossibile provare empatia per tutte queste persone. Sono davvero tanti anche per una saga famigliare. Le storie che mi hanno coinvolto di più sono state quelle di Achille e Angelica, quella di Adele e quella di Neve. L'autrice riesce però a trovare il giusto equilibrio, non fa confusione tra le varie vicende, questo denota un grande lavoro di anni e anni di scrittura e revisione, che io non posso negare o non considerare.
In realtà qui stiamo parlando di un romanzo con una storia completamente inventata, la stessa autrice lo ha detto in un'intervista, Viollca è un personaggio che la Raimondi inserisce nel libro ma non ha prove certe della presenza dei rom nelle famiglie del nord Italia. Sappiamo che nella Pianura Padana sono passati alcuni zingari, precisamente tra il 1417 e il 1430, infatti in quel periodo, dall’Italia all’Olanda, ci furono molte compagnie di pellegrini che si chiamavano“egiziani” e che transitarono e si stabilirono nel nostro paese.
Un'altra cosa che non mi ha convinta è il prologo, a mio avviso troppo lungo e poco coinvolgente, se avessi letto questa parte iniziale in libreria o in qualsiasi sito, non avrei preso in considerazione la lettura del romanzo, essendo un biglietto da visita importante mi sarei aspettata qualcosa di più.
Lo stile dell'autrice è semplice, pulito e lineare, la narrazione è molto scorrevole ma l'ho trovata piatta senza grandi colpi di scena; la Raimondi scrive bene, lo si percepisce tra le pagine però manca qualcosa per riuscire a consigliare questo libro.
Il realismo magico che dicevo all'inizio non è troppo marcato, ripeto io non l'ho mai sentito qui al nord Italia, mi sembra molto lontano dalle nostre tradizioni che non credono ai tarocchi o agli indovini, quindi su questo punto continuo a rimanere perplessa.
Possiamo dire che questo libro è "Senza infamia e senza lode", non mi sento di consigliarlo come ho spiegato sopra, sono cosciente delle molte recensioni positive ma non posso negare i mille dubbi e perplessità che ho avuto durante la lettura di questo romanzo. In realtà, a mio avviso, non basta dire che il romanzo è poetico e indimenticabile bisognerebbe spiegare bene il perché, sono aperta al confronto con chi la pensa diversamente da me.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La mia piccola grande Tokyo
Vedere Tokyo attraverso gli occhi innamorati di una italiana che ha scelto di mettere le sue radici in Giappone: questo è “Tokyo tutto l’anno”, una lettura piacevole e interessante.
Luisa Imai Messina è una giovane romana che, in seguito ad un primo viaggio, regalo post-lauream, nel magico Paese del Sol Levante, decide di restare ancora un po' e, complici prima gli studi di lingua giapponese e poi anche l’amore per Ryosuke, rimarrà soggiogata completamente dalla grande megalopoli orientale. Con la sua simpatica famigliola, il marito Ryosuke e i loro bambini Sosuke ed Emilio, la Messina ci prende per mano e ci mostra i principali luoghi di attrazione di Tokyo, come in una lunga ed affascinante gita in una qualsiasi domenica. Non ci si sente soli in questo viaggio. La scrittrice è una presenza viva, la sua voce è fresca, ricca di immagini, simpatica e riflessiva. Ora ti confida un ricordo che la lega ad un certo luogo, ora si interrompe per farti partecipe dei capricci di uno dei bambini, ora ti mostra una delle tante gothic Lolita che si incontrano nella città, un po' tenere bambine un po' giovani dark ladies.
Il libro è organizzato per mese, da gennaio a dicembre e riporta le principali festività del calendario lunare dell’antico Giappone con i rispettivi ideogrammi e la traduzione. Immancabili le parole stagionali, i kigo, un concentrato simbolico e una descrizione immediata di una stagione in cui si festeggia o si ricorda qualche evento importante. E così gennaio è il mese dedicato agli affetti, alla famiglia, febbraio è il mese “del vestirsi a strati”, marzo quella della crescita e dei primi fiori, e così via.
Le ricorrenze e le usanze sono veramente tante! Tokyo è di una complessità e di una ricchezza quasi uniche al mondo, talvolta è paradossale. Si trovano negli stessi interstizi luce ed ombra, la natura e la tecnologia, il passato e il presente, il vecchio ed il nuovo, il dentro e il fuori, lo yin e lo yang.
La natura è presenza fissa nella lingua e nella cultura di questo magico Paese. Come aveva scritto Cees Nooteboom nel suo libro che ho letto da poco : “Per i giapponesi la natura è animata, in senso letterale. Negli alberi, nei ruscelli, nelle colline vivono dei, spiriti, anime. Questo popolo ha un rapporto mistico con la natura, in nessun altro luogo è così evidente cime nei giardini zen”.
In effetti nei racconti, nelle illustrazioni su carta di riso, tornano questi spiriti, anche quelli degli antenati cui ogni casa dedica un piccolo altare, che vengono periodicamente ricordati col passare delle stagioni. Certamente il Nooteboom non è riuscito nei suoi innumerevoli viaggi a comprendere in fondo la realtà giapponese moderna, tornando ogni volta un po' deluso. Invece la Messina guarda alla città con occhi diversi, è innamorata del Giappone, è felice, è entusiasta di questa cultura così complessa e così estranea alla nostra.
È affascinata dalla creatività, dalla fantasia che divengono arte anche nell’impacchettare i regali, quasi in ogni attività, dalla cucina al giardinaggio, con la carta, con i fiori, con il cibo e trascina anche chi legge le sue pagine.
La cucina tradizionale è di una ricchezza notevole che richiede molta creatività e pazienza. Con in mano il cellulare ho cercato nel web le principali pietanze e sono rimasta colpita dalla delicatezza del colore di certi dolcetti che si preparano durante la festa delle bambine (Hina-matsuri), evento strettamente legato alla fioritura degli alberi di pesco. Non solo, ma anche tutte le pietanze di riso, di pesce, hanno in sé una spettacolarizzazione della creatività davvero unica e un richiamo alla ciclicità della natura.
“La natura ha tante parole e il giapponese dà il meglio di sé nella sua descrizione; pare espandersi all’infinito, quasi allungando al limite le braccia per accoglierla tutta: questa lingua punta sull’unica cosa destinata a restare”.
Io non ho mai visto luogo più bello del sakura-dori, il viale dei ciliegi: un tunnel rosa e bianco, di struggente bellezza. I fiori di ciliegio, quelli di deutzia, i crisantemi e tutti gli splendidi fiori che rendono questo posto esotico così magico insegnano che la bellezza è nella fragilità, nel passeggero e nelle cose destinate a terminare.
Bella la copertina rigida, con la sovracopertina illustrata da Igort, lo stesso artista che impreziosisce alcune pagine all’interno del libro. Un libro da regalare e da regalarsi.
Indicazioni utili
Tra Mitteleuropa e Sudamerica
Un operaio sloveno, o meglio austro-slavo, un sedicente re francese e infine una suora che potrebbe essere scambiata per un pinguino, sono i protagonisti strampalati delle tre brevi biografie che costituiscono la materia narrativa di questo originale scritto. La penna di Claudio Magris, colta e avvincente al tempo stesso, amplifica la curiosità del lettore che può cogliere le singole suggestioni derivanti dalla conoscenza di “tre vite vere e improbabili”, come approfittare della succulenta occasione per scoprire una vasta letteratura di nicchia che, non relegata affatto alla dimensione della narrazione avventuriera tipica della letteratura da viaggio, tocca i grandi nomi di Borges, Campana, Pascoli, Conan Doyle, Verne, Poe, Lovecraft, virando però, sapientemente verso i capolavori della letteratura guachesca come il poema nazionale argentino “Martin Fierro” di Josè Hernandez o ancora verso un romanzo dello scrittore polacco Andrzej Kusniewicz, “Il re delle due Sicilie”. Suggestioni, rimembranze, sodalizio da gente che vive in terre di confine, anche al limite del nulla, sembrano costituire la via aperta da Magris per scalare non una vetta ma l’invalicabile, la metafora del limite della conoscenza e la sfida, come contemplata nel canto di Ulisse, il XXVI dell’Inferno dantesco, all’ignoto, rappresentato in questo caso dall’estremo sud del mondo. I luoghi sono quelli compresi tra Patagonia e Auracania, i tempi racchiudono anni che abbracciano l’Ottocento e la prima metà del Novecento, un tempo sufficiente a far registrare il progressivo sterminio delle popolazioni indigene della Terra del Fuoco ma anche della Patagonia. Le storie, invece, sono quelle incredibili di tre persone che hanno sposato la causa araucana e quella patagone in nome della libertà e del rispetto delle genti contribuendo a mantenere viva, con la loro opera e i loro scritti, la memoria di popoli che non esistono più. Consigliatissimo.
Indicazioni utili
Chatwin
Sepulveda
Dante
Poe
e a chi vuole scoprire Daniele del Giudice
Famiglia genetica, legale, economica, filosofica,
“Costanza decise di tuffarsi. Come aveva fatto con la proposta di Henry. Avrebbe cavalcato l’onda fin dove l’onda l’avrebbe portata prima di infrangersi, o prima che lei stessa finisse contro uno scoglio.”
Dopo “I formidabili Frank” è ancora una volta la famiglia il fulcro della narrazione del nuovo libro di Michael Frank. Stavolta non siamo di fronte ad un memoir ma ad un classico romanzo.
Tutto inizia in Italia, a Firenze, dove Costanza, una donna di circa quarant’anni che fa la traduttrice, incontra Henry e suo figlio Andrew in una piccola pensione dove tutti e tre stanno trascorrendo un periodo di vacanza. Costanza ha per metà origini italiane, sua madre è ligure, mentre il padre, morto quando lei era adolescente, era statunitense. Sia Costanza che Henry ed Andrew vivono a New York, ma è nella pensioncina di Firenze che scatta l’inaspettata ed intensa attrazione fra i tre. Prima si conoscono Costanza ed Andrew. Lui è un ragazzo che deve frequentare l’ultimo anno delle superiori, è introverso e tormentato. Si è appena lasciato dalla sua ragazza, non ha un buon rapporto con il padre che considera troppo egocentrico e narcisista e dal quale non si sente amato fino in fondo. Poco dopo si conoscono anche Costanza e il padre di Andrew, Henry. Lui è un famoso medico specializzato nella fecondazione assistita, sicuro di sé, volitivo ed intraprendente in apparenza, in realtà ancora sofferente ed insoddisfatto dopo la separazione dalla moglie avvenuta ormai sei anni prima. Anche Costanza è un personaggio particolare, una donna molto bella ma non più giovane, è rimasta vedova da circa un anno di un famoso scrittore di cui stanno per essere pubblicati i diari postumi. Costanza ed Andrew diventano amici, anche se uno dei due è coinvolto sentimentalmente. Poco dopo Henry e Costanza iniziano una relazione molto intensa e promettente. Entrambi hanno un fortissimo desiderio di superare le loro solitudini e ritrovare la felicità che solo l’amore condiviso può offrire. Così, quando pochi mesi dopo si rivedono a New York, decidono immediatamente di andare a vivere insieme. Costanza vorrebbe avere un figlio e stranamente Henry subito la appoggia e anzi, quasi la spinge a perseguire questo obiettivo, nonostante si conoscano da pochissimo tempo. Quali motivazioni spingono veramente Henry a comportarsi così? Perché è quasi più ossessionato di Costanza nella ricerca di quel futuro figlio? Forse soltanto a causa della sua professione? Oppure c’è qualcosa che viene tenuto nascosto?
Michael Frank scrive un romanzo apparentemente molto lineare e leggero, in realtà abbastanza sofisticato e complesso. I temi trattati, la famiglia, la genitorialità intesa come fatto biologico, sociale o culturale, le relazioni fra le persone, che si portano dietro quasi sempre degli spazi misteriosi, sicuramente sono stati trattati e dibattuti in molti luoghi culturali diversi e vari. Tuttavia questo romanzo ha il pregio di riproporli con originalità e freschezza. In particolare, sono i personaggi ad essere tratteggiati in modo inedito perché, pur non suscitando grande simpatia e di conseguenza nemmeno molta empatia nel lettore (eccetto il tormentato, giovane e puro Andrew), riescono lo stesso a catturare l’attenzione e a suscitare l’interesse verso la storia narrata, anche e malgrado, la loro antipatia, la loro insincerità, la loro codardia.
Un buon romanzo, in grado di portare il lettore in luoghi conosciuti ma anche inaspettati.
Indicazioni utili
James o Maurensig?
Riguardo a questo racconto occorre fare un'importante premessa, emersa nel mio caso durante la lettura dell'introduzione: "Pimpernel” era in origine una novella di Henry James, ritrovata per caso da Paolo Maurensig il quale, giustamente, ha colto l'occasione per ricomporne le parti perdute e offrirle ai lettori. Quel che è strano è che questa cosa non sia tanto evidente né sbandierata da Einaudi perché, non me ne voglia Maurensig, ma il nome di Henry James e di un suo racconto ritrovato tirano molto di più, per quanto mi riguarda. Che il racconto fosse talmente rovinato - e dunque, pesantemente rimaneggiato - da non potergli assegnare il nome dell'autore statunitense? Molto probabile, ma l'occasione di specificarne l'origine era troppo ghiotta per non poter esser colta. Durante la lettura mi sono chiesto costantemente se stessi leggendo James o Maurensig, e ho trovato pace solo quando ho deciso che non aveva importanza e mi sono concentrato sul racconto in sé.
"Pimpernel” è un bel racconto, che si legge velocemente e con piacere. Si sente molto l'impronta ottocentesca, per fortuna, considerato che l'autore si prende spesso il tempo per fare discettazioni e riflessioni che possono coinvolgere il lettore, in questo caso perlopiù incentrate sulla Bellezza e sull'arte. Alcuni tratti sono piuttosto interessanti e vi spingeranno a soffermarvi un attimo per capire e anche per fare le dovute considerazioni.
“Pimpernel” ruota intorno a una storia d'amore (come suggerisce il sottotitolo), quasi un colpo di fulmine tra un giovane scrittore americano (probabilmente alter ego di Henry James) e una giovane donna, il tutto nella splendida cornice che è Venezia. Agli autori piace vincere facile. La ragazza, di nome Annelien, è un personaggio interessante: certo non la classica figura femminile poco sfaccettata che era molto diffusa nei romanzi di un paio di secoli fa. Questo dà un pò di spessore a una storia d'amore che in fondo non ha nulla di diverso da tante altre, almeno fino a quando il segreto di lei non viene fuori dando al tutto una sfumatura diversa e creando un collegamento anche con la vita privata di Henry James.
Alcune cose e situazioni presentateci nel racconto non hanno, a mio parere, un'evoluzione soddisfacente (ad esempio la storia con lo spretato Damiani, un po’ troncata) e molte cose che potevano essere approfondite restano invece col proprio potenziale inespresso. Un tema che mi è dispiaciuto non vedere approfondito, ad esempio, è quello del conflitto generato nello scrittore quando gli si pone davanti la scelta tra denaro e gloria, tra agiatezza e la necessità dello scrittore "vero" di trasmettere un messaggio, di lasciare un segno.
Nonostante tutto, “Pimpernel "è una lettura piacevole e che consiglio, soprattutto agli esperti di James, cosi che possano capire quanto di lui c'è in questa storia.
“L’umana bellezza rispetto alla bellezza dell’arte era transitoria, mutevole, fallace. Bastava che sul bel nasino di una donna spuntasse un foruncolo perché la sua bellezza ne venisse compromessa. Che dire, poi, dell’inevitabile invecchiamento?”
Indicazioni utili
Una lettura leggera
Probabilmente perfetta per una lettura estiva, questa raccolta di racconti di Georges Simenon esce per Adelphi a estate ormai finita. A parte il racconto che dà il titolo alla raccolta, le storie che vi sono contenute sono brevi: non vanno infatti mai oltre le venti pagine. Non c’è mai moltissimo da dire per quanto riguarda i racconti: a meno che non si parli di raccolte che hanno un evidente filo conduttore o se a scriverli sono mostri sacri del racconto breve come Borges o Bradbury.
Le storie contenute in “Annette e la signora bionda” non hanno evidenti punti in comune, solo qualcosa che si può cogliere qua e là ma non si può considerare un tema condiviso. Oltre questo, non si può dire che siano racconti con importanti pretese letterarie, ma solo un modo per passare qualche piacevole ora di lettura. Un tema che secondo me è emerso (ma sempre in maniera superficiale) è quello del rapporto uomo-donna, anche se trattato dal punto di vista di un uomo che ha vissuto in un epoca non molto lontana ma comunque diversa dalla nostra. Quel che emerge più marcatamente sono proprio le differenze di genere più radicate, e devo dire che in un tempo come il nostro in cui si cerca disperatamente di annullarle (cosa giustissima riguardo ai diritti, più discutibile quando si vogliono negare le peculiarità che ci rendono diversi, non migliori o peggiori) è stato interessante riscontrarle e fare un paragone coi nostri giorni.
Paradossalmente, credo che il racconto più scialbo sia proprio quello che dà il titolo alla raccolta: certo, è possibile che il mio giudizio negativo sia dovuto all’avversione spropositata che ho per i personaggi femminili sciocchi e superficiali, quale è la nostra Annette (che tuttavia ha dalla sua la giovanissima età), ma devo dire che è quello che mi ha colpito meno. Mi sono piaciuti molto di più “La strada dei tre pulcini” e “La moglie del pilota”, che sono quelli che possono dare qualche spunto in più. Oltre questo, non c’è molto altro di cui si possa discutere e credo che la vera discriminante che debba convincere un lettore è in primis il suo gradimento nei confronti di Simenon. Se ci si sta approcciando la prima volta a questo autore, potrebbe tuttavia non essere il libro migliore con cui cominciare, perché credo che non vengano fuori le sue qualità migliori e si potrebbe finire per considerarlo un autore di non così grande livello: certo, non parliamo di Doyle né tantomeno di Dostoevskij, ma se le sue opere continuano a essere pubblicate a oltre tre decenni dalla sua morte, un motivo ci sarà. Nonostante questo, essendo lo stile molto fluido e intrigante, potrebbe essere preso in considerazione se si vuole conoscere l’autore “senza impegno”, con qualcosa di più leggero.
Riassumendo: se vi piace Simenon o avete voglia di qualcosa di leggero leggetelo; se volete leggere un libro più impegnativo e profondo o cercate un approccio all’autore che sia più indicativo, virate su altro.
 Opinione inserita da ornella donna 07 Settembre, 2020
Opinione inserita da ornella donna 07 Settembre, 2020
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il mondo cinese e la cultura del tè
Lisa See, americana, è di origini cinesi, e ha raggiunto il successo letterario con Fiore di neve e il ventaglio segreto, a cui ha fatto seguito In una rete di fiori di loto, La ragazza di giada, La ragazza di Shangai, Le perle del drago verde e Come i fiori di notte. Ora torna in libreria con Come foglie di tè, un poderoso libro in cui viene messo in particolare evidenza tutto l’amore dell’autrice per il mondo cinese. Ma non solo: si fa risaltare anche la perfetta conoscenza di questa realtà, espressa anche nei piccoli particolari che pochi conoscono. Un testo che:
“ispirerà alla riflessione, discussione e desiderio travolgente di bere un raro tè cinese.”
Narra la vicenda di Li-yan che con la sua famiglia vive in un remoto villaggio alla periferia. La sua famiglia appartiene alla popolazione denominata Ahha e sopravvive solo grazie alla coltivazione e alla raccolta del tè. I ritmi di vita sono proprio soggetti a questo, e si svolgono in funzione di essa. Sono molto poveri, e soprattutto alle donne non è concessa alcuna istruzione. Ma fa eccezione Li-yan, che impara a leggere e a scrivere, con grande stupore dei consanguinei. Tutto si ribalta quando irrompe nel villaggio la civiltà: arriva uno sconosciuto a bordo di una Jeep e lei se ne innamora follemente. Rimane incinta. Ma la sua famiglia non accetta la creatura, che verrà abbandonata in un orfanotrofio avvolta in una coperta che nasconde una tea cake. Quella bambina, adottata da una famiglia benestante californiana, una volta cresciuta vorrà, però, avere delle spiegazioni circa la sua origine. Che accadrà? Incontrerà la madre? Come si porrà nei confronti della famiglia d’origine?
Un libro interessante, dove due sono gli elementi chiave: l’amore e la minuziosa conoscenza della realtà cinese in quanto tale, e la coltivazione e la raccolta del tè. Quest’ultima ha un ruolo veramente preponderante. Al tè sono legati usi e costumi della società. A lui si riconosce una importanza totale, per cui:
“Ogni storia, ogni sogno, ogni minuto della nostra vita pullula di coincidenze fatidiche che si susseguono. Persone e animali e foglie e fuoco e pioggia: turbiniamo gli uni intorno agli altri, come chicchi di riso che vengono lanciati in cielo a manciate.”
La vita del villaggio è semplice, sempre in precario equilibrio. Infatti:
“Comunque sia la nostra casa, come tutte le strutture del villaggio, è stata costruita per essere temporanea. (…) La nostra casa è costruita su palafitte di bambù, così da assicurare una area protetta.”
Fa da contrasto, reso con molta vividezza, il mondo occidentale americano, di cui la figlia abbandonata è simbolo e insieme superamento dell’arretratezza. Quale dei due mondi avrà la meglio?
Una lettura che mi ha stupito per la comunicazione e il ritratto di un mondo che non conoscevo. Di cui però ho fatto fatica a procedere nella lettura, un po’ per l’eccessiva prolissità, un po’ per i nomi dei personaggi. Nel complesso si rivela una lettura curiosa ed interessante per chi voglia affrontare temi differenti e lontani dalla nostra cultura. Un po’ troppo prolissa e descrittiva, per cui alla fine si tende a perdere il filo del discorso. Forse da affrontare a piccole dosi, sorseggiando una tazza di tè fumante ed odoroso….
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La scelta responsabile
Questo è un testo potente, che parla di un potere, quello talora più grave da gestire tra le facoltà umane, sebbene sia il più straordinario, e perlopiù meraviglioso, eccelso ed eminente insieme: la virtù di essere origine, radice, madre.
E perciò, inderogabilmente, trattasi di una prerogativa di donna.
Cosa significa concedere la vita? Quando e dove si inizia a divenire madre?
Questo il tema de “Il dono di Antonia”, un bel libro, l’ultimo in libreria, di Alessandra Sarchi.
Un libro difficile, in verità, per l’argomento trattato, a prima vista presenta anche una certa resistenza alla lettura, malgrado sia ben scritto, con stile elegante e prosa ricercata, mostra una sorta di pudore, una qualche ritrosia a estrinsecare tutto il suo potenziale, che è notevole, credo a causa di una certa delicatezza, più che riserbo oserei dire tenerezza, con la quale l’autrice affronta di straforo un tema attuale come la maternità suffragata.
Forse solo in questo è il suo unico neo, che ne frena forse la scorrevolezza.
In realtà il suo è un discorso più ampio, sussurrato più che esclamato, espresso con timidezza e finezza insieme, una garbata conversazione su cosa significa davvero divenire madre, come lo sente in sé questo sentimento una donna conscia e consapevole che ogni mese, per un periodo della sua vita, è depositaria della possibilità di effettuare un dono, o più spesso un rifiuto, di cui sottilmente e inconsciamente prova sempre una lieve frustrazione.
Antonia è una donna, una moglie, una madre, gestisce una piccola azienda agricola con caseificio annesso sulle colline intorno a Bologna.
Vive una vita come tante, apparentemente tranquilla, serena, forse anche monotona, le sue giornate trascorrono secondo orari dettati dai ritmi naturali, scanditi dai tempi della mungitura, del governo degli animali da latte, della produzione di ricotta e formaggi, della cura della casa e dell’orto.
Come tanti, nelle pause dal lavoro cerca nello sport e nell’attività fisica fine a sé stessa, supporto e conforto allo stress quotidiano dell’esistenza, inanellando vasche su vasche nella piscina annessa all’azienda.
Per benefica produzione di endorfine, certo, e catarsi in una parvenza di protettivo liquido amniotico.
Uno stress quotidiano il suo, in verità, un po' più accentuato che in altre famiglie: l’unica figlia, la diciottenne Anna, infatti, soffre di un disturbo alimentare insolito per le passate generazioni ma purtroppo in auge oggi nei tempi moderni, è anoressica.
L’esistenza della famiglia si regge quindi per il tramite di un filo assai fragile che lega le esistenze dei membri della famiglia, padre, madre e giovane impiegato, ruotano tutti intorno al problema evidente, mai negato e però nemmeno conclamato apertamente.
Tutti sono alla ricerca di un continuo equilibrio, in una atmosfera instabile, da un lato le blande e caute strategie dei familiari, la mamma Antonia in particolare, volte a convincere in qualche modo più spesso maldestro la giovane ad alimentarsi, ad introdurre un numero maggiore di calorie nella dieta quotidiana, dall’altro il sottrarsi della ragazza a quelle che considera pressioni ed intrusioni sgradite nella propria sfera di scelta e di azione.
Il tutto attraverso un gioco di finzioni, un senza parere, un gioco di convenzioni, di compromessi, di trattative, perché le insistenze, seppure dettate a fin di bene, non diventino ossessioni nefaste, o ritornelli e sproni compulsivi, e non diano la stura ad autentiche crisi isteriche di panico, così come caldamente raccomandato di evitare dai professionisti sanitari, e dai gruppi di supporto e di aiuto, costituito come tipico in certe patologie, dai familiari dei pazienti, tutte ragazze, afflitte da tale disturbo.
Una simile evenienza, il fatto stesso che tale disturbo sia a sola diffusione femminile, conduce inevitabilmente ad orientare lo spot sulla madre, sul rapporto madre- figlia, dai più ritenuto origine dello squilibrio emozionale che si estrinseca nel rifiuto di nutrirsi.
La protagonista del romanzo quindi è giocoforza sospinta a ridiscutere e a riconsiderare il suo ruolo di madre, e questo naturalmente la porta anche a ricordare gli eventi della sua vita trascorsa.
Perché è inevitabile: ognuno di noi è la conseguenza di quello che è stato, degli eventi che ha vissuto, delle scelte compiute o subite, e quello che è stato prepara il presente, e questo a sua volta è l’input del futuro.
Antonia ricorda quindi, o meglio è costretta a rinvangare quello che considera, o si è convinta a considerare, un errore di gioventù, il frutto di una leggerezza, una mossa tanto superficiale quanto istintiva e frettolosa, compiuta in assoluta buona fede e nobiltà d’intento in un’età quando ancora necessariamente difettano maturità e capacità di scelta giudiziosa.
Un evento di cui nessuno, se non il marito, è al corrente, una circostanza che in qualche modo ha forse lasciato memoria genetica in lei, e lo ha trascritto malignamente nei geni della figlia
In tal modo condizionandone il rifiuto ad assimilare energia vitale, quasi la ragazza intendesse punire come una nemesi storica-genetica Antonia, che le è madre ed è l’origine del suo primo cibo, la poppata da lattante, ripudiandolo e rifiutando ogni altra forma di alimento offerto.
Antonia infatti, ancora ragazzina, ventisei anni anni prima, fresca di studi universitari, aveva usufruito di una borsa di studi universitaria, trascorrendo un anno in California.
Era stata la sua una scelta accademica ricercata e voluta, sentiva il bisogno di evadere, di continuare gli studi il più lontano possibile da casa sua e specialmente dalla propria madre, con la quale aveva un rapporto di timore e disagio, di staccarsi dai luoghi natali, quasi intendesse sradicarsi e cancellare il ricordo di sé.
La giovane aveva provocato involontariamente una delusione cocente, lei unica figlia, all’autorità manifestatamente unanime della sua famiglia, la mater familias.
Una madre costei ben diversa di carattere dalla dolce e timida Antonia, una donna d’altri tempi, potere unico e assoluto, dotata di carisma e autorità congenita data la sua difficile, e ammirevole in verità, storia di emancipazione sociale.
Antonia era stata una tremenda delusione per sua madre, ne era stato motivo di umiliazione e forse sottile derisione di quanti la detestavano. Le aspettative della madre, e dei familiari, tutti infermieri e tutti occupati nelle professioni sanitarie, furono vanificate dalla scelta di Antonia di dedicarsi ad altro negli studi e nella professione, a causa di una sua innata e sconcertante repulsione per tutto quanto consono al sangue e alla medicina, addirittura perdendo incredibilmente i sensi in caso di prelievo di sangue, e ovvio conseguente rifiuto di divenire donatrice di sangue, come invece ruolo consolidato in tutti i familiari, da ferrea tradizione di famiglia instaurata appunto dalla madre.
A Los Angeles Antonia, semplice e ingenua, mal si adatta allo stile di vita e alle incongruenze anche atroci dell’opulenta, e assurdamente contraddittoria, società americana.
Di giorno vede gli americani bene riempire a dismisura i grandi carrelli dei supermercati di ogni sorta di cibo e di ben di Dio, la maggior parte del quale finirà sprecato; e di notte, gli stessi carrelli sono sospinti di nascosto, e con vergogna, carichi di povere cose, dagli homeless sbucati dal nulla in cui si nascondono nelle ore di luce e che con il buio gironzolano in giro in cerca di avanzi alimentari nei bidoni della spazzatura.
Questi sconvenienti controsensi turbano la giovane, la portano a insicurezze ed errori di vita che sfociano in un rapporto superficiale con un uomo più grande, e più immaturo di lei, che si conclude con un tragico, e doloroso, aborto spontaneo.
Salva il suo equilibrio e la sua sanità mentale, restituendole una parvenza di serenità, la sua amicizia, intensa e disinteressata, con Myrtha, una donna di poco più grande di lei, sposata e di famiglia agiata, con cui condivide la passione per il nuoto, e che le insegna come a lei, e a lei sola, spetta il compito di scegliere come essere felice, nessun altro al mondo può sostituirla in questa scelta responsabile, meno che mai la propria madre.
Per questo Antonia, grata all’amica del cuore, poiché questa per qualche motivo è sterile e desidera fortemente avere un figlio, le propone prima spontaneamente e poi la costringe ad accettare il suo dono, un pegno d’amicizia e di amore, il più grande, una maternità surrogata, le dona d’impulso, e con gioia, anche con un pizzico di incoscienza giovanile, un proprio ovocita, per cui tramite la fecondazione eterologa, l’amica possa esaudire il proprio desiderio di maternità.
La gravidanza procede, e Antonia capisce, con dolorosa coscienza, che non può più restare vicino all’amica: il suo dono non è come una donazione di sangue, non è un colmare una carenza momentanea di sostanza, è un creare ex novo, è un dono che non può essere donato, è una scelta responsabile ed irresponsabile insieme, magari giusta ma a cui non è preparata.
Pertanto, parte, anzi fugge, torna in Italia decisa a lasciarsi indietro tutta questa esperienza, e soprattutto la gelosia nel vedere una vita, che è anche sua, crescere in un’altra madre.
Sa che i figli appartengono a chi li cresce, li nutre, li cura, li segue, certo; ma appartengono.
Per essere, sono di chi li ha messi al mondo. Di più, di chi li ha creati. L’input primordiale.
Perciò torna in Italia, si rifà un’esistenza, provando a relegare nell’oblio una parte di sé.
Ed ecco, quell’ovocita non è più un gamete, è un giovane di nome Jessie, per una serie di circostanze ha saputo di sua madre biologica, e viene a cercarla perché…perché:
“Ogni culla chiede: da dove?”
Conoscere il passato per comprendere il presente e preparare il futuro, è una grande lezione di Storia. Anche della Storia degli umani.
Ognuno di noi necessita di sapere da dove viene, chi è, come è diventato quello che è, è scritto nel nostro patrimonio genetico, che ha un numero pari di cromosomi, perché ciascuna metà viene da un genere diverso, e combinandosi forma un tutt’altro che è sé e viene anche da due.
Conoscere i due, per avere coscienza di sé, è istintivo nella razza umana.
La concretezza di Jessie che la viene a cercare a Bologna è salvifica per Antonia e, come pare assai probabile, per la giovane Anna, la sorella almeno in parte di Jessie.
Poiché ambedue le donne sembrano recuperare qualcosa, riempiono una carenza che si era instaurata tra loro e che Anna manteneva volutamente vuota, evitando di riempirla di cibo, comprendendo che solo un certo tipo di Amore aveva il diritto di colmare tanta lacuna.
Amore fatto di chiarezza, apertura, sincerità e senza alcun timore di essere giudicati.
Perché i figli possono essere giudici severi, ma quasi mai sono attendibili, e nemmeno i genitori.
Bisogna saper affrontare le scelte, comprendendole e accettandole senza condizioni, nell’uno e nell’altro senso.
Antonia sia con Jessie che con Anna, ha fatto quello che poteva e sapeva fare in quel momento, del suo meglio, non altro. Perché una donna nell’arco della sua vita produce parecchie uova, e tutti le spiegano presto tutto al proposito, come fecondarle e come evitare la gravidanza.
Ma fare la madre, non te lo insegna nessuno, mai. Meno che mai la propria madre.
Ogni donna lo apprende da sé, è una scelta responsabile.
La sola che permette per esempio ad Antonia di ritrovare sé stessa, e la parte di sé che credeva persa.
Questo il senso del dono della maternità, il più grande dei doni, che neanche i tre Magi.
Indicazioni utili
“Mise en abyme”
"«Io credo soltanto che leggere aiuti le persone a sentirsi migliori di quello che sono.»
«O anche peggiori.»"
Torna in libreria Fabio Stassi con un nuovo lavoro che vede, ancora una volta, protagonista il biblioterapeuta Vince Corso. Torna la Roma multietnica e sofferente, che si muove intorno a via Merulana, con le sue stoffe variopinte, il suo odore di friggitorie e spezie orientali e la rassegnata indolenza di un gioco di dadi. Torna la musica francese, sottofondo roco e malinconico di tante storie. E tornano soprattutto loro, i veri protagonisti, i libri, riaccendendo la riflessione sul complesso rapporto tra vita e letteratura.
Vince, per professione, consiglia libri per curare i malanni dell’esistenza, e a loro ha affidato il ruolo di unica famiglia, presenza costante nella sua vita piena di solitudini, abbandoni e interruzioni. Ma è davvero così, il sentiero tracciato dalle parole scritte è sempre un cammino che conduce al bene, che sia consolazione se non salvezza? Oppure le parole possono anche tradire e trascinare involontariamente in un pozzo nero, un abisso in cui realtà ed immaginazione si mescolano senza senso e coerenza?
“Non so se il mondo esista per davvero, ma bisogna fare attenzione a quello che si immagina. Forse siamo solo il sogno di qualcun altro”.
Sulla scia di questa domanda, il romanzo prende dunque le sembianze di un sogno. Un enigma di tensione in cui efferati omicidi si impastano a rimandi letterari. Un labirinto di simboli e citazioni, di inseguimenti e smarrimenti. Persino i capitoli si susseguono dalla Z alla A, confondendo anche la direzione del tempo.
Con la sua voce elegante e cristallina, Fabio Stassi dà così vita non certo a un giallo canonico, bensì a un gioco di specchi, in cui realtà e finzione si guardano e si interrogano, in un ribaltamento ai limiti dell’assurdo, sulle proprie ombre e le proprie possibilità. La letteratura offre la lente attraverso cui guardare e capire il mondo e la vita, oppure un labirinto di storie e anfratti ove nascondersi, per perdersi senza ritrovarsi? I temi innescati appaiono forse fin troppo ambiziosi per svilupparsi con chiarezza nei confini di questa storia e l’architettura forse fin troppo cerebrale per toccare davvero le corde del cuore, ciò nonostante non si può che rimanere piacevolmente affascinati dalla ricchezza di spunti letterari, cultura e intriganti interrogativi che queste pagine sanno offrire.
Indicazioni utili
La sottile linea dura
Si conferma presso Adelphi sin dal 1985, anno in cui ha avuto inizio la pubblicazione dei romanzi duri di Simenon, l’attenzione per il belga. Non c’è da stupirsi di fronte al numero 78, tanti sono i titoli, compreso questo, in catalogo.
Leggo sempre volentieri Simenon, anche quando la trama, come succede per questo romanzo, langue, non è sviluppata e pare essere monca e priva di quel tempo necessario per la costruzione del corpo testuale. Tempo che il belga, stando alle sue “Memorie intime”ha sempre utilizzato in modo molto pragmatico, dedicando in maniera meticolosa solo le prime ore della giornata alla scrittura e dedicando tutte le altre alla dimensione più vitale dell’esistenza: la famiglia, gli amici, il mare, i viaggi e le sue innumerevoli passioni. Il mare, appunto, è una di queste e viene richiamato prepotentemente dalla sua memoria emotiva anche nel freddo e innevato Tirolo durante una vacanza, tanto da fargli sentire l’esigenza di rinchiudersi in camera accanto a una stufa di maiolica per far compiere un balzo all’odore salmastro della costa normanna in modo così repentino e prepotente da far evaporare il pur intenso e cristallino sentore dei pini.
E allora, con l’arrivo di una nave in porto l’atmosfera diventa di colpo brumosa, pesante e asfittica: tutto langue, solo l’arrivo del peschereccio Centaure, in un mare grosso che non promette niente di buono, rianima il paese, un piccolo borgo marinaro, poca gente la cui esistenza è scandita dal mare e da esso ne viene segnata. Qui vivono i due gemelli Canut, Pierre e Charles, e proprio l’arresto del primo, capitano del peschereccio, allo sbarco in quella brumosa mattina, dà il via all’azione: è accusato dell’omicidio di uno dei superstiti del Telemaque, imbarcazione che trent’anni prima affondò lasciando alla deriva su un canotto pochi uomini che, ripescati dopo una ventina di giorni, raccontarono come fecero a sopravvivere, in barca con loro il cadavere del giovane papà dei Canut, la cui morte è sempre stata ricondotta all’ombra nera dell’antropofagia. Ora anche l’ultimo dei superstiti è morto e la colpa ricade, per via indiziaria, su Pierre. A Charles, il compito di scagionare il fratello mentre langue in prigione.
Come si intuisce gli elementi ci sono tutti per destare la giusta attenzione del lettore che, grazie alle magistrali pennellate da atmosfera, si trova gradevolmente immerso in un’ottima lettura, salvo appurare poi che l’ingranaggio del giallo prende il sopravvento sull’approfondimento psicologico e che la sottile linea dura fatica stavolta a insinuarsi se non, debolmente, nelle ultime trenta pagine quando l‘ambivalenza umana fa capolino e i rapporti interpersonali paiono sgretolarsi in un amaro ritratto di famiglia, appena accennato.
Indicazioni utili
Melchor Marín
«Che ti ho detto?»
«Che nella Terra Alta non succede mai niente.»
Il suo nome è Melchor Marín e da quattro anni vive a Terra Alta, in Catalogna, dove svolge le funzioni di poliziotto. Originario di Barcellona dove è nato e cresciuto in uno dei tanti borghi periferici di dubbia liceità, il quasi trentenne, è stato trasferito da questa a seguito di una serie di fatti che lo hanno coinvolto da vicino e che avrebbero potuto riportare alla luce alcuni episodi della sua adolescenza e prima età adulta che era invece bene continuare a tenere sopiti. Figlio di Rosario, una prostituta in giovinezza bellissima, la sua vita ha perso la retta via intorno ai quattordici anni e anche se dopo è tornata sui giusti binari, quel che è accaduto continua a marcarlo e a influenzarne le sorti. Negli ultimi anni, però, la sua esistenza è mutata grazie al matrimonio con Olga, la bibliotecaria del paese, e grazie alla nascita della piccola, Cosette, in onore della figlia di Jean Valjean, protagonista de “I Miserabili”, il romanzo che ha aperto i suoi occhi in uno dei periodi più bui e che da allora lo ha reso un appassionato lettore e divoratore di pagine e storie. Deciso e intraprendente, l’uomo è adesso chiamato a dover risolvere un misterioso caso di omicidio; quello degli Adell, Rosa e Francisco, proprietari della Gràficas Adell, l’azienda più grande e potente del luogo espansa con due fabbriche anche in Spagna, una in Polonia, una in Romania, una in Messico e una in Argentina. Di fatto, i due deceduti, sono coloro che danno lavoro a praticamente tutta Terra Alta, seppur con salari bassissimi e altre opinabili condizioni lavorative. Vengono rinvenuti privi di vita a seguito, oltretutto, di una evidente sottoposizione a tortura. I loro corpi sono stati straziati da violenza e da ogni forma di sevizia. Ma chi può aver fatto ciò? Com’è possibile che sia stato anche disattivato l’allarme? E perché uccidere anche quella dipendente che stava semplicemente dormendo nella sua camera? Per eliminare ogni testimone o per altro motivo?
«Una terra di perdenti. Nessuno vuole bene a questa zona, è questa la verità, e la prova è che si ricordano di noi soltanto per bombardarci. Per cosa siamo conosciuti fuori da qui? Per la battaglia più feroce che si sia mai svolta in questo paese, una tempesta di fuoco degna di un castigo biblico, un’apocalisse che ha ucciso ragazzi di mezzo mondo. Quella battaglia, in cui naturalmente noi contavamo come il due di coppe, ha lasciato questa terra trasformata in una landa ancora più nera di quello che era, in un posto dove ottant’anni dopo può trovare rottami bellici nei campi, e se non ne trova molti di più è perché per anni noi stessi li abbiamo raccolti e venduti, per non morire di fame. È questa la Terra Alta.»
Con una penna rapida, fluida, meticolosa ed esaustiva, Javier Cercas torna in libreria con un titolo che è un giallo ma che è anche molto altro. Perché attraverso lo strumento della narrazione di un fatto di omicidio perpetrato nel peggiore e più brutale dei modi, egli invita il lettore a riflettere su molteplici tematiche e lo invita a rivivere fatti recentissimi – vedi attentati terroristici – e che sono già diventati parte della nostra storia contemporanea. E riesce in tutto questo con un protagonista che è un antieroe, un uomo che nella vita è caduto, ha errato ma che ha avuto anche la forza di rialzarsi e di porre rimedio ai propri sbagli. La figura di Melchor è infatti una figura completa a trecentosessanta grandi, è il portavoce perfetto per quello che è un mistero che arriva a interrogarsi sulla giustizia e sul naturale conflitto tra “giustizia formale” e “giustizia sostanziale”, principi che nel nostro ordinamento trovano più di un fondamento non soltanto in ambito processuale penale quanto anche costituzionale. L’autore, ancora, ci invita a meditare tra rispetto della legge e legittimità della vendetta ma ci invita anche a riflettere sul nostro più personale cammino. Perché come Marín è alla ricerca del suo posto nel mondo, come egli dovrà rischiare per mantenere quel che ha costruito e per proteggerlo, come anche noi, nel nostro quotidiano, siamo chiamati a fare altrettanto e spesso a cercare la nostra strada anche quando pensavamo di averla già trovata.
Forse un poco più debole nella seconda parte che conduce all’epilogo ma sicuramente un titolo esaustivo, godibilissimo, che si esaurisce in meno di due giorni e che conquista e tiene incollati alle sue pagine dall’inizio alla fine.
Indicazioni utili
Dissacrante, duro, spietato
Il suo nome è Frank, Frank Bill, ha sessant’anni ed è un giornalista ormai in pensione. Siamo a Schilling, Indiana, 32.000 abitanti nel corrente anno 2026 e Frank è dal medico in attesa di una quantistica del tempo che gli potrebbe restare approssimativamente a disposizione. Non ha più famiglia, l’uomo. Vanta all’attivo due ex mogli morte e due figli deceduti, tutti in circostanze molto particolari che non è dato opportuno anticipare. È consapevole di avere un male incurabile che lo sta divorando dall’interno e che ormai non c’è più ragione di perdersi dietro a cure o palliativi, adesso lui ha la lista ed è a quella che deve pensare.
«Per un po’ respirò a pieni polmoni e superò il momento di crisi. Ma qual era l’emozione che aveva cercato di sopprimere? Quella che il dottor Bowden avrebbe fatto fatica a capire? Era euforia. Perché Frank sapeva da mesi di avere il cancro.»
La sua è una lista composta da cinque nomi che rappresentano in parte il suo passato, in parte l’esito nefasto della sua esistenza. Originariamente erano soltanto due ma poi, dopo quel che era successo a Olivia, quei nomi sono aumentati e quella lista era diventata quello che uno psicologo avrebbe potuto definire una strategia di resilienza per incanalare la sensazione di impotenza e rabbia. Ma la verità è che quell’elenco non rappresenta soltanto questo. È molto di più. Ed è un qualcosa che, adesso che le ore i giorni anche per lui stanno per scadere, deve attuare quanto prima.
«Stava davvero per farlo? Frank, che non aveva mai fatto a botte in vita sua. Sì. Sì, stava per farlo. Voleva delle risposte. Voleva sentire quella vecchia cosa arrugginita e dimenticata: la verità.»
E così parte, Frank. Parte per quello che sarà il suo ultimo viaggio e il suo ultimo obiettivo nella vita. Certo, la realizzazione del progetto si presenta un po’ diversa da quella che aveva preventivato nella sua mente, si rivela essere forse uno strumento di minor successo di quanto auspicava ma certo ora non può sottrarsi a quanto compiuto e a quanto ancora da compiere.
«Dentro ognuna se ne trovano tante altre. La gente entra nella tua orbita, ne esce e poi ti torna in mente a Natale, quando stai pensando a chi spedire gli auguri o quando ti imbatti in una vecchia fotografia.»
È da questi brevi assunti che ha inizio “La lista degli stronzi”, ultimo lavoro a firma John Niven, che attraverso la storia di un uomo che ha perso tutto e che non ha più niente da perdere si interroga e interroga il lettore sul volto di un paese assunto a seguito di una serie di sconvolgimenti politici e sociali che ne hanno completamente ridisegnato i tratti. Affronta così i temi dell’uso legale delle armi e della loro vendita senza troppe formalità e regole, della violenza indiscriminata, della morte efferata, della droga, dell’aborto e le conseguenze del suo poter essere vietato, dell’abuso di “legittima difesa”, della giustizia, degli abusi sessuali su minori, della pedopornografia, della Corte Suprema Americana e dell’ideologia repubblicana, della pena di morte e degli effetti di un suo ulteriore inasprimento sui condannati e su chi condanna senza pensare di potersi un giorno trovare nella veste di innocente al posto di chi ha appena giudicato, del qualunquismo, del razzismo, della politica, della sanità, della discriminazione, dell’omicidio nelle sue più variegate vesti e ragioni, degli effetti del governo Trump e chi più ne ha più ne metta.
Il risultato di questo scritto, che certamente estremizza – ma poi nemmeno più di tanto – i connotati della realtà circostante, è la fotografia di uno Stato e di un mondo che si contraddice, che è un paradosso, che ha piegato la propria schiena, che ha perso la propria identità, che ha dimenticato i propri valori, che si è lasciato andare al peggio di se stesso.
Niven ne ha per tutti e non ne risparmia per nessuno. Un titolo diverso dai precedenti lavori, un titolo forse meno ironico ma molto più crudo, diretto, spietato. Scuote, fa riflettere e resta.
«C’era questo di buono se impazzivi negli Stati Uniti: esisteva sempre qualcuno messo peggio di te. Mentre andava lì, aveva incrociato un barbone che stava mangiando una cipolla come se fosse una mela.»
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 05 Agosto, 2020
Opinione inserita da ornella donna 05 Agosto, 2020
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il virus cancella memoria
Glenn Cooper, divenuto famoso grazie alla trilogia della Biblioteca dei morti, torna in libreria con Clean. Tabula rasa, un libro di grandissima attualità.
Racconta, con intensità, una vicenda legata all’invasione nel mondo di una nuova malattia, capace di debellare l’umanità. Ciò è dovuto alla nascita di un nuovo virus:
“Si diffonde per via aerea, come l’adenovirus, e infetta il cervello come un’encefalite giapponese. L’adenovirus è un virus a DNA. L’encefalite giapponese un virus a RNA. Come diavolo hanno fatto a ibridarsi?”
Un virus letale ce è tremendo, poiché:
“volevano salvare la memoria. L’hanno cancellata.”
Come nasce un simile flagello dell’umanità? Il dottor Steadman è riuscito ad individuare una particolare cura per l’Alzheimer. Lo sperimenta su una paziente che, nonostante i divieti, riceve la visita di suo nipote, apparentemente affetto da un banale raffreddore. Ma non è così, perché è seriamente malato. E’ ben peggio. Così ha inizio la contaminazione e la diffusione del virus.
L’unico a poter rimediare è il dottor Jamie Abbott, ma non ce la può fare da solo. Ha bisogno di Mandy Alexander,
“La Mandy (…) non era cambiata poi molto. (…) Non aveva potuto far altro che ricordarla com’era quand’erano entrambi molto giovani. “
Lei lo aiuta in una lotta all’ultimo sangue contro il tempo tiranno. Riusciranno nel loro intento? Riusciranno a salvare vite umane in pericolo e a trovare una soluzione?
Un thriller ad alta tensione. Una corsa veloce, contro tutto e tutti, ad alto tasso adrenalinico. Particolarmente adatto a chi ama le sfide impossibili, condotte sul filo del rasoio. Di grandissima attualità, si legge con sgomento ed angoscia visto anche la situazione mondiale attuale.
Indicazioni utili
La genetica in crittogrammi musicali
Finalmente tradotto in italiano dalla bravissima Licia Vighi, già traduttrice di Sussurro del mondo, vincitore del Pulitzer dell’anno scorso, THE GOLD BUG VARIATIONS approda in Italia con ventinove anni di ritardo! E non è mai troppo tardi per i bei libri!
Scienza, musica, arte, informatica e due storie d’amore sovrapposte. Un romanzo-mondo, espressione felice se abbinata a questo voluminoso libro. Niente è messo lì per caso, perché la Natura non fa niente senza un perché ed anche Powers sembra piegarsi a questo assioma. Ogni pagina ha una sua necessità, anche il titolo originale: The Gold Bug Variations infatti si rifà sia a Lo scarabeo d’oro di Poe e sia a Bach tramite un gioco di suoni, The Goldberg Variations. E ...
“Cosa potrebbe esserci di più semplice? Quattro
note scendono dal Sol lungo i gradi della scala.
Quattro siffatte battute sviluppano
quattro frasi, poi si torna al principio”.
Quattro.
Quattro le stagioni, i quattro punti cardinali, quattro le lettere del tetragramma, quattro le basi che formano gli acidi nucleici del DNA. Quattro le note basilari di un componimento musicale di Bach. “Quattro i corpi paralizzati dal desiderio al centro di un mondo brulicante di specie”.
Ecco spiegato anche il perché del titolo in italiano: ogni terza variazione dell’opera di Bach citata è detta canone e il desiderio, visto non solo come spinta sessuale, ma come motore della conoscenza è alla base di ogni ricerca in ambito scientifico, oltre ad essere l’attrazione che spinge due persone ad amarsi. Certamente la scelta editoriale de La Nave di Teseo, così come per l’altro libro di Powers, The Overstory tradotto con Sussurro del mondo, è stata fatta per rendere più accattivante l’opera, (tenuto conto del fatto che il lettore medio sceglie le sue letture in base ai titoli ed alle copertine).
Il quattro è al centro di uno schema magico cui il dottor Stuart Ressler , il personaggio più affascinante dell’intero romanzo, dedica tutte le sue energie per riuscire a codificare il DNA, la trama segreta della vita. Attraverso intuizioni illuminanti riesce, grazie alla donna di cui si innamora, Jeanette Koss, che lo avvicina alla musica, in particolare alle variazioni di Goldberg di Bach, a individuare in quest’opera la metafora più vicina al problema della codifica del DNA, la combinazione polifonica dei numeri, la musica alla base della vita umana, di questa particolare “scala di Giacobbe”, con una struttura molecolare a spirale con “due ringhiere appaiate che si attorcigliano luna all’altra” destinate a non incontrarsi mai.
Anche l’opera di Poe serve a Ressler da stele di Rosetta della genetica per ottenere la chiave di accesso dei codici cifrati, ma non si tratta assolutamente del comune gioco del cruciverba, decisamente no. Bisogna stare attenti a non confondere il messaggio della sequenza delle basi dei nucleotidi, con il meccanismo che serve a decifrare codici segreti.
La vita non è altro che una elaborata permutazione su un originale messaggio di quattro basi: timina, citosina, adenina e guanina. Usando le iniziali si possono ottenere una lunga serie di combinazioni.
Tutto il libro è ben architettato e ben connesso nelle sue parti, proprio come la filosofia alla base degli studi del dottor Ressler che tiene conto di tutte le relazioni e le connessioni possibili tra le cose, perché “ogni cosa è tale grazie a tutto il resto”.
La storia è per gran parte un lungo flashback a più piani temporali sovrapposti: il dottor Ressler è morto e il suo pupillo e collaboratore Franklin Todd e la bibliotecaria Jan O’Deigh, uniti dall’amore reciproco e dalla smisurata stima per il vecchio scienziato, cercheranno di ricostruire la sua straordinaria storia per far conoscere al mondo la melodia che c’era dentro di lui. Ed è così che il lettore conosce la storia d’amore delle due coppie Ressler-Koss e Todd-O’Deigh, narrate in concomitanza dall’inizio, in mezzo alla storia delle genetica molecolare, a importanti nomi della scienza moderna. Il difficile percorso di Ressler, le sue intuizioni magiche campeggiano in tutto il romanzo e la parte più ‘rosa’ - voglio tranquillizzare i lettori- è veramente minoritaria, anche se confesso, densa e coinvolgente.
Aggiungo: necessaria. Sì, necessaria per bilanciare e alleggerire con un pizzico di poesia e di erotismo -non esplicito - tutta l’opera.
Un libro bellissimo, in America è paragonato alle opere dei grandi scrittori del modernismo Don DeLillo e Pynchon. La prosa di Powers è scorrevolissima, così evocativa, così piena di perifrasi, metafore, spesso logorroica come un fiume in piena, ma che conserva sempre una sua delicatezza ed una sua musicalità (in italiano ciò è merito della eccellente traduzione). L’erudizione di Powers è notevole: citazioni e richiami derivanti da ogni ambito della conoscenza esatti e puntuali: arte, letteratura classica greco romana e contemporanea, astronomia, storia di ogni epoca, curiosità, chicche scientifiche. Bisogna immergersi nella lettura e segnare spesso cosa cercare nell’enciclopedia, a meno che non siate dei pozzi di scienza (ciò è quasi impossibile, anche se certamente augurabile).
Il libro è voluminoso e abbastanza impegnativo, è consigliato ai lettori ben motivati.
Indicazioni utili
MISERIA E SPLENDORE NEL BAYOU
“Now, when I was just a little boy
Standin' to my Daddy's knee
My Poppa said "Son, don't let the man get you do what he done to me"
'Cause he'll get you
'Cause he'll get you now, now”
(da “Born on the bayou”, Creedence Clearwater Revival)
Nel suo memoriale del 2013, “Men we reaped” (di prossima pubblicazione in Italia presso l’editore NN), Jesmyn Ward parla del suo fratello minore, ucciso nel 2000 da un autista ubriaco, e di altri quattro ragazzi di colore della sua cittadina natale, DeLisle, morti nello stesso periodo per cause diverse (un omicidio, un’overdose, un suicidio, un incidente automobilistico), ma tutte quante in qualche modo legate alle tristemente note condizioni in cui la popolazione nera vive ancora oggi in America. La Ward, la cui vita per certi aspetti è già un romanzo (lei e la sua famiglia cercarono di sfuggire nel 2005 all’uragano Katrina, ma rimasero incagliati con l’automobile in un campo pieno di trattori, e, quando furono ritrovati, si videro rifiutati l’assistenza e il rifugio dai proprietari bianchi del terreno), ha sempre inserito nei suoi libri temi come la violenza, il razzismo, la povertà. “La linea del sangue”, che chiude la trilogia di Bois Sauvage (ma che in realtà ne è il principio, essendo il romanzo d’esordio della scrittrice), non fa eccezione, raccontando un mondo in cui un giovane di colore trova di fronte a sé, una volta conclusi gli studi, due sole prospettive: un lavoro faticoso e mal pagato come cameriere a un McDonald’s o come scaricatore al porto (se è fortunato) oppure un futuro da piccolo spacciatore o da tossicodipendente (se la fortuna invece non gli arride). Per rappresentare questa tragica alternativa la scrittrice di DeLisle sceglie come protagonisti due gemelli, Joshua e Christophe, una coppia indissolubile fin dalla più tenera età (come il bellissimo prologo evidenzia alla perfezione, con la lirica immagine dei due ragazzi che si tuffano abbracciati, saltando da un ponte nel fiume sottostante) ma che le circostanze della vita si incaricano di dividere crudelmente. Niente di particolarmente originale – si dirà -, la cultura occidentale è piena di storie di fratelli dai destini opposti, da Caino e Abele a “Rocco e i suoi fratelli” alla “Trilogia della città di K.”. A fare da originale sfondo alla vicenda è però questa volta il bayou, una terra poco frequentata dalla letteratura statunitense e che la Ward descrive impressionisticamente, facendo percepire al lettore il calore ubriacante che cuoce le cose e le persone, la polvere argillosa che penetra nelle rughe e nelle narici, il tanfo salmastro delle paludi, il rumore sfrigolante degli insetti, i latrati dei cani randagi, lo strisciare dei serpenti nella macchia, lo scorrere impetuoso delle nuvole nel cielo e l’abbagliante fiammeggiare dei tramonti: una terra ostile e inospitale, spazzata periodicamente da violentissimi uragani (che sembrano rappresentare ipostaticamente la condizione esistenziale dei suoi abitanti), ma che pure (come pensa più volte Christophe, incantato da quel paesaggio primordiale da cui non vorrebbe mai allontanarsi) possiede una strana, inspiegabile bellezza, quella stessa armonia che percepiamo ogni volta che ci accingiamo ad ascoltare i blues aspri e ferrigni di un Howlin’ Wolf o di un Muddy Waters. Non è stata facile la vita per Joshua e Christophe, cresciuti fin dai primi anni dalla nonna materna, in quanto i genitori (la madre allontanatasi da casa per cercare fortuna ad Atlanta, il padre tossicodipendente) sono sempre stati assenti dalle loro vite. Quello delle famiglie disfunzionali è un vero e proprio leitmotiv della trilogia (ricordiamo la famiglia Batiste di “Salvare le ossa”, con la madre che ha lasciato orfani Esch e i suoi fratelli dopo essere morta di parto e il padre violento e prevaricatore, oppure quella di Jojo in “Canta, spirito, canta”, con la madre anaffettiva e con problemi di droga e il padre rinchiuso da tempo in carcere). Nonostante la colpevole assenza dei genitori, i vincoli familiari riescono ugualmente nei romanzi della Ward a ricomporsi e a trovare un nuovo equilibrio, con nonni e fratelli maggiori a fare da padre o da madre (come Randall con il fratellino Junior o Jojo con la piccola Kayla). Ne “La linea del sangue”, nonostante le proteste di Cille (“Eppure quella più importante per loro sono io, sono sangue del mio sangue, figurati se non li conosco, sono io la madre”), è la nonna Ma-mee ad essere la figura affettiva di riferimento. Quando Cille viene in visita a Bois Sauvage per qualche giorno, la Ward architetta una atroce scena familiare in cui la cortesia di facciata e il finto interesse per il futuro dei figli non riescono a nascondere l’egoismo e l’indifferenza della donna (“Ma-mee sentì una corrente d’aria fredda passare tra lei e la figlia […] e avvertì la preoccupazione evaporare dalla voce della figlia come pioggia sul fianco caldo di un cavallo”), la quale se ne sta seduta discosta sul divano, arrotolandosi distrattamente le ciocche dei capelli per vincere l’imbarazzo che grava nella stanza. La figura del padre, il tossico Sandman, che si aggira per le strade di Bois Sauvage come uno spettro lurido e barcollante, è anche peggiore, e la sua inquietante ricomparsa dopo anni di assenza fa addirittura precipitare tragicamente gli eventi. Jesmyn Ward ama però visceralmente i suoi personaggi, e non vuole togliere loro, come forse farebbe la vita nella realtà non romanzata, la speranza. Il mondo è duro, l’esistenza non fa sconti a nessuno, ma Joshua e Christophe sono forniti di una dote fondamentale, la resilienza, che li fa piegare ma mai spezzare del tutto. Nella stupenda e metaforica immagine finale, la Ward li paragona a quei pesciolini che, presi all’amo e ributtati feriti nel fiume, sanno sopravvivere, “danneggiati e scaltri”, alle “cicatrici lasciate dal morso degli ami” per “ricordare la breve permanenza nel deserto rarefatto dell’aria, le labbra che insegnano ai figli l’odore del metallo nell’acqua, il pericolo.”
“La linea del sangue non possiede il ritmo incalzante e la suspense irresistibile di “Salvare le ossa”, e neppure quell’originale e potente commistione di realismo e soprannaturale capace di elevare “Canta, spirito, canta” dalla prosaicità della storia raccontata, eppure è ugualmente un romanzo del tutto maturo e soddisfacente. L’inconfondibile stile della Ward, caratterizzato da una carica metaforica che permette di fondere i personaggi con la natura che li circonda, è già in grado qui di dispiegarsi in tutto il suo lirico splendore. Nelle pagine del romanzo le similitudini e le analogie scaturiscono con una straordinaria immediatezza e spontaneità, come se la sovrabbondanza di odori, suoni e sensazioni del bayou costituisse un motivo irresistibile di ispirazione. Frasi come “Sospirò, e sentì il viso e la voce di sua madre staccarsi e volar via dal suo cervello come il petalo di un fiore” ci fanno credere che la poeticità della Ward non sia frutto (almeno in apparenza) di una complessa ed elaborata costruzione teorica, ma sgorghi semplicemente, naturalmente, senza mediazioni intellettuali, dal paesaggio stesso. E così i nugoli di moscerini ronzano intorno alle teste come aureole, il dolore per la morte del marito è per Ma-mee “un incendio che l’aveva attraversata da capo a piedi, lasciandola annerita e sterile come un tratto di foresta arsa da un fulmine”, la strada all’interno del bayou si snoda “come una vena lungo il corpo del paese”, il dolore che Christophe sente al petto alla vista del padre è “un uccello ingabbiato che sbatteva le ali”, i capelli di Laila sono come un covone di fieno, ascoltare Al Green è “come tuffarsi nel fiume per la prima volta dopo un inverno gelido”, e così via. Jesmyn Ward non arretra neppure di fronte ai simbolismi, correndo consapevolmente il rischio di apparire didascalica: le ferite alle mani che Joshua si è procurato al lavoro assomigliano alle stimmate di un santo, mentre il taglio sulla lingua che Christophe si è inavvertitamente inferto con una lametta mentre cercava di assaggiare della coca sembra connotarlo diabolicamente (la lingua biforcuta del demonio). In realtà, i personaggi della Ward non rimandano ad altri che a se stessi, sono esseri fatti di pelle, di carne, di sangue, e la scrittrice ce li descrive matericamente, con i corpi solcati dal sudore, invasi dal sonno e dalla fatica, eppure sempre protesi a trascendere la loro condizione per proiettarsi nella tenace e innocente speranza di un futuro migliore. Jesmyn Ward, come ho già detto prima, li descrive con affetto, tenerezza e una smisurata empatia, soprattutto senza mai giudicarli, neppure quando commettono dei passi falsi e imboccano, come Christophe, una cattiva strada, conscia che, come diceva il mai abbastanza rimpianto Fabrizio De André in “Khorakhanè”, può essere nella posizione di condannare soltanto “chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio”.
Indicazioni utili
Alla prova durante l'epidemia
“Anche le pulci prendono la tosse” è il nuovo romanzo di Roberto Costantini. Viene definito “noir” ma non ne ha l’essenza, secondo il mio modesto parere. L’autore stesso dichiara che questa storia “è arrivata tutta insieme, nello spazio tra il tg della sera e la notte”, nel doloroso periodo del lockdown. Ebbene, nel corso della lettura si percepisce benissimo che si tratta di un romanzo scritto “di pancia”, sull’onda dell’emozione causata dall’eccezionalità del momento storico che abbiamo vissuto. Non è una narrazione che ha la pretesa di offrirci la profondità di uno scavo introspettivo nella personalità dei personaggi; piuttosto, l’intento dell’autore sembra essere quello di regalare uno sguardo critico su certe realtà dell’Italia di oggi, non attraverso un racconto verosimile ma grazie alla mediazione di un’ironia fortemente amara.
Ci troviamo quindi davanti ad un romanzo che racconta le vicissitudini di alcune persone di un paesino della provincia di Bergamo fra febbraio e la fine di marzo 2020. Sono personaggi di varia estrazione sociale e diverso ambito lavorativo: alcuni sono proprio dei criminali senza scrupoli, altri semplicemente dei perdenti: tutti conducono una vita vuota e senza alcun senso. Abbiamo la professoressa che non è ascoltata né considerata da nessuno; l’infermiera che inscena un incidente stradale pur di mettersi in malattia e non andare a lavorare; il poliziotto fallito che segretamente progetta di uccidere l’anziano padre; l’imprenditore che in realtà è un pericoloso criminale; il gestore di un ristorante che è invece un bordello, fanatico della religione, e così via. Nel romanzo domina un’ironia grottesca che riduce questi personaggi a delle caricature un po’ allucinate di loro stessi. Al termine della vicenda alcuni, proprio grazie alla dilatazione della percezione del bene e del male favorita dall’estremizzarsi degli eventi causata dal coronavirus, riusciranno a riscattarsi, altri invece rimarranno nel loro elemento di malvagità.
La storia scorre e si lascia leggere con facilità, sostenuta da uno stile semplice e leggero.
Il messaggio che sembra voler trasparire da queste pagine è che il covid 19 è riuscito a dissipare quella nebbia che ruotava intorno a molte esistenze, restituendo dignità a quelle persone che in fondo non erano veramente cattive ma solamente inette, e facendo definitivamente sprofondare nel fango della crudeltà i veri malvagi. Si tratta di una lettura che può far trascorrere delle ore piacevoli e che sottintende qualche riflessione, anche se forse un po’ troppo semplicistica per alcuni aspetti.
E’ importante, infine, ricordare che tutti i diritti d’autore di questo libro saranno devoluti a favore degli ospedali, nell’ambito della campagna di Rcs con La7 “Un aiuto contro il coronavirus”.
Indicazioni utili
A un passo dall'inferno
Quando mi appresto a leggere un nuovo libro di Joe R. Lansdale, ho ormai scelto l'approccio del "non mi aspetto nulla". Ho capito, infatti, che si tratta di un autore che può nascondere romanzi di rara bellezza, ma solo intervallati da tanti altri improntati a null’altro che intrattenimento. "Una Cadillac rosso fuoco" appartiene a quest'ultima categoria eppure, non so se per il mutare del mio approccio o se per un'effettivo miglioramento della qualità, l’ho apprezzato più di altre sue recenti pubblicazioni.
In primis è una lettura molto scorrevole: pur arrivando a quasi trecento pagine, si finisce in poche ore e le vicende, pur non spiccando per originalità, coinvolgono e spingono il lettore ad arrivare alla fine leggendo il libro tutto d'un fiato. Grazie alla narrazione in prima persona fatta dal protagonista Ed Edwards, si riesce a entrare in empatia con lui, seppure i nostri sentimenti nei suoi confronti potranno risultare piuttosto variabili.
Il protagonista di questa storia (che in certi tratti mi ha riportato alla mente "lo sono Dot") è un ragazzo mezzo bianco e mezzo nero, che è riuscito a nascondere le sue origini paterne e si arrabatta come venditore di auto usate. Nella sua vita ormai rassegnata alla mediocrità, arriverà un punto di svolta: dovrà infatti ritirare una Cadillac rossa a un cliente che ha smesso di pagare le rate, e in questa occasione conoscerà l'affascinante moglie dell'acquirente, che la picchia di continuo e non fa altro che ubriacarsi, per poi sparire per lunghi periodi. Sedotto dalla bellezza della donna e dalle sue attività (gestisce un drive-in ben frequentato e un cimitero per animali) Ed si lascerà andare e vedrà in tutto questo un'occasione per svoltare, per fare quella scalata sociale che darà una vita migliore a lui, a sua madre e alla sua bella e dotata sorella.
Tuttavia, spesso la realtà va molto diversamente da come l’abbiamo immaginata e programmata: piuttosto che portarci in cima, finisce per farci precipitare agli inferi.
“Prima di mandarti in quell’inferno, ti parlano di coraggio, di eroismo, di nobili principî. Poi, se ne esci vivo, non vedi l’ora di tornare a ciò che hai lasciato. Quando ci torni,. Ti accorgi che ciò che hai lasciato non c’è più. E se invece c’è ancora, lo sai cosa succede?”
“Cosa?”
“Ti accorgi che quella cosa non è così bella come te la ricordavi e cominci a fantasticare si come renderla migliore. Cominci a volere di più, sempre di più. E non basta mai.”
UN RITORNO AMARO
Trevor Benson è il protagonista di questo romanzo, ha 37 anni ed è un ex medico, la sua vita viene sconvolta quando in Afghanistan, un missile viene lanciato contro l'ospedale in cui lavorava, nel 2011. Questo ha colpito l'ingresso dell'edificio, provocando molte ferite all'uomo, ha perso l'occhio destro, alcune dita e l'orecchio sinistro, oltre a questo ha riportato numerose cicatrici sul petto e una sulla faccia. Inoltre ha avuto anche delle lesioni spinali e delle forti emicranie e tutt'oggi è in terapia per curare il suo disturbo da stress post- traumatico.
Quando il nonno muore, Trevor decide di tornare a New Bern, nel North Carolina, dove da piccolo durante le estati trascorreva il suo tempo con l'uomo; ora gli sono rimasti solamente i ricordi di quel periodo e la casa di legno accanto al fiume dove abitava.
In quelle estati ha imparato a pescare e a prendersi cura delle api, ma il nonno gli ha anche insegnato cosa significa amare un'altra persona, è stato sicuramente un periodo prezioso per il protagonista.
Trevor è un uomo che ha delle profonde ferite non solo fisiche, è psicologicamente molto provato da quello che gli è successo, ha paura di lasciarsi andare, di ricominciare e di emozionarsi di nuovo.
Trevor incontrerà due donne, una ragazza quindicenne Callie che aiutava suo nonno e Natalie, giovane poliziotta che fa breccia nel cuore dell'uomo, anche se ci viene descritto come un personaggio freddo, misterioso e complicato.
L'uomo non capisce come mai il nonno si trovasse nel South Carolina quando ebbe il malore che poi gli fu fatale, Trevor vuole capire cosa cercasse lì e anche cosa gli volesse dire prima di morire, poche parole incomprensibili dette negli ultimi momenti della sua vita.
Partiamo dal fatto che Nicholas Sparks scrive romanzi rosa con al centro una storia d'amore, questo libro presenta alcuni difetti che mi portano a non considerarlo tra i suoi migliori romanzi.
Per prima cosa la storia tra Trevor e Nathalie: tra di loro manca l'intensa, manca la passione, manca l'emozione, il lettore non la percepisce tra le pagine; Sparks la scrive a parole ma a mio avviso non viene trasmessa a chi sta leggendo. Non c'è chimica tra i due, il loro rapporto non funziona, è come se vedessimo due bravi attori che singolarmente sono perfetti ma in coppia non riescono a trovare la giusta sintonia.
Per Trevor proviamo empatia per la sua storia personale, mentre Nathalie rimane un personaggio neutro, anche dopo aver scoperto il suo segreto.
A mio avviso, l'elemento drammatico della storia personale di Trevor è convincente, rende il personaggio più vero, il suo tormento personale, il suo passato, le sue paure, le sue fragilità da sole reggono la storia, che altrimenti avrebbe fatto acqua da tutte le parti.
Il lieto fine nei suoi romanzi è scontato, anzi i lettori di romanzi rosa vogliono trovare quel finale altrimenti non leggerebbero questo genere, ma la storia d'amore non è coinvolgente come dovrebbe essere.
La storia del nonno e di Callie, fa solo da contorno al resto del romanzo, personalmente non l'ho trovata sviluppata al meglio, l'autore non spiega bene alcuni passaggi e non ho capito come mai abbia voluto intrecciare più storie e poi finire senza darci troppe spiegazioni.
La narrazione scorre velocemente, ma ho trovato lo stile di Sparks un po' pesante, non lo ricordavo tale, ha questo modo di descrivere ogni singola azione e a lungo andare diventa un po' faticoso, alcune volte sarebbe stato meglio tagliere queste parti e dare più ritmo alla storia.
Alcuni esempi per farvi capire.
"Dopo aver finito di cenare, portai dentro il piatto e lo misi nel lavandino. Mi strappai una birra e tornai in veranda a leggere un po'."
E ancora:
"Dato che ero stato io a invitarla, ed essendo della vecchia scuola, insistetti per pagare il conto. A suo merito, va detto che mi lasciò fare e mi ringraziò educatamente."
Per me queste frasi andrebbero tolte, sono particolari che non aggiungono nulla alla storia.
Ho apprezzato molto la descrizione dei luoghi in cui abita Trevor e la casa del nonno, questo ha reso la storia più vivida e reale.
Questo libro porta a riflettere su molte cose, su quanto diamo per scontato tutto quello che abbiamo, su quanto l'amore possa arrivare quando meno ce lo aspettiamo e quanto le difficoltà ci possano rendere più forti.
"Non avevo problemi a dormire e cominciavo a tornare quello di un tempo. Era come se, cercando di salvare [...], avessi finito in qualche modo per salvare anche me stesso."
Questa storia richiama in un certo qual modo le altre scritte da Sparks, ci sono degli elementi che ricorrono sempre, in primis il ruolo centrale della storia d'amore, le difficoltà nel coronamento dello stesso, il passato difficile dei protagonisti, qualche segreto da scoprire; insomma per chi è un amante dei suoi romanzi questo libro è ciò che ci si aspetta dall'autore.
Però, a differenza dei precedenti, ha una trama un po' piatta, la storia non decolla come dovrebbe e l'anello più debole è proprio la parte "rosa" della narrazione, che in alcuni punti ho trovato forzata e priva di una reale emozione.
Il lettore si aspetta che la storia prende una determinata direzione e l'autore segue sempre lo stesso schema e chi è un suo fedele reader, probabilmente sa già che troverà una conclusione della storia uguale a come se l'era immaginata.
" Il cuore va dove vuole."
Apprezzo sempre quando l'autore di un romanzo crea un protagonista imperfetto e fragile, che ha un vissuto particolare che lo porti a trovare nuove consapevolezze nella propria vita, che migliori e capisca cosa e dove sbaglia. In questo caso Trevor lo fa, questo libro è interessante da questo punto di vista, questo forte sentimento che prova per Natalie lo spinge a cambiare, sicuramente ne esce un personaggio complesso, che però proprio per la costruzione di questo tipo di storia d'amore perde un po' la sua forza.
"Era una giornata qualunque, ma non c'era niente di normale, per me; mi pungevano gli occhi per le lacrime, e avrei voluto soltanto che questo momento non finisse mai."
In generale credo che per Sparks non sia una novità raccontare dei personaggi con storie personali tragiche e vite da ricostruire, ma qui forse ha perso proprio la magia che troviamo nel titolo. Piccolo appunto, la parola magia è stata aggiunta dalla casa editrice, visto che il titolo scelto dall'autore era semplicemente "The return".
Sicuramente per i fan di Sparks questo romanzo sarà una conferma, ma onestamente la storia non regala molto emozioni.
Le cose positive sono il protagonista e il messaggio che l'autore vuole dare ai lettori, che è quello di non arrendersi mai e di ricominciare.
Spero che però anche i suoi fans siano obbiettivi nel riconoscere i difetti di questa storia.
Trovo impensabile dare un giudizio alto a questo libro, guardo indietro ad altri suoi romanzi e questo lo trovo nettamente inferiore; alcune volte meglio un'onesta verità che nasconderci dietro la fama dell'autore.
Sparks è sicuramente un ottimo scrittore nel suo genere ma non tutte le ciambelle escono con il buco, come in questo caso.
Se vi aspettate una storia d'amore appassionante non la troverete, se invece volete leggere un romanzo leggero, ma che fa anche riflettere in alcuni punti; allora potrebbe fare al caso vostro questa lettura.
A mio gusto personale, a questa storia manca qualcosa e quindi non consiglierei la lettura se non siete amanti dell'autore.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La setta dell'orrore
Colter Shaw è l’equivalente moderno del cacciatore di taglie del vecchio West. Si guadagna da vivere incassando le ricompense che privati e istituzioni offrono per rintracciare persone scomparse, siano esse pericolosi criminali evasi, delinquenti abituali che hanno violato la libertà su cauzione, oppure, al contrario, ragazzini scappati di casa o persone che, per un motivo qualunque, hanno deciso di far perdere le proprie tracce. Colter, però, a differenza di molti suoi colleghi, del passato e del presente, s’è dato ben precise regole morali di condotta, non necessariamente coincidenti con quelle stabilite dalla legge, ma assolutamente rigorose che lui rispetta in modo quasi religioso, nell'intento di raggiungere quella che ritiene essere la soluzione giusta di ogni caso. Anche per tal motivo, di solito, non procede a nessun arresto: si limita a segnalare a chi di dovere dove trovare il ricercato, poi lascia fare agli altri le dovute mosse.
In questa occasione, però, le cose virano subito al brutto; verso una direzione anomala. L’incarico che si è ripromesso di portare a termine lo porta nello Stato di Washington. Qui dovrebbe ritrovare due ragazzi che (forse), secondo lo stile del KKK, avrebbero dato fuoco a una croce davanti a una chiesa frequentata da gente di colore e poi avrebbero sparato un paio di colpi di pistola che hanno ferito alcune persone. Il compito parrebbe facile, sicuramente alla portata delle indubbie qualità di Colter. Tuttavia, non appena rintracciati (agevolmente) i due fuggitivi, si vede costretto a venir meno a uno dei suoi principi cardine per evitare che uno sceriffo integralista si faccia giustizia da sé: dovrà catturarli personalmente. Tuttavia nell'operazione qualcosa va dannatamente storto.
Così Shaw, sentendosi personalmente responsabile per ciò che è accaduto, vuol comprendere le ragioni dell’assurdo gesto compiuto sotto i suoi occhi. Dunque, decide di indagare di propria iniziativa su una misteriosa Fondazione verso la quale i due erano diretti.
Questa organizzazione (la Fondazione Osiride) è annidata in un luogo sperduto tra i territori selvaggi dello Stato. È guidata da un misterioso Maestro Eli e, ufficialmente, si ripromette di fornire aiuto a persone in grave difficoltà psicologica per far ritrovare loro la gioia di vivere, dopo il pagamento di una retta assai salata. Tuttavia, non appena Shaw mette piede nel posto sotto falsa identità, si rende conto che là c’è qualcosa di decisamente malsano: è testimone di inaudite violenze e di riti di annullamento personale quantomeno allarmanti. Comprende, quindi, che si tratta di pericolosa setta che fa un vero e proprio lavaggio del cervello (un “menticidio”) a coloro che le si affidano. I risultati potrebbero essere potenzialmente catastrofici. Così si impegna con i pochi mezzi che ha a disposizione di arrestare la tragedia che lui sente come imminente. Ma la missione sarà tutt'altro che agevole e indolore.
L’argomento trattato nel romanzo è quanto mai sgradevole e ostico, ma indubbiamente coinvolgente. Personalmente trovo decisamente disturbante l’idea stessa che un individuo o una organizzazione, come scopo d’azione, si prefigga il fine di sconvolgere la mente e l’autonomia di giudizio di un essere umano sino ad annullarle o soggiogarle alla propria volontà, sia per fini di lucro che per il mero gusto del potere. La cosa diviene ancor più terrifica se, per farlo, ci si approfitta di lutti o altrui debolezze psicologiche.
Jeffrey Deaver è stato particolarmente abile a sfruttare il tema che negli Stati Uniti ha sin troppi tragici esempi concreti a cui ispirarsi. Senza eccedere o scivolare su un livello eccessivamente truculento riesce a creare una tensione tangibile per quasi tutto il libro.
Il tema si sarebbe pure prestato, agevolmente, a svolgere un'approfondita indagine sociologica sul problema delle sette e per lanciare un non inopportuno grido d’allarme sul pericolo che esse costituiscono. L’A., però, ha preferito limitarsi all'aspetto meramente ricreativo della narrazione e non è uscito dai binari del thriller convenzionale.
La vicenda, in realtà, sarebbe potuta essere ben più intricata, invece procede in modo piuttosto lineare verso l’auspicato finale. Il comportamento di Colter è fin troppo perfetto e rigoroso e, nelle poche occasioni in cui si trova davvero nei guai, viene soccorso puntualmente da inaspettati alleati che all'improvviso compaiono come salvifici deus ex machina. Tuttavia, nonostante ciò, la lettura prosegue lungo una escalation di tensione emotiva sempre avvincente.
Debbo confessare che, inizialmente, mi ha un poco irritato l’abitudine, tipicamente anglosassone, di descrivere personaggi e ambienti con una minuzia eccessiva di particolari inutili e defatiganti (sino al punto da indicare marche di scarpe e indumenti, quasi si trattasse di uno spot pubblicitario). Poi, però, la narrazione, entrata nel vivo, diviene più fluida, prende quota ed è davvero difficile staccare gli occhi dalle pagine. Ho gradito meno l’intrecciarsi, con la narrazione principale, della storia personale di Colter; sfacciato escamotage per giustificare la prosecuzione della serie di romanzi con protagonista l’investigatore. In definitiva, però, si tratta di un romanzo avvincente e di piacevole lettura in totale svago.
_______________________________
Due considerazioni finali.
Pare che il personaggio di Maestro Eli (il guru della Fondazione) mostri caratteristiche che richiamerebbero quelle dell’attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ciò, nel pubblico americano, avrebbe determinato contrastanti reazioni. Ovviamente per noi è molto più difficile percepire queste attinenze, ma mi pareva opportuno segnalarlo per evidenziare anche un potenziale intento politico subliminale del libro.
La seconda considerazione rientra tra gli appunti dell’angolo del pignolo: ho provato una perversa soddisfazione nello scoprire che anche romanzieri di più lunga esperienza cadano in contraddizioni che in alcuni casi, sfiorano il comico. In questo romanzo ne ho trovate più di un paio. La più divertente riguarda le divise indossate dagli adepti della Fondazione che, in teoria, dovrebbero essere prive di tasche, ma alle quali, in qualche occasione, magicamente, ne spunta qualcuna giusto per consentire il porto occulto di un oggetto. Inoltre ignoravo che la verbena officinalis (in erboristeria consigliata come disinfettante orale, digestivo, analgesico e antipiretico) potesse divenire pure un fortissimo emetico che induce al vomito. Ma qui forse si tratta solo di un errore di traduzione e il riferimento è sbagliato.
Indicazioni utili
In generale consigliato a chi apprezza i thriller con costruzione solida e ben documentata ambientazione.
Minestra di acetosella
“Oh Eva devi scrivere questo libro, devi scrivere questo libro”…
“Se fosse per me ne sarei felice, soltanto che i commerciali dicono che questo non vende, quello non vende, nessuno legge più le biografie, nessuno legge più le raccolte di racconti, la poesia poi non l’ha mai letta nessuno”, la gente vuole soltanto libri su quanto è stronza Hilary Clinton e i cosiddetti graphic novels del cazzo, dove le parole proprio non ci sono”.
“Niente di strano che tu sia contento di esserne fuori”, disse Jake.
“Certo. Sono stufo di queste cazzate. E non sono solo gli editori, ci si mettono anche gli scrittori. Il novanta per cento di quello che viene pubblicato non ha alcun valore. Con un po’ di fortuna, e questo sarà il lato positivo di queste elezioni del cazzo, quando gli scrittori si sentiranno di nuovo oppressi, ricominceranno a scrivere libri che varrà la pena di leggere, al posto di tutta quella merda scritta sotto la presidenza Obama, roba da medio borghesi idioti, egocentrici liberal, gente che ha solo da stare lì a guardarsi l’ombelico. Voglio dire, Sheila Heti, Cristo santo. Che stupido libro del cazzo. Questa fa un pompino a un tizio e vomita. Ma chi se ne frega?”
“A me Sheila Heti piace un sacco” disse Sandra.
“Anche a me” disse Rachel. “Non la capisci perché sei un uomo”.
“Bene, allora Jeffrey Eugenides. E’ un segaiolo. Come quello stronzo di Jonathan Franzen, quello stronzo di Jonathan Lethem, e quel coglione di Jonatham Safram Foer. Tutti questi Jonathan di sto cazzo sono solo una manica di segaioli”.
Ammetto che mi aspettavo un testo molto diverso: pungente, satira politica, se non satira almeno qualche amara considerazione o comunque qualche considerazione sulla politica di qualsiasi tipo data la presentazione dell’editore e l’incipit che vede la protagonista Eva chiedersi come assassinare Trump dalla prima frase. In realtà, il romanzo è molto politically correct, anche troppo. Non c’è nessuna considerazione che non sia banale. I maggiori critici della presidenza Trump sono i cani, a cui Trump provoca un uso incontrollato di vescica e sfinteri per un disturbo da stress. Anche la protagonista Eva, sembra avere una allergia a Trump che la costringe ad acquistare un costoso palazzo veneziano probabilmente al triplo del suo valore. Ma l’allergia è davvero a Trump? Eva non è nemmeno andata a votare perché c’era troppa fila. Invece le file degli aeroporti non le danno fastidio. Insomma, il romanzo descrive molto bene una elite, gente che lavora senza avere un lavoro vero: scrittori, architetti, consulenti finanziari, decoratori di interni, cuochi gay improvvisati ma anche ospiti, insomma scrocconi che vivono delle briciole della elite. Gente infantile, li si potrebbe definire alto borghesi idioti, egocentrici liberal, gente che ha solo da stare lì a guardarsi l’ombelico, per citare l’autore. Gente che se ne va in giro con un cappello in testa a forma di passera. Sembra che vivano in un olimpo a parte. A un certo punto il marito di Eva, Bruce, sembra innamorarsi della segretaria malata di cancro che ha tutti i problemi della gente normale. La aiuta, le dà soldi, molti soldi ma non va a letto con lei, suggerendo uno spessore morale che in realtà non esiste. Infatti, poi nelle ultime pagine non si sa come né perché ha una relazione con Sandra. Insomma non era spessore morale, è che certa gente si mescola solo i suoi simili, stessa classe sociale. Tutti parlano, dall’inizio alla fine del libro, solo di Eva, che hanno eletto a perno del loro mondo, senza una vera ragione, per un capriccio. Ma il fatto che si parli sempre di lei dovunque è fastidioso. E’ come stare al centro di una combriccola di pettegoli che vivisezionano il loro bersaglio ma sempre con uno sguardo estremamente superficiale, per esempio ci sono pagine in cui la migliore amica di Eva descrive a tutti gli altri i dettagli anatomici intimi dell’amica. Le relazioni tra queste persone sono fastidiosamente false e stucchevolmente corrette, attente a non contrariare la sensibilità altrui, sensibilità alla forma ovviamente.
Insomma, dico la verità, il personaggio più simpatico del romanzo, per quanto sia una comparsa, è certamente Trump. Il libro è scritto molto bene, da una grande penna ma non dice niente. Può essere gradevole per architetti, dato che si parla molto di arredo di interni e cose simili.
Le pagine più caustiche non sono quelle che parlano di politica, i personaggi ci si approcciano solo per banalità con estrema cautela, dando una botta al cerchio e una alla botte, ma quelle che parlano di altri scrittori. Qui David (per fortuna non si chiama Jonathan) non ha freni inibitori. Non ha grande stima di parecchi colleghi che definisce segaioli e stronzi. Io ho solo un vaghissimo ricordo di un suo romanzo o forse erano racconti molto segaioli. Ho quasi pensato a quel tipo di scrittura con nostalgia, ma in effetti le poche pagine segaiole del romanzo sono così brutte che si possono saltare, anzi è consigliabile il salto.
Tutto sommato il libro non è brutto, è scritto bene, e descrive benissimo un ambiente improbabile e fuori dal mondo per cui sembra parlare di niente. Per essere cattivi, citando l’autore, devo concludere che a David per scrivere qualcosa di profondo non è bastata la vittoria di Trump, ma bisognerebbe augurargli il ritorno trionfale di Hitler.
Indicazioni utili
Un ‘armonioso’ triangolo
Quanto mi costa stroncare la Maraini, che ho tanto amato in “La lunga vita di Marianna Ucria”, in “Colomba”, “Buio”! La Maraini è una delle più importanti scrittrici italiane e la mia opinione è umile, ma dettata da una profonda delusione.
Questo breve romanzo (112 pagine) non mi è piaciuto. E probabilmente la mia è una voce fuori dal coro, perché ci sono recensioni positive e articoli che esaltano questa storia di un’amicizia tra due donne, più forte dell’epidemia di peste che le ha separate e dell’amore che provano per lo stesso uomo.
Due le motivazioni della mia delusione: non c’è la ricostruzione storica cui la scrittrice mi aveva abituata in ‘Marianna Ucria’ -forse è comprensibile vista la brevità del libro, quindi di storico c’è solo l’accenno alla peste del 1743 - e ho trovato assolutamente inverosimile il triangolo amoroso Agata-Girolamo-Annuzza.
Girolamo è sposato con Agata con la quale ha avuto una figlia, ma è innamorato ricambiato dalla migliore amica della moglie, Annuzza. Agata conosce tutto ciò, ma non rinuncia né al marito, poiché lo ama ed è il padre della sua bambina, né all’amica con la quale condivide ricordi di infanzia.
Una situazione troppa idealistica, troppo forzata. L’acme del paradosso è alla fine del libro, quando Agata scrive ad Annuzza che nella precedente lettera le aveva chiesto aiuto nel cercare un bravo marito cosicché possa finalmente dimenticarsi del bel Girolamo, marito di Agata:
“Ma cosa succederà a Girolamo se venisse a sapere che ti sei innamorata di un altro? (...) sono qui per pregarti di non smettere di amare mio marito, perché lo faresti soffrire e quindi lui farebbe soffrire me. (...). Ti sembro pazza?ti sembro dissoluta? (..)Annuzza ti chiedo di continuare ad amarlo, perché in questo triangolo si è creata una certa armonia che andrebbe persa se tu smettessi di cercarlo”.
Tutto il libro consta di questo: uno scambio epistolare tra due amiche innamorate dello stesso uomo, bellissimo come un dio, soggiogato dalla sua stessa bellezza. Sullo sfondo, una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo ancora adesso: una epidemia con tanto di corpi abbandonati senza il conforto dei familiari, fosse comuni, lazzaretti sovraffollati, clima di incertezza, paura per chi viene dal paese vicino...solo che siamo a Messina, nel 1743.
Se cercate la Maraini dei grandi romanzi resterete delusi come me. Se invece la tematica dell’amicizia spinta agli estremi vi piace, sopporterete il parossismo che mi ha fatto storcere il naso. Una cosa è sicura: di meglio poteva fare!
Indicazioni utili
- sì
- no
Un indovino gli disse
La pelle eburnea, bellissima e liscia come seta.
Implora il maestro tatuatore fino a che lui cede, aghi ed inchiostro, così il padre inizia ad incidere la sua arte sul giovane corpo della figlia.
Conosci la tripla maledizione?
Il serpente ingoia la rana, la rana ingoia la lumaca, la lumaca fa sciogliere il serpente.
Il corpo di Kinue, privo del torso, viene trovato in un bagno chiuso dall’interno.
Sul davanzale della finestra una lumaca scivola lentamente.
Una breve nota alla biografia dell’autore che pare essa stessa nata dalle pagine di un romanzo, Takagi Akimitsu nacque nel 1920 e dopo la laurea in ingegneria decise di abbandonare la professione per diventare scrittore, a seguito della profezia di un indovino.
Divenne uno dei più famosi giallisti giapponesi, questa è la prima pubblicazione italiana.
Edito nel 1948, sebbene la letteratura giapponese di quell’epoca mi sia particolarmente gradita, la lettura è stata controversa. Da un lato spicca affascinante l’incipit, che richiama miti e leggende dell’epoca Edo, immergendo le radici del delitto nel mondo sommerso ed illegale dei tatuaggi nel Giappone del dopoguerra. Dall’altro l’incedere lento e piuttosto dozzinale dell’indagine rende la lettura a tratti soporifera. Purtroppo, la caratterizzazione dei personaggi è poco incisiva ed il taglio psicologico blando, come pure le descrizioni della Tokyo occupata e sconfitta sono piuttosto scialbe.
Chi cerca un buon giallo vintage legga Agatha Christie, chi è affascinato dal mistery nelle atmosfere del Sol Levante e ritiene di assecondare le profezie di un indovino troverà in questo Takagi un apprezzabile compagno, seppur con riserva.
Indicazioni utili
- sì
- no
http://www.?
Roberto Bolano, affermò circa vent'anni fa che "la letteratura del XXI secolo apparterrà a Neuman e a pochi suoi fratelli di sangue". Ebbene non so se questa sua profezia si avverrà, ma posso senza dubbio affermare che in Neuman c'è molta sostanza e la lettura di "La vita alla finestra" ha superato le mie aspettative.
Autore argentino ma radicato in terra spagnola, pupillo di Roberto Bolano purtroppo solo per qualche anno dovuto alla prematura scomparsa del grande, descrive in questo libro il disagio dei nostri tempi. Net, soprannome derivante da "internet", descrive attraverso le sue mail - le lettere del duemila - la sua vita e quella della sua famiglia, a Marina una misteriosa ragazza con la quale si presume abbia avuto una storia ma che non risponde mai, tant'è che a un certo punto il lettore nutrirà qualche dubbio sulla sua reale esistenza nella vita di Net. Sembra più un personaggio costruito, un'amica immaginaria e, perché no, il lettore stesso, dato che a conti fatti le lettere le leggerà lui. ("Dove sei Marina? E' come se non fossi esistita. O eri già solo un personaggio dei ricordi, un miraggio che nomino per potergli parlare?" - "ora, mentre decido cosa raccontarti, mi accorgo che sai già tutto (...) perché sei dietro alle mie parole."). Un libro "epistolare" in cui le lettere vengono sostituite dalle mail, la carta bianca dalla finestra, l'inchiostro dalla tastiera e il motivo principale di queste confessioni è, il mal di vivere, la scrittura come rimedio ("Scrivere è un metodo per combattere gli incubi, ma non per vincere l'insonnia. Anzi: soprattutto di notte, chi scrive comprende di essere una sentinella. Che deve stare all'erta, come le sue parole e, al primo barlume di luce, correre a nominarla.") perché "forse sentiamo il bisogno di concepire sullo schermo la perfezione narrativa che manca alla nostra vita."
Una famiglia imperfetta, con screzi e problemi di comunicazione ("nella nostra famiglia, sempre tanto cinematografica, viviamo alternando l'horror classico e la commedia all'italiana. Il budget è piuttosto scarso. Il cast, francamente prevedibile." - "La famiglia sembra composta da tre satelliti che ruotano - ciascuno a diversa velocità e ampiezza d'orbita intorno a Paula, che emana luce ed evita collisioni.") e una instabile storia d'amore che molto mi ha ricordato quella di "Rayuela", sono gli aspetti che più sono destinati ad evolvere. Crea dei personaggi forti, caratterizzati solo da brevi frasi che si ripetono nel libro, con l'effetto di accentuandoli ancor di più, la madre per esempio è descritta "con lo sguardo perso in un bicchiere, fisso sulle polverine bianche che si sciolgono" o intenta ad annaffiare perennemente i gerani ormai ammuffiti dalla eccessiva umidità. Ho intravvisto anche un certo legame quasi incestuoso tra padre e figlia, magari sarà stata solo una mia illusione.
La prosa è molto poetica e densa, senza frasi prolisse ma prediligendo quelle stringate riesce tuttavia a trasmettere il grande disagio del narratore, i suoi momenti di smarrimento e incertezza, nonché a dimostrarsi un grande osservatore del mondo. Infatti sono rimasta piacevolmente sorpresa e nonostante sia un libro di centocinquanta pagine, la lettura rallenta e non è decisamente un libro di svago ma un libro tendenzialmente introspettivo.
L'unica nota negativa, se vogliamo chiamarla così, è che la forma sembra un po' invecchiata. Se lo contestualizzo all'anno 2002, anno in cui uscì per la prima volta, allora è rivoluzionaria, ora a distanza di quasi venti anni lo è un po' meno, infatti la si sente un po' obsoleta. Il contenuto però ha il profumo dell'immortalità e ha superato di gran lunga le mie aspettative. Non aspettatevi dunque un romanzo dalla trama movimentata e dal finale chiuso, è piuttosto un'ampia finestra sulla vita, per riprendere il titolo, dell'ampio respiro poetico e che fa riflettere per il suo contenuto profondo.
"Ho immaginato di infilare un dito dietro l'orizzonte e di sollevarlo come un tappetto, per vedere cosa c'era dietro."
Indicazioni utili
A tinte azzurre
“L’enigma della camera 622” segna il gran ritorno in libreria di Joel Dicker, giovane autore tra l’altro del fortunato “La verità sul caso Harry Quebert”.
Dati i precedenti, dovremmo indicare lo scrittore svizzero come un autore di gialli sui generis, un romanziere che a modo suo, in verità anche nuovo, e diverso dal consueto, si diletta a costruire comunque gradevoli enigmi e piacevoli misteri irrisolti, a uso dello svago librario del suo lettore. Con tutti i cliché possibili del genere: viene già nelle prime pagine perpetrato un delitto, quasi sempre il più abietto tra i reati, un omicidio; non si giunge a soluzione immediata data l’apparente inspiegabilità dell’evento occorso; qualcuno, non necessariamente un funzionario delle forze dell’ordine a tal scopo preposto, indaga accuratamente.
In un modo o nell’altro s’individuano possibili colpevoli, malgrado difficoltà e depistaggi, grazie all’acume dell’investigatore di turno: quindi, scoperta del movente, colpo di scena finale con spiegazione a sorpresa dell’esatto svolgimento del crimine, le sue motivazioni più o meno tanto occulte quanto banali, l’individuazione del sicuro colpevole che viene immancabilmente assicurato alla giustizia.
La fortuna di Joel Dicker, e il suo talento, consistono nel fatto che non fa niente di tutto questo.
I romanzi di Dicker non hanno nulla a che fare con i puzzle logici e appassionanti alla Agatha Christie, la Regina del romanzo giallo propriamente detto.
Differiscono anche dai pur valenti polizieschi nostrani, ciascuno a suo modo originali e gradevoli, che vedono protagonisti vicequestori che spinellano beatamente, squadre di poliziotti “bastardi” raccolti qua e là tra gli scarti dei commissariati cittadini, avvocati penalisti, investigatori privati vari, sostituti procuratori improbabili che scorrazzano in tacchi a spillo tra i sassi di Matera.
I libri di Dicker nemmeno richiamano i police procedural americani, o i mystery sensu strictu, o i delitti locali all’italiana, tanto di moda oggi nelle fiction televisive, dove ad indagare spesso e volentieri con esito felice sono personaggi che poco hanno a che fare, per professione nativa, con l’indagine e il delitto, come per esempio parroci di provincia, professoresse di liceo, specializzande di medicina legale, e chi ne ha più ne metta.
Joel Dicker sfugge a una qualsiasi superficiale etichettatura, sopra ogni altra cosa egli è semplicemente uno scrittore, un bravo romanziere, uno che scrive libri per il piacere stesso di scrivere, prima di ogni altra cosa.
Può piacere o no, ma scrive varie cose buone, e le sa scrivere bene.
Si tratta di un giovane encomiabile per un qualsiasi lettore, giacché egli scrive principalmente per se stesso, per un proprio bisogno esistenziale; perciò scrive bene e meglio, giunge facilmente al cuore del lettore, lo emoziona, come ogni lettore desidera essere deliziato tutte le volte che sfoglia le pagine di un libro, e come ogni bravo scrittore deve saper fare.
Dicker non fa fatica, si applica, lavora, scrive, cancella, riscrive, non si stacca dalla tastiera, trascura tutto per scrivere, proprio perché per lui non è una fatica, non è un lavoro, è amore per la scrittura.
Quando fai qualcosa che ti piace, non stai lavorando, stai seguendo la tua passione, e la passione non concede requie, è vero, ma provvede essa stessa a ricaricarti. Un circolo chiuso, un privilegio.
Joel Dicker è un bravo artigiano della scrittura, s’industria alacremente, ha talento, e il prodotto del suo talento ha un valore ancora maggiore perché costruito in giovane età.
Lo dichiara lui stesso, sic et simpliciter:
“…una storia prende le mosse innanzitutto da una voglia: quella di scrivere. Una voglia che si impadronisce di te e che niente può ostacolare, una voglia che ti allontana da tutto…la malattia degli scrittori…Puoi avere la trama migliore del mondo, ma se non hai voglia di scrivere, non concluderai niente.”
Joel Dicker ama scrivere, e allora scrive. Lo ripeto non piace a tutti, ma scrive piacevolmente.
Scrive di tutto: scrive di sé stesso, letteralmente, e manco a farlo apposta la sua partner nel romanzo non lo chiama mai con il suo nome, ma semplicemente: “Scrittore”, come volevasi dimostrare.
Scrive della sua vita, della sua arte, scrive di amori e di editori, d’inizi e di fiaschi, di città, dove è nato e dove è stato. Di persone cui è grato, di donne di cui si è innamorato, e da cui è stato piantato.
Parla di viaggi, di alberghi, di camere di albergo con numerazione insolita; descrive fatti passati del tempo e li attualizza con gli eventi correnti, inventa personaggi, e ne segue la sorte, gli intrecci, la crescita, gli sviluppi, le coincidenze.
Romanza su un delitto irrisolto, e allora il romanzo si tinge di giallo; s’incanta in una lunga e travagliata storia d’amore, e allora il libro assume tonalità rosa.
Descrive vite disastrate, corrose dal bisogno, dalla povertà, dalla miseria e che anelano condizioni di vita migliori, quasi una rivincita sulle ristrettezze, i disagi e le privazioni dell’esistenza; allora possiamo dire che questi suoi capitoli sono pervasi dal verde della speranza.
Enuncia fatti misteriosi, nascosti, celati agli occhi del pubblico: in questo suo “Enigma” ci sono Servizi segreti, insospettabili agenti sotto copertura, intrighi politici e diplomatici; il mondo della grande finanza e dell’egemonia mondiale delle banche svizzere, con i giochi di potere che sempre si scatenano attorno alle grandi fortune, delitti e segreti, persone di mondo e sordidi personaggi privi di ogni scrupolo, un noir vero e proprio quindi.
Direi che se una tonalità va scelta per questo tomo, in definitiva, è l’azzurro quello più appropriato, come rimanda la copertina del libro: azzurro come il cielo, perché quella di Dicker è una bella storia, lunga e avvincente, una storia grande come il cielo, e bella come quello.
Un grande palcoscenico dove si alternano mimi e saltimbanchi, valenti attori ed esperti capocomici, truccatori, trucchi e truccati, nobili russi, sapienti analisti di bilanci e medici analisti della psiche umana, vecchi ebrei, maschere greche, trucchi alla Diabolik e alla Fantomas, governanti innamorate del padrone di casa, banchieri disposti a folli baratti e baratti realizzati con un misto di magia e possessione diabolica, perché in fondo la vita è un’illusione, una maschera, un travestimento, un gioco di prestigio:
“Quando si vuole veramente credere a qualcosa, si vede solo quello che si vuole vedere”.
Ancora, si narra di avventure, di pistole, di passioni, di anelli scomparsi, di cime innevate di neve e acque turchine delle isole greche.
Su tutto, aleggia la colonna sonora delle musiche di Wagner, o di un vecchio carillon a molla.
Più che le storie che scorrono sul palcoscenico, Dicker eccelle nel dietro le quinte; si dilunga sugli antefatti, sui trascorsi, sul passato per comprendere il presente, perciò il romanzo si rinnova continuamente, i racconti si presentano con altra veste, gli intrecci si disfano e si riformano con trame nuove e si percorrono risvolti inesplorati, tutto si può dire della sua Storia, mai che annoia.
Soprattutto, c’è tutto l’originalità dello scrittore Dicker in questo suo libro, un giallo dove la vittima assassinata, si badi, la vittima, non l’assassino, si scopre chi è solo dopo due terzi del libro.
Quale giallo comincia così, identifica la vittima con tanto ritardo?
Questo non è un giallo di Joel Dicker, è un romanzo di Joel Dicker, che si tuffa a corpo morto nella scrittura:
“Quando mi concentro sulla storia, vengo completamente assorbito. È come se ci fossi anche io nel romanzo, all’interno dello scenario. E ci sono tutti quei personaggi attorno a me…”
Direi inoltre che l’”Enigma della camera 622” è anche una bella storia d’amore, il numero neanche è casuale, magari richiama una data o un orario con un significato affettivo per i protagonisti; è una bella, lunga e duratura storia sentimentale, di quelle rare, uniche, speciali, eppure contrastate e controverse, perché:
“…Facevamo fiorire, ognuno per conto proprio, il nostro piccolo giardino segreto, ma siamo stati incapaci di coltivare un orto insieme”.
Una storia d’amore grande in tutti i sensi, tra un uomo e una donna, ma anche tra padre e figlio, tra docente e discente, tra chi non ha figli e chi non ha identità, tra chiunque abbia un cuore e sappia amare:
“Cosa siamo capaci di fare per difendere le persone che amiamo? È da questo che si misura il senso della nostra vita.”
Siamo grati a Joel Dicker per questo suo libro: ci ha donato un bel romanzo, e non è poco.
“La cosa più importante, in fondo, non è come va a finire, ma in che modo ne riempiamo le pagine.”
Esattamente come diceva Daniel Pennac, la vita è: “Come un romanzo”.
Lo afferma, uguale, anche Joel Dicker.
Indicazioni utili
Senza amore e senza pietà
È davvero un mondo senza amore, e anche senza pietà, quello contro cui si trova a scontrarsi fin da giovanissima la protagonista del nuovo romanzo della scrittrice palestinese Susan Abulhawa che, a distanza di cinque anni da “Nel blu tra il cielo e il mare” e di circa un decennio dall’ancor più famoso “Ogni mattina a Jenin”, ritorna ora nelle librerie italiane con una storia intensa e drammatica, al centro della quale non avrebbe potuto non trovare spazio la terra d’origine dell’autrice.
Da lunghi decenni rimpianta e agognata, la Palestina rimane la patria perduta, luogo dove ricomporre radici e identità stravolte dall’esilio forzato a causa di quella che tuttora si chiama “an-nakba”, la Catastrofe per eccellenza del mondo arabo. Un dramma senza fine che ormai non sembra fare nemmeno più notizia. L’Abulhawa lo riporta alla ribalta proprio in un momento alquanto critico nella storia del popolo palestinese, che dal 1948 a oggi non ha conosciuto altro se non il fango e l’umiliazione dei campi profughi e speranze puntualmente deluse.
Nahr ne ha ben poche, di speranze, forse nessuna. Quando la incontriamo è una detenuta ormai ingrigita e spossata che, da lunghi anni di cui ha perso il conto, sta scontando una pena detentiva all’interno di una cella anomala che lei chiama il Cubo, dove il tempo si annulla e la luce e il buio che vi si alternano sono quanto di più innaturale possa esistere. Chiusa in questa manciata di metri quadrati di cemento armato, la donna ci racconta a poco a poco la sua vicenda, partendo dai giorni trascorsi felici sotto il sole del Kuwait, quando per lei la Palestina si riduceva soltanto a vecchie storie di famiglia, fino a quelli bui sopraggiunti dopo l’arresto da parte di Israele con l’accusa di attività terroristica; nel mezzo, disillusioni, amarezze, umiliazioni, violenze, ma anche un inatteso spiraglio d’amore di cui il mondo dimostra di essere per buona parte privo. La penna dell’autrice ritrae una donna di carattere che non si arrende dinnanzi alle brutture vissute e che, a ogni caduta, impara a rialzarsi senza piangersi addosso: una donna dai tre nomi (Nahr, Yaqoot, Almas) che si adattano a momenti e stagioni della sua vita, mentre il bisogno di avere radici e di appartenere finalmente a un luogo diviene con gli anni più impellente. Ovunque, anche là dove sembra che si possa vivere bene, la condizione di profugo presto o tardi acquisisce un sapore amarissimo diventando talvolta il capro espiatorio di situazioni esplosive, come infatti accade persino nel Kuwait all’indomani del ritiro dell’esercito di Saddam Hussein nel 1991; molto interessanti, a tal riguardo, le pagine che raccontano ciò che si è verificato nel piccolo emirato del Golfo sotto il ra’is iracheno, a dispetto della versione americana rivelatasi già in passato non affidabile.
“La gente pensa che l’occupazione irachena del Kuwait sia stata una specie di massacro, ma non è così. Gli orrori veri e propri successero quando l’Iraq se ne andò, […] Per me contava soltanto che quella notte Saddam Hussein mi aveva salvato la vita e che, durante la permanenza irachena in Kuwait, ero una donna libera e felice.”
L’io narrante della protagonista risulta molto coinvolgente e diversi personaggi, oltre a quello della stessa Nahr, si presentano ben caratterizzati; in particolare, colpisce quello della maîtresse iracheno-kuwaitiana Um Buraq che, anzitutto, squarcia il velo dell’ipocrisia sempre vigente nell’ambito delle società islamiche in fatto di prostituzione e la cui promessa di un tempo viene mantenuta nella parte conclusiva del romanzo: “Qualunque cosa accada in questo mondo ingrato, ci rivedremo, sorella mia.”
Nel complesso, dunque, la storia narrata sa catturare il lettore e gli argomenti trattati, da quelli umani a quelli politici in relazione alla causa palestinese, hanno indubbiamente un peso innegabile. Tuttavia, forse si avverte qualcosa di diverso nello stile della Abulhawa rispetto soprattutto a “Ogni mattina a Jenin”, qualcosa che non consente una valutazione del libro a pieni voti. Inoltre, ho riscontrato un paio di inesattezze che, con tutta evidenza, devono essere sfuggite al lavoro di editing: a pagina 161 si parla della città di Haifa situata di fronte all’oceano (le coste del Vicino Oriente non si affacciano sul Mar Mediterraneo?); più di una volta si fa riferimento alla preghiera islamica dell’alba chiamandola, con le parole arabe corrispondenti, “fajr salat”, che però disposte in questo modo (imputabili al testo in lingua inglese?) significano in realtà “alba della preghiera”, mentre l’espressione corretta è “salat al-fajr” (la preghiera dell’alba).
In ogni caso, “Contro un mondo senza amore” è un coinvolgente romanzo meritevole di lettura: nel solco dei precedenti lavori dell’autrice, esso ribadisce la ferma e coraggiosa denuncia della violenta arroganza degli occupanti israeliani, i quali bollano come terrorismo qualsiasi forma di resistenza da parte palestinese e, al tempo stesso, nei Territori praticano impunemente la tortura e ogni forma di abuso. Ciò che Susan Abulhawa scrive non è soltanto fiction (anche le fonti non arabe parlano delle stesse cose) e quello di Nahr, così come quello a suo tempo di Amal in “Ogni mattina a Jenin”, è l’urlo di dolore – vero, straziante, inascoltato – di un popolo intero che attende ancora giustizia e almeno un briciolo d’amore.
Indicazioni utili
Et voilà. Anzi: vualà.
Italianizzare, è questo l'imperativo. Per Anita e Clara, ventenni torinesi, storpiare italianizzando le parole straniere è un piccolo gioco privato, perché il regime fascista è, nel 1935, ancora qualcosa su cui è possibile scherzare. L'atmosfera è nebulosa, ambigua, e tutto quello che si può fare è tenere gli occhi aperti e le antenne puntate per captare i segnali di una verità oscura e minacciosa, di cui si avverte l'invisibile presenza dietro la finta verità di splendore diffusa al cinegiornale.
Lo sente Clara, studiosa e intelligente, che vorrebbe poter leggere senza censure, farsi un'opinione con la propria testa ed esprimere le proprie idee. Lo sente Anita, bellissima e un po' civettuola, che soffre le imposizioni e la mancanza di libertà. Ed è proprio un improvviso e inaspettato slancio di libertà ad indurre Anita, di fronte alla tanto anelata proposta di matrimonio da parte del fidanzato Corrado, a rispondere con una richiesta inusuale: lavorare, lavorare per sei mesi prima delle nozze. Proprio lei, che ha sempre pensato che un battito di ciglia e un sorriso fossero più utili di qualunque nozione, purtroppo anche quelle di stenografia. Proprio lei, che a scuola non ha mai mostrato interesse per le pagine scritte. Eppure, il destino e un po' di furbizia porteranno Anita a trovare impiego proprio nel mondo dell'editoria: dattilografa per una rivista di racconti hard-boiled americani.
E così, trascrivendo con la propria Olivetti quelle storie di detective stropicciati, vicoli bui e bicchieri pieni di whisky (anzi: uischi), Anita capirà perché quelle storie piacciono tanto alla gente. Perché sono belle, innanzitutto. Perché a quei protagonisti un po' malmessi ci si affeziona facilmente, con i loro problemi e le loro disgrazie in cui rispecchiare le proprie. Perché fanno ridere, mozzare il respiro, fantasticare, ma, soprattutto, accendono la voglia di investigare e stanare la polvere che si cela sotto il tappeto. Che è poi il motivo per cui esse danno tanto fastidio alle autorità, che cercano di italianizzarle e piegarle ai dettami del regime.
Anita si innamora così della lettura (e chissà, forse non solo di quella), in un percorso di crescita che potrebbe portarla lontano, a scoprire la forza di una storia e il bisogno che ha l'anima di trovare la propria voce, ribellandosi al silenzio. E, nel frattempo, io mi innamoro di questa nuova serie. Alice Basso si dimostra ancora una volta abilissima nel miscelare umorismo, romanticismo e un soffio di mistero (data l'esilità, definirla trama gialla mi pare fin eccessivo), avvolgendo il tutto in un contesto storico che offre tantissimi spunti, sul ruolo femminile, la libertà di pensiero, la difficoltà di aprire gli occhi su verità scomode e il coraggio che serve per raccontare quel che si è visto. Si tratta di intrattenimento, intrattenimento che strizza innegabilmente l'occhio alle vendite, ma a renderla una lettura accattivante e piacevolissima è l'inconfondibile tocco di grazia e freschezza, capace di regalare un sapore speciale alle pagine, lasciando all'ultima riga il desiderio di proseguire oltre.
Posso solo immaginare quanto sia difficile per un autore abbandonare un personaggio che ti ha regalato popolarità e successo, ma in questa storia ho ritrovato una vitalità e un entusiasmo che quelle della famosa ghostwriter Vani Sarca avevano a mio avviso ormai perduto. Quindi, per quel poco che conta il mio giudizio: benvenuta Anita, aspetto già la tua prossima avventura!
"La lingua può essere indisciplinata, ma il silenzio avvelena l'anima" [Antologia di Spoon River]
Indicazioni utili
Ottocento pagine di... cosa?
"Questa tempesta" è il secondo libro della seconda Tetralogia di Los Angeles, diretto successore di “Perfidia". Con questo ciclo narrativo, unito alla prima Tetralogia (che include un bellissimo libro come "L.A. Confidential”) e la Trilogia Americana, pare che Ellroy si sia proposto la grande ambizione di un affresco storico di oltre trent'anni (1941-1972), popolato da personaggi reali e di finzione che si mescolano tra loro e compaiono in diversi libri.
L'idea è certamente ammirevole, anche perché il contesto presentato è ben descritto e interessante, ovvero quello di un’America che vive la Seconda grande guerra da lontano, avendola toccata con mano solo con l’attacco inaspettato di Pearl Harbor. Altrettanto interessante è vedere come i tanto osannati Stati Uniti, sempre dipinti come liberatori senza macchia, abbiano essi stessi avuto una condotta discutibile e perpetrato nei confronti dei giapponesi una discriminazione simile a quella nazista. I giapponesi venivano infatti internati e, seppure non subissero le stesse brutalità subite dagli ebrei e dagli altri prigionieri nazisti, erano comunque maltrattati e non di rado uccisi senza alcun tipo di rimorso. Mentre in “Perfidia” questo aspetto era riuscito a farmi perdonare la troppa carne messa a cuocere dall’autore, in “Questa tempesta” tutto questo non è bastato e i motivi sono diversi.
Andrò con ordine.
Nelle prime centinaia di pagine sono sciorinati una serie infinita di nomi che l’autore ci presenta come se dovessero esserci familiari, ma che al lettore non dicono nulla e finiscono per confonderlo nei già ingarbugliati meandri della storia a cui si appresta ad assistere. Ellroy fa decine e decine di nomi, li ripete fino allo sfinimento mettendoli continuamente il correlazione tra loro e pretendendo che il lettore ne cavi qualcosa, mentre quest’ultimo sta invece tentando con tutte le sue forze di raccapezzarsi, invano. Questo aspetto rimarrà lungo tutta la storia, ma all’inizio è davvero irritante.
Quando i nomi più ricorrenti cominceranno finalmente a diventare familiari, ecco che emergono le tediosità della storia. A parte qualche raro stralcio d'azione (ben scritto, questo c'è da dirlo), "Questa tempesta" è tutto una continua ripetizione: Ellroy ribadisce le stesse cose fino allo sfinimento; tutto quello che i personaggi scoprono viene ripetuto quando un personaggio che ne era ignaro ne viene finalmente a conoscenza. Queste scoperte, poi, molto spesso lasciano totalmente indifferenti perché parte di un intrico troppo ingarbugliato per essere compreso o perché coinvolge personaggi lontani dallo spettro emotivo e cognitivo del lettore. Poche sono le rivelazioni davvero interessanti, che vengono oltretutto attutite dall’apatia che tutti gli altri eventi incomprensibili hanno generato. La storia non coinvolge mai: è troppo intricata, politica e in tutta sincerità poco interessante. Ottocentocinquanta pagine e si ha la sensazione di non aver letto nulla se non nodi e contronodi mentali: un esercizio intellettuale folle che l’autore ha fatto con la sua capacità stilistica e la sua conoscenza approfondita del periodo storico, che con questo cocktail si sono tuttavia annullate penosamente. Non si riesce a capire cosa Ellroy abbia voluto davvero raccontarci.
Per concludere, io sono un estimatore degli autori che vogliono offrire qualcosa più di un semplice intrattenimento: stimo ancora di più quelli che riescono a coniugare intrattenimento con letteratura impegnata. Anzi, vi dirò di più, è questa la letteratura che amo, e mi fa male vedere come Ellroy abbia fallito nei suoi nobili propositi, nella creazione di un contesto storico-narrativo che potesse lasciare il segno. Ma sebbene in "Perfidia" sia parzialmente riuscito nell' intento, in "Questa tempesta" credo abbia toppato alla grande e rappresenti un passo falso da cui difficilmente si possa riprendere, almeno per quanto riguarda questo ambizioso progetto. Non so se ha avuto eccessiva fiducia nei propri mezzi, se si sia lasciato prendere la mano, o abbia voluto semplicemente strafare; ma con la sua sconcertante mole non giustificata dai contenuti, "Questa tempesta" non ha generato in me altro che un sospiro di sollievo. Quando l'ho finito, si intende.
P.S. la menzione sul retro, in cui Joyce Carol Oates definisce Ellroy il Dostoevskij americano, è oltremodo offensiva nei confronti sia del russo, che di autori americani davvero meritevoli come Cormac McCarthy, che definisco il Dostoevskij americano da una vita. E io non sono nessuno. Davvero non capisco come personaggi di spicco possano fare affermazioni così azzardate.
“Tutti vogliamo essere qualcosa di più bello e dorato di quello che siamo.”
Indicazioni utili
Buon appetito!
"Il mondo ipocrita non vuol dare importanza al mangiare; ma poi non si fa festa, civile o religiosa, che non si distenda la tovaglia e non si cerchi di pappare del meglio" [“La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene”, P. Artusi]
Chissà cosa penserebbe Pellegrino Artusi dei giorni nostri, in cui la cucina ha guadagnato un ruolo da protagonista, imperversando nei programmi televisivi, in libreria e persino nelle conversazioni quotidiane? Chi poi durante questo periodo di lockdown non si è trovato, come si suol dire, con le mani in pasta, alle prese con pane e focacce?
Mi piace immaginarlo guardare con un sorriso sornione, nascosto dai baffoni austro-ungarici, tutti i veri e presunti chef di oggi, lui che ha codificato l'arte di mangiare in modo pratico e semplice, per gente che sapeva tener giusto in mano un mestolo, agiata gente borghese, che non disdegnasse il viver bene e il goder della tavola. Come lui.
Nel suo famosissimo libro di fine Ottocento, Artusi scrive di gastronomia per riabilitare l'arte del gusto, affiancando alle ricette un companatico fatto di spirito benevolmente gaudente, di tanti aneddoti e di un pizzico di scienza. Marco Malvaldi non poteva quindi rendergli oggi omaggio migliore se non preparando un romanzo a base di quegli stessi ingredienti.
La piacevolezza. Perché, se nella prefazione al suo ricettario, Pellegrino augurava ai "nevrotici lavoratori di cervello" un po' di aria fresca e un buon manicaretto, Malvaldi sembra augurare qualche ora spensierata in compagnia di pagine divertenti e ironiche, talvolta un tantino insolenti magari, ma sicuramente in grado di regalarci qualche genuino sorriso.
Il gusto di raccontare. Prima di tutto, la trama gialla, ben costruita e intrigante, in cui il sempreverde enigma della camera chiusa si fonde al fascino di un castello toscano con i suoi imprevedibili ospiti. Ma anche molto altro: la decadenza dell'impero Ottomano a inizio Novecento, i primi esperimenti imprenditoriali italiani, l’atmosfera della “belle époque” e, infine, qualche personaggio storico come appunto Pellegrino Artusi e il suo amico professor Mantegazza, che arricchiscono la narrazione con qualche curioso aneddoto attinto dalla loro vita.
Ed infine, non manca una bella strizzata d'occhio alla scienza. Per il chimico Malvaldi dev'essere stato bello poter dare un po' di rilievo proprio a questa scienza, rivelandone l’essenziale utilità tanto nell'arte di cucinare quanto in quella di confezionar omicidi.
Non so se questo sia uno dei migliori scritti del simpatico e colto scrittore toscano, in altri romanzi i personaggi, soprattutto quelli a contorno, mi sono parsi meglio costruiti e il passo più felicemente ritmato. Rimane comunque una lettura gustosa e saporita, che consiglierei a tutti quelli che amano il giallo, umoristico e storico, e a tutti quelli che amano Pellegrino Artusi, che qui rivive in tutto il suo spirito di ironico ottantenne romagnolo.
Indicazioni utili
Sopravvissuta.
«La morte è sempre a un passo da noi. Ed è davvero solo un piccolo passo, pensai.»
Un bastone di ferro conficcato nella pancia, una preghiera: fa che Yoichi viva. Una speranza, cioè, che l’ultimo soffio di vita vada a lui perché gli occhi della donna hanno visto, hanno assaporato paesaggi stupendi e una miriade di istanti, perché ella ha avuto un tetto sotto cui dormire, due bravi e premurosi genitori, tanti sorrisi, pasti lauti e soddisfacenti, un corpo sano e forte. Il sogno, il nonno e le sue parole. La consapevolezza di essere lei, Sayoko, la sopravvissuta. Perché Yoichi è morto sul colpo con le parole dolci e a voce bassa cantate dall’amato Leonard Cohen.
All’epoca la protagonista aveva ventotto anni e ancora credeva che la vita potesse durare in eterno, che l’amore e la possibilità di realizzare i propri desideri fossero una verità improcrastinabile. Aveva da tempo una relazione a distanza con l’uomo, lui residente a Kyoto e lei a Tokyo. L’incidente è avvenuto lungo la strada per Kamigamo dove si trovava l’appartamento del defunto che fungeva anche da suo studio. Una relazione, la loro, anche per ragioni lavorative, non ben vista dai genitori di lei che confidavano in quella distanza quale possibilità di una separazione. E la separazione è avvenuta, ma per altro motivo. Le loro vite si sono spezzate, si sono divise inesorabilmente e mai potranno riunirsi. Ella non mancherà mai di risentire nella sua pancia la sensazione di quel ferro arrugginito, non potrà mai dimenticare quelle sensazioni. Anche se il dopo lo ha vissuto come se si trovasse in una bolla di sapone. La perdita del suo Mabui, la ricerca. Ma cosa ne è di chi resta?
«Avevo anch’io un effetto sul mondo. E non lo sapevo. La luce che emanavo mi veniva restituita in egual misura. A volte era un luccichio, a volte un bagliore, come un’onda, come l’eco. Per quanto insignificante fosse la mia presenza, le mie emozioni erano in grado di mettere in movimento tutto il resto. C’era un intero mondo, invisibile agli occhi, in cui le cose avvenivano, e cambiando prospettiva potevo vederle: ecco che cosa avevo imparato dall’altra parte.»
Ambientato tra i templi e gli onsen di Kyoto, l’ultimo lavoro di Banana Yoshimoto è scritto all’indomani del terremoto e dello tsunami di Fukushima e non è altro che un inno alla vita, alla speranza. Perché chi sopravvive a una catastrofe, a un qualcosa che colpisce qualcuno che abbiamo al nostro fianco, un nostro affetto, una persona cara subisce gli effetti del contraccolpo, della perdita. E non perde soltanto quell’affetto emblema di un legame, perde anche tutto quel che quel legame può significare, ivi compreso il senso della propria esistenza, la ragione del proprio vivere.
«Ognuno di noi vive la propria vita portandosi dietro il peso del dolore che ha provato. Ci sono anche quelli che non provano niente e che non portano alcun peso: basta un’occhiata per capire chi sono. Sembrano automi, sono diversi dagli altri. Quelli che portano un peso li riconosci dal colore, dall’incedere pieno di grazia. Ecco perché sono contenta di avere un peso da portarmi dietro. Finché avrò giorni da vivere, voglio vivere con grazia.»
Chi sopravvive si porta dietro un dolore che fa parte di un bagaglio che non può essere scardinato e che lo colloca in una dimensione diversa da quella vissuta da chi non lo ha mai provato. Banana ci ricorda quanto può essere flebile la vita, quanto non possa essere altro che un alito, un soffio di vento ma anche quanto sia importante viverla. Viverla in ogni secondo, in ogni anfratto, in ogni piccolezza, in ogni alto e basso. Alla ricerca del proprio Mabui perduto, alla ricerca del proprio posto nel mondo.
«Non è affatto salutare, ma è la vita, non c’è altro modo di spiegarlo. Alla fine le persone, ovunque vadano, fanno incontri, incontri che non potrebbero fare se non fossero vive. […] Avevamo tutto, eravamo fortunati. Da vivi o da morti non ci manca mai niente. Non manca niente a nessuno. Si deve morire per riuscire a rendersene conto.»
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 25 Giugno, 2020
Opinione inserita da ornella donna 25 Giugno, 2020
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La strage di Jonestown del 1978
La congregazione di Alessandro Perissinotto si ispira ad un fatto di cronaca, realmente accaduto. Il fatto è noto come il massacro di Jonestown del 1978, dove viene annientato il progetto del Tempio del Popolo, elaborato dal reverendo Jones. Fu il più grande suicidio collettivo della storia moderna e vide la morte di più di 900 membri di una setta religiosa, che volontariamente o comunque sotto costrizione si uccisero assumendo dosi letali di veleno. Alessandro Perissinotto prende spunto da un gatto di cronaca del passato per elaborare, con puntigliosità e sapienza letteraria, un perfetto thriller intrigante ed appassionante.
La vicenda narra di come Elizabeth, detenuta con cavigliera elettronica, sceglie di scontare la sua pena a Frisco, Colorado. Lì ha ereditato il vecchio cottage appartenuto a sua zia, una donna poco amata da tutti, di cui lei serba un ricordo alquanto sgradevole. Il suo progetto di recupero le impone anche un lavoro alla stazione di servizio locale, che per lei, una ex spogliarellista, rappresenta l’avvio verso una nuova vita. Lei è:
“Una donna che aveva sempre camminato sulla linea sottile che separa l’arte di arrangiarsi dal crimine vero e proprio.”
A guastare un quadro così idilliaco una serie di messaggi inquietanti, che vanno dall’introduzione forzata in casa sua, alla sua stessa devastazione totale successiva, ad una cartolina bellamente posata dove non dovrebbe essere. Per la protagonista un ritorno inevitabile ad un passato che lei ha cercato in tutti i modi di superare . Da dove viene questa minaccia? E perché costui la perseguita dopo quarant’anni? Elizabeth riuscirà a superare tanto dolore per tornare a vivere?
Un libro che per struttura e prosa ricorda i thriller americani ad alto tasso adrenalinico. Un mix potente di realtà e fantasia: la strage di Jonestown è descritta con perizia storica:
“La vicenda di questa setta punta a una follia di massa di fronte a cui crollano i canoni del crimine e della psichiatria.”
La prosa è fresca, e tagliente, trascinante ed adrenalinica. I personaggi descritti bene senza troppi fronzoli per una trama ben congegnata. Una lettura che trascina lontano il lettore, in un episodio tragico della Storia americana, secondo solo a quello delle Torri Gemelle, che si libra alto nel cielo con forza narrativa non comune. Un confine sottile tra realtà e fantasia per un romanzo assai intrigante, costruito con la tecnica di continui flash back su e giù lungo il tempo, che provocano nel lettore un forte impatto emotivo.
Indicazioni utili
| 1719 risultati - visualizzati 201 - 250 | « 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 35 » |