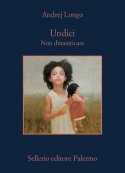Le recensioni della redazione QLibri
| 1719 risultati - visualizzati 101 - 150 | « 1 2 3 4 5 6 ... 7 35 » |
Ordina
|
Terzo conflitto mondiale e crisi planetaria
«L’ho visto con i miei occhi. […] Il bambino dimagrisce, ma all’inizio non sembra una cosa grave. Poi si ammala. Magari è un’infezione di quelle che prendono tutti i bambini, con le macchie sulla pelle, il naso che cola o la diarrea, però il piccolo denutrito ci mette di più a riprendersi e si ammala di nuovo. È sempre stanco e piange in continuazione, smette di giocare, se ne sta sdraiato e tossisce. Poi un giorno chiude gli occhi e non li riapre più. E certe volte la madre è troppo stanca per piangere.»
Quando ci avviciniamo a un romanzo di Ken Follett, che sia esso politico, storico, thrilleristico o del genere narrativo, siamo sempre consapevoli di trovarci innanzi a un qualcosa di difficilmente banale e ancor meno scontato. Con Follett abbiamo riattraversato gli anni del Novecento, abbiamo assaporato nel dettaglio i due Grandi conflitti, abbiamo rivisto le conseguenze della Guerra Fredda, siamo giunti a Barack Obama e ai cambiamenti che già la sua nomina ha comportato, ma siamo tornati anche negli anni medievali con un’altra trilogia altrettanto importante e bella quale quella che ha avuto inizio con “I pilastri della terra”. Follett, ancora, ci ha accompagnato in un viaggio altrettanto avventuristico e immaginifico con una serie di scritti più o meno recenti anche proprio intrisi di una caratteristica poliziesca e ha sempre e immancabilmente costruito personaggi solidi capaci di farsi amare quanto odiare.
Giunge adesso in libreria con “Per niente al mondo”, opera dal titolo originale “Never” che in Italia è stata edita da Mondadori e che ha visto la pubblicazione planetaria in contemporanea il 9 novembre. Così negli Stati Uniti come nel resto del pianeta. Follett tra queste pagine ci ricorda quanto il Primo conflitto mondiale sia stato terrificante, per la sua portata ma anche per la sua nascita così inaspettata quanto prevedibile, quanto ancora studiata, quanto ancora anticipata da segnali ritenuti inoffensivi, quasi sciocchi. Ma cosa accadrebbe, si chiede e ci chiede questo, laddove si manifestasse una Terza guerra mondiale? Non una Guerra Fredda tra equilibri precari ma solidi nel loro essere glaciali, una guerra, al contrario, dettata da interessi diversi e frutto di chissà quali paesi e quali interessi sottesi. E in uno scenario ove il mondo è sul baratro della sua fine, dove una guerra devastante è il risultato possibile di un attentato terroristico in una località africana dimenticata da Dio, come muoversi? Come sopravvivere?
Ancora una volta, esattamente come nelle trilogie più famose quali la trilogia del Novecento, le vicende si sviluppano per il tramite di più voci e più precisamente di quattro personaggi che alternano la loro narrazione e che per mezzo del loro narrare portano a ricostruire il puzzle delineato dal romanziere.
Le vicende si aprono proprio alla Casa Bianca ove è stata eletta la prima Presidente donna, Pauline Green, repubblicana. Costei è colei che dovrà prendere le decisioni più complesse anche nel caso e nell’ipotesi di una guerra nucleare. Perché soltanto lei ha il potere di attivare il meccanismo. Nel frattempo, nel Sahara, due agenti segreti d’élite si trovano a dover rintracciare un gruppo di terroristi dediti al contrabbando di droga. Ma cosa succede quando il lavoro si mescola con l’amore e il sentimento può mettere a rischio anche le rispettive carriere? E cosa succede, ancora, se un dittatore golpista africano di nome Kim Jong Un, detto il generale, prende possesso del Ciad e nel suo utopico illusionistico scenario pensa di essere al pari delle grandi potenze mondiali? Altresì, in Cina, assistiamo alla diatriba tra un funzionario del governo molto ambizioso, per se stesso ma anche per il paese in cui vive, e i residui di un governo comunista mixati all’ipotesi di una guerra che potrebbe coinvolgere anche la Corea del Nord. Inequivocabile la parafrasi fra Kang U-Jung, presidente in carica della Corea del Nord, con il noto Kim Jong Un.
A far da cornice e sottofondo, una serie di reti e legami che intrappolano il mondo in una complessa rete di alleanze fatta di pesi e contrappesi in cui a far da padrone è la complessità dei rapporti politici. Il risultato è quello di un thriller in chiave geo-politica in cui viene fatta una perfetta fotografia della società contemporanea. Il tutto tra una serie di colpi di scena che nulla risparmiano al lettore che se da un lato è incuriosito dalle vicende che trattano i personaggi dall’altro è chiamato alla riflessione per quello che tra queste pagine è racchiuso a livello di attualità.
L’autore sembra ricordarci quanto sia impensabile talvolta lo scoppio di una guerra, quanto questo possa derivare anche da piccole inezie, da piccoli passi falsi apparentemente innocui. Follett, ancora, ci ricorda quanto questa si ripeta, quanto questi avvenimenti banali che viviamo anche nel nostro quotidiano che diventa storia, poi banali non siano.
Non mancano le ambientazioni geografiche, non mancano le caratterizzazioni dei personaggi, non mancano quegli aspetti più propriamente propri dello scritto follettiano in tutte le sue forme e modus operandi. Lo stesso vale anche per la tecnica narrativa abbracciata dal narratore e ormai diventata metodo di studio per tanti autori contemporanei e aspiranti tali.
Ecco allora che Follett ancora una volta stupisce, spiazza e scuote. Nel bene e nel male. Abbracciando una diversa forma di romanzo, storico ma anche contemporaneo, raccontando con molta semplicità una crisi globale che minaccia di sfociare in una Terza guerra mondiale e i cui segnali potrebbero già essere stati disseminati.
«Appoggiò le braccia sul tavolo e chinò la testa. Pensò ai morti e a quelli che stavano morendo alle Hawaii, a coloro che presto sarebbero morti in Cina e subito dopo nelle grandi città degli Stati Uniti. Strinse forte gli occhi, ma continuava a vedere quelle immagini. Ogni compostezza l’abbandonò, come il sangue in un’arteria recisa. Fu assalita da un dolore così travolgente e disperato che cominciò a tremare. Le parve che il cuore stesse per scoppiarle e pensò che poi sarebbe morta. E poi, finalmente, cedette alle lacrime.»
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 17 Novembre, 2021
Opinione inserita da ornella donna 17 Novembre, 2021
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il sottile confine tra vita e morte
Guillaume Musso torna in libreria con un libro intitolato La sconosciuta della Senna, edito dalla casa editrice La Nave di Teseo. Un romanzo complesso, che non smette di stupire, anche nello stesso, curioso, finale.
Siamo a Parigi, in prossimità del Natale, e Roxane, capitano in odore di sospensione, è costretta a confinarsi:
“Il problema riguardava lei. Da parecchi mesi si era inoltrata in un tunnel senza fine. (…) il suo destino, ormai, la proiettava lontano dai confini della polizia nazionale.”
Visti i suoi precedenti meriti le è, comunque, concesso una possibilità di redenzione. Farà parte del BANC, ovvero:
“Il Bureau des Affaires Non Conventionnelles è stato creato nel 1971, dipende direttamente dalla prefettura di polizia. All’inizio il suo obiettivo era indagare sui casi un po’ insoliti per i quali la polizia giudiziaria non riusciva a trovare risposte razionali. (…) Ma l’avvento al potere del partito socialista e l’evoluzione della società hanno cambiato la natura dell’Ufficio, progressivamente utilizzato come punto di raccolta di poliziotti malconci o in affanno dopo un’irregolarità.”
Facente parte di tale struttura, Roxane dovrà occuparsi di un caso sensazionale: una ragazza viene trovata nuda nella Senna. E’ salva, ma non sa neppure chi è. Viene condotta all’ospedale, ma riesce a scappare. Riuscirà Roxane a trovarla? E perché è scappata?
Ma non è finito: dagli esami emerge una verità che ha dell’incredibile. La ragazza è, senza ombra di dubbio, tale Milena Bergmann. Ma come è possibile? Un dato non torna: la famosa pianista Milena è morta in un incidente aereo un anno prima. Come si spiega? E’ al contempo viva e morta. Come può accadere un fatto simile? Se lo domanda anche lo stesso fidanzato di Milena, lo scrittore Raphael Batailley, che dal canto suo ha una pletora di segreti a cui attingere …
Una storia che intriga, e che trae spunto da un fatto realmente accaduto. Negli anni Ottanta, infatti, una giovane donna non identificata, morta in circostanze non chiarite, fu ritrovata senza vita tra le acque della Senna presso il Quai du Loure. Una donna così bella da indurre un dipendente dell’obitorio a realizzare un calco in gesso per immortalarne il viso. Questa maschera sarebbe poi stata replicata fino a diventare una sorta di icona letteraria, che ritroviamo nella Parigi bohemienne degli anni Venti e Trenta.
Partendo da questo fatto l’autore costruisce una trama perfetta, ricca di malia e di mistero. Parigi è descritta minuziosamente, anche nei piccoli dettagli:
“Si era messo in moto un ingranaggio mortale che spingeva la gente a detestare coloro che erano stati designati per proteggerla. Nei centri delle città costoro tendevano imboscate, assediavano i commissariati, insultavano i poliziotti nelle manifestazioni, gli tiravano addosso pietre e molotov in piena Parigi. I loro figli andavano a scuola, con lo stomaco rattrappito dalla paura, le loro famiglie si sfaldavano e, sabato dopo sabato, manifestazione dopo manifestazione, le reti d’informazione, con oscena delizia, li facevano passare per nazisti.”
Una storia nella storia, animata da personaggi misteriosi, le cui personalità sono spesso indefinite, buie, tortuose. Nulla è mai ciò che sembra e i colpi di scena sono tanti ed inaspettati. La trama è intricata e complicata, i misteri si susseguono. In definitiva una vicenda in cui il lettore è, abilmente, accompagnato in un vortice di sensazioni e di emozioni cui soltanto lo scioglimento della storia trova una sua naturale spiegazione. O no?
Per gli amanti della suspence e dell’inspiegabile.
Indicazioni utili
Bello, ma non un capolavoro
Stephen King ci riprova col thriller, abbandonando per un attimo quello che da sempre è il genere in cui rende meglio, ovvero quello orrorifico fantastico. C'è da dire che i suoi romanzi che preferisco - "Il miglio verde" e "22/11/'63" - sebbene presentino importanti espedienti narrativi fantastici, hanno un tono realistico simile alle sue prove thrilleristiche. Tuttavia, in questo genere il Re ha anche avuto dei grossi strafalcioni, principalmente rappresentati dalla trilogia che ha come capostipite il romanzo "Mr. Mercedes", di certo non il suo lavoro meglio riuscito.
"Billy Summers" si infila in mezzo a questi capolavori e sfondoni, risultando un romanzo piacevole da leggere e in certi tratti avvicente, ma lontano dal rivelarsi davvero indimenticabile.
A livello stilistico è il King di sempre, scorrevole, anche se forse meno evocativo del solito, ma questo è ovviamente dovuto al genere di appartenenza del romanzo. La struttura narrativa presenta un elemento interessante e innovativo - oltre che sorprendente nel finale - che permette all'autore di intrecciare il main plot con una storia secondaria che fa al tempo stesso luce su quello che è il passato del protagonista; un espediente apprezzabile soprattutto da chi è appassionato di scrittura, seppure ben lontano dall'essere considerato come un qualcosa di accostabile al saggio-biografia "On writing", come fanno in una delle immancabili ed esagerate marchette in quarta di copertina.
La storia si concentra su Billy Summers, cecchino reduce della guerra in Iraq, che al suo rientro decide di diventare un sicario che, tuttavia, accondiscende ad eliminare soltanto gli obiettivi che siano degli "uomini cattivi". Forse un idea un po' banale per addolcire e generare empatia per la figura del protagonista, ma tant'è. L'incarico per il quale verrà chiamato e che sarà al centro dell'intreccio di questo romanzo è anche quello meglio remunerato e pericoloso, oltre che l'ultimo che Billy vorrà intraprendere prima di ritirarsi definitivamente dalle scene. L'elevato premio per il conseguimento di questo compito non è dovuto all'importanza sociale dell'obiettivo da eliminare - che in fondo è un assassino da quattro soldi - ma per le informazioni che quest'ultimo dice di possedere, che possono mettere nei guai alcuni pezzi grossi. Oltretutto, Billy dovrà assumere un'identità di copertura per diversi mesi: dovrà fingersi uno scrittore impegnato nella scrittura di un romanzo, che ha il suo ufficio in un grosso edificio che affaccia proprio sul tribunale in cui, in un giorno imprecisato, l'obiettivo dovrà essere condotto. Per rendere più credibile la copertura, Billy questo romanzo dovrà scriverlo davvero e per lui, che si è sempre finto tonto di fronte ai suoi referenti della malavita ma è in realtà un amante della bella letteratura e in particolare di Émile Zola, è qualcosa di incredibilmente eccitante.
Si dedicherà dunque a questo "roman à clef" che prende spunto dalla sua biografia, che rappresenterà l'espediente narrativo di cui parlavamo prima e che darà vita a un interessante colpo di scena, probabilmente il punto più interessante e intelligente del romanzo.
Un libro che sa intrattenere, ma è ovviamente lontano dai capolavori del passato.
“Ecco che cos'ho imparato nella Casa della Ripittura Eterna: che non esistono solo 2 categorie di persone, i buoni e i cattivi, come pensavo quando ero un ragazzino che prendeva quasi tutte le sue idee dal modo in cui si comportava la gente in televisione. Ce ne sono 3, invece. Il terzo tipo di persone si adatta e tira a campare, come mi aveva detto di fare l'agente F.W.S. Malkin. Rappresenta la maggioranza, e io credo che il suo colore sia il grigio. È gente che non ti farà mai del male (almeno, di proposito), ma che non ti darà mai neppure una mano. Ti dirà sempre fai quel che vuoi e che Dio ti aiuti.”
Garlaschelli feat Miller
Si lamentano della mia pelle fredda, per forza ripeto.
Un tempo ero di pietra.
Osservano che sono terribilmente pallida, certamente asserisco ogni volta.
Un tempo ero di pietra.
Lasciatemi libera, portatemi al sole. Il sole scalda la pietra.
Rivisitazione in chiave moderna del Mito di Galatea e Pigmalione, è un racconto che vorrebbe parlare di un amore controverso. Di esercizio del potere e di sottomissione, di solitudine, umiliazione e sofferenza, di candore e coraggio. Di bellezza, di maschilismo, di una ragazza dalla pelle algida, della dolcezza di una madre. Di un uomo in carne e ossa con un cuore di marmo e di una donna di pietra, con un cuore pulsante.
Vorrebbe, scrivo obbligata al condizionale, poiché buono sarebbe il potenziale se il contenuto fosse sviluppato opportunamente.
Il nome di Miller come autrice permeava di una certa sicurezza il lettore inconsapevole che è in me. Ebbene, dimenticativi della penna voluttuosa e corposa della scrittrice di Circe -che avevo divorato- questo è un raccontino appena schizzato e nemmeno troppo bene, purtroppo.
Breve e con una penna poco curata, da solo non avrebbe potuto essere pubblicato ed infatti il volume è accompagnato dalle belle illustrazioni di Ambra Garlaschelli, specializzata in arti visive.
Chiamiamo le cose col loro nome, più che un embrione di Madeline Miller corredato delle immagini dell’italiana, lo definirei un piacevole albo di Garlaschelli, argomentato da un cenno letterario di Miller.
Consiglio vivamente di sfogliarlo in libreria, piuttosto che acquistarlo on line. Credo sia il modo migliore per valutare se possa essere un libro adatto ai propri gusti o meno, non avendo nulla a che vedere con la produzione precedente dell’americana. Diversamente, se amate la grafica, sono immagini molto belle, appassionate ed evocative.
Vita e morte tra quelle mura
Una vetusta dimora storica è un luogo che desta ricordi, le pareti hanno accolto e ascoltato storie di vita, si sono impregnate di fragranze, le stanze sono mute testimoni di passioni e vendette, di lacrime e sorrisi.
Simona Vinci parte dalle mura datate e misteriose di una villa situata nella pianura bolognese, per ricostruire in parte le reali vicissitudini dei proprietari che l'hanno abitata a cavallo tra Ottocento e inizio del secolo successivo, intrecciando il documentato con altri piani temporali e con personaggi di fantasia.
Le immagini frammentarie ed immaginate della vita della mezzosoprano Giuseppina Pasqua, contemporanea di Verdi, che ha realmente attraversato queste stanze insieme al consorte, il baritono Giacomelli, si mescolano con una storia di coppia attuale, di passione e di solitudine, di morte e di rinascita.
Un romanzo dalla struttura complessa, studiato nella forma e nei dettagli storici utilizzati, pervaso da un'aura cupa che smorza ogni slancio di ottimismo; a tratti visionario e astratto sembra inghiottire il lettore in un buco nero, ricalcando il climax tipico del romanzo gotico.
La stratificazione temporale che mescola periodi e volti in maniera rapida, crea un gioco di specchi seducente, obbligando il pubblico ad una decriptazione dei significati sottesi.
Un'analisi di due mondi distinti ma in simbiosi, quello dell'anima di una dimora e quello intimo e spirituale di chi la abita. Una connessione intrigante e misteriosa, un flusso di sensazioni e di scambi, la creazione di un unico corpo.
Una riflessione sui luoghi in cui trascorriamo le nostre esistenze, sul calore o sul gelo che vi alberga all'interno, sui destini incrociati tra la luce della vita ed il terreo della morte.
Indicazioni utili
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Via dell'alba
Il cielo è al di sopra del tetto,
così azzurro, così calmo!
Un albero, al di sopra del tetto,
culla il suo ramo.
Inchiostro simpatico è un romanzo che parte dall' indagine su una donna scomparsa. Su di lei si hanno poche informazioni, quasi tutte sbagliate. Il capo dell’agenzia investigativa dà lui stesso informazioni inesatte al narratore, e più che un investigatore sembra qualcosa di diverso, a me sembrava una specie di angelo che indica una direzione e un destino o una missione. Il narratore lavora nell’agenzia solo per breve tempo, ma ruba il fascicolo quando si licenzia avendo per il caso una sorta di fascinazione.
In realtà il romanzo non è poliziesco, l’indagine è un pretesto per percorrere quello stato d’animo particolare che subentra nella mente quando i ricordi si cancellano e si cercano tracce de passato. E’ uno stato sospeso che ricorda una giornata di nebbia, una giornata che sembra prolungarsi nel tempo o essere senza tempo e tendere all’infinito. Così come il passato perso nella memoria non è perso ma è come scritto in inchiostro simpatico, per cui c’è una tensione in noi che sfugge al presente e tende all’eterno. Questa tensione è resa non con riflessioni filosofiche ma con una scrittura malinconica e piena di echi emotivi, molto interessante. Nelle ultime pagine il narratore cambia e si viene a capo del mistero. A me invece sarebbe piaciuto continuare a sentire la voce di lui fino alla fine.
Indicazioni utili
Ricerca e serenità ma anche equilibrio
«Passando sfiorò una mano a Fausto, e Santorso avrebbe preferito non notarlo. Non gli piacevano i fatti degli umani. Preferiva i fatti dei lupi, delle volpi, dei galli di montagna.»
Il suo nome è Fausto e da poco il suo rapporto amoroso con la compagna di una vita è venuto a sgretolarsi. È alla ricerca di lucidità e di serenità quando decide di tornare alla natia Fontana Fredda, luogo che conosce sin da bambino. Un legame che si sgretola nel silenzio, forse perché semplicemente aveva raggiunto il suo naturale estinguersi.
«Ci pensi mai agli altri, mentre fai la tua decrescita felice?»
È qui che Fausto si dedica alla cucina presso il locale di Babette, luogo dove egli incontra anche Silvia. Colei che ha finito di studiare, che ha un passato come libraia, colei che sta sperimentando la vita mentre tra quei tavoli serve. La stessa Babette è fuggita da Milano seppur molto tempo prima, la stessa Babette è alla continua e ancora costante ricerca di quel calore.
E poi c’è lui, Santorso. Lui che ci vede lungo anche se beve troppo. Colui che mai avrebbe pensato di potersi affezionare a quel forestiero schivo e dai modi spicci.
È in questo contesto che Fausto inizia piano piano a ritrovare il piacere per le piccole cose, che assapora il tepore di un corpo al suo fianco, un corpo con cui impara a fare l’amore a “modo nostro” ogni volta, che impara ad assaporare il piacere per la cura degli altri. È tra questi boschi che ritrova la sua serenità. Nella natura, tra il profumo dei tronchi, tra gli aromi del tempo che passa e le vette che osservano, tra il desiderio di tornare a respirare e a osservare proprio da quelle vette e da quelle altezze.
«Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di miracolo.»
Ed ecco allora che prende forma e avvolge “La felicità del lupo”, scritto nato in tempo di Pandemia proprio quando allo scrittore che tra queste pagine si respira nella sua essenza, quella montagna viene impedita, vietata, ostruita. È un libro dove i corpi faticano ma tornano anche a riaffiorare, è un libro dove vi è emozione e similitudine con il luogo in cui si vive e con la ricerca che si pone in essere. È una ricerca costante di noi stessi in un contesto dove non serve il superfluo per ritrovarci. Anche per questo “La felicità del lupo” è uno scritto che trasmette serenità. In questa voglia costante di camminare e muoversi, di cercarsi e cercarci, di appellarci a ogni singolo nostro appiglio anche se l’appiglio umano non serve o non c’è.
«Il motivo è che sto bene dove sto. Il mare è verde e c’è un cormorano nero che ha scelto come casa lo scoglio qui sotto, è da stamattina che lo osservo. Provo quel senso di respiro che ti può dare un paesaggio nuovo, e che da tanto tempo non provavo.»
Amore per le montagne, desiderio di cambiare vita, desiderio di ricominciare e di trovare una propria serenità. Sono questi gli elementi che compongono l’ultimo scritto di Paolo Cognetti, opera dal grande contenuto autobiografico, dove si respira interamente Cognetti in ogni personaggio e luogo, scritto nato ancora in un periodo storico altrettanto particolare; eppure, intriso di profonda serenità. Breve ma lascia il segno.
Indicazioni utili
IL RESTO DI NIENTE
L’ultimo felice lavoro di Chiara Gamberale è un racconto di contenuti e contenitori, di piatti pieni o miseramente vuoti, di abbondanza e carestia.
Di figure e persone, personaggi e protagonisti.
Una storia che comprende madri e padri, figli e famiglie, eventi e accidenti; povertà e ricchezza, amicizie e amori, passeggiate a manina o passioni sensualmente travolgenti.
Ancora: la vita come accade, i Natali, le Pasque, i Capodanni, le relazioni furtive, le emozioni nascoste, le canzoni dell’epoca, i tristi e miseri rotocalchi televisivi di gran successo, le chat di gruppo e i gruppi di lavoro, le unioni riuscite o disunite, le apparenze da salvaguardare, le scelte rimandate all’infinito nei tempi a venire, di tutto, di più. O meglio, tutto o niente.
Croce e delizia, come è sempre l’esistenza: poiché più spesso croce, allora è un’esistenza stile “mai una gioia”, senza niente. Senzaniente. La saga dei senzaniente.
Solo che a scriverlo tutto questo, ed a scriverlo bene, compenetrandoci con il narrato della protagonista principale, dandole un senso ed una morale, rendendolo una bella lettura, una buona storia scritta meglio ancora, è una scrittrice forte, agile, fluente, che ci riporta adesso qualcosa.
Chi conosce i titoli precedenti dell’autrice, ne riconosce un paio da quanto appena detto, che esemplificano al massimo il senso dell’ultimo lavoro.
Poiché questo romanzo è uno step successivo, un gradino qualitativamente più alto di quello già eccelso di partenza, qui la scrittrice romana appare più matura, completa, profonda.
“Il grembo paterno” di Chiara Gamberale è un ben più di adesso e qualcosa: lo è perché dice molto, non solo qualcosa, e andando su e giù nel tempo, non solo adesso; per i tempi oscilla tra adolescenza e maturità, per la quantità enumera tutto quanto costi e comporti il passaggio dall’uno all’altra condizione, e viceversa.
La protagonista, Adele, dapprima adolescente e poi giovane donna, col suo narrare in prima persona, che pare un continuo intercalare da un punto all’altro, di palo in frasca, dice il suo e un attimo dopo ripete il detto altrui o i rumori di sottofondo della scena con una onomatopea impressionante, ci porge in realtà un discorso preciso, un descrivere accurato, un eloquio diretto mirato al dunque, con il proprio idioma, i suoi modi di dire particolari ed intensi, talora struggenti nel riportare il suo vissuto.
Chiara Gamberale, con sensibilità e pudore, soprattutto con rispetto e riguardo, si pone in ascolto di quanto la sua protagonista le confida da pari a pari, da donna a donna, e lo fa con attenzione, cioè proprio con l’attributo che sempre è mancato a Adele: l’attenzione.
Tutti necessitiamo di attenzione, e di tutto quanto questo comporta, perché tutti noi per indole ci innamoriamo, le donne più degli uomini, le bambine addirittura iniziano prestissimo innamorandosi del principe azzurro più bello del mondo, il proprio papà, e non vedono l’ora di crescere per poterselo sposare, e guai a chi, senza merito, senza ruolo o virtù, osa mettergli gli occhi addosso.
Tutti ci innamoriamo, prima o poi, più prima che dopo, tutti abbisogniamo di interesse, premura, riguardi, la vita stessa pretende che i viventi si innamorino, e l’amore inevitabilmente, quasi per definizione, ci rende fragili, cagionevoli, vulnerabili, e ciò che si incrina pretende attenzione per non infrangersi, forse silenziosamente o in modo attutito, ma sempre dolorosamente.
Crescere significa coltivare un terreno brullo, serve il giusto concime, l’amore, in mancanza del quale il grano soffoca e la malerba prospera.
“…Quello che ci guarisce, è quello che ci ammala.”
“Il grembo paterno” in estrema sintesi altro non è che un ribadire forte di quanto il contesto in cui si cresce affettivamente influenzi il nostro divenire, quello di chiunque, permettendo un equilibrato evolversi della persona o, all’inverso, lasciandoti letteralmente senza niente.
Perché nessuno nasce imparato, e ciascuno è una tabula rasa all’origine dell’esistenza, possiamo efficacemente forgiarne l’anima, riempiendo il quadro vitale di cenni lievi, colorati con brio o a tinte dolci, lineari, affettuose, educare coloro affidati alla cura parentale con attenzione, comprensivi, coerenti, partecipi e presenti. Fornirli di un bagaglio di immagini e sensazioni positive con cui alimentare la loro crescita, la loro autostima, perché sbaglino tranquillamente mille volte nell’imparare a vivere, e ogni volta riprendano il cammino, con le ginocchia sbucciate e l’animo più forte ed esperto, sempre fiducioso nel meglio a venire.
“…nessuno ha quello che si merita: ma ognuno di noi può avere quello che spera di meritare.”.
Perciò chi cresce figli con relativi onori ed oneri deve tracciare nei particolari disegni a linee graziose, accurate, idonee a rendere un insieme gradevole, confortevole, delizioso, per delineare non un quadro idilliaco, sarebbe utopistico, troppi i parametri da far collimare alla perfezione, ma più spesso un habitat semplicemente umano, un lessico familiare normale nelle intenzioni e nelle azioni.
Succede invece che, a colpa o a ragione, qualcuno si ritrovi purtroppo a vergare graffi rabbiosi, con tinte nere, distribuite a caso con spatole a punte scheggiate, in grassetto feroce: ne deriva allora una tela cupa quando non lacerata, un urlo più che una immagine, un vero disastro, e la conclusione disperata e disperante, in alterna misura, è conseguenziale. Ancora, peggio ancora, è il non disegnare nulla, assolutamente nulla, non aggiungere niente, il resto di niente: questa è l’ignavia di comodo, quella che ti assolve, come se non fosse di nostra stretta pertinenza, quasi avessimo già dato abbastanza. Quanto ne deriva è lasciato assolutamente al caso, e se stramberie, insensatezze, fatti insoliti ne derivano, non è cosa di cui preoccuparsi, sono solo ragazzate. O invece tragedie.
Amare è una cosa seria, crearsi una famiglia con amore lo è ancora di più, è un genere di amore cui si cumulano ai sentimenti i bisogni pratici da soddisfare, almeno quelli primari, e questo ti assorbe, spesso completamente, ti porta via tempo e testa da dedicare alle attenzioni. Ed a non farsi distrarre. La famiglia contempla figli per discendenza diretta: le linee diritte pretendono esempi lineari, non rette spezzate, ma coerenti, esemplari, equazioni chiare e verificate.
Elementi discordanti disorientano, predicare bene e razzolare malissimo svia, confonde, disturba già dall’origine, nel grembo materno, figuriamoci poi in epoca delicatissima e vulnerabile quale sa essere l’adolescenza di chiunque, allorché magari l’incoerenza dell’esempio genitoriale è palese. Particolarmente gli uomini, i padri, chissà perché proprio ai tempi dell’adolescenza dei figli eccellono nel porgere questa distorta immagine che risulta dal loro agire, anche il grembo paterno, perciò, ha le sue belle responsabilità in proposito, fallendo nel ruolo precostituito di guida, di esempio, di rettitudine di mente e di azione.
A lungo andare, certe circostanze si palesano per quello che sono, infidi tradimenti, uno sconquasso nella fiducia ciecamente riposta e vilmente tradita, un estremo insulto, un oltraggio che nell’insieme provocano disorientamento, discrepanze, disturbi dell’anima, fenomeni che si manifestano poi in disordine inverso, una cosa ed il suo esatto contrario, come la bulimia o l’anoressia, che si rivelano in tutta la loro drammaticità appunto nell’epoca più delicata e vulnerabile tra le età umane, l’adolescenza. Disordini alimentari che risultano tanto diffusi tra i giovani in quella stagione della vita, tali da diventare oggetto di discussione nelle trasmissioni televisive rivolte a quel target, spesso stolidi rotocalchi che spettacolarizzano, sotto una veste amichevole o di servizio, i tanti guasti arrecati all’anima da un’incuria genitoriale.
L’adolescenza, la primavera della vita, che per qualcuno primavera non è esattamente, diviene allora l’età in cui puoi avere tutto, ma in realtà non hai nulla, nemmeno il resto di niente, sei solo e soltanto una ragazza senza niente, che prova inutilmente a riempire le proprie carenze con compulsiva ossessione, con veemenza, una Signorina Ancora, ancora e ancora, senza fine.
Adele è una giovane che ha vissuto la propria adolescenza in maniera tanto particolare da ridefinirla “adelescenza”. Originaria di un piccolo paese di una piccola provincia, come dire un borgo vicino ad una Piccola Città, è cresciuta come tanti suoi coetanei con i sogni ed i desideri tipici delle sue coetanee, gli studi, gli amici, i pochi svaghi, le trasmissioni televisive che vanno per la maggiore negli anni in cui si svolge l’azione, il mito per la Grande Città, la metropoli oltre la provincia, quindi.
La ragazza è la prima figlia, ha due fratelli gemelli minori di lei, e la sua è una famiglia speciale del paese, poiché una volta il papà, allora piccolo bottegaio di alimentari, a malapena sbarcava il lunario, portava avanti la sua famiglia con fatica, privazioni e sacrifici, tanto che erano conosciuti come una famiglia tanto povera da non possedere nulla, quindi, dei ”senzaniente”, appunto, come erano additati con una punta di velato disprezzo. Senonché il padre, a prezzo di fatiche e sacrifici, riesce a fare il gran salto sociale, si ritrova padrone di un supermercato, ma il palese miglioramento economico suscita sempre inevitabile livore, gelosie ed invidie nelle piccole, e pettegole, comunità, per cui il disprezzo non accenna a diminuire, viene semplicemente celato. Le cose si ripercuotono sulla famiglia, prima sul genitore, provocandone un sottile ma incisivo cambiamento, poi con strazio e dolore in Adele, disturbandone la vita. Paradossalmente, Adele farà dei suoi disturbi materia professionale, finendo per andare a vivere nella Grande Città, come nei suoi desideri giovanili. E divenendo madre di una bimba, Frida, concepita senza genitore, con inseminazione artificiale all’estero. Una famiglia completa però richiede dei ruoli precisi, delle presenze fisse: Adele prova la chiusura del cerchio con Nicola, un medico già legato con moglie e figli. Sono i giorni del primo lockdown, la grande città densa di traffico, di gente, di animazione, si chiude in casa, ognuno resta solo e staccato dai suoi affetti; ma la reclusione forzata è invece un’occasione, una opportunità, un’apertura per Adele, che realizza che quanto in effetti vive, è una replica, una rivisitazione mal riuscita, un buffering che rischia di protrarsi all’infinito, impedendo il normale scorrere dello streaming della corretta crescita della sua figliola:
“…quella fuori dalla finestra, adesso ero io.”
Frida, la sua bimba ha bisogno di ben altro che cure parentali: non quanto può dare un amico dottore, ma di un balsamo che è panacea universale, l’amore. Amore quello vero perché esclusivo.
Chiara Gamberale lo afferma forte e chiaro, in bella grafia: con amore, nessuno è un senza niente.
Indicazioni utili
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
EXEUNT OMNES
Un uomo in ospedale, alle prese con una spietata malattia, che lui chiama metaforicamente "riccio". Antidolorifici che lui chiama "topolini di cioccolato", quelli che riceveva da piccolo per stare buono. Un diario di quindici giorni su questa degenza ospedaliera, in parte autobiografica al punto che l'uomo si chiama Antonio Antunes, diario stilisticamente fuori dall'ordinario dato che non troviamo le annotazioni quotidiane del narratore ma le sue sensazioni frammentate, come se il lettore fosse nella mente dell'uomo. Pochi momenti di lucidità e tanti momenti in cui la sua mente divaga a ripercorrere la sua vita e quella dei suoi familiari sin dall'infanzia, ricordi fugaci interrotti dalla voce del dottore o dall'infermiere, oppure dal rumore delle ruote del carrello delle vivande che attraversa il corridoio ospedaliero, una vita intera che passa davanti agli occhi del malato che sembra estraniarsi completamente a questo mondo.
"- Da un certo punto in avanti il cervello divaga
ed è proprio così, divaga, non soffrono,perdono interesse, non si preoccupano, si estraniano, confondono l'ospedale con una casa, progettano di andarsene come se fosse facile andarsene, nessuno se ne va, nemmeno noi sani, mettiamo radici credendo di spostarci e se ci spostiamo tutto si sposta insieme a noi, mia moglie o il debito in banca che non sono riuscito a saldare (...)"
Antonio Lobo Antunes oso affermare, per chi non lo conoscesse, che è il più importante scrittore portoghese vivente. Può piacere o non piacere in quanto la sua prosa ha un forte carattere e uno stile determinato, non facilmente fruibile, con ampio utilizzo di flusso di coscienza e narrazione a più piani, però il suo valore e il suo contributo alla letteratura è innegabile. Nelle sue tematiche ricorre spesso l'argomento del colonialismo portoghese in Angola, a tal riguardo consiglio vivamente "In culo al mondo" e "Lo splendore del Portogallo", in questo libro invece, nuovo di stampa in Italia ma uscito già nel 2007 il tema focale è la malattia, il dolore e la morte, viste come fine della vita di un uomo perché "EXEUNT OMNES", ovvero "tutti se ne vanno", siamo una sorta di fiume che scorre verso la foce dove si trasformerà e farà parte del mare, così anche la nostra vita scorre come in fiume verso un mare che speriamo esista:
"e allora compresi che il Mondego una malinconia costosa che lottava per esprimersi, chiamano quella cosa fiume e ci lasciamo portare lì sopra nella speranza che diretto al mare quando nessun mare, pini, voglia di conoscere donna Lurdes e domandarle per educazione
-Di cosa morirà?
con la figlia a rispondere in sua voce
-Un problema all'aorta
i denti di donna Lurdes tutti all'aria, inutili, il naso un dente che fiutava mordendo l'aria a casaccio, morda l'aria donna Lurdes, morda se stessa, si divori mentre sua figlia le tiene il braccio lasciando lì la manica, se vuole l'aiuto a divorarsi come faccio con me stesso, ho già inghiottito la cartilagine che si muove sotto la pelle quando mi hanno dato la medicina (...)"
"-Non si agiti che arriviamo, signorino
e il dolore nella stanza vuota affinché il medico lo distribuisse tra i pazienti, non si abbandonava l'ospedale con il dolore, non c'è dolore per tutti, nel dimettere i pazienti perquisivano le tasche:
-Il dolore dov'è?
annunciando
-Quello che ha speso in dolore è sul conto
forse anche il futuro di rondini pagato e la paura di morire carissima, perfino la pioggia doveva loro (...)"
Siccome la natura vuole un certo equilibrio, verso il finale del libro, ci sarà anche un nascita: "tre chili e duecento che avvolgevano nel lino e lui a scorrere sopra i fiumi diretto alla foce"
Lo stile caratteristico della prosa fa sì che ci siano delle lacune, parole mancanti, dialoghi spezzati, che il lettore legge lo stesso tra le righe di questo flusso continuo, sconnesso, pieno di poesia e che prende una sorta di vita propria al punto che la lettura sembra essere una esperienza sensoriale. Anche se l'argomento è triste, l'estraneità della voce narrante verso la sua situazione mitiga il senso di angoscia. Libro che consiglio assolutamente, magari in un momento in cui si è predisposti a queste letture malinconiche, consiglio inoltre di lasciarsi andare e seguire il flusso senza pretendere di capire tutto perché un delirio non può essere compreso e non ha un filo logico.
Indicazioni utili
UN VUOTO DA COLMARE
Un piccolo borgo arroccato sull'Appennino, un vecchio falegname un po' strambo, vittima di irrisione da parte dei compaesani, finche l'idea di ricavare un figliolo da un ciocco di legno cambierà i suoi orizzonti, proiettandolo in una nuova dimensione alla ricerca spasmodica di quell'affetto mai donato e mai ricevuto.
Una riscrittura del celeberrimo Pinocchio ma dedicata in via esclusiva alla figura di Geppetto, un anziano, un solitario, un umile lavoratore abituato a creare oggetti utili con l'abilità delle proprie mani, un uomo avvolto nel silenzio delle mura della propria casa-bottega per lungo tempo forse per una vita intera, rallentato nei gesti quotidiani ma ancora lucido e pulsante il suo cuore triste.
La delicatezza stilistica propria della penna di Stassi ha dato vita ad un nuova chicca letteraria, con la consueta capacità di utilizzare una storia ed un volto infondendo anima, linfa vitale, spessore umano, trasportando il lettore in una ballata vorticosa che sembra astrarre dal mondo reale ma al termine del viaggio lo catapulta senza sconti tra le braccia del quotidiano.
Uno scritto per riflettere sulle solitudini declinate in più forme, siano esse amaro frutto della vecchiaia oppure del seme funesto della malattia, che si sostanziano in un declino doloroso e sfiancante che ingiustamente intacca molto spesso la dignità dell'essere umano.
Dietro ad ogni volto scavato di un Mastro Geppetto c'è un cuore che batte e che non si arrende anche se intorno è sceso il silenzio, anche se nessuno tende una mano.
Fabio Stassi allunga quella mano che tanti ritraggono, per donare una carezza a chi è scivolato nella voragine della dimenticanza, a chi è orfano del calore familiare, a tutti coloro a cui si è spento l'interruttore della memoria.
Una parabola amara e accidentata quella del canuto falegname, bersaglio di tiri crudeli, avvezzo all'incomprensione e all'isolamento, ma in nome di un briciolo di affetto è pronto a plasmarsi una creatura con cui condividere il proprio cammino.
Un percorso ad ostacoli doloroso che abbandona i guizzi della fantasia per sostanziarsi in una verità commovente e palpabile.
Indicazioni utili
Una storia dall’Iran
“Figlia mia, ci sono un sacco di cose che devi ancora imparare riguardo a questo Paese e al suo popolo. Ha settemila anni, forse anche di più. Quando qualcosa arriva a una simile età comincia inevitabilmente a incrinarsi. Comincia a marcire. L’albero più vecchio è il primo a prendere fuoco”.
“Aria” è il romanzo di esordio della scrittrice iraniana trapiantata in Canada, Nazanine Hozar, e narra la storia di Aria, una bambina abbandonata alla nascita e cresciuta da ben due madri adottive in momenti diversi.
Potrebbe rientrare per certi aspetti, ma non per altri, nel romanzo di formazione così come potrebbe rientrare anche nel romanzo storico, ma non a pieno titolo.
Aria vive nel pieno della rivoluzione Khomeinista e la sua storia personale, si intreccia strettamente con quella dell’Iran dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Raccolta in fasce in una notte d’inverno, tra i cumuli di immondizia e gli alberi di gelso in fiore, da quello che diventerà il suo Bobo (il suo papà), Behruz, vivrà una infanzia di abbandono e di degrado, trascurata da Zahra, moglie di Bobo, che non riesce ad affezionarsi a lei. Zahra è una iraniana malvista dalla gente di Teheran sud, perché ama vestire all’occidentale, ama truccarsi, girare per le strade senza velo e coi tacchi, però non ama né il marito né la bambina che questi ha raccolto per strada. Zahra rimarrà per tutto il romanzo una figura enigmatica, forse la più interessante, una madre degenere, paradossale, tesa tra la superstizione e il desiderio di cambiamento, che sparirà nella prima parte del romanzo per lasciare il posto ad altri personaggi.
Aria: questo è il nome che Behruz aveva dato alla bambina, perché amava la canzoni e la musica classica.
“Ti chiamerò Aria, come tutti i dolori del mondo e tutti gli amori del mondo (…) Sarà come se tu non fossi mai stata abbandonata. E quando aprirai la bocca per parlare, tutto il mondo ti conoscerà”.
Gli amici più cari di Aria saranno Kamram, il bambino dal labbro leporino che vedeva la piccola Aria lasciata sola sul balcone tutto il giorno, picchiata e maltrattata da Zahra, e poi, nell’adolescenza Mitra e Hamlet. Si tratta di una lunga storia che ci immerge nelle atmosfere dei bazar:
“…venditori di tappeti, di noccioline e di gioielli; aleggiava l’aroma del fegato bollente, tagliato a pezzetti e infilzato su sottili spiedini di metallo che la gente addentava”
Ci introduce e ci fa addentrare nel cambiamento che l’Iran sta vivendo:
“Erano sparite le foto dello scià. Non c’era neanche una bottega che ne esponesse il ritratto. Scelse un vicolo a caso e comincio a percorrerlo lasciandosi portare dalla folla, sbirciando dentro le botteghe. Non si vedeva da nessuna parte l’immagine dello scià. Ma quello che ne aveva preso il posto lo lasciò stupefatto. In ogni negozio era esposta una foto incorniciata di un vecchio mullah, un uomo che Ramin riconobbe e il cui ricordo risaliva ai tempi lontani in cui era stato messo in prigione. Era lo stesso mullah che aveva fomentato una protesta ed era stata mandato in esilio”.
Si tratta di Khomeini, ormai osannato per le strade di Teheran e non solo, che da Parigi era riuscito, tramite una fitta rete collaboratori, a far diffondere i suoi messaggi per una rivoluzione culturale e politica in Iran. Insieme ai suoi messaggi il Paese conosceva la musica e i divi americani.
Il romanzo è diviso in quattro parti, ognuna prende il nome di una donna : Zahra, Fereshteh, che si prenderà cura di Aria, Mehri, che è la madre biologica della protagonista e poi Aria.
Si apre e si chiude col rosso, come un anello: il rosso del sangue del parto di Mehri e il rosso, colore della passione “Amore. Furore. Cuore. Sangue. Abbi sangue, abbi cuore. Non scomparire mai” le dirà Yaghut, la pazza della città, che inviterà Aria a chiamare la sua bambina Ghermez. Rosso rubino.
L’opera è vasta e contiene molte tematiche: l’amore, l’amicizia, l’abbandono, la violenza, il rapporto e il contrasto tra zoroastrismo, Islam ed ebraismo, la questione femminile, spie e sospetti. Senza contare che i personaggi che ruotano attorno ad Aria sono ben caratterizzati e interessanti. La narrazione è in larga parte lineare, senza piani temporali che si sovrappongono. Ottima scelta stilistica tenendo conto della corposità della storia.
Per essere un esordio va riconosciuto alla scrittrice il merito di aver tenuto sotto controllo una materia multiforme e varia, anche se in qualche punto il romanzo risulta essere dispersivo. Ho trovato un po’ frettolosa la parte finale, quella dedicata agli episodi di guerriglia nei mesi della rivoluzione islamica,che probabilmente sono stati rappresentati in maniera molto più soft di come i sopravvissuti la ricordino.
“Assassinavano le persone per paura? -chiese Mitra.
“C’è mai altra ragione oltre questa? “
Indicazioni utili
Femminile singolare
Oliva Denaro è una adolescente, poco più di una bambina, convintasi che, nel tempo e nei luoghi in cui si dipana la sua esistenza di ragazzina prima e giovinetta poi, il massimo che le è consentito senza vincoli sociali di sorta è esprimere una predilezione, una preferenza, una propensione, e niente altro: vive in un contesto tale che può tutt’al più dichiarare, in segreto ed esclusivamente a sé stessa, di essere “favorevole” o “non favorevole” ad una qualsiasi opzione di vita.
Un auspicio, forse, ma certo non la proclamazione di una decisione, una scelta, un indirizzo, una alternativa da intraprendere. Oliva è femmina, e come tale, sic et simpliciter, per semplice definizione, non appartiene a sé stessa. Da quando può ricordare, e cioè da sempre, si sente ripetere che il suo destino è già scritto dalla notte dei tempi, scolpito nella roccia, immutabile ed inevitabile perché predeterminato non dalla sua intelligenza, volontà, capacità ed opportunità che la vita offre, ma esclusivamente dal suo genere: quello femminile. Siamo nel 1960 a Martorana, piccolo ed in verità misero e depresso paesino della assolata provincia rurale siciliana, qui ed allora il termine “femmina” non è indicativo di genere, ma di ruolo: indica l’obbligata collocazione sociale, il livello inferiore e sottomesso alla Padronanza maschile. L’uomo non è un pari, un compagno, un marito, un padre, un fratello o che, è un Uomo, è padrone, è superiore, può prendere quando desidera e poi, magnanimamente, “riparare”.
E se qualcuna decide di non voler essere “riparata”? Di restare “un brocca rotta”?
Il titolo dell’ultimo romanzo della scrittrice napoletana Viola Ardone richiama subito, direttamente, senza se e senza ma, il nome della protagonista, come a dire che estrinseca immediatamente al lettore il cuore della storia: il racconto edificante della vita di una giovane donna, ed il suo contenuto ideale, costituito da autentici tesori di fermezza, coraggio e dignità, che insieme costituiscono un valore etico non altrimenti monetizzabile.
Capitali e significati ancora più pregiati perché eroici ed esemplari per i tempi ed i luoghi in cui si svolgono gli avvenimenti narrati.
Oliva Denaro è un fiore di donna appena sbocciato, ed insieme a lei qui si narra anche di altri petali del fiore, di altre donne, che nell’insieme costituiscono il sottofondo, il coro greco che fa da colonna sonora alla narrazione.
Risuonano perciò, a volte rauche, a volte stridule, talora cristalline o talaltra spezzate dalle lacrime, tante voci femminili, ad iniziare da Amalia, la madre di Olivia, arida ed aspra per le tante delusioni dell’esistenza, schiacciata dal peso del suo fardello di paure e timori ancestrali.
Segue la sorella Fortunata, costretta al silenzio sottomesso di chi ha confuso ingenuità, fragilità e cedevolezza per amore e passione; poi le amiche, le vicine di casa, le insegnanti, specie quelle davvero tali, come la maestra Rosaria, che educano e lasciano il segno tirando fuori il meglio degli allievi.
Ancora, si menzionano anche le compagne di scuola, e via dicendo altre compagne più importanti e formative, quelle solidali di vita, di consiglio, di supporto, di battaglia: Liliana, per esempio, o Maddalena Criscuolo…emana perciò dal libro un sentore di pluralismo al femminile.
Ma è solo una sensazione, un accenno, questa non è una storia di matriarcato, assolutamente: qui gli uomini ci sono, ed è vero, ritratti spesso nei loro tratti peggiori, maggiormente iniqui e detestabili, ma con qualche lieta eccezione, sorprendente e delicata, deliziosa, affettuosa, paterna e insospettabile.
In verità, qui il plurale non c’entra, questo è un testo declinato esclusivamente al femminile singolare, solo singolare, è la storia stessa del genere femminile che lo richiede, ogni donna si salva da sola, per prima cosa, e dopo tutte insieme.
Oliva perviene giovanissima, purtroppo attraverso un personale, e doloroso, itinerario di vita, all’assioma che, certamente, la solidarietà di genere va richiesta, procurata, ricercata, diffusa, elargita.
Battersi per l’autonomia delle scelte di una donna, e perché venga riconosciuto il loro valore di donna persona e non donna oggetto di angherie e sottomissione, è qualcosa di assolutamente indispensabile per una qualsiasi crescita civile.
Serve farlo però innanzitutto in prima persona, sacrificandosi, mettendosi in gioco, rischiando l’embargo, l’ostracismo, l’esilio, a costo di finire in una presunta “lista nera” nelle chiacchiere della gente, agli occhi dell’opinione pubblica.
Opinione pubblica maschile, ovviamente; quella che negava finanche dignità di lavoro alle donne:
“…E della donna che lavora, che ne pensate? …Qualcuno rideva dando di gomito al vicino, le poche femmine presenti guardavano per terra…”
Solo agire in prima persona conferisce efficacia all’impresa di cancellazione radicale di tutto quanto storto, arbitrario ed arrogante viene imposto dalla casta d’altro genere, spadroneggiante per motivi di tradizioni, usi e consuetudini di comodo, assolutamente infondati, fasulli, illegittimi, diffusi ad arte per opprimere, schiavizzare, vessare.
Spesso, se non sempre, utilizzando la forza fisica, la violenza per prevaricare.
L’input iniziale del cambiamento può essere solo e soltanto singolare: la forza delle donne di ribellarsi e battersi contro abusi, ingiustizie, violenze e vessazioni, di cui sono vittime dall’alba dei tempi, e che perdura ancora oggi come le cronache dimostrano, è sita nella durezza della catena, non di acciaio ma di diamante, che costituiscono legandosi tutte insieme, per resistere e lottare per il cambiamento, tutte sodali come una sola donna.
Tuttavia, ogni anello della catena stessa deve essere forgiato di quel materiale, della stessa tempra e robustezza, non si può permettere nemmeno ad uno solo di essi di avere composizione, forma, convinzione diversa. La rottura di una unità sconvolge l’intera architettura, ognuno perciò deve obbligatoriamente essere un singolo forte, non va mostrato nessun punto debole dove fare leva.
Il femminile singolare è d’obbligo, l’agire in prima persona è requisito essenziale: il totale lo fa la somma, se uno solo degli anelli tentenna, oscilla, non sa decidersi, non osa, allora salta, la catena si spezza, perde l’anello debole, poi sbanda per riallacciarsi, comunque il totale appare deficitario all’appello. Crea un precedente, semina dubbi, paure, incertezze, terreno fertile per la protervia maschile. Nessuna donna può essere lasciata indietro, le problematiche femminili le coinvolgono tutte indistintamente, ma le soluzioni iniziano necessariamente dalle singole reazioni di ribellione, per poi diffondersi a catena, letteralmente, e giungere a tutte.
“Oliva Denaro” è un bel libro, molto ben scritto, con uno stile descrittivo in prima persona, direi a voce alta, chiara, intonata, i pensieri della giovane protagonista riportano esattamente non solo quella che è e quella che diviene, quanto pensa e cosa desidera, le sue emozioni, le paure, le incertezze ed i faticosi distinguo, ma con accuratezza, direi con immediatezza visiva il testo riporta mirabilmente atmosfere, modi di dire e di essere dei tempi e dei luoghi in cui Oliva vive, soprattutto i capitoli riportano precisamente la mentalità corrente, lo stile di porsi tutto biecamente maschile in una società arcaica e medievale, crudele e opprimente per tutte quelle che hanno avuto ”il marchese”.
Il menarca per una giovane è allora una pesante linea di demarcazione, tra l’essere una “piccinina”, comunque un bimbo di rango inferiore, all’essere una “femmina”, un oggetto sottoposto all’unico arbitrio maschile.
“…Da quando sono diventata femmina, sto come sotto una tettoia durante un temporale: non mi allontano per non bagnarmi…”
Da qui, tutta una cappa di comportamenti assurdi ed obbligati che gravano sull’universo femminile, che soffocano la vitalità dell’esistenza femminile già alla nascita, al solo dichiarare l’appartenenza di genere. Perciò questo è, più di tanti reportage storici, un testo esemplare e educativo, delizioso da leggere perché ben costruito, con cura, con attenzione, soprattutto con un pudore, una discrezione, una riservatezza encomiabili; è una lettura scorrevole, piacevole, parla di crescita e maturazione, racconta di emancipazione e di dignità, esalta la giustizia, anche quando difetta la giurisprudenza.
Una storia che parla di amore, certo: ma amore quello vero, come inteso da una donna. Un sentimento intensamente affettivo, che si scambia, non si impone:
“…Chi ti vuole bene non ti strapazza, non ti intimorisce, non ti forza…”.
La vicenda narrata è romanzata, ma casi simili sono veramente accaduti; quindi, non è solo un racconto fine a sé stesso, questo è un testo che arricchisce, che spinge a riflettere, a porsi domande e soprattutto spiega la magnificenza del divenire storico dell’universo donna, ed il prezzo pagato, spropositato ma elargito senza esitare, data la posta in gioco.
Le battaglie delle donne per il riscatto della propria autonomia di vita sono state un’epopea eroica, degne di stima, di rispetto, di ammirazione, l’immedesimarsi induce in chiunque sentimenti affettivi fortissimi nei confronti delle protagoniste.
Credo che qualsiasi uomo con un minimo di onestà intellettuale dopo aver letto “Oliva Denaro”, si inginocchierà in un “woman lives matter”, un doveroso omaggio all’universo femminile.
Perché il problema non appartiene a loro, non è che le donne siano colpevoli di qualche cosa perchè magari vanno in giro con un abito troppo corto, troppo provocante, o che girino sole per strada, il problema appartiene a noi uomini che, vale tuttora per troppi di noi, non abbiamo ancora imparato, o non vogliamo imparare, di non avere alcun diritto di sfiorarle MALGRADO vadano in giro da sole e con gonne corte. Un problema tutto maschile, dipanato dal mondo femminile: non credo che esista altro di più eroico e assurdo insieme.
Ancora non si è spenta la gratitudine di tanti lettori nei confronti di Viola Ardone, per averci già in precedenza deliziati con la lettura di quel piccolo gioiello della recente narrativa italiana che è stato “Il treno dei bambini”: chi lo ha letto ricorderà quel romanzo di crescita e riscatto che vede protagonisti un bambino e sua madre. Anche qui troviamo una storia costruttiva di crescita e riscatto, che vede al centro stavolta una giovane e sua madre, e sua sorella, e le compagne, e le donne…
Ma sia chiaro, “Oliva Denaro” non è affatto una elegia del femminismo, anche se emergono nella scrittura caratteri predominanti tutti al femminile come tempra, fierezza, incisività, soprattutto intelligenza e esemplarità.
E gli uomini non sono tutti cattivi, ce ne sono tanti, e per fortuna sono tantissimi, che sono teneri, gentili, delicati, e servono…a cosa servono?
“…mi hai chiesto che cosa faccio. Questo faccio io…Se tu inciampi, io ti sorreggo.”
Viola Ardone ci offre una storia al femminile singolare, che prima diventa plurale per poi tornare all’unità, perché è la scelta del singolo che compie l’opera di aggregazione.
È un racconto di donne che tutte insieme si dannano per un percorso di crescita civile per tutte le appartenenti al genere, un discorso corale che infine, per logica conseguenza, porta ad un femminile singolare, perché le cose cambino serve l’impegno personale, lo sforzo individuale, la svolta effettuata in prima persona.
“…ci è voluto tempo, ci sono volute donne più combattive di me e tanti altri “NO” gridati più forti del mio, che si sono sommati al mio…”
Trattandosi di una storia di donne, tratta anche della controparte; perciò, è anche una storia della peggiore prevaricazione maschile, e quindi non si contano atti e atteggiamenti di alterigia, insolenza, tracotanza, e la logica violenza che ne deriva.
Sempre il più forte o presunto tale ricorre alla forza quando non si cede alle sue infondate pretese, non ha altri mezzi: per cui è anche un racconto violento. E però:
“…Ogni cosa viene per chi sa aspettare…”.
E lotta per quello in cui crede. Ed insieme ad altre riesce a far abrogare, e finalmente, una norma di legge assurda, abominevole, turpe ed abietta, portando alla definitiva chiusura delle “officine di riparazione”. Vincendo le proprie paure, perché le paure:
“…sono porte che esistono solo fino a quando non abbiamo il coraggio di attraversarle.”
Peccato che, ogni tanto, qualcuno ci prova, ancora oggi, a riaprire abusivamente certe officine, a ripristinare con un femminicidio certe storture.
Costoro vanno combattuti, sono peggio dei talebani, e serve farlo tutti insieme, uomini e donne.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il blues, espressione dell’inquietudine americana
“I went to the crossroad, fell down on my knees
I went to the crossroad, fell down on my knees
Asked the Lord above, "Have mercy, now, save poor Bob if you please" ”
Così inizia il testo di Crossroad Blues di Robert Johnson, cantante afroamericano, uno dei più grandi interpreti del blues, genere che trae origine e ispirazione dai canti degli schiavi neri dell’America coloniale.
Non a caso “Crossroads” è il titolo dell’ultimo lungo romanzo di Jonathan Franzen. Con questa definizione si riunisce il gruppo giovanile della comunità di New Prospect, Chicago, sotto la guida del Pastore Rick Ambrose, con l’intento di superare e risolvere con fraterno aiuto reciproco le tensioni e le ansie di ciascun membro. E’ in questo crocevia di esperienze che si rivelano i conflitti interiori più drammatici di ognuno. E’ su questo sfondo che deflagrano i contrasti più aspri maturati all’interno della famiglia del Pastore Russ Hildebrandt. Ritorna, dunque, la magistrale abilità di Jonathan Franzen nell’ analizzare le crisi esistenziali e sociali della famiglia borghese americana, come già avvenuto nello splendido “Le correzioni” e successivamente in “Libertà” e “Purity”.
Il romanzo è diviso in due parti, la prima “Avvento” si concentra sulle aspettative di ogni singolo membro della famiglia Hildebrandt, aspettative spesso deluse e tradotte in ansie struggenti. Ogni personaggio rivela qui i suoi limiti, dal padre Russ, colpito in età matura da una passione irresistibile per una giovane parrocchiana, alla madre Marion, debole eppure forte nella sua consapevolezza di aver vissuto fin lì una vita trasgressiva e peccaminosa, ai quattro figli, Clem, Becky, Perry e Judson, ognuno dei quali esce da un’infanzia felice vissuta nell’ammirazione di genitori apparentemente impeccabili, per entrare in un’adolescenza e una giovinezza che non risparmiano loro la disillusione dovuta a una naturale presa di coscienza dei limiti e delle fragilità degli esseri umani. Crescere vuol dire anche cambiare prospettiva, iniziare un cammino verso l’accettazione delle debolezze altrui, in nome di un amore che non ha nulla di superficiale. I bambini vedono i genitori come una specie di eroi, attribuiscono loro forza fisica e morale, ignari della delusione che proveranno il giorno in cui, ormai adulti, li vedranno nella loro dimensione reale.
La seconda parte è intitolata “Pasqua”, con un esplicito riferimento ad una sospirata resurrezione spirituale dopo la dolorosa discesa agli inferi.
Tutto il romanzo è pervaso dal frustrante senso di colpa che ciascun personaggio alimenta nel proprio animo, consapevole dei propri peccati e delle proprie colpe. E’ l’eredità dell’educazione puritana di certi ambienti medio borghesi della società americana, che trovò già espressione ne La Lettera Scarlatta e The Birhmark di Hawthorne. E’ costante la presenza del sentimento religioso come necessità di purificazione attraverso il pentimento e l’espiazione. Ciò implica, di conseguenza, la difficoltà di ricomporre un nucleo familiare drammaticamente separato dagli eventi. La conclusione al lettore, secondo la sua sensibilità e la sua logica individuale.
Un romanzo molto bello, che non trascura l’aspetto sociale e politico degli anni settanta, la guerra in Vietnam, L’affare Watergate, la condizione degli indiani Navajo nella mesa, lo sfruttamento indiscriminato e criminale delle miniere di carbone, il problema della droga. Grande spazio è concesso all’amore, amore sincero, amore come inganno, amore fraterno e materno, amore come puro piacere. Un romanzo che coglie quasi tutti gli aspetti della vita il cui corso è lungo e doloroso.
Indicazioni utili
Una raccolta a tema gelosia
Piccola ma doverosa premessa: se già conoscete Jo Nesbo e vi aspettate di trovarvi davanti a uno dei suoi canonici romanzi potrete restare con “Gelosia” sorpresi o delusi. Sopresi perché l’autore si cimenta in una raccolta di racconti di cui appunto uno omonimo al titolo, delusi perché l’impronta che viene data a questi scritti si allontana molto dai soliti gialli/thriller a cui questo ci ha abituati. Sia per mole che per contenuti che per colpi di scena.
In libreria dal 7 settembre scorso, il libro ha inizio con un racconto intitolato “Londra”. In questo ci troviamo su un aereo con destinazione intuibile, un uomo e una donna sono vicini di posto, ella è in lacrime, lui cerca di consolarla, si professa addirittura psicologo. Lei confessa di aver firmato un contratto dal quale è impossibile recedere. Entro tre settimane questa morirà per mano altrui, una piccola vendetta perfettamente architettata per vendicarsi del marito che ovviamente la tradisce con la bellissima (ex) migliore amica. Il colpo di scena giunge sul finale e spiazza per quelle che erano le basi di partenza anche se il lettore resta perplesso già durante lo scorrimento da quell’organizzazione che lavora su desiderio di morte altrui. Il meccanismo è farraginoso.
“Gelosia” è anche il secondo racconto che vediamo in questa carrellata che Nesbo ci propone. Più corposo dei sette è ambientato su un’isola greca e vede quali protagonista due gemelli a cui interessa la medesima donna. Uno dei due scompare e a essere sospettato è l’altro. Da Atene sopraggiunge “l’uomo della gelosia”, esperto di crimini mossi proprio da questo sentimento.
Nel terzo racconto, “La fila”, conosciamo una commessa che decide di vendicarsi di un torto del passato sfruttando gli obblighi della pandemia. Tra tutti gli scritti questo è il più slegato tra gli altri non essendo condotto da un vero e proprio denominatore comune.
In “Spazzatura”, ancora, ad essere protagonista è un operatore ecologico che non si occupa solo dei rifiuti da caricare sul camion e da smistare. Cosa succede se proprio durante queste operazioni subentrano dei problemi con i proprietari?
In “La confessione” conosciamo un uomo e la sua passione per gli snack, passione che veniva condivisa con la moglie e che lui non abbandona anche se le sorti di questa non sono state così rosee.
In “Odd” conosciamo uno scrittore vittima dell’ossessione che i personaggi da lui costruiti suscitano sugli altri, qui il pensiero va immancabilmente a King e ad alcune delle sue opere più celebri.
Una raccolta di racconti, quella proposta da Nesbo, dove a far da padrone è un senso costante di umiliazione affiancato dal desiderio di vendetta. Da questo si scatena la gelosia in tutti i suoi dogmi incontrollabili. L’obiettivo dello scrittore è certamente quello di dare un volto a tutte le sfaccettature della gelosia e su questo fronte si può dire riuscito almeno in parte l’esperimento.
La pecca di questo elaborato? La mancanza di quella tensione che è propria dei suoi lavori. Dunque, se cercate un Nesbo alla “L’uomo di Neve”, tra queste pagine non lo troverete. Se cercate un Nesbo più psicoanalitico, meno thrillerista e più giallista, qui lo troverete. A fare da ulteriore scriminante alla piacevolezza del componimento vi è anche la formula narrativa adottata che per definizione tende sempre a dividere.
Nel complesso una lettura non entusiasmante, non ai massimi del norvegese ma piacevole. Si esaurisce in poche ore ed è adatto a chi cerca un leggere non troppo impegnativo e con cui staccare la spina.
Indicazioni utili
Occhi che accarezzano l'anima
«Un giorno, quando ero solo una neonata, qualcuno aveva deciso che non servivo e che potevo anche morire. Mi aveva abbandonato senza curarsi affatto delle mille persone che sarei potuta diventare, delle parole d’affetto che avrei potuto rivolgergli una volta cresciuta.»
Quando Miki è stata ritrovata sul soffice letto di alghe, era appena una neonata. Una neonata abbandonata dalla madre ma trovata da un’altra donna desiderosa di donarle, insieme alla sua famiglia, tutto il suo affetto e il suo amore. Ecco perché Miki non sente mai la mancanza della madre naturale. Certo, ci pensa come è atavico che sia, ma al contempo è sopraffatta dall’amore che la famiglia Ohira ha a lei destinato negli anni. Il suo sguardo verso il mondo che la circonda è fatto di meraviglia, gioia e felicità e questo non manca di destare il disappunto di chi, al contrario di lei, non riesce a guardarsi intorno con gli stessi occhi.
La vita di Miki scorre normale e tranquilla fino a che tutta una serie di avvenimenti la portano a dover conoscere anche altri sentimenti oltre all’amore; tra questi, l’amarezza e l’odio. Conosce anche il senso della perdita, la bellezza del ritrovarsi. E forse, in un certo senso, scopre anche cosa significa amare. Perché se da un lato sono gli affetti principali ad essere toccati, dall’altro il tornare a casa di un coetaneo trentenne vecchio amico a sua volta toccato dalla morte della moglie, la porterà a riscoprirsi e la porterà a interrogarsi sul senso di quel che la circonda.
«Poi qualche volta otteniamo qualcosa, ed è la prova che ce la siamo cavata. La vita è un ripetersi continuo di questo gioco: quanto ci insegna l’esperienza? Come affronteremo le successive tentazioni?»
“Su un letto di fiori” è una delle opere in assoluto più mature di Banana Yoshimoto. È uno scritto che trasmette dolcezza, tenerezza, che fa sorridere. Miki entra nel cuore, lo solletica con la sua semplicità e genuinità. Tuttavia, al contempo, questo scritto è anche il più triste ed emotivo della narratrice nipponica. È infatti un titolo che lascia un retrogusto dolce come amaro e questo, probabilmente, perché ha l’obiettivo di sconfiggere le tenebre e illuminarle proprio passando per la ragione per il quale nasce.
Banana da dedicato e scritto questo racconto per il padre, per affrontare la sua perdita e quel dolore incolmabile lasciato da questo vuoto. È un libro ancora che parla di viaggi anche in senso metaforico, ma di radici. Perché tutti abbiamo il nostro posto nel mondo e talvolta dobbiamo solo capire quale questo è.
«Dietro casa nostra forse le piante si erano già riempite di gemme, e in breve tempo avrebbero coperto tutte le cose brutte che erano capitate in passato. Le leggi della natura non conoscono rallentamenti. Scorrere, marcire, nascere. E non conoscono nemmeno accelerazioni. Il tempo della natura è la sola legge che conosciamo. […] Di fronte ai grandi cambiamenti, possono verificarsi situazioni positive o negative. È un fatto scontato. Ad agitare la superficie calma del lago si solleva ciò che si era depositato sul fondo e anche l’aria esterna ne risente. L’acqua si intorbidisce, ma ogni movimento fa affiorare nuove meraviglie. Poi l’acqua si calma e torna limpida, ma il lago non è più identico a com’era prima. Non è migliore né peggiore, è solo cambiato.»
«Ecco perché ho scelto di vivere pienamente, apprezzando ogni istante, giorno dopo giorno. Ecco perché ho scelto la vita semplice e infinita che questo piccolo villaggio, quest’angolo di mondo, ha voluto offrirmi.»
Indicazioni utili
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Storia di parole non dette
Farò già subito un'associazione bizzarra a questo romanzo: "Lavversario" di Carrère, o quello che avrebbe forse dovuto esserlo. "La mano" di Simenon ha come protagonista un uomo realizzato, con una brillante istruzione alle spalle, è socio di uno studio legale, marito fedele e premuroso e un buon padre, una casa nella provincia e una vita "normale", adagiata in un perbenismo e in una armonia tipicamente americana, annaffiata da bicchieri di whiskey e scotch. E così, dopo ben diciassette anni di quiete, basta una porta aperta su una scena a scatenare una tempesta, sia fisica in quanto il libro si apre con una tempesta di neve ma anche e soprattutto interiore nella quale per la prima volta il protagonista rivaluta se stesso, il suo trascorso e mette sulla bilancia i suoi desideri veri e l'attuale vita che si è costruito su dei modelli predefiniti. Durante queste intense pagine, si scoprirà un altro Donald, cinico, anaffettivo, egoista e vigliacco, invidioso e dulcis in fundo con istinti omicidi. La differenza sostanziale con Carrère è che "La mano" è scritto rigorosamente in prima persona e il viaggio è soprattutto interiore, si entra nel vortice dei pensieri del protagonista che man mano diventano sempre più oscuri e sempre più ossessi, si percepisce il suo squilibrio psicologico e l'epilogo è segnato già dall'inizio. Certo, "L'avversario" è la ricostruzione di una storia vera, ma quante storie vere non ce ne sono, nel mondo, come quella di Donald? Più di quello che pensiamo... Lo stile della scrittura è molto accurato e la narrazione è molto più profonda di quello che può apparire, c'è un intenso gioco di elementi contrari che si attraggono e si respingono, a partire dal silenzio condiscende della moglie di Donald, Isabel - che gli parla con i sguardi, sguardi che lo ossessionano e che il lettore non potrà mai sapere se effettivamente corrispondono ai messaggi che Donald capta oppure se sono solo sue malsane impressioni - e i pensieri irrequieti, svegliati dal letargo dopo tutto questo tempo che assillano in modo assordante Donald. Anche i personaggi sono antitetici: Donald e Ray, Isabel e Mona. Si cerca anche di motivare in qualche modo questo insano atteggiamento di Donald con una rigidità affettiva da parte dei genitori quando era piccolo, modello che probabilmente lui ha ricercato da grande in Isabel ma personalmente non credo in queste cose e non so se ha seminato questi dettagli come possibile motivazione del suo comportamento oppure come cliché ironico. Ad ogni modo "La mano" è davvero un testo intenso, scritto molto bene, con delle suggestive ambientazione e rappresenta, a mio avviso, un modello per ciò che "L'avversario" di Carrère avrebbe dovuto essere, ossia uno scavo nella mente del protagonista, la realtà vista attraverso i suoi occhi.
PS: ho trovato l'ultima battuta del libro, volutamente assurda, che spiazza e lascia il dubbio su chi sia il vero matto della situazione.
Indicazioni utili
“Non finirà finché non parliamo”
Tra le emozioni della narrativa e le nozioni del saggio, senza forse tralasciare nemmeno ricostruzioni riconducibili al genere della biografia, il libro di Colum McCann si presenta al lettore, fin dalle primissime pagine, come “un romanzo ibrido”. È lo stesso autore, nato in Irlanda e residente da tempo negli Stati Uniti, a sottolinearne la natura al termine di questa sua lunga opera che prende pian piano la forma di un poligono dal numero infinitamente numerabile di lati. “Apeirogon”, appunto, curioso, laconico, perfetto titolo preso in prestito dalla geometria.
Apparso in lingua originale nel 2020, il volume è stato pubblicato in Italia da Feltrinelli lo scorso mese di marzo. La nota introduttiva di McCann non lascia dubbi su quanta realtà vi sia nel contenuto delle sue oltre cinquecento pagine che – non è da escludere – avrebbero potuto continuare ancora a oltranza il loro racconto, proseguire seguendo una miriade di strade che si intersecano fra loro, anche perché il tema affrontato è senz’altro ricco di vicende e sfaccettature diverse. La “fiction”, dunque, si riduce a ben poca cosa attorno ai due protagonisti che si muovono sullo sfondo della purtroppo incancrenita questione israelo-palestinese, ormai da più di sette insanguinati decenni al centro delle cronache internazionali e all’attenzione, non sempre in verità così attenta, delle diplomazie occidentali che, a ben vedere, nulla hanno risolto. Bassam Aramin e Rami Elhanan, arabo palestinese il primo ed ebreo israeliano il secondo, si ritrovano accomunati dal dolore e dalla perdita: le rispettive figlie, Abir e Smadar, seppur a distanza di due lustri, sono cadute vittima della violenza e dell’odio più assurdi che generano lutti da ambo le parti. Era il 2007 quando Abir, all’età di soli dieci anni, dopo aver acquistato un braccialetto di caramelle del valore di due shekel (“le caramelle più costose del mondo”), in prossimità della scuola venne colpita alla testa da un proiettile di gomma sparato dal fucile di un giovane soldato israeliano a bordo di una jeep; Smadar, invece, era quasi quattordicenne allorché, nel 1997, un attentato suicida a opera di tre palestinesi in Ben Yehuda Street a Gerusalemme aveva reciso la sua giovane vita.
La penna di McCann si sofferma in modo particolare su questi drammatici fatti, ritornandoci a più riprese in tutto il corso della narrazione, quasi sezionandoli con estrema cura nel tentativo di estrarne tutti i dettagli, persino quelli più macabri, come il recupero delle parti dei cadaveri disseminate nell’area dell’attentato, addirittura di un bulbo oculare posatosi sulla tenda di un caffè. Ogni singolo elemento, dal giubbotto degli attentatori alle rotte migratorie degli uccelli, dallo zaghareet a “Le mille e una notte” o al Casinò di Gerico, solo per fare pochissimi e assai differenti esempi, viene sviscerato per dare subito il via a rivoli di associazioni e relative annotazioni, andando spesso a cogliere curiosità e fatti vicini o molto lontani nel tempo, anche riportando alla luce storie singolari come quella del funambolo francese Philippe Petit. Tutto questo sempre ruotando attorno alla morte delle due ragazze e alla vita dei loro padri, uniti, oltre che dalla tragedia, pure dal convincimento che un altro modus vivendi sia possibile e che il dialogo e l’accettazione dell’altro, in quanto essere umano, possano essere la sola via d’uscita dalla spirale di morte e vendetta che avvelena la Terra Santa. La trascrizione delle parole di Rami e Bassam, tratta da alcune interviste e riportata nelle pagine centrali del libro, induce a riflettere come non mai e, specie nel caso del primo, costituiscono un vero pugno nello stomaco per lo stato ebraico che dal 1948, come riconoscono anche tanti attivisti israeliani tacciati immancabilmente di tradimento, attua una vera e propria occupazione ai danni di un popolo, quello palestinese, privato della propria dignità.
«Mi chiamo Rami Elhanan. Sono il padre di Smadar. Sono un graphic designer di sessantasette anni, un israeliano, un ebreo, un gerosolomitano di settima generazione. […] Quando qualcuno uccide tua figlia vuoi mettere le cose in pari. Vuoi uscire e uccidere un arabo, qualsiasi arabo […] Poi dopo un po’ cominci a farti delle domande […] E ti chiedi, Uccidere qualcuno mi restituirà mia figlia? […] Non tornerà, la tua Smadari. E a questa nuova realtà ti ci devi abituare. Pertanto, in un lento passaggio graduale e complesso, ti sposti dall’altra parte: cominci a chiederti, cosa le è successo, e perché? È difficile, è terribile, è estenuante. Come è potuta succedere una cosa simile? Cosa potrebbe portare qualcuno a essere tanto arrabbiato, folle, spietato, disperato, e così stupido e patetico, da essere disposto a farsi esplodere accanto a una ragazzina di nemmeno quattordici anni? Come fai a capire un simile istinto? Dilaniare il tuo stesso corpo? […] Che cosa lo ha spinto? […] Chi gli ha insegnato una cosa simile? Gliel’ho forse insegnata io? Gliel’ha insegnata il suo governo? O il mio governo? […] Certe persone hanno interesse nel mantenere il silenzio. Altre hanno interesse nel seminare odio basato sulla paura. La paura produce denaro, produce leggi, prende la terra, costruisce insediamenti […] Ai nostri politici piace spaventarci. A noi piace spaventarci l’un l’altro. Usiamo la parola sicurezza per tappare la bocca al prossimo. Ma non si tratta di sicurezza, si tratta di occupare la vita di qualcun altro. […] L’Occupazione non è né giusta né sostenibile. Ed essere contro l’Occupazione non è in alcun modo una forma di antisemitismo. […]»
«Mi chiamo Bassam Aramin, sono il padre di Abir. Sono un palestinese, un musulmano, un arabo. Ho quarantotto anni. […] Da bambino pensavo che essere palestinese, musulmano, arabo, fosse una punizione divina. E me la portavo dietro come un grosso peso intorno al collo. Da bambino non fai che chiedere perché, ma da adulto, di chiedere perché te lo sei ormai dimenticato. Accetti e basta. Hanno distrutto le nostre case. Accetti. Ci hanno ammassato attraverso i checkpoint. Accetti. […] Ma in prigione cominciai a riflettere sulle nostre esistenze, sulla nostra identità, in quanto arabi, e questo mi portò a riflettere anche sugli ebrei. E a quel punto compresi che l’Olocausto era reale, era successo per davvero. […] Ci sarà sicurezza per tutti quando avremo giustizia per tutti. Come ho sempre detto, è un disastro scoprire l’umanità del tuo nemico, la sua nobiltà, perché a quel punto non è più tuo nemico, non può proprio esserlo. […] Abbiamo bisogno di imparare a condividere questa terra, altrimenti la dovremo condividere nelle nostre tombe. […]»
Parole che i due genitori, stretti da vera e sincera amicizia, nonché membri di movimenti e associazioni che riuniscono famiglie appartenenti a entrambi i lati della “barricata” (“Parents Circle” e “Combattenti per la Pace”), hanno iniziato a ripetere all’infinito, portandole in viaggio ovunque, anche all’estero. Perché parlare e raccontarsi significa infine condividere il proprio dolore, che coincide con quello altrui, e contribuire così a una “lotta” non violenta a dispetto di quanto invece esigono le rispettive leadership. “Non finirà finché non parliamo” recita la scritta in ebraico sul paraurti della motocicletta di Rami, ed è vero.
“Apeirogon” non è un libro semplice, la sua lettura risulta alquanto impegnativa e lo stile adottato qui dall’autore potrebbe cogliere impreparati, ma ha il grande merito di puntare il dito anzitutto contro l’occupazione, raccontata con franchezza nella propria brutale quotidianità fatta di check points, incursioni delle jeep militari, perquisizioni e umiliazioni di vario tipo (e chi ha messo piede in Cisgiordania almeno una volta, anche per poco tempo, sa bene che queste non sono fantasie da scrittori). Trattare un simile argomento equivale a camminare su un terreno minato per tanti motivi; tuttavia, penso che Colum McCann, nonostante alcune polemiche dopo l’uscita del volume, lo abbia affrontato con onestà; il risultato è un’opera coinvolgente e di assai ampio respiro che può dare il proprio valido contributo alla conoscenza di quanto realmente avviene in Palestina e smuovere, di conseguenza, la coscienza dell’opinione pubblica in generale. Affinché nessun bambino sia più l’inerme bersaglio del fucile di un soldato, al pari di una cisterna piena d’acqua, e nessuno debba più saltare in aria per mano di quella premeditata follia suicida che non potrà mai essere la soluzione all’ingiustizia e all’oppressione. Perché anche il soldato che preme il grilletto e i kamikaze imbottiti d’esplosivo, come sottolineano gli stessi Bassam e Rami, sono vittime dell’intero sistema di guerra perenne. Una lettura decisamente consigliata!
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 19 Luglio, 2021
Opinione inserita da ornella donna 19 Luglio, 2021
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
ultimo episodio di una saga
Lucinda Riley, scrittrice di successo, recentemente scomparsa in ancora giovane età, ha ideato la saga delle “Sette Sorelle”, di cui il volume intitolato La sorella perduta costituisce l’ultimo tassello.
Ad ogni sorella è stato dato dal padre adottivo , Pa’ Salt, il nome di una costellazione, ovvero Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra. Di ognuna di esse è stato narrato il proprio vissuto e il proprio percorso di vita.
La costellazione delle Pleiadi, a cui il padre si è ispirato, però prevede sette stelle e l’ultima dovrebbe chiamarsi Merope. Di lei però le sorelle non sanno nulla. Non è vissuta con loro, ma l’avvocato paterno Georg Hoffman, incaricato di far valere le volontà testamentarie del de cuius, afferma con forza la sua esistenza. Si tratta, dunque, di compiere delle indagini per scoprire dove ha vissuto e chi è. Perché si chiedono tutte, non si è mai fatta viva con loro? L’avvocato fornisce loro un indizio determinante: un anello di smeraldo a forma di stella e un nome. A chi appartiene? Il viaggio alla scoperta della “sorella perduta” inizia così. Riusciranno a trovarla? O si perderanno in giro per il mondo?
Un romanzo di genere, dedicato principalmente ad un pubblico femminile, molto voluminoso, che si legge in un baleno. Lo caratterizza una prosa fluida, ricca di dialoghi e di descrizioni ambientali minute e di caratterizzazioni dei personaggi particolareggiate. La trama è solida, e la si può leggere sia come libro a sé, che come ultimo tassello di una saga, iniziata sei volumi fa. Una bella avventura che colpisce il lettore che ama il genere, disposto ad arrivare fino alla fine di una narrativa che travolge e completa. Bello, ma poderoso e più adatto ad un pubblico femminile, ripeto.
Indicazioni utili
ACARI E DEI, CROCI, MEZZELUNE E RUOTE DENTATE
“Il delirio non è una scoria della realtà, ma è parte di essa, e a volte la sua parte più preziosa.”
“E all’improvviso […] mi ha colto un terrore che nemmeno nei miei sogni più spaventosi ho mai provato; non di morte, né di sofferenza, né di orribili malattie, né dello spegnimento dei soli; il terrore al pensiero che non capirò, che la mia vita non è stata sufficientemente lunga e la mia mente sufficientemente abile per capire. Che mi sono stati dati tutti gli indizi e non ho saputo leggerli. Che marcirò anch’io per niente, nei miei peccati e nella mia stupidaggine e nella mia ignoranza, mentre il fitto, intricato, pressante enigma del mondo perdurerà, limpido, naturale come il respiro, semplice come l’amore e che sfocerà nel nulla, immacolato e insoluto.”
In “Netocka Nezvanova”, un romanzo giovanile di Fedor Dostojevskij rimasto incompiuto, e perciò sconosciuto ai più, il patrigno della protagonista, Efimov, è un violinista di provincia dal grande, smisurato talento, ma, incapace com’è di applicarsi e di studiare come l’arte musicale richiederebbe, rimane inesorabilmente un dilettante, una promessa non mantenuta, un artistucolo il cui brillante futuro si sgonfia di fronte alla cruda legge della realtà, in cui la sregolatezza soffoca il genio e il fallimento uccide i sogni di gloria. Efimov, questo uomo “per sempre morto all’arte”, è uno dei tanti uomini del sottosuolo dostojevskijano, ma paradossalmente ha trovato un suo emulo contemporaneo nel narratore di “Solenoide”, il quale altri non è se non Cartarescu stesso, ma non il Cartarescu scrittore di fama, idolatrato da una folta e affezionata schiera di estimatori, bensì una sorta di suo doppio sfortunato il quale, nonostante la sua divorante passione per la poesia, semplicemente non ce l’ha fatta ad affermarsi ed è stato costretto a mettere le sue ambizioni artistiche in un cassetto e a guadagnarsi il pane svolgendo l’umile, routinario e malpagato mestiere di professore in una fatiscente scuola della periferia di Bucarest. Come il Borges de “Il giardino dei sentieri che si biforcano” o l’Auster di “4 3 2 1”, Cartarescu immagina che la presentazione a un reading letterario di un suo poema giovanile, nel quale riponeva enormi aspettative, si sia rivelata, a differenza di quanto effettivamente avvenuto nella sua biografia reale, un fiasco clamoroso e che questo trauma, e l’incapacità di superarlo, lo abbia fatto desistere dall’intraprendere la carriera di scrittore. Come una moneta lanciata in alto e caduta sul lato sbagliato, la sua esistenza ha preso perciò di colpo una piega differente, lasciando l’altra possibile vita (insieme alle infinite altre vite che non si sono realizzate, perché “sbatto ora le palpebre e la vita mi si ramifica, perché avrei potuto non battere gli occhi e allora sarei stato un altro, sempre più lontano da colui che li ha battuti, come le vie che si dipartono da un’angusta piazza”) una mera virtualità (ad un certo punto il narratore si diverte a immaginare il se stesso fallito che, in coda per farsi autografare la copia dell’ultimo libro pubblicato, incontra il “gemello” diventato uno scrittore affermato, in un paradosso che ricorda certi controintuitivi esperimenti della fisica quantistica, come quello, famoso, del gatto di Schroedinger).
Il narratore di “Solenoide” non rinuncia del tutto a scrivere, ma confina la sua passione di grafomane alla redazione di un anonimo manoscritto in cui registra scrupolosamente gli avvenimenti della sua vita, e soprattutto gli strani sogni che lo ossessionano fin dalla adolescenza. Addirittura egli arriva a giudicare in maniera estremamente negativa tutti quei romanzi che, celebrati da critici e lettori, affollano l’ideale museo della letteratura, i quali non fanno altro che dipingere sulle sue pareti, in trompe-l’oeil, porte ritratte meravigliosamente, con una minuziosità e un preziosismo ammirevoli, ma che in fin dei conti non si aprono da nessuna parte, e che quindi “eludono l’unica ragione di essere che la scrittura abbia mai avuto: quella di comprendere te stesso fino in fondo”. “Un libro, perché significhi qualcosa – sostiene Cartarescu –, deve indicare una direzione […], deve essere un segnale […], deve richiedere una risposta”, ed è per questo che gli unici testi che andrebbero letti sono quelli non artistici e non letterari, “quelli che i loro autori hanno avuto la follia di scrivere, ma che sono scaturiti dalla loro demenza, tristezza e disperazione come delle sorgenti di acqua viva” e “che hanno scritto su ogni pagina l’unica parola che conta: io”. I libri devono essere messaggi, vangeli, piani di fuga per evadere da quella ripugnante e desolata prigione che è il nostro mondo, ma questi libri i professionisti interessati solo a festival, premi, autografi e interviste, e alla perenne ricerca di un posto d’onore nella storia della letteratura, non sono in grado di scriverli.
Ora, tralasciando il fatto che Cartarescu, autore – non dimentichiamolo – in odore di Nobel, possa sinceramente invidiare il destino di un suo doppio fallito, che è un po’ come se un miliardario rimpiangesse la vita libera e senza preoccupazioni di un nullatenente, è assai interessante soffermarsi sulla filosofia che sta dietro le pagine di “Solenoide”. La posizione di Cartarescu si potrebbe definire, con qualche approssimazione, esistenzialista. Il mondo è spaventoso, crudele e senza significato, “ci schiaccia osso dopo osso nel suo abbraccio”, e l’uomo, nella sua breve esistenza, sperimenta la disperazione più profonda, quella di essere solo e impotente, sostanzialmente privo di libero arbitrio, “rinchiuso nella goccia d’ambra del suo destino”, come in una tomba in cui è condannato a marcire da vivo, sconvolto dal terrore (“La realtà è soltanto paura allo stato puro, paura rappresa. Vivo nella paura, respiro paura, deglutisco paura, verrò seppellito nella paura”), L’uomo, o perlomeno colui che è in qualche modo un eletto, un predestinato (e “Solenoide” è pieno di queste persone, da Charles Howard Hinton, il creatore del tesseratto, un ipercubo quadridimensionale, a Nicolae Minovici, che disegnava le visioni avute durante le sue sedute di impiccagione controllata, da Nicolas Vaschide, l’onirista, lo studioso dei sogni, a Nikola Tesla, un cui discepolo dissemina di solenoidi, in corrispondenza di misteriosi nodi di energia, il sottosuolo di Bucarest), intuisce però che la realtà non si esaurisce in ciò che è percepito dai suoi sensi limitati, che c’è qualcos’altro, un oltre enigmatico e inconcepibile verso cui tendere, se solo fosse in grado di riconoscere i segni, interpretare le chiavi, decifrare le croci, gli asterischi e le ruote dentate di cui è composto quel gigantesco crittogramma che è la sua esistenza. Come una figura che vive in un foglio bidimensionale non può oltrepassare i suoi margini se non capisce che l’unica uscita è perpendicolare al foglio, nell’inconcepibile terza dimensione, così noi che viviamo nella terza dimensione dovremmo cercare di intuire e di trovare la pagina cubica in cui è scolpita la realtà superiore, e così respirare l’aria pura che ci permette di non morire soffocati nell’angusta cella della nostra vita così sconsolatamente limitata. La vita è perciò come un gioco di abilità, un test di perspicacia, un puzzle a due facce di cui non conosciamo la figura complessiva, un complicatissimo cubo di Rubik da ricomporre con tutte le facce dello stesso colore, e il romanzo stesso diventa quel gioco, quel test, col protagonista che, scavando nel suo passato così come nel suo inconscio, e sceverando i segni fatidici dalle mere coincidenze, tenta di dare una spiegazione a tutte quelle anomalie (bizzarre levitazioni, visite notturne di personaggi misteriosi, sogni stranissimi eppure di una concretezza straordinaria) di cui è costellata la sua esistenza. Al pari del narratore, il lettore stesso è chiamato, come se si trattasse di un giallo metafisico, a riconoscere i segnali, gli enigmi, le allegorie sparsi nelle mille pagine del libro per cercare di addivenire, come se avesse davanti agli occhi un autostereogramma, alla visione fatale della quarta dimensione.
Cos’è, venendo al dunque, la quarta dimensione per Cartarescu? Ricordo che un giorno mi imbattei in un’opera di C.S. Lewis (“Il cristianesimo così com’è”), in cui Dio era paragonato a uno scrittore che vive fuori dal tempo interno del racconto (quello per cui un personaggio deve lasciarsi alle spalle A prima di arrivare a B e non può raggiungere C senza abbandonare B) e che può pertanto contenere in un unico pensiero tutta la storia dei suoi personaggi, dall’inizio alla fine. Analogamente, gli abitanti (dei, angeli, demoni?) di un mondo a quattro dimensioni sapranno sempre su quale lato, testa o croce, cade la moneta nel nostro mondo, e conosceranno il futuro altrettanto bene che il passato. Di fronte a loro, inattingibili e inafferrabili, noi siamo come degli acari che scavano inconsapevolmente delle gallerie nella loro pelle, ignorando del tutto quali possano essere i loro trascendenti pensieri e i loro straordinari poteri, così come un acaro che vive nella mia epidermide non riuscirà mai a raggiungere la profondità delle mie percezioni e dei miei ragionamenti logici. A un certo punto del romanzo, Cartarescu porta alle estreme conseguenze la sua fantasmagorica metafisica, immaginando, con un vertiginoso sforzo mentale che sembra avere più a che fare con gli effetti visionari di un trip allucinogeno che con le ponderate elucubrazioni di una dissertazione filosofica, la presenza di più universi, di più dimensioni, di più spire, differenti per dimensione, ordini e livelli di complessità, ma tutti ugualmente permeabili tra loro, se solo ci si sforza di non accontentarsi del proprio mondo, della propria contingente realtà, ma si cerca di interpretare ed accogliere i segnali provenienti dal misterioso aldilà. Se un foglio di carta, piegato cinquanta volte, può arrivare fino alla luna, è allora ipotizzabile che non solo vi sia una divinità nei cui confronti siamo come degli acari, ma che a sua volta questa divinità sia senza saperlo su un vetrino tenuto fra le dita di un dio ancora più elevato, e così all’infinito. In una pagina geniale che non teme di apparire blasfema, Cartarescu immagina addirittura una sorta di bizzarra transustanziazione, di grottesca incarnazione, in cui il narratore viene inviato dal bibliotecario-demiurgo Palamar a diffondere, in una colonia di acari da quest’ultimo allevati sulla propria epidermide e lui stesso trasformato in acaro, un paradossale messaggio di salvezza, in uno spericolato parallelo zoomorfo con la vicenda raccontata dai Vangeli.
Affrontando il romanzo di Cartarescu, il lettore deve sospendere spesso e volentieri l’incredulità. “Solenoide” è infatti un’opera che introduce nel suo impianto sostanzialmente realistico, similmente a un autore come Murakami, massicce dosi di fantastico. Ho già accennato alle levitazioni e ai visitatori notturni, ma in “Solenoide” c’è molto di più: un’enorme statua in bronzo che prende vita come un moderno golem, sorveglianti di un sanatorio per bambini tubercolotici che si rivelano essere degli automi, cortocircuiti temporali (la moglie del narratore che, attraverso la fessura di una finestra, guarda inopinatamente negli occhi lo stesso narratore bambino, e questi si ricorda di come moltissimi anni prima, dall’altra parte di questa finestra, aveva visto la donna che un giorno sarebbe diventata la sua compagna), fino ad arrivare alla scena miyazakiana della città di Bucarest che, sospinta dai solenoidi, si solleva dalla terraferma e inizia a galleggiare nell’aria. Il surrealismo allucinatorio di Cartarescu, influenzato dai meccanismi psichici dell’attività onirica (fondamentale nell’economia del romanzo, al punto che lunghe pagine sono dedicate alla descrizione dei sogni del protagonista), mi ha ricordato molto un pittore come Salvador Dalì (penso a dipinti come il “Sogno causato dal volo di un’ape” o a “La tentazione di Sant’Antonio”, tra l’altro citato espressamente nel testo), ma anche uno scrittore come Kafka (che, tra l’altro, annotava meticolosamente i suoi sogni nei diari), soprattutto in quelle pagine in cui la casa a forma di nave in cui vive il protagonista (come il palazzo imperiale di “Un messaggio dell’imperatore”) pare a volte essere sconfinata, ed egli vi si aggira per ore, percorrendo chilometri di corridoi, attraversando infinite stanze, ritrovandosi in saloni non solo sconosciuti ma anche lontani nel tempo e nel ricordo, prima di giungere alla propria camera da letto. Sono immersioni vertiginose nei meandri labirintici della propria psiche e del proprio inconscio, come quando il narratore bambino, una notte, trovando l’ascensore guasto, scende per ore le scale dell’edificio in cui vive con la famiglia, senza riuscire a trovare l’uscita ed entrando invece in un mondo fantastico pieno di caverne misteriose e creature inquietanti. “L’intera mia vita è onirica”, afferma Cartarescu, e con questo intende non tanto, o non solo, che tutto accade in sogno, ma che i sogni e le altre manifestazioni dell’inconscio penetrano all’interno del mondo diurno fino a determinarlo e a diventare parti essenziali, insopprimibili, di esso, così come l’infanzia influenza profondamente l’età adulta e più in generale l’interiorità, lo spirito condizionano la realtà fino a farla identificare con essi (Cartarescu si definisce un “agrimensore e cartografo, esploratore delle protuberanze e dei sotterranei, delle botole e delle carceri della mia mente”). Alla luce di quanto detto, il lettore deve aspettarsi letteralmente di tutto, a partire dall’ambientazione stessa, una Bucarest indimenticabile, nel bene e nel male, e che, così come il protagonista è un doppio virtuale dell’autore, sembra essere una copia fantasmatica della reale capitale romena, definita da Cartarescu come la città “più triste del mondo”, progettata e costruita fin dal principio come una città già in rovina (“questo oceano di tetti bizzarri e di figurine di gesso sbeccate, di muri ciechi e di lucernai con i vetri rotti”), ma al tempo stesso – paradossalmente – l’unica davvero autentica. Bucarest è “un grande museo a cielo aperto, museo della malinconia e del decadimento di ogni cosa”, ma lo scrittore non si stanca mai di descriverla con un affetto che traspare da ogni riga.
Non so se la mia lettura sarà condivisa da tutti, ma a me “Solenoide”, tra le innumerevoli interpretazioni che gli si possono affibbiare, è parso anche una intelligente metafora del comunismo, con l’evasione dal nostro mondo verso la quarta dimensione che diventa la fuga dal regime di Ceausescu alla volta di un Occidente enigmatico e incomprensibile, ma incontestabilmente più libero e democratico (non è un caso che le vicende del romanzo si collochino nei premi anni ’80). Lascio a chi leggerà queste righe la confutazione della mia ipotesi, fatto sta che la decisione finale del protagonista, ovverossia la scelta dell’amore terreno per la propria famiglia e per i propri simili (e quindi, parlando fuor di metafora, del proprio paese, della propria terra) a scapito di una conoscenza superiore e di una verità trascendente a lungo agognate (l’esilio), collima con la biografia dell’autore, come se, in una sorta di tardiva resipiscenza, di posticcio happy end, egli avesse deciso di riunire le traiettorie divergenti dei suoi antitetici io, come binari di un treno che dapprima si allargano e si allontanano per poi invertire la direzione e rincontrarsi definitivamente. Finale a parte, non nego che qualche perplessità “Solenoide” me l’ha lasciata. Partendo, come già accennato in apertura, da una posizione esistenzialista (il mondo è orribile e senza senso, e la fuga da esso, come la rivolta di Camus, è l’unica strada praticabile per strappare un significato all’assurdità della condizione umana), e passando attraverso il nichilismo del connazionale Cioran (il “mistico senza Dio” che sostiene che l’uomo è sì consapevole di essere libero ma al tempo stesso è prigioniero nell’angusta cella dell’universo, e può salvarsi solo in forza di se stesso, attraverso la disperata negazione del valore positivo del mondo), Cartarescu approda alla fine a uno gnosticismo (la fuga dal mondo materiale per abbracciare una realtà superiore, trascendente, spirituale) che assomiglia molto più a Gurdjieff (la sua “quarta via” richiama inevitabilmente la quarta dimensione di “Solenoide”) o a Madame Blavatsky, se non addirittura all’esoterismo o alla new age, che a Sartre o a Cioran. Del resto Cartarescu osa consapevolmente il kitsch più deteriore (penso alla setta dei manifestanti, che protestano davanti a cimiteri, ospedali e obitori contro la morte e la sofferenza, contro il destino e la tirannia della caducità, con cartelli su cui sono scritti slogan tipo “Boicottate l’agonia!”, “Abbasso la leucemia!”, “Stop agli ictus!”), ma va comunque apprezzato per il suo inesausto tentativo, durato quasi mille pagine, di “esprimere l’inesprimibile, percepire l’impercettibile, intuire ciò che non è intuitivo”, pur conscio che ci vorrebbe un numero molto superiore di sensi, al di là dei cinque, modesti e limitati, a disposizione dell’uomo per riuscirci.
Cos’è quindi, alla fine dei conti, “Solenoide”? Parlare di “romanzo-mondo” appare quasi riduttivo, tanto grandi sono i territori che, forse avventatamente, pretende di esplorare, non sempre riuscendo a tenerli insieme in una struttura omogenea e coesa. Forse sarebbe più facile provare a dire cosa “Solenoide” non è. Usando le parole stesse di Cartarescu, le storie di “Solenoide” “non sono romanzo e nemmeno poema, poiché esse non sono finzione (o non del tutto), né studio oggettivo, dal momento che molte delle mie vicende sono singolarità che non si lasciano riprodurre nemmeno nei laboratori della mia mente. […] Le storie del mio resoconto saranno fantomatiche e trasparenti, ma sono così i mondi in cui viviamo simultaneamente”. Indipendentemente da ogni definizione, “Solenoide” è un libro scritto meravigliosamente bene, e di fronte a tale sfoggio quasi esagerato di bravura il lettore non può che rimanere abbagliato, irrimediabilmente conquistato da uno stile sintatticamente ricco e variegato, lessicalmente prezioso e ricercato, barocco senza mai essere ridondante, immaginifico ma sempre con un occhio alla realtà, complesso senza mai essere arzigogolato, sempre pienamente comprensibile anche nelle sue pagine più astruse. Ritengo che pochi scrittori al mondo sarebbero in grado di definire il battito delle palpebre come “una brezza petaloidea”, o le minuscole finestre di una casa come “simili ai pori di una friabile madrepora”, o ancora i ricordi dell’infanzia e gli altri reperti di un’intera vita che il narratore colleziona compulsivamente come “quisquilie eterotopiche”, per fare solo alcuni esempi pescati tra innumerevoli altri. Del resto, Cartarescu è straordinariamente abile a scrivere pagine memorabili anche su avvenimenti semplici o addirittura prosaici, come le abluzioni in una vasca da bagno o perfino l’atto quotidiano della minzione. Se il tono dell’opera è profondo ed elevato, non mancano però le pagine argute e spiritose, normalmente riservate alla vita scolastica del protagonista, come il premio scolastico dell’ateo migliore, per aggiudicarsi il quale gli studenti si prodigano in una gara di sputi per colpire l’icona sacra della professoressa Radulescu, oppure la tragicomica raccolta obbligatoria da parte degli studenti di bottiglie vuote e di cartastraccia. In un romanzo dalla innegabile impronta autobiografica (soprattutto nelle pagine dei ricordi dell’infanzia del protagonista), a sorprendere di più sono però le geniali metafore che Cartarescu dissemina con doviziosa generosità. Cartarescu ad esempio paragona l’umanità, che produce indefessamente e incurante della propria caducità le poesie e i quadri, i monumenti e le chiese, le idee e gli ideali destinati a sopravviverle, a una chiocciola, verme molle e appiccicoso, la quale secerne con fatica, trasformando la bava in madreperla, la meraviglia geometrica della sua conchiglia a spirale, “icona immortale nel mondo platonico della mente”. E, qualche pagina dopo, definisce coloro che sognano come dei pescatori di perle, che scendono nottetempo nelle acque profonde della mente e riemergono, quasi asfissiati, stringendo tra le dita (ma più spesso tornando a mani vuote, perché i sogni si sono dissolti al risveglio) le perle preziose costituite dai “piccoli frammenti della nostra interiorità vellutata”. Parlando di metafore mi viene giocoforza in mente il nome di Marcel Proust, uno scrittore che maneggiava queste figure retoriche in maniera altrettanto sapiente. Il paragone con l’autore francese non è del tutto peregrino, perché sia Proust che Cartarescu cercano nelle loro opere, ostinatamente, di recuperare il tempo perduto dell’infanzia. Se però il tentativo di Proust è destinato al successo e il miracolo della resurrezione del passato riesce epifanicamente a realizzarsi, per Cartarescu i dentini da latte, le treccine infantili, le foto in bianco e nero di quando era piccolo che il narratore conserva in una scatola come il lascito prezioso di un’epoca d’oro non si trasformano mai nelle madeleine e nelle irregolarità del macadam della “Recherche” e rimangono inesorabilmente “prigionieri di una bolla d’aria fatta del cristallo enigmatico del ricordo”, prove semmai dell’irrealtà del tempo, segni tangibili di un “universo privo di confini e privo di senso”. Anziché il recupero del tempo perduto, assistiamo qui a un’allucinante moltiplicazione, per nulla confortante, del passato, con la inquietante coesistenza di tutti quei miliardi di io, ognuno più giovane dell’altro di qualche secondo, che il narratore, crescendo, si è lasciato dietro come la muta di un insetto e che nel finale egli addirittura vede, come in un allucinante film in 3D, stesi, uno accanto all’altro, sui tavoli dell’obitorio. I ricordi sono solo proiezioni illusorie delle ombre del passato nel nostro cervello, ma non sono in grado di farci riconoscere alcunché. Eppure, nonostante la chimerica fallacia della letteratura, di cui parlavo all’inizio di questa recensione (“la letteratura è un museo chiuso ermeticamente, un museo delle porte illusorie, […] una macchina che produce dapprima felicità, poi delusione”), e l’impotenza dello scrittore a riportare in vita il passato, a essermi rimasta alla fine maggiormente impressa, gemma minuscola e quasi invisibile all’interno di un libro ciclopico, è proprio una breve pagina che descrive la meraviglia provata dal narratore bambino al cospetto del suo primo libro: “Il mio mondo sparisce e, come negli alambicchi contorti del sogno, appare all’improvviso un altro mondo, un altro spazio visivo e mentale, nel quale mi dissolvo con uno stupore solenne. […] Leggevo, sull’altalena verde, questa prima pagina di un grande libro, bianco, e non riuscivo a credere, non che qualcuno l’avesse potuto scrivere, ma che io fossi capace di riceverlo, di decifrarlo, di trasporlo dalla logica di un’altra mente alla logica della mia mente, che rivestissi il suo scheletro con articolazioni fini e simmetriche, con ossa agili del testo con la carnagione della mia stessa vita, dei miei diretti ricordi. […] Un uomo morto da tanto aveva impiantato, nel mio cervello, un innesto, uno spicchio del suo cervello. […] L’autore era il lettore, il lettore era l’autore, come alle due estremità di un ponte su cui circolano le allucinazioni. Ero in lui, e lui, benché morto da tanto, viveva in me.” Una magia che tutti coloro che sono amanti dei libri, devoti sacerdoti di quella strana, totalizzante, e per molti incomprensibile, religione che è la lettura, avranno sicuramente riconosciuta, avendola sperimentata in maniera altrettanto stupefacente, in un tempo ormai lontano ma indelebilmente impresso per sempre, come un marchio di ferro rovente, nella propria memoria.
Indicazioni utili
Tre. Tre vite. Tre volti
Dopo “Cambiare l’acqua ai fiori” e “Il quaderno dell’amore perduto” Valérie Perrin torna in libreria con “Tre”, un titolo brevissimo se considerate le seicento pagine che conta lo scritto, e di grande significato dal punto di vista dello sviluppo narrativo, ma che al suo interno racchiude l’intera essenza dello stesso.
Tradotto da Alberto Bracci per Edizioni E/O, “Tre” ci conduce tra le sue pagine per mezzo della voce di tre protagonisti e per un lasso temporale che va dal 1986/7, quando i tre ragazzi Etienne, Adrien e Nina si conoscono all’età di dieci anni, sino al dicembre del 2018. L’opera a firma Perrin appare sin dalle prime pagine quale un romanzo circolare e cioè atto, tra i suoi salti temporali tra presente e passato, a ricostruire un unico disegno più grande con un inizio e una fine che consegue, congiunge e si ricollega al punto di partenza.
I personaggi che vengono descritti tra queste pagine sono eroi come tutti noi, giovani uomini e donne con le loro fragilità, le loro paure, le loro debolezze e quel bisogno intrinseco di crescere. La vita li sottoporrà a tante e dolorose prove, in alcuni casi anche drammatiche, e loro non potranno far altro che sperare di poter andare avanti guardando al futuro.
Siamo a Le Comelle, una piccola realtà nel dipartimento di Saona e Loira, al centro di quella che è la Francia continentale. Qui vive Etienne Beaulieu tra agi e ricchezza grazie a una famiglia benestante composta dalla madre Marie Laure, il padre Marc e la sorella minore Louise. E se Etienne è il fascinoso giovane ricco e consapevole di ciò, Adrien Bobin è un timido e studioso giovane uomo che vive con la madre Josephine abbandonata dal compagno nonché padre del ragazzo e che ora vive nella capitale con nuovi figli e una nuova moglie. La sua presenza nella vita del protagonista si limita a sporadiche apparizioni.
Nina con la sua pelle ambrata e gli occhi scuri ha un temperamento artistico ma anche dedizione e bravura nello studio. Abita con il nonno, non ha mai conosciuto il padre, la madre Marion l’ha abbandonata appena nata e conosce soltanto l’amore infinito di Pierre Beau, il postino del luogo.
Tre volti tra loro diversissimi ma che eppure sono legati da una amicizia indissolubile che li rende inseparabili tanto da condividere tutto; dalla scuola alla vita sociale. Passano gli anni, Etienne è amatissimo dalle ragazze, Adrien scrive e si trasferisce a Parigi dove porta a termine il suo progetto e il suo sogno di romanzo che riscuoterà grande successo ma che verrà pubblicato sotto pseudonimo e infine Nina, che ormai sola al mondo a causa della morte del nonno in un incidente dai contorni strani, decide di sposare il ricco Emmanuel Damamme. Egli è innamoratissimo della ragazza ma ne è anche estremamente geloso e possessivo. Sarà questo un amore tossico seppur travestito di perfezione.
Ed è appunto anche di amore che si parla in queste pagine. Un amore dannoso come quello di Nina, un amore puro come quello di Adrien, un amore frivolo ma anche fatto di non detti, quello di Etiénne. Non mancano poi forme di amore quali quello genitoriale, quello verso chi è emarginato, amore come forma di cura, amore per gli animali abbandonati, vero l’arte, verso la propria professione, verso tutto quel che può esserne destinatario.
E non manca nemmeno il mistero: perché i tre ragazzi non si vedono e non si parlano da quattordici anni? E chi narra davvero la storia? Chi è la voce portante? Chi è Virginie con i suoi capelli a caschetto e con qualche filo bianco? Cosa succede nel 2003, anno della frattura della loro relazione? E cosa è successo a Clotilde Marais, ragazza popolare che aveva una relazione con Etiénne e che scompare misteriosamente nel 1994 per poi essere rinvenuta priva di vita e ormai in decomposizione nel 2017 a bordo di un’automobile che giaceva sul fondo del lago nei pressi di La Comelle? Etiénne, che adesso fa parte delle forze dell’ordine e vi lavora, sarà colui che dovrà prima di tutto fare i conti con quella pagina del passato che ancora oggi è in grado di metterlo in crisi.
Tante, ancora, le problematiche trattate dall’autrice tra queste pagine. Un libro che parla di radici, di radici famigliari perse e ritrovate, di abbandono dei genitori, di legami affettivi, di malattia, di sessualità, di pulsioni, di violenza sulle donne, di identità di genere, di difficoltà ad affrontare le pulsioni legate alla sessualità, alla vita, al vivere e all’esito finale della vita, alla morte.
La grande bravura dell’autrice risiede nel riuscire a trattare tematiche importanti con grande sensibilità, ben mixandole con personaggi vividi e una mole corposa, rendendole vivide e cristalline nella mente dei lettori, lasciandole giungere con una vena di leggerezza che conduce e appassiona ma che mai cade nello scontato o ne appiattisce la sostanza. “Tre” è un titolo che si legge con rapidità, che solletica il cuore, che trattiene, che emoziona e che commuove. Un libro che conferma le capacità narrative della scrittrice e che non deluderà le aspettative di chi ha amato i suoi scritti. Ancora è un elaborato che può convincere anche chi, al contrario, non ha amato “Cambiare l’acqua ai fiori” perché più stratificato, più maturo per temi e trattazione, più completo. Buona lettura!
Indicazioni utili
Nirvana ?
Ho trovato l’arresto un romanzo caotico distopico, ma non ingarbugliato al punto giusto. Fantascientifico forse, oppure psicopatologico nel senso di schizofrenico ossessivo. Di cosa parla bisognerebbe chiederlo a Lethem, ma pure lui pare non avere chiaro per primo quello che succede. I personaggi principali sono due fratelli, che ricordano la genesi maschio e femmina li creò, persone con un legame speciale diversi come il giorno e la notte: lui è Garzone livellamento temporale detto Sandy e lei semplicemente Maddy. Garzone lavora per uno sceneggiatore Todbaum, in particolare a un film Un altro mondo ancora. Maddy fa l’opposto di quello che fa il fratello, ma le riesce meglio, compresa la sceneggiatura del film Un altro mondo ancora.
Infatti, la brillante Maddy che in genere sceglie in tutto strade opposte a quelle del fratello cui è legatissima, va a trovare il fratello e viene per due giorni rapita da Todbaum dopo di che riparte mortalmente offesa, non si sa di che. In conseguenza del non si sa che appena capitato, i rapporti con il fratello si deteriorano. Garzone è infatti ritenuto in qualche modo responsabile del fatto ( perché non saprei, ho vagliato varie possibilità, tra cui quella che lui e Todbaum siano la stessa persona). Cosa potrebbe esserle accaduto? Violenze fisiche, psico fisiche, torture mentali? Oppure qualcosa di ancora più virtuale e diabolico? Non si sa, ma questo è il meno. Ritroviamo i due fratelli a fare una la produttrice di colture bio Spodosol e l’altro l’aiuto macellaio in uno scenario post arresto, ovvero post apocalittico. Ricompare pure Todbaum a bordo di un veicolo pensante (con la testa di chi? Propria, di Todbaum, di Garzone?)a propulsione nucleare che pare il suo carapace. A questo punto sorge nel lettore la difficoltà di capire che cosa sia successo nel mondo e ai personaggi. La difficoltà non è solo del lettore ma pure dell’autore che pare vagliare le diverse possibilità nel corso della storia: mondo creato dalla mente dei due fratelli o di uno dei due più Todbaum? Nel caso da quale dei due? Esiste un io, cioè i vari personaggi hanno identità diverse? La sorella Maddy, nota scienziata ha inventato una stanza entrando nella quale uno entra uno spazio virtuale, qualcosa che ricorda vagamente il bellissimo film Nirvana? Ci sono buoni e cattivi e se sì chi sono? Ci sono persone reali? L’arresto è stato reale o immaginario? Todbaum è una specie di figura luciferina che vorrebbe proporre a Maddy una “ricreazione” un altro mondo ancora in cui lui Todbaum e lei Maddy ricoprano il ruolo di protagonisti assoluti come Adamo e Eva? Non lo sapremo mai.
Alla fine di questo romanzo dichiaro socraticamente che so di non sapere. Se qualcuno sa qualcosa di più o ha una sua teoria la faccia sapere agli altri. Io per onestà però il libro lo sconsiglio caldamente.
Indicazioni utili
Rassegnazione e malinconia in stile Ford
Dopo tanti autori italiani avevo una gran voglia di "americanità", e chi meglio di Richard Ford per sentirmi in America, per coglierne l'essenza?
"C'era, bisogna ammetterlo, la vaga sensazione di essere un semplice spettatore della vita. Ma era l’America. Erano tutti spettatori. Nessuno, gli sembrava, era dentro fino al collo in qualche cosa”.
Dieci racconti.
Dieci volte una fine.
Fine della vita, fine di un amore, fine di rapporti famigliari, di amicizia...
Fallimenti, perdite, lutti, separazioni.
Tutti i protagonisti perdono qualcuno, qualcosa... o si sentono fuori posto, inadeguati.
Patteggiano col dolore.
Poche parole per rappresentare interi universi.
Siamo negli Stati Uniti del Nord- Est, perlopiù nel Maine, ma c'è anche molta Irlanda, Canada, Parigi...tutti luoghi cari allo scrittore.
I suoi uomini sono rappresentanti della classe americana medio-alta, fatta di professionisti, avvocati, intellettuali, artisti.
Lo stile è minimalista e asciutto, molto elegante, fatto di dialoghi densi e moltissime riflessioni nascoste.
Ford fotografa momenti apparentemente minimi, insignificanti, eppure decisivi, di uomini e donne ormai maturi, che hanno attraversato unioni, allontanamenti, amori, disamori, che hanno perso tutto e ricominciato, e si ritrovano di nuovo soli, stanchi, sfiniti di fronte a nuove deviazioni della vita.
Aleggia fra le pagine un sentimento che abbraccia il rimpianto, la rassegnazione e la malinconia, come se quello che poteva (e doveva) accadere fosse già accaduto ed ora non rimane molto altro da fare, da dire, da vivere, il meglio è già passato.
Niente da dichiarare.
Eppure il libro non è deprimente, anzi... in qualche modo persino consolatorio.
Ford ci tiene in una sorta di penombra, condizione ideale per fare bilanci esistenziali.
Indicazioni utili
A tutto campo
Questo è l’ultimo romanzo di Antonio Manzini, ultimo in duplice senso, perché è quello di più recente uscita in libreria, ed è anche l’ultimo che ha come protagonista il suo oramai notissimo personaggio, il vicequestore romano Rocco Schiavone.
Il lettore affezionato ha seguito fedelmente fin qui il suo beniamino nelle sue avventure, succedutesi quasi sempre in un clima lattiginoso, tanto rigido quanto è ruvido il carattere del nostro, trasferito com’è da tempo, suo malgrado, in servizio presso la questura di Aosta.
Si sa, anche nei mesi più miti il meteo di quella città è quanto di più lontano dalle classiche temperate giornate della capitale, mal si adatta ad un romanaccio purosangue qual è Schiavone, tuttavia non è questo il solo motivo ostico al completo inserimento del vicequestore nel tessuto cittadino valligiano.
Aosta non è stata una scelta, ma una imposizione, una destinazione ad hoc, quanto più distante possibile dalla capitale, proprio per motivi disciplinari utilizzati però a iniquo pretesto, perché Schiavone per i suoi nemici, e ne ha tanti, ad ogni livello, è quello che si dice un cane sciolto, una mina vagante, una testa dura difficile da ricondurre a più miti consigli.
Un uomo cocciuto che non volta la testa se vede cose storte per la propria indole, meno che mai la testa la china davanti al potere rancido e corrotto, ed è un investigatore scaltro, abile, capace: un cliente difficile, un testimone scomodo per un certo sottobosco politico-affaristico che prospera nella capitale, assai più infido e malavitoso di quello della delinquenza usuale.
Rocco Schiavone, per chi non lo sapesse, prima ancora di essere un poliziotto è un uomo di buon senso, che ha appreso la lezione più difficile della vita direttamente sul campo, sulle strade dei quartieri popolosi e popolari in cui è nato e cresciuto.
L’ha appresa a menadito in certi ambienti rustici, ruspanti, spesso degradati e saccheggiati, dove l’esistenza ti costringe a vivere al limite, in ogni senso, e con quelle compagnie che ti ritrovi insieme e intorno, con cui giocoforza interagisci umanamente, creando vincoli tanto sodali quanto inestricabili nel tempo, talmente forti e sentiti che vanno come devono andare, oltre ogni legame di sangue.
Il tutto prima ancora che l’etica e la morale che si presume giusta e corretta ti venga impartita con lezioni sui banchi universitari o alla scuola di polizia.
Chi viene da certe scuole native, in quelle successive, se ha la fortuna di poterle frequentare, amplia gli scenari, si affina, si perfeziona, ma i principi fondanti dell’umana convivenza, quelli più forti, concreti e degni di essere vissuti, restano inalterati. Perciò Rocco Schiavone è una comune persona perbene, che viene da un sano pragmatismo, rifinito e perfezionato dalla crudezza del mestiere che esercita; il vicequestore creato da Antonio Manzini è un personaggio che piace perché è persona leale e trasparente, lo è nel bene e nel male, quando si concede un inopportuno spinello come quando indaga minuziosamente, sa quando e se intervenire con severità o tolleranza, essere intransigente o umanamente comprensivo, è uomo che vive e perciò ama e soffre, e più spesso, come per noi tutti, la sua vita è costellata di dolori più che di gratificazioni. Schiavone è una persona umanamente di valore, ma tosta perché disincantata, sa perfettamente che bene e male non sono tali come stabiliti dai codici. Fondamentalmente è una persona onesta, ligio ad una propria etica che presenta capisaldi come l’amicizia e l’amore per la donna amata, anche se la propria morale è basata più sul senso della giustizia che sul rispetto pedissequo delle leggi. Perciò il titolo ben si addice, in effetti dopo che l’autore si è felicemente cimentato in altri romanzi senza il suo protagonista seriale come, per esempio, ne “Gli ultimi giorni di quiete”, questa volta si riallaccia direttamente al racconto immediatamente precedente a questo, “Ah l’amore, l’amore!”.
Quindi ritroviamo in rapida successione tutti, ma proprio tutti, i comprimari e coprotagonisti che accompagnano il quotidiano del poliziotto. Ad iniziare dai suoi fedeli collaboratori e colleghi, superiori e sottoposti, ci sfilano davanti tutte le “vecchie conoscenze”, da Michele Daruta, il poliziotto che alterna la propria attività principale con il dare una mano nottetempo al forno gestito dalla moglie, sottraendo per questo volentieri ore al sonno e al riposo, a Domenico d’Intino, il classico pasticcione e però devoto come nessuno alla squadra, e ai compagni, e che idolatra il suo capo, per finire ad Ugo Casella, che ha finalmente dato sbocco alla sua vita sentimentale acquisendo anche un figlioccio geniaccio del computer, le cui abilità informatiche vengono utilizzate nel lavoro di polizia. E poi ancora l’efficiente e prezioso viceispettore Antonio Scipioni, e Italo Pierron, poliziotto confuso che un po' si è perso per strada, o meglio ha perso un po' l’amicizia e confidenza con il vicequestore, che pure si ostina sempre a porgergli la mano. Ritroviamo il giudice Baldi, il questore Costa, il medico legale Fumagalli, che scopriamo essere zio di una nipote anch’essa medico legale, efficiente come lo zio, poi la ormai conclamata compagna del patologo legale, Michela Gambino della polizia scientifica, tanto stramba ed eccentrica quanto preziosa ed efficiente. Infine, gli inseparabili, fidatissimi fino e oltre la morte amici d’infanzia e d’avventura, Sebastiano, Brizio, Furio, a cui Schiavone è indissolubilmente legato a vita, senza dimenticare gli amori perduti e passati, la moglie Marina, la giornalista Sandra Buccellato e finanche l’incantevole agente Caterina Rispoli, di cui si erano perse le tracce. Non può mancare il fidatissimo pet Lupa.
Sullo sfondo, un omicidio su cui indagare, un enigma ben congegnato, solido, appare difficile da ricostruire l’assassinio, tanto brutale quanto privo di un movente sufficientemente valido, ai danni di una studiosa ormai avanti con gli anni.
Un caso in cui le prove di ogni genere, da quelli dattiloscopiche a quelle indiziarie riconducono con tutta evidenza ad un unico colpevole, e però Schiavone non si fa convincere, meno che mai si lascia fuorviare, intuisce l’esatta dinamica e cerca certosinamente gli elementi che ne diano riscontro, sarà proprio la sua testardaggine, il suo acume, soprattutto il suo spirito di osservazione, il colpo d’occhio del borgataro attento ad ogni sfumatura, a portarlo sulla strada giusta, inchiodando il vero responsabile con prove inoppugnabili.
Schiavone protagonista assoluto, quindi, e tutte le vecchie conoscenze a girargli intorno.
Invece non è così.
Antonio Manzini qui e ora si è superato, ed alla grande: questo è tra i volumi dedicato a Rocco Schiavone forse il più corposo, certamente il più bello, completo, ed esaustivo.
Le vecchie conoscenze di cui al titolo vengono esaminate a tutto campo, sono loro, per una volta, i veri protagonisti e Schiavone fa da comprimario.
Lo scrittore con una prosa attenta, semplice ed elaborata ad un tempo, molto più matura e ricercata, di uno step superiore rispetto ai primi volumi della serie, ci propone un romanzo nuovo, con le fondamenta usuali, e però con una struttura diversa, migliore perché frutto dell’esperienza, più moderna ed efficiente, ci offre tutto il mondo attorno al suo protagonista non in una luce nuova, ma con chiarore più forte, più potente, ce lo mostra con un numero maggiore di lumen, volto a cogliere i minimi particolari spesso lasciati nella penombra.
Intendiamoci, lo stile, il modo di raccontare, il tutto è però sempre incantevole e delizioso, attraente e avvincente, una prosa fortemente descrittiva di luoghi, azioni, persone, con i loro sentimenti e soprattutto con i loro stati d’animo ottimamente delineati, in piena luce, trasparenti.
Illuminando tutta la scena a tutto campo, ampliando al massimo la visuale offerta al lettore, risalta anche Schiavone, forse ancora di più di quanto prende tutta la scena da solo, ce lo fa comprendere meglio come uomo e come investigatore, Antonio Manzini aumenta i particolari dell’insieme per condurci al punto focale del quadro. Questa volta lo scrittore si è occupato in primo luogo, senza parere e senza far torto al protagonista, dei personaggi ricorrenti, e lo fa con molta delicatezza, con discrezione, quasi con pudore, direi autentico amore per le sue creature.
Perciò ammanta tutta la storia di modernità, perché i valori fondanti di Schiavone sono valori moderni perché eterni, sono i valori universali di tolleranza, accettazione, accoglienza, fedeltà agli amici e agli amori. Perciò in questa storia troviamo tante storie, quasi quanti sono i comprimari citati, abbiamo per esempio racconti dei problemi di identità di genere, e tutto quanto questo comporti in termini di disagio, vergogna e clandestinità, di sensi di colpa e di persecuzione per coloro ancora costretti a subire certi pregiudizi; abbiamo il sentirsi inadeguato e però decisi a cogliere una nuova opportunità da parte di chi è stato suo malgrado protagonista in negativo di fuoco amico; abbiamo vecchi amori che si dissolvono, altri che si riscattano, Lupa che si perde con un lupo, Manzini racconta in “Vecchie conoscenze” tutto il buono della vita. Ed anche il non buono: perché l’esistenza è fatta anche di delusioni, dolori, tradimenti, non sarebbe vita se non ci fossero anche le disillusioni.
Le sorprese sgradite, le disillusioni amarissime, anche loro sono vecchie conoscenze, per noi tutti, non solo per Rocco Schiavone.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Strampalati omicidi ferroviari
Gli shinkansen sono i famosi treni-proiettile ad alta velocità giapponesi che collegano in poche ore le tante città dell’arcipelago. Su uno di essi, che percorre la tratta Tokyo-Morioka, si ritrovano, per una serie di incredibili, fatali coincidenze, alcuni delinquenti usi all’omicidio e a ogni diverso efferato tipo di crimini.
L’alcolizzato Kimura è salito a bordo per vendicare in figlioletto, che un teppistello di nome Oji (ragazzino delle medie evidentemente sociopatico) ha spinto giù da un tetto per il suo solo perverso divertimento. Ora, il bambino sopravvive legato alle macchine in ospedale e Kimura vuole uccidere chi l’ha conciato così. Sul treno, ovviamente, c’è pure Oji che si diverte, con assoluta noncuranza, a manipolare le persone, a provocare loro dolore e, se del caso, ucciderle.
Qualche carrozza più in là c’è la strampalata coppia formata da Mikan e Lemon (soprannominati gli Agrumi, perché Mikan è uno dei nomi che in Giappone viene dato al miyacawa, frutto simile al mandarancio). Hanno liberato il figlio del potente, crudele boss Minegishi, che era stato rapito da una banda rivale. Dovrebbero riportarlo a casa assieme alla valigia con il riscatto, ma qualcosa va subito storto: il ragazzo muore, la valigia scompare e loro sono nei guai sino al collo.
Sullo shinkansen c’è pure Nanao (soprannominato Coccinella). È un delinquentello da poco, perseguitato dalla sfortuna, ogni incarico che gli offrono si trasforma in una tregenda piena di contrattempi. Questa volta il suo procuratore, Maria, gli ha ordinato l’ennesimo lavoretto facile: rubare una valigia e scendere alla prima stazione, ancora entro l’hinterland di Tokyo. Ma, guarda caso, la valigia da rubare è proprio quella col riscatto e la sfortuna cosmica di Nanao gli impedisce di scendere a Ueno. Da quel momento tutto andrà storto, perché per lui “non esistono lavori facili”.
Le vicende dei protagonisti si intrecceranno tra loro e con altri figuri non più raccomandabili. Tutti, volenti o nolenti, si trovano a interagire gli uni con gli altri, ostacolandosi (uccidendosi?) a vicenda in una complicata serie di imprevisti al limite della credibilità.
Come ho sperimentato già altre volte, leggere un romanzo giapponese è come calarsi in un mondo alieno nel quale anche interpretare la mentalità dei protagonisti richiede impegno e non comune forza d’astrazione. In questo caso l’impresa si è rivelata ancora più ardua, tanto da lasciarmi sconcertato. Molti dei personaggi che si agitano in questa bislacca storia sono decisamente caricaturali e sembrano agire in modo illogico, folle o, perlomeno, non molto razionale. Lemon, ad esempio, basa i suoi comportamenti sugli “insegnamenti” ricevuti imbottendosi la testa coi cartoons del “Trenino Thomas”. Nanao è perennemente incerto su come comportarsi, ha la quasi totale certezza che se solo prevede un inconveniente quello gli si presenterà davanti decuplicato, quindi si limita ad improvvisare. Kimura è un padre affezionato seppur distratto e obnubilato spesso dall’alcol, ma è pure maldestro e suggestionabile. Oji, all’aspetto è un diligente, gentile ragazzino “delle scuole medie”, ma agisce come un serial killer psicotico, riuscendo ad avere la meglio, con le sue doti di manipolatore e la sua fredda razionalità, di persone ben più scafate di lui, ma si muove al solo scopo di divertirsi a provocare ira e disperazione negli altri, senza piani precisi e in modo sostanzialmente caotico. Non molto più lucidi appaiono gli altri protagonisti. Ma la cosa che più sconcerta è l’assoluta spregevole immoralità con cui agiscono tutti, come se spezzare il collo alle persone o spingerle sotto un camion a un incrocio stradale sia una normalissima attività con cui guadagnarsi da vivere, solo “entro un giro un po’ più pericoloso degli altri”.
Leggendo questo romanzo surreale possiamo dimenticarci il Giappone classico, odoroso di fiori di ciliegio in cui le persone si salutano con gentili inchini e sono restie a invadere la sfera personale del prossimo. Ci viene mostrata un’altra faccia del Paese, dove un bullismo crudele e spietato è endemico nelle scuole, dove una fetta della popolazione, per sbarcare il lunario, entra in pericolosi giri criminali dove tutto è lecito.
Più e più volte viene da domandarsi se quella rappresentata sia una realtà credibile nel Giappone moderno o solo la trasposizione in letteratura delle fantasie dell’A. ispirato da manga, film di Tarantino, letteratura pulp e videogiochi stile Street fighter. Il nonsense dei fratelli Marx si intreccia con la logica mafiosa. Analisi sociologiche, anche profonde, servono solo per giustificare azioni asociali. Comportamenti all’apparenza infantili (anzi bambineschi) conducono ad azioni efferate.
Lo stile è semplice, molto ricco di dialoghi anche se spesso su argomenti banali e infarciti da pesanti volgarità. La trama, caotica e disordinata è, nel contempo, abbastanza lineare e, come lo shinkansen, procede diritta verso il finale, ma, a differenza del treno, con una certa lentezza e ripetitività.
In conclusione sono rimasto parecchio perplesso su come giudicare questo romanzo. Da un lato si meriterebbe il minimo dei voti, vuoi per i temi trattati, per il modo in cui ciò viene fatto e per la morale che suggerisce; vuoi per la sua assoluta inutilità, anche a mero fine ricreativo. Dall’altro non si può negare che, comunque, l’attenzione del lettore resti catturata dalla storia e l’inevitabile lieto fine (almeno secondo la logica che ci viene imposta) in fondo appaghi.
Inoltre, va dato il merito a questo romanzo di schiudere una porta su un Giappone insolito che, probabilmente, non è né vero né fittizio, ma un’immagine distorta di una preoccupante realtà sotterranea. Poi, parecchi ragionamenti fatti dai protagonisti, anche se a tutta prima possono apparire semplicistici, se non qualunquisti, hanno un fondo di verità inquietante su cui vale la pena meditare.
Chiudo con un pensiero. La morale del libro, forse, può essere tratta dalla domanda che Oji insistentemente ripropone a tutti (“perché non si devono ammazzare gli altri?”) e dalle risposte che riceve da Lemon (“Che l’omicidio debba essere punito è solo una regola stabilita da quelli che non vogliono essere ammazzati! Gente che da sola non è in grado di combinare nulla, e pretende di essere difesa”), da Mikan, citando Dostoevskij (“il delitto non è più pazzia, ma è proprio un atto di buon senso, quasi un dovere, per lo meno una nobile protesta. Su via, un assassino colto come può non uccidere, se ha bisogno di denaro?”) e dal mite professor Suzuki, l’unica persona “normale” su quel maledetto treno, (“Uccidendo gli altri, si mette in difficoltà lo Stato” […] se non si salvaguardasse la vita umana, o per lo meno non si facesse finta di farlo, si bloccherebbero le attività economiche”). Non so quale delle tre risposte sia più agghiacciante.
Così preferisco cercarla nel titolo giapponese del libro, Maria Bitoru, translitterazione di uno dei nomi inglesi dati alla coccinella (Lady, cioè Maria, Beetle) e nella leggenda in base alla quale la coccinella rechi sette puntini sul dorso a ricordo dei sette dolori di Maria e quando, risalita sino in cima a una foglia, spicca il volo, con sé porti via un po’ di quelle sofferenze. Il finale del libro sembra volerci consolare con questa speranza.
Indicazioni utili
- sì
- no
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Ricordi da tenere nascosti
La ragazza A è stata l'unica che ha avuto il coraggio di fuggire dalla prigione dove è stata rinchiusa da suo padre. Il suo gesto ha salvato i suoi fratelli e sorelle. Dopo parecchi anni, diventata adulta, avvocato di successo e trasferitasi negli Stai Uniti torna nel Regno Unito, a seguito della morte della madre. Non si tratta di richiamo alle origine, o di amore filiale, ma solo della chiamata da parte dell'avvocato che si è occupato delle ultime volontà della donna prima di morire in carcere. Vittima di un terribile carnefice, talmente terrorizzata del marito da non riuscire neppure a difendere i figli, oppure spietata complice di quel mostro. I dubbi rimangono e in realtà la ragazza A neppure li vuole sciogliere, tanto che ha scelto di non aprire nessuna delle lettere che la donna le ha inviato nel corso degli anni. Ma nominata esecutore testamentario decide di assumersi questo onere, andare a rivedere il luogo del suo martirio, incontrare i fratelli e lasciare la sua mente libera di ricordare, farsi domande, ricostruire avvenimenti e correggere i ricordi, quelli che la sua mente ha costruito modificando i fatti, solo per permetterle di diventare abbastanza grande e forte da affrontare la verità.
Questo libro è per certi versi terribile da leggere. quello che è successo a questa famiglia è inimmaginabile. Come sempre viene da chiedersi some fatti di questo tipo siano passati inosservati in una comunità piccola, ma i fatti di cronaca periodicamente ci confermano che in realtà i mostri esistono, sono astuti e hanno una intelligenza primordiale che gli permette di mostrare all'esterno una faccia diversa da quella che svelano in casa. Il tema di questo romanzo forse è un po' abusato , anche se qui l'autrice ci va giù piuttosto pesante. Quello che però differenzia il romanzo dagli altri del genere e che secondo me lo rende degno di essere letto è l'analisi delle dinamiche che si sono venute a creare tra le vittime. A volte solidarietà, altre volte a prevalere è l'istinto di sopravvivenza che cerca di preservare la propria vita a discapito di quella di un altro, oppure la cattiveria pura, perché alla fine quella sembra l'unica regola che vige in quella casa.
Abigail Dean ha uno stile diretto e pulito, ci racconta i fatti senza tanti fronzoli, senza commenti e senza lasciarsi coinvolgere dalla tentazione di dare giudizi morali. I fatti sono quelli che sono nudi e crudi, sarà il lettore, tenendo conto di tutti gli elementi che gli sono stati dare valutare se sia il caso di condannare qualcuno, o tutti, oppure di essere indulgente e comprensivo verso questo gruppo di varia umanità che in fin dei conti ha solo dato retta al proprio istinto di sopravvivenza.
Indicazioni utili
Il colore intimo delle persone
Da quel giorno e fino all’ultimo della sua vita, in cui anche lei sarebbe arsa (…) , Mio avrebbe sempre cercato il colore intimo di ogni persona.
Quella sfumatura unica, precisa, che la riassumeva”.
Mio è letteralmente nata nei colori: la sua famiglia possiede un atelier dove vengono tinte stoffe, cuciti su misura i kimono nuziali per le giovani spose. Dalla madre e dalla nonna apprende la sapiente arte dell’abbinamento delle stoffe, della resa dei colori e della magnificenza dei ricami, in tenera età già si incanta a ripercorrere con le dita i fili dei ricami e ad ascoltare la nonna che “parla” affettuosamente agli obi -le alte cinture dei kimono- alle stoffe, accarezzandole come se fossero bambini.
Mio è letteralmente nata nei colori. Possiede un rarissimo dono di natura: la visione tetracromatica. “…gli occhi di Mio individuavano milioni di colori in più degli altri”, grazie ad un numero elevato di ricettori del colore nella retina.
E i doni hanno un prezzo.
Mio da bambina è diversa, se ne accorge subito la madre, con molta apprensione consulta medici e tutti le dicono di stare tranquilla, sicuramente la bambina è solo un pò più pigra degli altri nel linguaggio. La piccola Mio non è ancora in grado di trovare la maniera per esprimere in modo comprensibile agli altri l’esplosione cromatica che la investe ogni giorno, perché per lei un “giallo” non è un “giallo e basta”, ma trova una miriade di colori diversi per definire il giallo del limone, oppure quello di un particolare tipo di fiore, o di una fase precisa del giorno.
Capirà fin da subito che l’ossessione per i colori la accompagnerà per tutta la vita.
Il libro si apre con l’immagine di due bambini, in spazi differenti, alle prese con dei disegni: Mio e Aoi, una bambina e un bambino. Il loro diverso comportamento di fronte ai colori dimostra da subito i due diversi approcci alla vita e alla morte dei protagonisti che conosceremo meglio da adulti. L’una si diverte a giocare con la gamma del verde, incollando sul foglio qualsiasi cosa verde che si trovi davanti, anche la finta pelle che ricopre la borsa della madre, l’altro disegna un albero usando colori poco realistici.
Attraverso le pagine scopriremo meglio la vita di Mio, da bambina (saltando l’adolescenza e la prima giovinezza) al momento in cui lavora presso un’azienda, la Pigment, che si occupa di belle arti e di colori. Scopriremo meglio il suo carattere nel momento stesso in cui si innamorerà di Aoi, che si presenta da lei per una richiesta di consulenza cromatica. Lui la affascina sin da subito e non riesce a capirne il perché, scatta in lei una vera ossessione: rispetto alle altre persone, di Aoi non riesce a individuarne il colore che lo caratterizza e poi…il suo mestiere, la attrae e la terrorizza allo stesso momento. Impresario di pompe funebri.
Lei ricorda le parole della madre: “In fondo è esattamente ciò che non sai di una persona a farti innamorare di lei. Cerca di trovare anche tu qualcuno di cui non sai quasi nulla. Ne rimarrai innamorata tutta la vita”.
Niente poteva essere più ossimorico, una storia che si costruisce sui contrasti. Da una parte Mio, esplosione di colori, rifiuto della morte e, dall’altra, lui, Aoi, che familiarizza con la morte ogni giorno e non ha un colore dell’anima definito.
Aoi rappresenta per Mio quello di cui ha bisogno: accettare la morte con calma e compostezza, quello che sinora non è riuscita a fare.
“Le vite nascoste dei colori” è un romanzo multitematico: l’amore, la passione, storie familiari difficili, l’accettazione della morte.
La storia è piacevole, la scrittrice è sicura, spedita e con una delicatezza, che non è mai leggerezza o sciatteria, sa narrare i passi più crudi e duri. In questo libro ha dato prova di grandi capacità narrative, toccando la tematica alquanto scomoda e difficile della morte e del trattamento dei cadaveri (in Giappone vengono truccati) senza indugiare in passaggi descrittivi, ma accennandoli, restituendoci, così, pagine toccanti, che non mi sono sembrate da “sentimentalismo spicciolo”.
Il libro si divide in tre parti più un epilogo ed ogni parte è contraddistinta da brevi paragrafi titolati che si leggono velocemente, introdotti da una piccola “rubrica” in corsivo che ne riassume il contenuto. Ciò conferisce alla narrazione il tono fiabesco, anche se l’ambientazione è una modernissima Tokyo, con le sue mille sfumature, la sua folla di persone, le sue contraddizioni, tanto amate dalla scrittrice, che l’ha battezzata quale seconda patria. La presenza di una città viva e reale, con i suoi luoghi specifici, i suoi giardini, i suoi negozi, la sua stazione, permette alla Messina di costruire una fiaba contemporeanea credibile che comunica insieme la magia della cultura giapponese (che non è assolutamente uno sfondo) e il dramma della storia personale di Mio.
Completa l’opera un glossario dei termini giapponesi utilizzati nel romanzo e un utilissimo inserto, “Il taccuino dei colori di Mio”, che raccoglie tutte le sfumature di colore, in realtà dei colori a se stanti, precisi e concreti, scritti in una o due parole giapponesi, ma che tradotte in italiano diventano delle vere e proprie perifrasi per rendere meglio al lettore la specificità di quel colore. E allora “seitai”non è un semplice blu, ma “un blu sobrio e profondo, picchiettato di un nero carbone e lampi di giallo castagna”, lo shikkoku non è un nero qualsiasi, ma “un profondo e brillante nero lacca”.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Può un’intelligenza artificiale colmare la solitud
È un romanzo ricco di interrogativi ai quali è difficile dare risposte certe, l’ultimo romanzo di Kazuo Ishiguro, Klara e il sole. In un mondo che va perdendo, giorno dopo giorno, il senso della solidarietà e della umanità per assumere sempre più spesso atteggiamenti cinici ed egoistici, l’individuo sembra condannato a vivere in uno stato di solitudine incolmabile.
È per rendere più lievi le lunghe giornate solitarie di Josie, ragazzina vivace e intelligente, ma affetta da un male oscuro, che Klara, l’Amica Artificiale, le viene acquistata e affiancata. Pur essendo una macchina, Klara sembra possedere grande sensibilità e molta affinità con Josie. Assai ben predisposta all’apprendimento, essa coglie i limiti della società che la circonda, ne vede i pericoli che incombono sulla esistenza e sulla sopravvivenza degli esseri umani con i quali si relaziona e ai quali sembra addirittura affezionarsi. E questo è uno dei molti interrogativi che Ishiguro pone a se stesso e ai lettori. Quanto può un’intelligenza artificiale avere sentimenti propri, non programmati? Entro quali limiti può essa muoversi autonomamente? È certo che nel suo rapporto con gli altri personaggi, la Madre, il Padre, Rick, Domestica Melania o Direttrice, Klara mostra una sensibilità eccezionale, che non può, tuttavia basarsi sull’esperienza, dal momento che, al contrario degli umani essa non ha storia, non ha passato, non ha ricordi. Persino la sua visione del mondo che la circonda è generalmente frammentata e raggiunge solo di tanto in tanto una unitarietà. Eppure è lei che più degli altri ha coscienza del degrado ambientalistico, dell’inquinamento che viene causato dalle “Cootings Machines” con i loro fumaioli sbuffanti fumo nero che offuscano il cielo e coprono il sole. Nel sole, l’elemento essenziale alla sopravvivenza di Klara, che si nutre della sua energia, essa ripone ogni speranza, anche l’ultima speranza che Josie possa guarire e continuare la sua vita sia pure in un mondo ingiusto e socialmente discriminante, che distingue e seleziona i giovani tra i più “potenziati” e i “non potenziati”. A Klara non sfugge nulla di ciò che non va in questo mondo, cerca persino di migliorarlo, anche se invano e nel momento in cui prende coscienza dei suoi limiti, si rivolge al Sole, con una preghiera che nasce dal cuore, quel cuore che non ha fisicamente, ma che sente in sé battere d’amore per Josie come per Rick o per la Madre.
Le macchine durano un tempo limitato, come gli uomini. Gli uomini vengono pianti, sinceramente o ipocritamente. Le macchine vengono semplicemente dimenticate.
L'ultimo degli uomini
Intelligentemente ripubblicato da Ponte alle Grazie in tempi di pandemia “Oryx e Crake” non è altro che “L’ultimo degli uomini”, pubblicato dalla stessa casa editrice nel 2003. Il motivo è chiaro: diversi aspetti riguardanti il virus e la pandemia descritti in questa storia ricordano moltissimo quella che ci stiamo ritrovando a vivere ormai da due anni. Devo dire che, prima di informarmi riguardo alla data di prima edizione di questo romanzo, ho pensato che la Atwood avesse voluto cavalcare l’onda del momento presentandoci cose che ci sono ormai familiari; quando ho scoperto che la scrittrice le aveva invece pensate quasi venti anni fa, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Soprattutto nella parte finale del romanzo, infatti, quando si chiariscono le dinamiche che hanno portato allo scoppio della pandemia nella storia narrata, ho pensato: “vabbè, ci sta proprio sbattendo in faccia quello che vediamo e sentiamo tutti i giorni durante i telegiornali, alla Atwood piace vincere facile.”.
E invece… la cara scrittrice ci ha visto (purtroppo) molto lungo.
Ora, senza andare a scomodare mostri sacri («Atwood meglio di Orwell» tuona il The New Yorker), è evidente quanto la scrittrice canadese sia una delle migliori in circolazione al giorno d’oggi, una di quelle che meglio interpreta quello che secondo me è il mantra della letteratura moderna: trasmetti un messaggio intrattenendo; temi importanti devono avere come veicolo vicende coinvolgenti. Ora, c’è da dirlo, in questo romanzo i temi che emergono non vengono sviluppati con la potenza che ci si aspetterebbe considerando lo scomodo paragone con Orwell, ma è percepibile quanto la Atwood si metta una spanna sopra ad altri autori che si limitano all’intrattenimento e a nulla più: tiene in sospeso come loro, coinvolge come loro, ma è chiaro che la storia narrata ha più di queste semplici ambizioni, supportate da uno stile impeccabile.
Riguardo alla storia, ha diversi risvolti originali - spaventosamente vicini a noi - sebbene segua le linee e le idee narrative classiche dei post-apocalittici; ma come ben sappiamo inventare una storia che sia del tutto originale al giorno d’oggi è pressoché impossibile, quantomeno la Atwood lo fa bene. Fattore da non dimenticare, la prima pubblicazione di questo romanzo risale quasi a vent’anni fa, quando il genere non era stato sfruttato tanto quanto lo è oggi.
Il nostro protagonista è Snowman, classico ultimo degli uomini che si arrabatta per sopravvivere; uomo che divide una terra ormai desolata con una strana tribù: i Craker. Grazie a una struttura narrativa ben congegnata, riusciremo a districarci tra il presente e gli eventi passati che hanno portato Snowman- o meglio Jimmy - e gli esseri umani verso la loro spaventosa fine. Primo romanzo di una trilogia, devo dire che ha suscitato la mia curiosità e la voglia di leggere il resto.
P.S. Però non toccatemi Orwell… marchette maledette.
“Ora beveva da solo, la sera, un brutto segno. Non avrebbe dovuto farlo, lo deprimeva e basta, ma doveva smorzare il dolore. Il dolore di cosa? Il dolore della carne viva delle ferite, delle membrane danneggiate nei punti in cui si era scagliato contro la Grande Indifferenza dell’Universo. La bocca di un grosso squalo, l'universo. File e file di denti affilati come rasoi.”
L’ araba fenice
La consuetudine richiede di etichettare un romanzo in base al genere letterario.
Secondo quest’ usanza, l’ultimo libro di Ilaria Tutti sarebbe da ascrivere al genere thriller, o giallo, o mystery che dir si voglia, insomma una semplice narrazione di genere poliziesco, che tiene avvinto il lettore producendo tensione e suspense.
Certamente è anche questo, un dramma, un enigma che tiene desta l’attenzione e l’interesse: però prima di ogni altra cosa è davvero una bella storia, un racconto interessante, intrigante, intenso e profondo, un romanzo elegante.
“Figlia della cenere” di Ilaria Tuti è un libro fine, di gran classe, fluente, impeccabile, presenta una scrittura linda, scorrevole, pregiata, un modo di narrare colto, ma accessibile e attraente per chiunque.
La storia attira e incuriosisce, soddisfa e appaga, e intanto insegna, suggerisce, istiga a riflettere su quel mosaico umano non solo metaforico, anche reale, antico, un affascinante reperto archeologico citato in questo libro:
“…dentro una chiesa…ad Aquileia…c’è questa cripta incredibile…il pavimento musivo paleocristiano più esteso ed antico d’Europa rimasto sotto terra per millecinquecento anni.”
Un mosaico intricato e complicato, formato da un numero innumerevole e finito di frammenti esistenziali, di tasselli da puzzle, di tessere tutte diverse eppure tutte uguali, intarsiate, pregevoli, o anche infime, disastrate, più spesso ottagonali, con angoli, forme, colori, rotture e screziature varie e variegate, che nell’insieme rappresentano un reperto che richiama alla mente l’animo umano come effettivamente è, un mosaico di sentimenti di vario genere visti nella sua costituzione, e nel loro intrecciarsi ed interagire tra loro nel progredire dell’esistenza.
Tutto il racconto è porto al lettore in forma accurata, premurosa, un modo di fare semplice ed elegante ad un tempo, presenta una struttura narrativa su tre piani temporali intersecantisi tra loro in modo armonico: l’alba dei tempi, e poi l’ieri, ed infine l’oggi, con un narrare mai sofisticato o fine a sé stesso, ma luminoso, illuminante, limpido e lucente.
L’autrice racconta, e illustra; ci fa vedere quanto narra, lo delinea in tante tessere e di tutte le singole miniature dispiega i minimi particolari, li riporta in luce, fossero anche sepolte sotto strati di terra, spolvera via la polvere del tempo, rivela così i motivi profondi dell’agire e del sentire e dell’essere dei propri protagonisti, siano essi un commissario di polizia o un assassino seriale a cui lo stesso dà la caccia.
Questa è un’opera curata nel tempo, lavorata a lungo, che ha richiesto analisi, accertamenti, riscritture, insomma fatica e impegno, non c’è un solo capitolo, o paragrafo o rigo fine a sé stesso, ogni termine trasuda la ricerca del modo più semplice, chiaro ed efficace per giungere al cuore ed alla mente del lettore e trasmettergli l’anima della storia narrata.
Per questo è un romanzo elegante: perché ordinato, perfetto, tirato a lustro.
In sintesi, è un libro al femminile, che possiede un’anima bella, e la veste elegante, agghindata in maniera regale e inappuntabile.
È una storia completa, compiuta, non solo perché porta a termine come meglio non si potrebbe l’epopea della protagonista principale della maggior parte dei romanzi di Ilaria Tuti, il commissario di polizia Teresa Battaglia, ma può leggersi anche senza nulla sapere delle sue avventure precedenti.
Solo, vale ricordare che sempre le protagoniste principali degli editi della Tuti sono donne, il commissario Battaglia di cui abbiamo accennato, e altre donne, come il fiore di roccia Agata Primus e le altre “portatrici carniche”, tutte originarie dei luoghi natali della scrittrice, il Friuli.
Sempre la Tuti ambienta le sue storie nella sua regione, tra le sue valli, le sue montagne, ogni volta riportandoci luoghi e fatti di cui molti sono all’oscuro, forse ignoti anche alla stessa autrice prima di rinvenirli. Qui, ad esempio, ci parla di Aquileia:
“Aquileia la dimenticata, Aquileia la sconosciuta. Non da tutti, ma da molti.”
I personaggi femminili di Ilaria Tuti, le “sue” donne e forse la scrittrice stessa, se è vero che ogni scrittore mette un po' di sé nei suoi personaggi, sono la quintessenza della moderna femminilità: non femministe, ma donne perché donne, liete di essere tali, non mogli, madri, figlie o etichette varie ma persone, consce del loro valore e del loro essere senza presunte superiorità di genere, differenti solo dal carattere biologico e da un sentire diverso dall’altrui genere, certo non per capacità e intelligenza.
Soprattutto sono donne in virtù dell’empatia particolare che sono in grado di provare per il resto dell’umanità, specie per quella più sofferente, non a caso Teresa Battaglia è una profiler di alto livello, e lo è non solo per gli studi e le competenze, ma per l’empatia che prova per gli autori dei delitti su cui indaga.
“Quella donna conosceva il linguaggio del corpo. Avrebbe potuto sezionare lui e le sue insicurezze con considerazioni spietate, e Dio solo sapeva quanto avrebbe avuto ragione.”
Teresa Battaglia sempre prova amore, e poi pietà, e autentico dolore, per le vittime dei crimini su cui indaga: e però sa perfettamente che la prima vittima di un serial killer è l’assassino stesso.
A differenza dei sodali e colleghi maschili, magari posti più in alto nella gerarchia del comando, la Battaglia comprende che per scoprire un assassinio serve investigare sui motivi che lo hanno spinto a divenire tale.
Più spesso, si tratta di motivi tali che ad essere perseguiti dovrebbero essere altri, gli autori di efferatezze fatte agli assassini, in epoca particolarmente sensibile, più spesso consapevolmente.
“Siamo tutti vittime di qualcuno e tutti siamo stati almeno una volta carnefici”
Solo una donna può possedere tale speciale empatia, non è la sua una banale motivazione sociologica o presunta tale, una forma perbenista finto alternativa di giustificazione dell’assassino, è un’empatia reale, unica e sottile nei suoi confronti, fortemente connotata di umanità, che solo una donna può essere in grado di estrinsecare per farsi guidare nella giusta direzione.
Teresa Battaglia assicura gli assassini alla giustizia innanzitutto perché smettano di continuare a fare del male a sé stessi, prima che agli altri, rinuncino una volta per sempre a punire sé stessi, e per farlo serve solo l’amorevole sensibilità di una donna, difficile da riscontrare in un uomo.
“Teresa Battaglia, invece, accettava la loro natura e così facendo la strappava al senso di repulsione. Lei riusciva a prendere tutto dalle persone che aveva davanti, anche l’orrore più grande, come un dato di fatto. Ecco perché era così brava nel suo lavoro. Non giudicava, non si scandalizzava. Cercava sempre di comprendere. Ma questo aveva un prezzo. Soffriva, con loro.”
Pertanto, Teresa Battaglia è l’emblema della battaglia che ogni donna quotidianamente intraprende per vivere la propria realtà esattamente come sa di poterla vivere, senza se e senza ma, solo come persone senza condizioni, conflitti o prevaricazioni o altri inutili e pretestuosi distinguo.
Un buon romanzo, in definitiva, e certo, un buon thriller.
Perché è la vita stessa che è un thriller: non sappiamo però cosa definisce meglio un simile genere, se la presenza tra i personaggi di un assassino seriale, oppure se è più specificamente da dirsi thriller, perché in realtà è un’azione ben più violenta, l’orrore indicibile ed inverosimile di torturare nel fisico e nella psiche in formazione un bambino, quasi a punirlo di essere al mondo, negargli amore, affetto, attenzione paterni, addirittura il nome, agire con tanta crudele indifferenza ed anaffettività da provocargli un buco al cuore ben più grave di una disabilità congenita di cui è sfortunatamente affetto.
“Chi può spaventare lo spavento?”
Cosa provoca maggior timore, paura autentica se non vero terrore, un comune accidente delittuoso, o il vivere ritrovandosi come marito un compagno brutale, violento, temibile per gli atti, le parole, le angherie fisiche e morali al chiuso delle pareti domestiche?
È un thriller, quello sì, la violenza sulle donne, la violenza domestica, le torture di ogni genere che una bestia esercita quotidianamente sulla propria compagna; come definire se non un orrore, un thriller, la sottile, subdola, vile, tragica violenza domestica di genere, per mero malato possesso di una donna?
“Avrebbe voluto dirle che a volte le persone non si avvicinano per ferire o infierire, e avrebbe voluto chiederle che cosa le fosse successo per farle credere il contrario…”
Sconvolge e annienta la perdita di un figlio, ancora in grembo, da parte di chi quel figlio avrebbe dovuto averne cura: questo suscita terrore autentico, questo sì, ti riempie il cuore di dolore e di pietà, molto più di un omicidio, per quanto efferato.
Ilaria Tuti tutto questo ce lo racconta, solo per questo la si definisce scrittrice di thriller; io la definirei piuttosto una ricercatrice, che rinviene il thriller celato nel comune quotidiano.
Ancora oltre, siamo quello che siamo in virtù del nostro vissuto, delle nostre esperienze: serbandone ricordo, modelliamo il nostro comportamento futuro, quindi la nostra consapevolezza di vivere coscientemente al meglio, inseguendo speranze e progetti, anelando attimi di felicità.
Non c’è thriller peggiore di accorgersi che, lentamente ma inesorabilmente, i nostri ricordi tendono a svanire per non ripresentarsi mai più.
Non esiste thriller peggiore, o migliore secondo i punti di vista, della sindrome di Alzheimer, o di altre forme di demenza, tali da provocare un lento, inarrestabile declino delle capacità di memoria, del pensare e del ragionamento.
I ricordi, lieti o meno, ci rappresentano, siamo quello che ricordiamo.
Perderli, significa perderci: in tutti i sensi, soprattutto significa perdere la nostra fiamma vitale, l’amore. Significa bruciare l’albero della vita che siamo, ridurci in cenere.
La cenere non brucia oltre, non alimenta fiamme.
Puoi solo stringerla tra le dita, ma impalpabile com’ è, sfugge via, si dissolve nel vento: questo sì che provoca sensazioni da thriller.
Polvere eravamo e polvere torneremo ad essere, è scritto: polvere, non cenere.
Quello che brucia si esaurisce, e scotta.
Teresa Battaglia è figlia della cenere, ma potrebbe invece definirsi più propriamente come l’araba fenice, che si diceva in grado di rinascere dalle proprie ceneri.
Perché Teresa Battaglia, in qualche modo, riesce a rimettersi in gioco, dopo le disgrazie e gli errori.
“…era rinata, e non dalla costola di un uomo che si credeva fatto a immagine e somiglianza di un Dio, ma dalle proprie, incrinate, doloranti, spezzate.”
Teresa Battaglia rinasce dalle proprie ceneri, come l’araba fenice: sanno farlo ogni giorno tante altre donne, come lei, e come lei impegnate ciascuna in una personale battaglia.
Esattamente come ci racconta Ilaria Tuti in questo bel thriller, pardon, in questo ottimo romanzo.
Indicazioni utili
REQUIEM
Mark Behrendt, due vite disgiunte da un grave trauma: lo stimato psichiatra del prima, l’alcolizzato privato del suo titolo del dopo.
Lara Baumann, due personalità scisse da una tragica perdita: la quasi più giovane primaria della Waldklinik del prima, la commessa del planetario del dopo.
Il ragazzo riposa in stato di shock, viene svegliato da un rumore insolito per quel reparto silenzioso. Vede muoversi qualcosa sotto il letto vuoto accanto al suo. I piedini frusciano, lentamente una bambina carponi scivola allo scoperto, sembra stia cercando qualcosa…poi si gira.
A casa di Doreen, acqua fredda in bottiglia ed antipasti italiani. Il campanello, il vuoto, un dolore pungente al collo, poi buio.
Due giorni. Nove ore. Ventitré minuti.
Questo è il tempo che hai a disposizione per trovare qualcuno, non sai chi e non sai dove, una chiave in tasca. Uccidilo, altrimenti lei morirà.
Wulf Dorn riesce in un’impresa veramente incredibile, scrivere un perfetto requiem dei colpi di scena. Li stermina con un accanimento sbalorditivo, che il Dio del thriller abbia pietà di lui.
Badate, non deve essere stato facile, perché la trama è fitta ed i soggetti interessanti, ma senza suspense questo genere non sfonda.
La lettura è stata noiosa e a tratti mortificante perché ogni tasto si rivela a corde scoperte, ci si ritrova a sapere cosa succederà senza nemmeno leggere, in questa maledettissima scelta di prevedibilità. Un colpo di coda sul finale schiaffeggia brioso il lettore dormiente, ma darne un giudizio è complicatissimo. Ci sono contenuti di pregio, ma il razzo non decolla e verso Wulf Dorn io sono pretenziosa.
Benino ma non benissimo.
Vita da barcaiolo
I burchi dal fondo piatto percorrono il dedalo di canali e lagune venete trasportando merci di ogni genere fin sul finire degli anni sessanta del secolo scorso.
Sulle sponde e agli attracchi fioriscono piccoli borghi il cui fulcro è un'osteria, luogo di incontro per rifocillare con un bicchiere di vino e due chiacchiere i “barcari” corrosi dai giorni trascorsi vogando. Faticoso e pittoresco insieme questo mestiere una vocazione per qualcuno un'eredità gravosa per altri, tramandata di padre in figlio.
Sono anni in cui l'Italia sta mutando, i servizi igienici prendono posto all'interno delle abitazioni, la televisione è l'oggetto più ambito, il motore soppianta il traino a cavallo e le imbarcazioni a remi, la fabbrica è la nuova dimensione lavorativa.
Mentre le acque dei fiumi sembrano soggiacere sempre alle stesse regole della corrente e delle piene, il paese morde il freno e corre verso la modernità.
La generazione di adolescenti del 1965 come il giovane Ganbeto, vive appieno questa metamorfosi socio-culturale; lasciare gli studi per fare il mozzo sul burchio di famiglia per volontà del nonno, assume le sembianze di una eccitante avventura nella fase iniziale per divenire poi costrizione e insofferenza col tempo.
Densamente realistico lo spaccato regionale proposto da Paolo Malaguti, in grado di raccontare un pezzo di storia che merita di essere ricordata, conferendo dignità ad una popolazione vissuta in territori disagevoli e complicati, dedita ad antichi mestieri che facevano dell'acqua strumento di lavoro e di sopravvivenza per portare un pezzo di pane sulla tavola.
Un mondo arcaico quello lagunare e fluviale, dominato da proprie leggi non scritte e tradizioni.
Animi duri, forgiati dalle correnti e dalle privazioni, dai sacrifici e dalla caparbietà.
Un flusso narrativo che si affida in buona parte ai dialoghi, colorandoli di termini e locuzioni dialettali per creare una fusione ottimale tra persone e luoghi, tra volti e contesto sociale.
Un romanzo il cui genere fa tornare alla memoria l'indimenticabile Sebastiano Vassalli, per la nitidezza dei protagonisti attraverso le cui storie personali si vuole raccontare la grande Storia di un Paese dalle forti caratterizzazioni regionali come il nostro.
Il titolo è stato selezionato per concorrere all'edizione 2021 del Premio Campiello.
Indicazioni utili
La parabola discendente dei Florio
«All’inizio è un sussurro, un mormorio portato da una bava di vento. Nasce nel cuore dell’Olivuzza, al riparo di tende tirate, in stanze immerse nella penombra. Il vento afferra la voce e questa sale d’intensità, si mescola al pianto e ai singhiozzi di una donna anziana che stringe una mano fredda.»
Con “L’inverno dei leoni” giunge a conclusione la saga dei Florio iniziata con “I leoni di Sicilia” classe 2019. Torniamo dunque tra i membri della famiglia Florio, tra anime che si sono allontanate dalla terra natia per farvi ritorno, perché a quel mare è impossibile sottrarsi così come alle origini che segnano ciascuna esistenza, e altrettante che in questa terra siciliana sono riusciti a fare fortuna.
È Ignazio a dover portare avanti la storia di Casa Florio. Vincenzo Florio, senatore del Regno d’Italia e patriarca della dinastia muore nel 1868 mentre il figlio, trentenne e unico maschio, si è sposato nel 1866 con la baronessa Giovanna d’Ondes Trigona. Questo si traduce nel traguardo di aver portato sangue nobile nella famiglia. Ma Ignazio non dimentica le sue origini e quel lavoro che da sempre è stato radicato in lui come culto. Non dobbiamo mai dimenticare, leggendo queste pagine, che alla base dei Florio vi è il desiderio di riscatto sociale e di raggiungere sempre quel traguardo in più. Ecco perché se nel 1799 i fratelli Paolo e Ignazio sbarcando a Palermo sognano di fare fortuna prima come commercianti di spezie, poi con il commercio di zolfo e ancora acquistato terreni e abitazioni, mai si fermano nel loro desiderio di ascesa e conquista. Questa costante ambizione segna il loro divenire e la loro discendenza nel bene e nel male, con scelte giuste e altrettante errate che non risparmiano nemmeno i volti femminili che abitano la saga.
«Allora, solo per loro, lì, nello specchio, Franca è di nuovo giovane e bellissima. È nella sua stanza, quella con il pavimento coperto di petali di rosa e i puttini sul soffitto. Gli occhi verdi sono limpidi, la bocca è aperta in un sorriso sereno. Indossa un leggero abito bianco e le sue perle. E in quel momento, tanto perfetto quanto impossibile, è davvero felice. Come non è mai stata davvero.»
Ma è sufficiente un nome per portare avanti una dinastia e mantenere il successo e la fortuna di chi è partito dal nulla per giungere al tutto e all’ammirazione – e invidia – generale? Come gestire quella articolata ed estesa rete d’affari che va oltre il pensato? E quanto ancora può costare davvero il rinunciare a quell’amore per un destino segnato da responsabilità e un desiderio di ascesa inarrestabile? Come fronteggiare, ancora, quella parabola discendente che sembra voler porre una fine a quel divenire senza confini?
Tanti i presupposti di partenza per questo secondo e conclusivo capitolo delle avventure della famiglia di imprenditori siciliani. Se da un lato il lettore è incuriosito dall’evoluzione che le vicende prenderanno, è affascinato dall’idea di rivivere ambientazioni già note, dall’altro sin dalle prime pagine l’opera trasmette un senso di respingimento. I personaggi sono sì ben caratterizzati e non mancano le descrizioni degli orpelli e oggetti vari dei Florio così come dei luoghi ma è innegabile una sproporzione rispetto al narrato tanto che l’attenzione si affievolisce, l’intensità perde di forza e vigore, il conoscitore è rallentato nel suo interesse tanto che a più riprese si chiede anche dove effettivamente si arriverà con l’evoluzione della narrazione. Seppur questo conosca il dato relativo al fatto che ne “I leoni di Sicilia” a esser narrati erano prevalentemente i fatti relativi all’ascesa dei Florio e che qui al contrario quel che viene delineato è la caduta di questi, il rovinare dal più alto dei piedistalli, la lettura tende a essere farraginosa e non funzionante, macchinosa ed eccessivamente prolissa. Che si sia voluto far troppo e mettere troppa “carne sulla brace”? Che sia una conseguenza data da una responsabilità troppo grande per un pubblico esigente? Può darsi, tuttavia, tanto il lavoro di documentazione storica è inciso e meticoloso, tanto manca quel coinvolgimento emotivo proprio di quel filone narrativo cui appartiene il narrato.
“L’inverno dei leoni” è uno scritto da leggere se si è letto il precedente episodio per dare una conclusione a un qualcosa di già cominciato, è un romanzo strutturato per un pubblico specifico di lettori, è un elaborato che risente di una impostazione rigida e che non è riuscito ad andare oltre a quel meccanismo preimpostato che lo accompagna. È uno scritto che sembra aver imbrigliato tra le sue maglie l’autrice stessa quasi come se la medesima avesse avuto difficoltà nel romanzare tanto da essere la prima “prigioniera” di quel congegno innescato con i Leoni. È dunque un titolo che convince solo in parte e a cui si riconosce l’impegno e il lavoro di ricostruzione e documentazione senza però poter gridare al capolavoro letterario.
«Se ci ripensa, prova un vago fastidio, ma non dolore. Persino dipendere dalle figlie e dal fratello lo lascia indifferente. Non ha più neanche un soldo, lui, anche se, almeno formalmente, Casa Florio non è mai fallita. Quello che gli strappa l’anima è l’idea che con lui si perda… un nome. Una storia. La loro storia, racchiusa in quel piccolo cerchio d’oro reso sottile dagli anni. […] “Vero è.” Si gira e sorride alla bambina e al vecchio. “Gli altri sono gli altri. Noi siamo i Florio”.»
Indicazioni utili
- sì
- no
No = a chi non ama il genere e cerca un altro tipo di romanzo storico.
UNA STORIA CHE NON RIESCE A EMOZIONARE
Alla fine di questa lettura quello che ho provato è stato un profondo senso di frustrazione.
Questa storia manca di emozione, sembra una favola romantica di quelle che leggevo da bambina, purtroppo però questo libro risulta banale e narrato con estrema superficialità.
Quello che mi ha sconvolto è il trattare un evento drammatico senza alcuna profondità e sensibilità, ho trovato questa cosa molto irritante e per me era meglio non inserirlo, se l'autrice pensava di impietosire il lettore credo che abbia ottenuto l'effetto contrario. Non sempre la soluzione giusta per intenerire i lettori sia descrivere una malattia o una morte di un amico o di un proprio caro, ma alcune volte una storia può emozionare senza dover andare a scavare nelle paure che tutti noi abbiamo.
Ora vi spiego meglio cosa ne penso ma partiamo con ordine.
L'incipit di questo romanzo sicuramente attira molto, Cristina entra nel negozio di un'amica e scoppia una rapina, poi la storia torna indietro a quando la protagonista incontra Andrea e i due si innamorano.
Cristina è ormai una donna ultracinquantenne e nel momento in cui la paura prende il sopravvento ripensa al suo passato e alla sua vita e ai suoi amori.
Questo prologo crea molte attese nel lettore, come giustamente dovrebbe essere una buona introduzione, la curiosità è moltissima e continua fino a quando l'autrice non tornerà a raccontarci come andrà a finire.
La protagonista incontra Andrea quando ha ventidue anni, i due si piacciono subito però Cristina non ha esperienza con i ragazzi e si trova a provare dei sentimenti nuovi che sperava di sentire anche lei prima o poi nella sua vita. Quando era piccola per un incidente su uno scivolo di un parco pubblico, dovette stare sdraiata a letto per moltissimo tempo e da quel momento i suoi genitori sono sempre stati molto protettivi e apprensivi con lei.
Hanno cercato di tenerla lontana dai pericoli della vita, ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza come in una bolla di vetro, ma forse questo non ha aiutato molto la protagonista nel suo percorso di crescita.
Cristina si trova impacciata e indietro rispetto alle altre ragazze della sua età, si sente di aver perso moltissimi anni senza fare tutto quello che invece era "normale" per le sue coetanee, come uscire la sera o indossare un abito alla moda.
"Le mie compagne viaggiavano a una velocità diversa. Me ne accorsi subito. Non parlo della preparazione, ma del modo di porsi, anche solo per spiegare quel poco che conoscevamo." (citazione)
Nessun ragazzo si è mai veramente interessato a lei e quello che sente per Andrea è un sentimento così nuovo, così inaspettato ma sorprendentemente bello che gli dà fiducia, crede a quello che sta nascendo tra di loro.
Tutto avviene in pochissimo tempo, i due si innamorano e si sposano, come dicevo prima una favola romantica che ho trovato molto inverosimile e affrettata.
Purtroppo la narrazione scorre troppo velocemente nel giro di pochissime pagine, passano dieci anni di matrimonio tra Cristina e Andrea, quello che mi ha lasciato perplessa è che la protagonista non ha un'evoluzione, pensa e dice le stesse cose di quando era una ventenne insicura e capricciosa. Ha delle ambizioni personali ma non riusciamo mai del tutto a capirla e a scoprire come sia veramente, la vita le scorre davanti e lei non è mai la protagonista della storia, lascia sempre la scena a qualcun altro.
I personaggi di questa storia non sono poi molti però manca un vero e proprio approfondimento psicologico, di Andrea per esempio sappiamo veramente poco, probabilmente l'autrice doveva "investire" di più su questo aspetto anche se la storia è corta come in questo caso.
Il passo dal raccontare un dramma a un melodramma è breve, quello che fa la differenza è la cura dei dettagli dell'aspetto emotivo e più intimo dei vari personaggi, quando le emozioni passano in secondo piano succede quello che abbiamo letto in questo romanzo.
I personaggi sono multi-dimensionali e dobbiamo scoprire le loro particolarità, le loro caratteristiche dopo una serie di trasformazioni, quindi capiamo a poco a poco, quello che loro pensano, quello in cui credono. La loro evoluzione personale, influenza il loro approccio alla vita e le loro scelte, ma anche il loro modo di reagire quando accade qualcosa di drammatico.
C'è troppa carne al fuoco in questa storia, la trama non è originale e a tratti l'ho trovata inverosimile e superficiale, come diceva un vecchio modo di dire sulla scrittura "less is more" ovvero che la semplicità è la sfida più grande per uno scrittore.
Non si percepisce il dolore che Cristina prova, sì lo leggiamo, capiamo quanto questa ragazza meriti di essere amata e di amare e di quanto abbia bisogno di essere felice.
"Mi sentivo in subbuglio. Tutti i pezzi della mia vita che credevo di essere riuscita a ordinare, impacchettare e nascondere dentro un armadio chiuso a chiave erano ancora una volta sparsi in disordine sul pavimento della mia vita. [...]" (citazione)
Lo stile dell'autrice è molto semplice, si percepisce da subito che la Rattaro sa scrivere, che ha esperienza però purtroppo la narrazione risulta essere piatta e senza alcuna evoluzione positiva.
Per me verso la fine il libro la storia peggiora ulteriormente cercando di dare una conclusione che in un qual modo cerchi di mettere ordine e felicità nella vita di Cristina con scarsi risultati però.
L'idea era molto buona, le primissime pagine mi hanno coinvolto però il proseguo della narrazione mi ha lasciato alquanto perplessa e stupita in negativo.
La parola semplice la troviamo nel titolo, io ho capito quale fosse lo scopo di questa storia però il risultato è stato alquanto deludente, quasi non riconosco l'autrice che sa scrivere meglio di così.
Indicazioni utili
- sì
- no
Bene ma non benissimo
Alice Basso torna in libreria con il secondo libro dedicato alla serie di Alice Bo ambientata al tempo del fascismo. Alice ha vent'anni, è una bellissima brunetta che fa girare gli uomini per strada e ha deciso di posticipare il matrimonio con Corrado di sei mesi, per prendersi del tempo per lavorare; le sue poche doti da dattilografa l'hanno portata a lavorare per la rivista “Saturnalia” solo che quello che doveva essere un semplice impiego momentaneo è invece diventato qualcosa di più.
Alice ha scoperto l'amore per i gialli, romanzi di cui si occupa la sua rivista e con Sebastiano, figura centrale nonché autore, danno vita ad un nuovo personaggio:
“”Dobbiamo ricordarci per quale ragione abbiamo dato vita a J.D. Smith”, dice Sebastiano. “Doveva essere per poter raccontare le storie escluse dalla giustizia ufficiale e dai giornali, giusto? Per portare alla luce i soprusi che la legge non vuole punire. Perché non passino totalmente sotto silenzio, e le vittime possano ricevere quantomeno un po' di empatia, di riconoscimento e di affetto dai lettori visto che tanto un vero risarcimento ufficiale non arriverà mai.””
Alice Basso, documentandosi, mette in luce la vita delle donne e soprattutto delle ragazze madre e delle prostitute al tempo del fascismo. Con leggerezza parla di argomenti importanti che spesso molti evitano di approfondire ma che purtroppo fanno parte della nostra storia. Il giallo questa volta è più presente, entra subito nel vivo rispetto all'altro romanzo e l'indagine è più approfondita. L'autrice punta sempre sui suoi protagonisti e in questo volume anche Clara e Candida ( le mie preferite) diventano personaggi più presenti.
La Basso parla di amicizia, di amore e della giustizia che purtroppo non sempre fa il suo giusto corso. Mette in luce le difficoltà del tempo e come le apparenze spesso sono l'unica cosa che conta. Dà parola anche a quelle persone che al tempo non ne avevano. Fin qui tutto bene, cosa stona almeno per me in questo libro? Semplicemente lo stile e le ripetizioni. La Basso non si migliora rimane sempre allo stesso livello, non vedo una crescita ma casomai una decrescita. Per me è una scrittrice che va letta a piccole dosi o a dosi singole, in quel caso fa colpo perché lo stile è particolare e valido ma sul lungo andare la monotonia stilistica non aiuta, la simpatia perde di brio, quello che divertiva all'inizio alla fine diverte meno. Vorrei non che stravolgesse il suo modo di scrivere ma apprezzerei dei cambi di registro o comunque qualche novità.
“Il grido della rosa” è un libro leggero, adatto sotto l'ombrellone che farà divertire le meno “fiscali” e che farà apprezzare il contesto storico alle più esigenti. Un libro spensierato, adatto a chi cerca cose del genere, per letture più impegnative rivolgersi altrove!
Buona lettura!
Indicazioni utili
I VORTICI DELLA MENTE
È il racconto di quattro anni della vita del noto scrittore, quelli che lo hanno impegnato nella stesura del suo ultimo libro, questo appunto, ma che lo hanno anche segnato dal punto di vista personale per una serie di eventi, primo fra tutti il suo ricadere in uno stato di melanconia tale da farlo virare rapidamente da depresso generico a persona che vive un “episodio depressivo maggiore, caratterizzato da elementi di malinconia e idee suicidarie in un quadro di disturbo bipolare di tipo II”. Eppure è al culmine della grazia, il suo ego profondamente narciso è appagato dal successo che la sua attività di scrittore gli ha concesso, apparentemente nulla osta a un grado di felicità apparente, è inoltre pronto a una nuova avventura letteraria: scrivere un libello sullo yoga, disciplina che ha praticato per tutta la vita e che sa essere poco conosciuta o perlomeno vittima di stereotipi conoscitivi per cui sente l’esigenza di dare il suo personale contributo divulgativo, nulla di più. In realtà, proprio la scrittura di questa opera che ricalca in fondo la sua tendenza autobiografica, presente in tutti i suoi romanzi, vira presto in una sorta di autobiografia sull’onda lunga del comun denominatore dei suoi anni, ovvero la ricerca di un equilibrio interiore tramite yoga, meditazione e tai chi. Insomma chi è a digiuno di entrambi, parlo della conoscenza delle discipline appena citate e dello stesso scrittore e delle sue opere, può cogliere l’occasione di abbeverarsi a entrambe le fonti, di contro, chi è invece edotto di tali materie, può trovare quel senso di riconoscimento identitario e di appagamento che si provano nel rispecchiarsi nei propri interessi.
Lo scritto in sé si apre con un impatto di grande fascino, è infatti la restituzione sotto forma di reportage di quattro giorni trascorsi all’interno del programma Vipassana: si tratta, in poche parole di un internamento volontario di dieci giorni - con il divieto assoluto di parlare con gli altri ospiti della struttura che li accoglie e di abbandonare il programma prima del tempo - da trascorrere solo nell’immersione totale in pratiche di meditazione, staccando la propria vita da qualsiasi filo relazionale con l’esterno per concentrare le energie al recupero dell’interiorità. Il racconto è fluido, di impatto, incuriosisce quasi quanto una distopia ma presto si interrompe per l’evento fortuito che porta lo stesso Carrère a lasciare la struttura in seguito all’attentato a “Charlie Hebdo”. Il suo rientro nella vita consuetudinaria coincide con un malessere interiore tale da necessitare cure specialistiche in una struttura sanitaria e con la difficoltà a portare a termine quello scritto che si prospettava così facile e immediato e, per sua stessa ammissione, in un certo senso confezionato ad hoc proprio tramite l’internamento volontario a Vipassana. La profezia del programma si è avverata: non è possibile interrompere un viaggio di introspezione così intenso senza gravi ricadute sull’equilibrio personale. In verità, dal racconto dello stesso Carrère si evince che la sua stabilità mentale è sempre stata labile, il malessere preesistente, lo yoga e le altre pratiche un tentativo o meglio una necessità di auto mutuo aiuto paradossale perché profondamente individuale. E così il racconto, mentre inanella una serie di definizioni sulle pratiche meditative che lo scandiscono e permettono di tenere il leit motiv della narrazione, diventa autobiografia episodica di ampio ventaglio a coprire gli anni necessari a ultimare lo scritto, a curarsi, ad aprire una nuova pagina della sua vita. In tutto questo il lettore partecipa di un universo iniziatico allo yoga, fatto di zafu e vritti, e di una fetta di vita altrui. Interessante.
Indicazioni utili
Celeste, Nadir & Pietro
«Quelle le ha volute Nadir. Io ho scelto un altro ricordo. Uno scolorito e imperfetto dove non ci sopportiamo.»
Un semplice salto da uno scalino le è valso quel piede rotto. Una matita tenuta tra le dita – forse – in modo troppo stretto le è costato quelle dita fratturate, quel viaggio, ancora, nella natura che a causa di un battente tornato indietro da una folata di vento le costa un polso rotto. Celeste ha soltanto otto anni quando scopre che le sue ossa sono così fragili da avere la consistenza di una persona di ottant’anni. Scopre di avere “la malattia delle ossa di vetro”, una particolare patologia che la obbliga da un giorno all’altro a cambiare completamente la propria vita e la propria realtà. L’abitazione dove vive con il padre e la madre Mara viene completamente privata di ogni spigolo e adattata alla possibilità di tutelarla da ogni urto, la sua educazione viene mutata in modo tale che ella possa sempre rendersi conto dei pericoli che la circondano e dall’importanza di stare sempre attenta. Ma Celeste è anche una donna adulta, adesso. Una donna che convive con la sua malattia e che torna indietro nel tempo per rivivere quegli anni di mutamento e quegli affetti privati. Perché se ella ha un padre e una madre ha anche un fratello più grande, Pietro, nato dalla relazione del papà con un’altra donna, Lucrezia. Quest’ultima, medico che si occuperà delle cure della protagonista, è la madre di questo ma anche di Nadir, nato dall’unione con il nuovo compagno neurologo. Entrambi i bambini, Nadir e Celeste, dipendono dal fratello maggiore e nutrono verso di lui un sentimento di grande profondità e intensità. Si detestano all’inizio proprio perché si contendono il suo affetto cercando, ciascuno a suo modo, di diventare il preferito di Pietro. Gli anni passano e il rapporto tra Nadir e Celeste cambia assumendo sfumature diverse, non più di odio quanto di un altro sentimento dalle tinte della complicità. Un sentimento che alterna attrazione e respingimento, ferite e crepe, legami che non possono sciogliersi anche con quella lontananza voluta o obbligata.
Ma cosa accade a Pietro? Perché adesso Nadir è scomparso alla ricerca di una verità e di un perché? Perché la trentatreenne Celeste ha scelto proprio quel ricordo di lui “combattente” e di loro tre così imperfetti per ricordarlo e convivere con la sua perdita e assenza?
«Che non eravamo fratelli.
Che non si sapeva cosa fossimo, non c’era un grado di parentela per descriverci.
Non era certo una cosa che capitava a chiunque.»
Valentina D’Urbano propone ai suoi lettori un titolo che si sviluppa tra infanzia, adolescenza ed età adulta dei tre personaggi principali. Quel che viene narrato è un sentimento d’amore e amicizia che passa per speranza, solitudine, dolore, distacco e separazione soprattutto per quell’età della maturazione che nel sopraggiungere ci ricorda quanto sia impossibile tornare indietro. Affrontiamo i venticinque anni di vita tra scelte giuste e sbagliate, errori e consapevolezza. Conosciamo una Celeste che fa della sua malattia il metro con cui affrontare il vivere quotidiano, un Nadir che cattura le emozioni e che non può essere imbrigliato a qualsivoglia forma di catena e un Pietro che in veste di ricercatore intraprende quella strada per proteggere e difendere chi non può e chi ancora non riesce a far con le proprie forze.
«In questa vita niente e nessuno ci appartiene davvero, e arriva il momento in cui ognuno di noi deve restituire qualcosa al mondo.»
L’opera è avvalorata da uno stile scorrevole, una forma narrativa in prima persona, una prosa non particolarmente elaborata ma piacevole. Tuttavia il romanzo non convince completamente e non riesce a coinvolgere totalmente il lettore. Forse perché le voci delineate risultano essere troppo costruite, forse perché la storia nel suo complesso risente di una impostazione troppo rigida che non lascia spazio a quella naturalezza che di solito coinvolge e caratterizza le opere della scrittrice. Non mancano ancora espressioni che rimandano al luogo comune e una costante sensazione di déjà-vu con titoli precedenti della stessa e con tematiche sin troppo gettonate.
Nel complesso la lettura è gradevole ma non convince interamente, non spicca per originalità e maturazione tanto da non potersi annoverare tra le migliori della scrittrice. Una lettura estiva, non impegnativa e dalla quale non aspettarsi troppo.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 05 Giugno, 2021
Opinione inserita da ornella donna 05 Giugno, 2021
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il passato per Manrico Spinori
Torna il pm Manrico Spinori , felice creatura di Giancarlo De Cataldo, ne Il suo freddo pianto. Il pm è soprannominato “il contino” per le sue nobili origini. Purtroppo una madre ludopatica, donna Elena, si è giocata tutto il suo patrimonio, compreso lo stesso palazzo in cui abitano, concesso in usufrutto per amicizia vita natural durante. Lui, appassionato melomane, convinto assertore della teoria per cui ogni caso di cui si occupa ha un preciso riferimento a qualche opera lirica, in questa avventura è alle prese con un enigma che viene dal passato. Veronica, transessuale di alto bordo, viene uccisa nel suo stesso appartamento in cui riceveva i clienti. Un omicidio che colpisce, avvenuto una decina di anni prima:
“un appartamento di tre stanze. L’ingresso. Un soggiorno con un divanetto nero, di fronte a una porta finestra che dava su di un terrazzino con gelsomini rampicanti e qualche pianta grassa (…). Tutto lasciava intendere che “il fatto” fosse avvenuto in quell’ambiente. Su una mensola una piccola Handycam. (…) Proseguendo nell’esplorazione, un piccolo studiolo con una biblioteca essenziale di titoli alla moda, un bagno con una vasca di notevoli dimensioni, pulitissimo, una camera da letto dalle pareti rosa con un grande specchio ovale dalla cornice dorata e un imponente letto tondo. Lì, sulle lenzuola di raso nero, Lo Moro Francesco.un ricamo bizzarro di sangue che dall’orecchio sinistro si disperdeva verso le labbra semichiuse, le palpebre calate con tracce di ombretto, le braccia distese accanto al lungo corpo, la camicetta color cremisi abbottonata, gli slip neri e le calze autoreggenti velate, così incongrue per quel fondo d’estate.”
Di quell’omicidio fu accusato un colonnello, l’ultimo cliente con cui si era intrattenuto. Ora le dichiarazioni di un pentito rimettono tutto in discussione e per Manrico il sospetto di aver condannato un innocente. Ma è davvero così? Gli interrogativi sono tanti: il pentito sta dicendo la verità? Perché rivangare un vecchio caso? Quali alte sfere sono coinvolte in un tentativo , riuscito, di depistare la verità? Manrico e la sua squadra provano a far luce.
Un giallo che risponde bene alle caratteristiche classiche del genere a cui appartiene. In gran parte centrato sulla figura del pm, che in questa avventura pare essere più malinconico , più riflessivo, preda ai mutamento ondivaghi dell’amore. Bellissime le riflessioni, ad esempio, intime che si prefiggono lo scopo di riconoscere o meno se un sospetto sta dicendo la verità:
“Manrico e il malavitoso si fissarono per un breve istante, occhi negli occhi. Era un confronto, un reciproco scrutarsi, uno di quei momenti in cui la ragione deve farsi da parte e cedere il passo ai sensi. Quelli di Manrico erano all’erta. Non gli sfuggì il guizzo che aveva animato lo sguardo del Farina. Un guizzo simile Manrico l’aveva colto in decine di sospetti o confessi che aveva interrogato. Compariva quando qualcuno aveva qualcosa da nascondere. Non necessariamente una colpa. Capitava a volte che un sospetto si cacciasse nei guai per non volere rivelare l’alibi che lo avrebbe magari salvato da un’accusa ma danneggiato in qualche altro modo.”
In questo romanzo, tuttavia, un particolare accento è anche posto sulla squadra che collabora con il pm, in cui ruolo diventa strettamente decisivo:
“Brunella, la sospirosa, segretaria perennemente alle prese con amori sfortunati; Gavina Orru, la maga della rete, con le sue connessioni neuronali veloci quanto quelle di un’astronauta selezionato dalla Nasa per i voli interstellari; Deborah Cianchetti, un metro e ottanta di tatuaggi e sovranismo, meraviglioso fiore di borgata, guardiana della notte in una città che “si me facevano comanna’ du’ mesi a Roma qua diventava ‘a Svizzera”. “
Intenso e costante è anche il continuo riferimento alle opere liriche, che in questo romanzo, in particolare, è a :
“Lulu, Alban Berg si era ispirato al dittico di Frank Wedekind, Lo spirito della terra e Il vaso di Pandora. Lo spirito della terra è Lulu, l’eterno femminino incarnato nel serpente che, nel prologo dell’opera, il domatore mostra al pubblico. Ma è un femminino perverso, mortale, demoniaco: “creata per diffondere sventura, per sedurre, adescare, avvelenare, per assassinare senza farsi accorgere.” Ecco. Veronica era stata la loro Lulu.”
In definitiva ne emerge un giallo intenso, scritto con una prosa perfetta, mai ridondande , ma ricca di fascino intrinseco. Un romanzo i cui punti cardini sono la figura del protagonista, un uomo professionalmente preparato, preda, però, nella vita personale, di sentimenti contrastanti; e la costituzione di un trama perfettamente elaborata, dove nulla è lasciato al caso, e nulla è come appare. Una lettura per gli amanti del genere e dello scrittore.
Indicazioni utili
Un canto infinito
Finalmente sono riuscita a finire questa impegnativa lettura di "Il canto del boia", premio Pulitzer nel 1980. Fa parte del genere "true crime" e narra le vicende di Gary Gilmore un criminale che fu condannato a morte per fucilazione. Bisogna dirlo subito: è stata una lunga esperienza a tratti tediosa perché il libro si presenta piuttosto corposo sia come numero di pagine (1068) ma anche e soprattutto come contenuto, un libro farcito all'inverosimile di migliaia di dettagli e personaggi che possono facilmente stancare il lettore e fargli perdere di vista il filo portante della vicenda nonché l'interesse complessivo. Ho avuto costantemente l'impressione che l'autore puntasse più sulla quantità che sulla qualità con un indubbio sforzo da parte sua ma speso male. Dettagli del tutto superflui con dialoghi a tratti imbarazzanti e poco curati a livello stilistico dove la parola "disse" padroneggia (infatti sarei curiosa in una edizione elettronica fare una ricerca e capire quante volte viene utilizzata!) ma anche passaggi di racconti davvero fugaci: già i dettagli sono futili e non funzionali alla storia, se poi gli descrivi pure male e di sfuggita, la noia sale alle stelle. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi abbastanza introspettivi e scritti anche molto bene e che ho apprezzato -come per esempio le lettere che Gary invia a Nicole dal carcere- ma rimangono episodi sporadici e lo stile è prevalentemente freddo e come dicevo, poco curato. Anche alcuni personaggi sono a tratti poco verosimili, o meglio, il loro comportamento risulta esserlo come per esempio Brenda stessa, la cugina di Gary, mentre molti altri sono dei personaggi disturbati come molte problematiche come Nicole o April.
La parte più densa del romanzo si concentra decisamente sul sistema legale sulla pena di morte, che contrariamente agli altri detenuti Gary cerca di abbreviare i tempi burocratici e ad affrontarla stoicamente, anche consolato da un pensiero di incarnazione futura (a tal proposito mi ha ricordato "Il vagabondo delle stelle" di London, letto di recente), il tutto sotto le luci mediatiche della televisione.
Sicuramente Gary Gilmore susciterà la compassione del lettore e a fine lettura un po' lo si perdona per i suoi crimini, tuttavia rimane schiacciato dai troppi, infiniti dettagli che finiscono per confondere e allontanare il lettore, a meno che non si è amanti del genere e non vi disturbino le trame ricche.
Concludo con un assaggio della prosa, che a me è piaciuto particolarmente:
"Ti ho detto che ultimamente non ho dormito - sono calati i fantasmi e si sono posati su di me con una forza che non credevo che avessero. Io li allontano con uno schiaffo ma loro tornano indietro di soppiatto e s'arrampicano sino al mio orecchio e da quei demoni che sono mi raccontano barzellette sporche, vogliono fiaccare la mia volontà, bere la mia forza, distruggere la mia speranza lasciarmi abbandonato privo di speranza smarrito vuoto solo sporchi demoni bastardi dal lurido corpo peloso che sussurrano cose orribili nella notte sghignazzando e ridendo con ripugnante gaiezza nel vedere che mi rivolto insonne in una prigionia orribilmente dura e tramano per avventarsi su di me con una folle stridula rabbia quando mi allontano con i loro piedi lunghi e repellenti e gli artigli gialli e i denti che gocciolano fetida saliva e uno spesso muco giallo verde.(...)"
Indicazioni utili
- sì
- no
Colpevoli o innocenti?
Correva l'anno 1480 quando la Repubblica di Venezia processa e condanna a morte tre cittadini veneti di fede ebraica. L'accusa è grave e desta orrore tra i fedeli cristiani; sono stati identificati come gli artefici del rapimento di un bambino cristiano per compiere un sacrificio rituale di sangue durante il periodo pasquale.
Accuse fondate o fango gettato su innocenti nell'eterna lotta tra credo religiosi ed interessi economici da tutelare?
Partendo da eventi storici tracciati dalle cronache del tempo, Molesini imbastisce un racconto mixando il realismo del dato storico al colore e sentimento dell'immaginazione, facendo calcare la scena a personaggi realmente vissuti unitamente ad altri che egli stesso costruisce con grande maestria.
Il percorso narrativo diventa una bolgia della cattiveria, dell'ipocrisia, della viltà umana, una rappresentazione della peggior parte dell'uomo “lupo”, pronto a sbranare il prossimo per un favore politico, per convenienza economica o per cieca sottomissione ad un credo.
La scrittura è graffiante con i termini e con le immagini, dagli intrighi dei palazzi ai bassifondi dove si svolge la vita più grama; dai bordelli sordidi alle carceri, dalle stanze delle torture alle esecuzioni sulle pubbliche piazze, dallo strazio dei vinti all'esultanza dei vincitori.
Ma dove alberga la morte, la doppiezza e la falsità, che valore potrà assumere la vittoria?
Un quesito che emerge prepotente alla stretta finale e che assale il lettore rendendolo partecipe di tutto il buio narrato.
Un romanzo storico crudo che denota il carattere della penna di Molesini ed apre le porte alla riflessione storico-politica e non solo.
Indicazioni utili
Metti un po' di musica leggera, anzi leggerissima.
Rosa è una donna triste, cresciuta da una madre triste.
E’ avvenente, si fa scivolare addosso gli uomini senza molto interesse. Ha studiato botanica, ma vede alberi senza guardarli.
Rosa è un fiore francese tra le peonie di Kyoto, mentre aspetta la lettura del testamento del padre giapponese, mai conosciuto.
“Dopo le ceneri, le rose”
Durante la lettura di questo breve romanzo ho spesso pensato ad alcune righe scritte da Mishima Yukio, in cui sosteneva la bellezza di un abito tradizionale indossato da una donna del paese di appartenenza. E’ splendida un’indiana in sari, è affascinante una giapponese in kimono. Scambiate gli abiti e, pur restando graziose, si avvertirà una nota stonata. Questo libro è un vestito indossato da qualcuno che lo imbruttisce, sforzandosi di sedurre con un tessuto che non sa valorizzare.
I punti di forza dovevano essere la voce dell’autrice dell’Eleganza del riccio, il Paese del Sol Levante e il mondo vegetale, tutti elementi che amo.
Se avete gradito il più famoso romanzo di Barbery, sappiate che della penna di carattere del suo best seller qui non c’è neppure un’ombra sfocata.
La narrazione è tanto scorrevole quanto banale, con dialoghi veloci ed elementari al limite dell’imbarazzo. Del Giappone si parla spesso, con una profusione di descrizioni piuttosto irritante poiché si tratta di una carrellata bella, ma senz’anima. Manca lo stupore della prima volta, manca la poesia, manca l’eccitazione o un tangibile dissenso. Latita il realismo.
La botanica è disseminata nel testo con lo scopo di mostrare il disinteresse di Rosa per la botanica stessa, non aggiungo altro. Per il resto, trascorrerete le giornate tra birra, ristoranti e templi, dove piatti e bicchieri son ampiamente riforniti e altrettanto espressi, ma nei santuari buddisti echeggia solo il vuoto di una spiritualità assente e di un sarcasmo urticante. Tra gli altri orrori, una storiella d’amore che non pubblicherebbero nemmeno nella Posta del cuore della rivista Intimità.
Se il vostro intento è di mettere un po' di musica leggera -anzi leggerissima- perché avete voglia di niente, questa è una buona opzione.
Per chi necessiti di un minimo di spessore nella forma o nel contenuto, questo libro è un bacio sulla bocca da un estraneo febbricitante nell’annus horribilis 2020. Scappate.
Gli irregolari, gli interrotti, i dispersi...
Mi piace Desiati, mi piace il suo modo di parlare della mia generazione (i quarantenni di oggi), il suo modo di raccontare la mia terra con i suoi odori, colori, tradizioni, modo di pensare, di "mettersi", il suo sguardo aperto verso il mondo, ma sempre, in qualche modo, ancorato alle origini, la dolcezza e la ruvidezza che si incontrano e si scontrano nella sua scrittura dando forma alla reale consistenza della vita.
Un libro di partenze, di ritorni, di amore e sesso vissuti senza il peso del giudizio, di ricerca interiore e liberazione dalle catene mentali.
Spatriati, ovvero "spatrièt?" in dialetto martinese (Martina Franca, paese di origine dell'autore), non sono semplicemente coloro che sono senza patria, che sono andati via, ma sono gli interrotti, gli irrisolti, i disorientati, i dispersi... in un senso più ampio e metaforico.
Possono essere anche i ritornati, quelli che hanno provato a cercare se stessi altrove e non ce l'hanno fatta, e continuano a vivere con una valigia sempre pronta.
È un concetto legato ad un modo di pensare che ti vuole "sistemato" in un luogo fisico e mentale ben incasellato, in un genere ben preciso, in relazioni stabili, con lavori facilmente definibili, e che fatica a comprendere la complessità del sentirsi fuoriposto in ogni luogo, perché ancora alla ricerca della propria identità, dei propri desideri più reconditi.
Ci sono persone affamate di vita, che sentono il bisogno di ampliare i propri confini, di spingersi oltre il limite per poter conoscere e accettare i propri, che hanno necessità di prendere le distanze dalle proprie origini per trovarsi davvero, scevri dall'influenza della famiglia e del "pensiero comune"...
Persone dalla consistenza più fluida che, molto spesso, nello squilibrio, riescono a trovare nuovi equilibri, nuove forme, e non tornano più.
E poi ci sono quelli che non ce la fanno, che sentono forte l'appartenenza, che provano ad allontanarsi, a sperimentare, magari trovando anche una dimensione più grande capace di contenere tutte le sfumature del loro essere e sentire, ma poi immancabilmente ritornano.
Ed ecco che Francesco Veleno (sí, un nome che ritorna da "Il paese delle spose infelici" ? e dalle pagine de "Il libro dell'amore proibito", promosso da soprannome a cognome) e Claudia danno voce a questa generazione che cerca il proprio spazio, la propria identità sociale e sessuale, dando vita ad una relazione che non è amore, non è amicizia, non è sesso, ma è tutto questo e molto altro.
Nessuna etichetta, neanche nei sentimenti.
Lei è proiettata verso la scoperta, ha bisogno di aria, di spazio, di libertà... libertà che troverà prima a Londra, poi a Milano, infine a Berlino.
Lui ha bisogno di lei, invece.
Quindi partirà anche lui, la seguirà, e troverà lì, nella capitale della trasgressione, il coraggio di essere veramente se stesso, senza censure, senza tabù... ma poi tornerà a Martina Franca, spatriato, solo, senza famiglia, ramingo in casa propria.
A casa, ma comunque sradicato.
Alla fine, qui al sud siamo tutti un po' spatriati, quelli che vanno via e anche quelli che restano.
Indicazioni utili
Le “Occasioni” di Susanna
“Alla fine siamo fatti di ingredienti semplici. Ossigeno, carbonio, idrogeno, azoto, calcio, fosforo, sodio, magnesio, ferro, alluminio - tutta roba riciclabile.
Siamo questo. Siamo il mucchio ambulante di tutto questo”.
Un libro breve, fatto di piccoli paragrafi, come piccole macchie impressioniste che compongono il tessuto narrativo. Flusso di coscienza che salta, come sempre, dal presente al passato, due fili temporali che si intrecciano magnificamente sotto l’egida di un binario stilistico che sapientemente passa da un linguaggio lirico ad uno più colloquiale e prosastico.
“Ottobre lo acchiappo, capita di sera ma non sempre, a volte ci riesco. Mi viene facile su quelle strade tra campagna e cemento, quando si sente ancora frinire qualche grillo tra i ciuffi del guardrail, viene facile e lo acchiappo”.
Susanna sa trovare piccole “occasioni”(mi verrebbe da dire “montaliane”) di vita autentica, piccole sorprese che sanno meravigliare la bambina che è in lei (una pascoliana “fanciullina” , con tutte le distanze da prendere del caso?): lei una non mamma.
Una donna non è per forza una mamma, ma lo status di madre, nella società dei nostri tempi è ancora pregnante e qualificante. È come se Susanna vivesse in una specie di limbo sospeso tra la realtà e la fantasia, tra il mondo “normale” di una donna con una vita sentimentale appagante e un lavoro che la rendono felice e un altro mondo, fantastico nascosto dietro le piccole cose, luoghi che non tutti riescono a vedere, presi dal caos della vita quotidiana, un mondo senza bambini, ma dove la bambina è lei.
“…da non mamma sono facilitata, non ho nessuno davanti e nessuno alle mie spalle. (…) Vedi come sto in piedi bene, vedi che non cado anche se il mondo si capovolge e mi fa girare la testa?”.
Una non mamma è una donna libera, “sono mia figlia e mia madre. (…) mi educo e mi vizio” e se ne va “a zonzo cercando un atomo di serenità”.
E questi atomi costellano tutto il libro, scritti in uno stile che ho trovato toccante, anche per i continui contrasti tra immagini liriche e prosaiche. La stessa ambientazione agli occhi si lei si rivela come luogo magico: Roma è sospesa e senza tempo, ma a volte il sogno e l’incanto si spezzano, rotti da qualche battuta dialettale, ma è giusto un attimo, l’epifania è dietro il nuovo angolo, laggiù sopra l’asfalto bollente, tra i versi delle cicale nascoste tra i piccoli punti di verde.
“L’estate a Roma è un pezzetto di cuore spezzato, è un pranzo di ferragosto, è un guarda che bella che è. All’angolo del parcheggio il ramo fronzuto, vigoroso nonostante la capitozzatura, offre la sua ombra rinata. Fremono le acacie dai grappoli cremosi e il ciuffo di papiri che non conoscono il Nilo. (…) Nella Roma che odora di catrame e di fiume, papaveri led si accendono tra le fratture del muretto ad indicarmi l’uscita”.
Eppure in tutto questo, la felicità non è completa, ho ravvisato tra le pagine la mancanza di quel bambino che lei ha perso prematuramente, nel wc dell’ufficio. Questa assenza riempie i suoi sogni di presenze: eccola ora è una bambina che si fa asciugare dopo aver giocato in mare, ora è sulla piccola bici rosa, ora è un bambino, Lorenzo, il vicino di ombrellone, bloccato in un fermo immagine mentre gioca a fare castelli d’acqua in riva al mare.
Bellissima lettura.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il noir come metafora della vita
“Il giallo, la detective story è la testimonianza commovente che il mondo sia un posto decente dove vivere. L’ordine del mondo viene rotto da un omicidio? Niente paura, arriva il detective e scopre il colpevole. Al contrario, il vero noir è l’esplorazione del mondo visto come un labirinto caotico al quale il protagonista, che è spesso un criminale, cerca di imporre un ordine parziale. Il noir assomiglia alla vita.” Con queste parole, che delineano un preciso quanto giusto distinguo tra i due generi letterari, il giallo e il noir, Raul Montanari ha introdotto su Il Fatto Quotidiano del 7 maggio 2021 una breve presentazione del suo ultimo romanzo “Il vizio della solitudine”.
Come sempre nelle sue opere Montanari affronta temi tanto attuali quanto problematici, attraverso storie che per la loro dinamicità risultano avvincenti e interessanti.
Qui il tema centrale è sicuramente la discrasia che si rivela fin troppo spesso tra la legge voluta dal legislatore e il concetto di giustizia. Approfondire l’argomento implicherebbe necessariamente valutazioni di tipo politico, poiché nella nostra società non esiste un’univoca opinione sulla materia. Non si può tuttavia negare che troppo spesso la legge si presta a interpretazioni contrastanti o viene applicata con minore o maggiore rigore. È dunque su questa base che si muovono i protagonisti de “Il vizio della solitudine”, i quali rifuggendo dall’idea di lasciare impuniti alcuni tra i più biechi criminali che in qualche modo hanno evitato una giusta pena per i crimini commessi, si ergono essi stessi a giudici arbitrari, con l’illusione di fare giustizia. Ma, ovviamente, è lo stesso concetto di giustizia arbitraria che è inaccettabile in un paese democratico, ed è in fondo questa stessa consapevolezza che rende difficile la vita all’ispettore Ennio Guarnieri, che si ritrova infine impigliato in una rete da cui gli riesce difficile districarsi. Il senso di colpa emerge inevitabilmente e induce l’ispettore a parlarne con un sacerdote, il quale confessa di non sapere cosa Dio pensi dei crimini degli uomini, egli sente che il suo compito è solo quello di riconciliare i peccatori con se stessi.
Siamo dunque di fronte a una storia di solitudine, la stessa solitudine che spesso affligge l’uomo contemporaneo, incapace di scelte coraggiose che aprano il suo animo al mondo esterno con disponibilità e tolleranza.
Temi forti e impegnativi in una trama scorrevole, un romanzo avvincente.
Indicazioni utili
Iris al cioccolato e morti ammazzati per Vanina
Giovanna Guarrasi, detta Vanina, vicequestore in forza al reparto Reati contro la persona della Questura di Catania si trova ad affrontare due spinose situazioni. La prima riguarda l’omicidio di un mite professore di filosofia, Enzo La Barbera, amato da tutti, schivo e gentile, attivo nel recupero dei ragazzi tossicodipendenti. È stato trovato, accoltellato, in una piccola grotta naturale, scavata da un fiumiciattolo che scorre sotto Catania, che viene usata come séparé di un pub cittadino.
La seconda questione la riguarda personalmente: alcune settimane prima si è trovata a casa una busta contenete un proiettile: tipica intimidazione in stile mafioso e, da quel giorno, non può spostarsi senza una nutrita scorta che le limita i movimenti e le impedisce di agire come vorrebbe. Vanina si sente in gabbia.
Nel frattempo l’indagine per la morte di La Barbera si indirizza verso due distinte direzioni. O è stato un omicidio di mafia, perché qualcuno s’è sentito infastidito dall’opera contro la diffusione delle droghe che svolgeva il professore. Ma la mossa di per sé sarebbe stata stupida e i mafiosi sono tutt’altro che stupidi. Oppure i moventi vanno ricercati in fatti risalenti addirittura a oltre trent’anni prima, quando Enzo era un ragazzo ribelle che soggiornò in una comune di hippies ove accaddero fatti inquietanti.
Nonostante le intrinseche difficoltà in cui si trova a dover indagare Vanina riuscirà a venire a capo di entrambe le vicende, mentre, d'altro canto, la sua situazione sentimentale si farà particolarmente complicata.
Non conoscevo l’opera di Cristina Cassar Scalia e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. La scrittura è fresca e scorrevole e la storia si fa leggere con piacere anche da chi non conosce gli antefatti per non aver letto i tre romanzi che precedono questo.
Onestamente è difficile combattere la diffusa sensazione di déjà-vu che il personaggio di Vanina e il suo entourage suscitano. Una volta accettato ciò, però, questa spontanea e vulcanica “Lolita Montalbano” risulta indubbiamente simpatica e alcuni personaggi di contorno sono davvero divertenti. Purtroppo collaboratori e comprimari sono tanti e spesso restano dei semplici nomi che è difficile inquadrare caratterialmente. Ma la storia fluisce senza intoppi, con una ragionevole cadenza da vicenda verisimile, cioè con tutti gli inevitabili tentennamenti a cui, nella realtà, un’indagine va incontro.
Anton Checov scriveva che se in una narrazione compare una pistola questa, prima o poi deve sparare. La Cassar Scalia ci mette davanti agli occhi ben due pistole metaforiche ed entrambe “spareranno” prima della fine del romanzo. Quindi un lettore attento non deve stupirsi se già da pagina 140 riesce a immaginare quale sarà l’epilogo della storia. Tutto sommato, però, non l’ho ritenuta una circostanza spiacevole, ma, al contrario, appagante e rassicurante: certe assurde giravolte che alcuni autori infilano negli ultimi capitoli, giusto per creare il colpo di scena finale, sono più irritanti che divertenti.
In definitiva ho trovato il libro gradevole e anche le incursioni in catanese stretto (non pervasive e onnipresenti come in Camilleri) contribuiscono a dare freschezza al testo. Consigliabilissimo come lettura distensiva.
Indicazioni utili
Assassinio allo specchio
L’ultimo thriller della nota scrittrice svedese Camilla Lackberg non preannuncia un delitto, un crimine o un fatto di sangue, oggetto di intervento da parte dell’investigatore di turno, nemmeno ci presenta un mistero.
Racconta invece di una festa, più o meno innocente, con qualche trasgressione e parecchie esagerazioni con l’alcool, ma niente di che, a ben pensarci, dopotutto è un giorno di festa, anzi di una delle feste istituzionali più sentite in tutto il mondo, il Capodanno, e come si suol dire, semel in anno è lecito andare sopra le righe.
Una festa in casa tra giovani, dove per casa per meglio dire intendiamo una lussuosissima villa, una di quelle strabilianti costruzioni hollywoodiane, talora ricchissime quanto pacchiane, piantate su pilastri a guisa di eccentriche palafitte, tutte saloni e vetrate a parete intera, da dove lo sguardo scorre libero su scenari e panorami mozzafiato, specchiandosi isomericamente sulle analoghe costruzioni dei vicini sodali nel benessere.
“…Le ville sono imponenti, affacciate sullo stretto. Le più belle hanno la spiaggia privata, naturalmente…le grandi finestre panoramiche diventano come degli acquari in cui vivono i ricchi”.
Una festicciola per pochi intimi, quattro giovanissimi, due ragazzi e due ragazze, amici intimi tra di loro potremmo dire dalla culla:
“…abbiamo sempre fatto tutto in quattro…perché eravamo i più rovinati. Perfetti e funzionanti all’esterno, ma tristi e danneggiati dentro…”
Mentre nella villa di fronte, a portata di vista, date le enormi vetrate illuminate a giorno, si svolge un analogo festeggiamento di fine d’anno, presenti i genitori dei quattro giovani, che pure sono soliti frequentarsi, coltivare tra loro rapporti di amicizia come accade tra i loro ragazzi.
Dopo tutto, si tratta di pari grado dell’agiata classe capitalistica del paese, imprenditori di successo, affaristi, professionisti arrivati.
Insomma, una gran festa di membri affermati della ricca, opulenta, società svedese, uomini in smoking e donne ingioiellate con tanto di capi firmati di alta sartoria.
Sono presenti qui, equamente divisi, adulti da un lato e giovani dall’altra, le famiglie al completo degli enfant prodige di un capitalismo sfrenato, disinvolto nell’accumulo di denaro e nell’arroganza mostrata. La ricchezza sfrenata esibita come trofeo che li autorizza a sentirsi padroni senza limiti.
Come spesso succede potere economico e disprezzo per chi ne è privo vanno di pari passo in tutti i paesi del mondo, anche nella Svezia considerata a torto isola felice socialmente parlando.
La ricchezza, specie da speculazione, si accompagna facilmente ad un degrado morale, il lusso fa perdere sempre la testa a chi non possiede maturità per gestirla, né etica né morale, e nemmeno l’intelligenza per capire la sottile e fondamentale differenza tra l’avere e l’essere, tra il possedere valori ed essere il valore di quanto si possiede.
In estrema sintesi, il romanzo della Lackberg, o per meglio dire il racconto lungo della scrittrice svedese, trattandosi di un volumetto di poco più di un centinaio di pagine, focalizza un primo ambiente, quello dei “grandi”, tratteggia gli adulti lì presenti, ricchi e meschini, arrivati ma egoisti, egocentrici e villani, sono radunati qui adulti che a torto o a ragione perdono progressivamente la loro umanità man mano che progrediscono nella scala della ricchezza, divengono miseri e miserabili malgrado i mezzi, il denaro, la posizione raggiunta.
Restano primitivi delle caverne, malgrado le ville, accecati dal loro egoismo, dalla loro avidità, dal loro individualismo, perciò sono vili e spregevoli, e come tali criticati, se non disprezzati, dalla rispettiva prole, per le loro mancanze nei loro confronti.
Esistono famiglie in cui, sollevato il velo delle apparenze, si scopre un verminaio insospettabile, comportamenti crudeli ed aberranti, e i figli, i giovani, per definizione i più fragili ed innocenti, sono sempre vittime di questo tipo di genitori.
I loro comportamenti non sono solo anaffettivi, e sarebbe il meno, infatti adulti che dovrebbero fungere da guida ed esempio spesso sotto l’egida della famiglia compiono autentiche nefandezze, sono disastrati e disastrosi, le loro azioni nei confronti dei figli sono sempre gravissime, tanto di più quando si tende a tenerle nascoste da una patina di perbenismo e correttezza di ipocriti modi d’essere e di vivere.
Come in tutte le feste con famiglie amiche, si provvede a sistemare gli adulti ad un tavolo ed i bambini ad un tavolo a parte, solo che dato il livello di sfrenata ricchezza a cui appartengono i protagonisti di questa storia, non di tavoli si parla ma di ricche ville adiacenti.
Ed ai giovani non vengono distribuiti cibi più semplici, il raffinato catering distribuisce comunque a entrambe le dimore aragoste, caviale, champagne, cibi pregiati e vini costosi, e nel malaugurato caso finissero le scorte, la dispensa di casa è naturalmente fornitissima di ogni ben di Dio, e del più costoso anche, si tratta in ogni modo di giovani della borghesia agiata e privilegiata.
Giovani che, quasi volessero dimenticare le sofferenze patite dai congiunti, che festeggiano laidamente nella villa adiacente, si rifugiano nel loro mondo, cercano scampo nei momenti felici dell’età dei giochi, giochi da ragazzi, e quindi, manco a farlo apposta, trascorrono le ore prima del cambio d’anno cimentandosi nel gioco dei ragazzi per antonomasia, il Monopoli.
Il quale è come una sorta di cammino di vita capitalistica, un accumulo di beni, case, terreni, costruzioni, inevitabilmente ai giovani viene in mente il loro futuro a simile guisa, letteralmente soccombono alla paura, al terrore, di divenire adulti spregevoli esattamente uguali ai congiunti che vedono festeggiare dall’altra parte delle vetrate. Degni eredi dei loro killer, destinati a divenire tali.
Davanti ai loro occhi scorre un vero e proprio assassinio allo specchio, si prefigura un destino abietto di identificazione coatta in modi di essere che li hanno straziati a dismisura nel fisico e nel morale.
Il Monopoli, a cui hanno sostituito alle inutili banconote false, obblighi di dirsi la verità e pegni rivelatori che inconsciamente li portano a deflagrare, li ispira, confessandosi a vicenda i torti, le sofferenze e gli abusi subiti, fa da catarsi, da input ad agire per riprendersi in qualche modo le redini della loro esistenza.
“Segreti e bugie vengono portati alla luce, dipanati di fronte agli altri. Scoppiano come bolle.”
Solo che crescere educati in un certo modo, innesta comunque modi errati di risolvere le questioni, difficilissimi a sradicare, specie quando non si ha ancora raggiunto un certo grado di maturità, che rappresenta poi la vera liberazione di una persona.
Il racconto della Lackberg in verità non stupisce, non presenta colpi di scena o lieta fine liberatoria.
Resta però un buon romanzo, scritto bene, con personaggi tracciati in poche linee ma a tinte marcate, un racconto lungo, e forse per la sua brevità non particolarmente esauriente del discorso.
Pieno di dolore, di violenza, di brutalità, ci presenta una realtà appena sorta, perciò pulita ed innocente, sporcata, screziata irrimediabilmente dall’egoismo e dalla meschineria altrui, ancora più perfida perché proviene dalla famiglia, che dovrebbe essere rifugio sicuro, affettuoso ed accogliente, dove genitori e figli giocano insieme all’aria aperta, di giorno.
Non un coacervo di perfidie, un gioco della notte, da tenere nascosto, come la vergogna che è.
Indicazioni utili
Risurrezioni diluite
Come tutti i manoscritti, anche questo che sta alla base de ”Il vino dei morti” ha una storia affascinante: non è rilegato, è composto di 331 fogli, è a firma Romain Kacev, è siglato dalla data 1938- il che lo colloca come l’opera prima di R. Gary -, fu consegnato alla donna che amava all’epoca e da lei conservato fino al 1992 per poi finire all’asta ed essere così ritrovato da Philippe Brenot che ne ha curato l’edizione per i tipi di Gallimard nel 2014. Ora Neri Pozza ci dà occasione di leggerlo in traduzione italiana e di migliorare dunque la conoscenza dell’autore di numerosi romanzi che hanno riscosso successo anche presso il pubblico nostrano, da “La vita davanti a sé” a “Gli aquiloni” o ancora “Educazione europea” o “Il senso della mia vita” per citarne solo alcuni.
Più che godere di un’esperienza di lettura al netto, ci ritroviamo però a scoprire che questo è il pozzo sacro dal quale l’autore ha continuato ad attingere per la creazione di molti dei suoi romanzi futuri: interi stralci di questo primo scritto sono infatti stati riversati in “Educazione europea” o in “Mio caro pitone” o ancora in “Pseudo” o ne “La vita davanti a sé”. E questo ci porta a sconfinare quasi nell’esegesi non tanto di questo romanzo quanto dei successivi, nel tentativo di penetrare il segreto di una scrittura che fu, come ben sappiamo, truffaldina, legata allo schermo dello pseudonimo Émile Ajar, irriverente, scanzonata e al tempo stesso delicata e profondamente umana. È come se Gary avesse insomma scritto un unico grande romanzo. Proprio ciò che questo primo non è, esso infatti si presenta come una giustapposizione episodica di grotteschi quadretti dall’aldilà. In fuga nell’oltretomba è il novello picaro Tulipe che, dopo aver scavalcato il cancello di un cimitero, si ritrova nel mondo dei morti. Inizialmente questi hanno le sembianze che avevano da vivi ma a guardarli da vicino il loro disfacimento è ancora in divenire: vermi fuoriescono da orbite oculari o da ombelichi, arti si staccano, a volte basta uno starnuto per rompere l’illusione dell’integrità corporea. Sono morti viventi: soggetti a tutte le manifestazioni corporali, anche le più volgari, parlano tra di loro e ricordano episodi della loro vita. Sono sbirri per lo più, prostitute e caduti in guerra. Un universo di miseria umana in una visione tutta terrena scaturita da un vino di pessima qualità, quello bevuto dal protagonista prima del suo ruzzolone nel perimetro infernale. Perché inferno è, questo.
“ Il vino dei morti” è così paragonabile a un negativo pronto allo sviluppo che restituirà, come in una risurrezione diluita, personaggi già stazionati all’inferno, da lì provenienti, pronti per un nuovo giro di giostra, nell’inferno fatto terra.
Indicazioni utili
- sì
- no
Parkour
Il mio professore di letteratura tedesca un giorno disse che, all’inizio di una lettura, lo scrittore stringe un patto col lettore dandogli un’idea di ciò che dovrà aspettarsi in seguito: se lo scrittore ci dà indizi di natura fantastica, il surreale non ci apparirà strano ma bensì atteso; nel racconto realista l’approccio sarà molto più ancorato alla verosimiglianza mentre in quello storico il lettore si aspetterà anche una corrispondenza precisa e priva di errori alla Storia. Quello che fa Michele Vaccari in questo romanzo è prendere quest’idea (che è quasi una regola), accartocciarla con sdegno e gettarla via.
Questi tre elementi da me citati si fondono, mostrando ambizioni piuttosto ardite.
Nella prima parte ci troviamo in una Genova distopica (di cui vengono citati i nomi di molti luoghi che, se non li conosci, non ti dicono nulla), dominata da una sorta di governo vegano (?) che sembra aver tratto la conclusione che l’estinzione di massa sia l'ambizione più giusta da perseguire per l'umanità. Parte dunque il massacro delle madri: essere incinte è una cosa fuorilegge e uno dei nostri personaggi principali è proprio una di loro, ovviamente provvista del classico “dono” capace di sovvertire gli schemi, un dono che sarà ancor più potente nella figlia eletta. Sa un po’ di cliché attualizzato, ma quantomeno siamo ancora nei limiti “dell’atteso” di cui parlavo prima, con tanto di strizzatina d’occhio a Orwell con l’introduzione della cosiddetta Lingua Nuda, che tuttavia a differenza della Neolingua non sembra essere altro che un miscuglio di termini presi dalla peggior gioventù, da internet e dallo spagnolo (???) senza avere un effettivo scopo come lo aveva la “creatura” del Socing. Se la meta è l’estinzione, qual è il motivo per il quale il governo vorrebbe introdurre una nuova lingua? Potrebbe esserci, ma non è chiaro; in realtà sembra più un modo di scimmiottare una piega del linguaggio moderno, portandolo all'estremo.
Nella seconda parte ci troviamo catapultati in una sorta di poliziesco-fantascientifico, per mezzo del racconto di un altro personaggio già incontrato nella prima parte e macchiatosi di un’orribile colpa. I riferimenti alla storyline di base, tuttavia, ci sono ancora.
Nella terza parte però avviene la frattura che mi ha fatto storcere il naso definitivamente: ci troviamo davanti a un lunghissimo flashback che ci catapulta all’interno del mondo partigiano, cent’anni lontano dagli eventi finora narrati. Certo, si tratta di un flashback di un personaggio importante ma il lettore (o almeno io) si ritrova scagliato molto lontano, per un numero di pagine troppo lungo e con un livello di dettaglio che appare un po' eccessivo. Questo perché la priorità dell’autore sembra essere quella di sviscerare il tema della diversità, di voler provare a includere tutti i motivi della nostra contemporaneità (Covid compreso) e sbatterceli davanti, ma credo che il modo in cui lo faccia sia (probabilmente per volerli includere tutti insieme) un po’ banale e intacchi il procedere della storia. Perché non concentrarsi su uno, due temi? Il lungo flashback di Spartaco Delfino è rivolto a Egle per il raggiungimento di quello che sarà il suo destino, ed è proprio per questo che il soffermarsi su determinati dettagli e discettazioni è per me forzato: qual è, per Egle, l’utilità di conoscere i dettagli precisi della vita sessuale del nonno? Non meritava, il tema trattato nel flashback di Spartaco, una storia a sé? L’autore vuole mettere tutto insieme e questo si scontra violentemente con la coerenza del racconto, deviando da quel che dovrebbe essere davvero utile ai fini della storia principale.
Le prime tre parti sono un’evidente preparazione per le ultime due parti, ma per quando ci arrivi ti senti già sfiancato e confuso, incapace di poter dire davvero cosa tu abbia letto. A questo si aggiungono pagine colorate di diverso colore (che hanno il loro bell’impatto visivo, ma il cui contenuto non fa che confondere ulteriormente), parti in corsivo inserite qua e là in cui la voce narrante cambia tono, citazioni da manoscritti… l’inventiva è una cosa buona, ma va dosata: le idee ci sono e in certi casi anche buone, così come alcune riflessioni, ma è troppo. Oltretutto, io sono un amante di tutti i generi toccati da questo romanzo, ma qui si salta dall’uno all’altro come una lunghissima ed estenuante sessione di parkour.
“L’Ottimo è nemico del Buono”, mi hanno sempre detto. Hanno ragione.
Tutto muta, nulla muta
Massimo Carlotto ha scritto numerosi romanzi tra cui: Arrivederci amore, ciao; L’oscura immensità della morte, La signora del martedì. E’ l’inventore del personaggio investigatore Marco Buratti, detto l’Alligatore. Ora torna in libreria con E verrà un altro inverno.
Un libro che si legge con piacere. Un ritratto puntuale e anche un po’ amaro sulle condizioni di vita di certa provincia italiana.
Racconta, con uno stile preciso quanto scarno che colpisce per l’assenza di emotività, la vita di un piccolo paesino di provincia del Nord, dove chiunque entra a far parte della comunità viene definito e trattato come “uno straniero” da tenere a bada. E’ quanto accade a Bruno Manera, ricco imprenditore, che sposa Federica Pesenti. Lui:
“Era un uomo abbastanza colto e dai gusti raffinati nel campo enogastronomico e della moda. Requisiti fondamentali per frequentare certi ambienti senza essere scambiati per arricchiti o pidocchi rifatti, come si usava definirli.(…) non era uno spilungone ma nemmeno basso, occhi nocciola, un ciuffo di capelli sale e pepe sulla fronte alta, un sorriso accattivante.”
Lei, erede di una dinastia di imprenditori, molto considerati, anche se nei contenuti non poi così ricchi a causa di speculazioni economiche sbagliate, ma facente, comunque, parte di quella che è considerata:
“L’elite dei capitani di industria, detto dei “maggiorenti”,
Federica trentenne, è molto più giovane di lui, e un insieme di motivazioni lo rendono particolarmente avverso a tutti. La situazione precipita quando Bruno Viene brutalmente aggredito, e nessuno mostra solidarietà nei suoi confronti, neppure la moglie. Anzi, lo accusano, velatamente, di essersi arricchito illegalmente e di aver portato il crimine in un paese molto tranquillo. L’unico ad aiutarlo è Manlio Giavazzi, vigilante della locale banca. Chi è costui? Un uomo
“Che si portava addosso la croce di un passato che nessuno voleva condividere, soprattutto senza il conforto di una solida situazione economica.”
Che cosa ha in mente il vigilante? Perché cerca di risolvere tutti i suoi problemi? A cosa mira veramente?
Massimo Carlotto scrive un romanzo che colpisce duramente. Splendido e capace ritratto di un microcosmo, dove tutti gli esseri umani hanno qualcosa da nascondere, dove regna incontrastato un clima di ipocrisia e di grettezza mentale inverosimile. Uno spaccato di provincia che suscita nel lettore un profondo senso di sgomento:
“Da quelle parti si badava al sodo anche quando ci si ammazzava, sentimenti e passioni non avevano mai scatenato pulsioni omicide. “
Una trama ricca di colpi di scena , personaggi perfettamente delineati, e uno stile arguto e preciso caratterizzano un romanzo che parla di attualità, che trascina il lettore in atmosfere noir che non concedono scampo. Perché:
“verrà un altro inverno”,
e tutto cambierà, per non cambiare niente. Intenso, particolare, annientante.
Indicazioni utili
Onora il padre
La scrittura di Erri De Luca si riconosce per un attributo semplicissimo, subito evidente, immediatamente lampante: la sua essenzialità.
Lo stile dello scrittore napoletano è peculiare come non mai per questo motivo, vanta un’asciuttezza di modi che non rimanda al prosciugato, al riarso ed al laconico, bensì al breve, all’agile, al conciso ma costruttivo, ai suoi testi smilzi non corrisponde mai una povertà di contenuto, tutt’altro.
De Luca è autore potente, colto, elegante, forbito: usa termini adatti, racconta con parole precise, perciò solo per questo le sue conclusioni sono esaurienti ed esaustive, esprime sempre compiutamente il suo dire con le opportune locuzioni.
Un suo testo non è brusco e stringato, semplicemente non è ridondante, perché non ha necessità di dilungarsi per esternare ancora meglio il concetto, è superfluo un ulteriore dire.
Per questo i suoi testi non contano molte pagine, come questo volumetto “A grandezza naturale”, e però per quanto esile il racconto restituisce una natura grande, estesa, ricercata e particolareggiata.
Erri de Luca è uomo nato in una città di mare, espansiva, dispersiva e contraddittoria, a quella appartiene ed in essa è cresciuto a sua immagine, assorbendone gli umori insieme alla salsedine, e però ha anche acquisito negli anni, smussandolo ad arte, cesellato dai suoi trascorsi di vita, l’animo brusco, non rude ma sollecito, non burbero ma silenzioso, di uomo di montagna, di montanaro con scarponi, piccozza e dita forti da arrampicata, vista la levatura morale raggiunta, direi montanaro di alta quota. Non un semplice esteta dei monti, direi una stella alpina, con i colori di anemone di mare.
Così anche la sua scrittura ci appare, aspra e rocciosa, solitaria e silenziosa, di pochi concetti essenziali espressi con ancora meno parole: l’alta montagna vanta aria gelida e rarefatta, non permette di arieggiare inutilmente i denti. Nemmeno sott’acqua puoi darti a conversazioni, ma a brevi cenni.
Resta perciò un uomo che della vita ha assorbito e conservato al meglio tutte le esperienze: pertanto sia dai vasti orizzonti di mare, che degli sguardi sconfinati diffusi sulla valle dalle vette alpine, ne conserva l’ampiezza. La profondità, ed il suo significato: spazia sull’orizzonte ampissimo, lo riporta uguale con vocaboli esatti, la restituisce sfrondata, rifinita, essenziale, ma se ne sprigiona comunque copiosamente l’etica e la morale acclusa, e questa sua peculiarità ne fa un testimone attento, critico e misurato della società civile del suo secolo, che gli ha dato i natali a metà del suo corso.
Tema di “A grandezza naturale” è la paternità, un concetto ed una esperienza comune ma anche non di tutti: tutti abbiamo la prerogativa di essere figli, molti invece padri non lo sono e non lo sono mai stati, tra questi si conta anche De Luca, che padre di suo non è, ma un padre lo ha avuto, come tutti.
Come dire, un’esperienza a metà, figli sì ma padri no: ciò malgrado, il tema è sempre comunemente sentito, giunge cioè sempre il tempo della vita in cui lo status di genitore va considerato in toto, qualche riflessione la propria coscienza la sollecita comunque in sede di bilanci e revisioni, e se non si è dato personalmente alla luce bambini, e quindi non si può discettare su se stessi in tale veste, comunque bambini, giovani, figli lo si è stati, nell’uno e nell’altro caso o in ambedue i ruoli si può, si deve, riconsiderarsi e porsi in confronto con l’insegnamento e l’esempio paterno ricevuto, il pensiero torna inevitabilmente al proprio di genitore, lo si voglia o no.
E la conclusione, spesso, è una sola: onora il padre. Senza se, e senza ma, a volte è una conclusione quasi inevitabile, aveva ragione lui, viene da dirci quando siamo avanti negli anni.
Il ciclo della vita è un cerchio, prima o poi si ritorna all’origine, al punto di partenza, l’origine ci ha decisi e poi plasmati, non è un punto infinitamente lontano ormai svanito anche nel ricordo e non più riconoscibile, tutt’altro: cuore e mente te lo riportano integro così com’era, nel bene e nel male, a grandezza naturale.
In un modo o nell’altro con la paternità, in sintesi, giunge prima o poi un momento della vita con cui bisogna farci conti.
A prima vista, il concetto di paternità è visto, specie in età adolescenziale, da chiunque, come un nodo. I nodi per definizione prima o poi vanno sciolti, sono fatti per questo, l’intreccio della canapa ha una funzione concepita in maniera duplice, per unire e poi separare.
Quando invece stretti, impossibili a sciogliersi, vale a dire privati dell’ambivalenza d’uso, allora è una deviazione dalla norma. Non legano, strozzano, sono privi di opzione.
I nodi migliori sono ad esempio quelli delle guide alpine capi cordata, i quali si legano ai compagni che li seguono con un tipo particolare di nodo: questo, quando sollecitato da un brusco strappo, si allenta anziché stringersi, si scioglie invece di serrare, in modo che, nel malaugurato accidente di un incidente, di un piede in fallo, la guida non trascina nella rovinosa caduta nell’abisso tutti i compagni di cordata. Tuttavia, il più delle volte, il nodo appare invece talmente inestricabile, che il distacco tra padre e figlio, più spesso per mano del secondo, avviene con uno scioglimento gordiano, vale a dire con un taglio secco. Ma questo non è uno sciogliere, è un troncare, significa in sintesi rimandare il concetto del distacco a considerazione futura.
Su queste riflessioni di base, Erri De Luca poggia la sua riflessione espressa in questo libro, che è permeato, e forse originato, dai suoi personali studi sull’ebraismo e sull’idioma yiddish.
Dopotutto, il primo e più maestoso esempio di apparente severità paterna nei confronti dell’educazione del proprio figliolo, che in realtà ha dei motivi non immediatamente riconoscibili, viene proprio dai testi sacri, la divinità che per i suoi scopi sacrifica il proprio figliolo.
Il proprio unico figliolo, perciò ancora più amato, che in punto di morte lo scongiura di scostargli l’amaro calice da bere, che lo accusa finanche di averlo abbandonato: e come dargli torto?
Chi poteva davvero capirne le ragioni?
E si parla del Padre e del Figlio per antonomasia.
Un concetto ribadito dal celebre episodio di Abramo e Isacco, in cui il patriarca non esita a portarsi sul monte con il suo unico figlio deciso a sacrificarlo come ordinatogli.
Isacco non capisce, e questo emblematico episodio da un lato esterna il difficile concetto di paternità da un punto di vista dell’obbedienza del figlio, per antica consuetudine dovuta sempre e comunque al proprio genitore.
Dall’altro, Abramo ha i suoi buoni motivi per compiere senza esitare l’insano gesto richiestogli, è anche lui tenuto all’obbedienza cieca per un Padre, che Isacco naturalmente non comprende; lo comprendiamo noi, ma a cose fatte, viene da dire a babbo morto.
Isacco, essendo figlio, obbedisce, potrebbe facilmente sciogliersi, è più giovane e forte, potrebbe sopraffare il genitore che è deciso a incaprettarlo, e però non si ribella.
“…Da loro in poi, il rapporto padre-figlio è una disputa tra un nodo e il suo disfacimento...”
L’episodio biblico è quanto mai esemplare di come sia difficile definire cosa è giusto e cosa no nella paternità, comprendere certe decisioni e non altre, esistono limiti dipendenti da troppi parametri, sempre assai sfumati, nella paternità, vista dall’uno e dall’altro estremo della corda che unisce i due in un nodo agile, leggero, stretto, inestricabile, e via così.
Su questa falsariga, Erri De Luca dipana il suo raccontare sul concetto di padre e figlio, e viceversa, inoltrandosi in un excursus che inizia dall’alba dei tempi, passa per Marc Chagall, pittore ebreo fuoriuscito dalla Russia che omaggia il proprio genitore con un quadro riconoscente, l’olio su tela “Il padre”, appunto, sviscerando i motivi e della tela e del metodo di lavorazione e dei motivi della raffigurazione, giunge a ricordare l’epopea di un maestro di scuola ebreo che non ebbe figli, e però amò tanti figli, i suoi alunni, si improvvisò padre per morire insieme ai figli degli altri, i suoi scolaretti ebrei, nelle camere a gas a Treblinka. Naturalmente, oltre ai figli De Luca ci racconta anche delle figlie, come la ragazza che un giorno scopre di essere figlia di un criminale di guerra nazista, che si nasconde ed ha una doppia vita per sfuggire ai cacciatori di nazisti:
“…il sangue non sporca…accusa…”
L’etica della giovane è contraria, agli antipodi con quella del padre, gli vuole però comunque bene, non lo abbandona né lo denuncia, ma non può ammettere che la sua progenie discenda da quella responsabile di simili orrori, quindi sacrifica sé stessa per amore filiale, sceglie di negarsi per sempre la discendenza, riscattando le magagne paterne nell’accudire quella abbandonata.
De Luca non si sottrae, ci racconta anche di sé, dei suoi genitori, persone semplici, frugali, essenziali:
“Sono debitore a loro due della migliore scuola di economia, farsi bastare quello che c’è. Mi è servito pure con la scrittura…”
E potremmo riportare ancora altro: da Napoli, dove:
“…l’adolescenza è stata un’età adulta…”
a Vienna, dalla Terra Promessa ai campi di sterminio dell’est europeo, la voce di Erri De Luca racconta quanto detto e altro ancora, ed è incredibile che lo descriva accuratamente in poco più di un centinaio di pagine.
Perché sia chiaro che lo descrive, non lo evoca, lo dice chiaro e tondo, con parole precise, non secche, ma sostanziali. Riferite ad un concetto, quello della paternità, a cui desidera restituire a grandezza naturale il suo peso basilare: di più, essenziale.
Indicazioni utili
Parlami della guerra soldato
Adagiato sulla sedia a dondolo all'ombra del suo portico, il vecchio veterano è pronto ad affrontare un viaggio nel passato stimolato da una giovane ricercatrice per ripercorrere alcuni degli episodi più cruenti e controversi della sanguinosa guerra civile americana.
Mentre le mani tremanti sorreggono un bicchiere di limonata per smorzare la calura degli stati del sud, la memoria di Dick pur vacillando sul presente, comincia a ricordare con lucidità le decine di compagni d'armi, le avanzate nei boschi, i guadi nelle paludi melmose, la fame, la malattie e le ferite, insomma tutti i volti di un conflitto che ha portato solo morte e disperazione nella totalità delle case.
I ricordi del veterano sono un fiume in piena, pronto ad abbandonare gli argini e a travolgere colei che ascolta alla ricerca di uno scoop giornalistico ed in secondo luogo il lettore.
Si tratta di un racconto fatto di immagini forti, per nulla edulcorate dalle nebbie del tempo.
Le violenze legate al razzismo e alla resa in schiavitù di esseri umani si legano a filo doppio allo scempio della guerra.
Nefandezze, soprusi e bestialità predominano su umanità, fratellanza e giustizia.
A cavallo tra verità storica e romanzo, lo scritto di Barbero è strutturato come un minuzioso flusso di coscienza, per contenuto e veste stilistica. Discorso diretto e indiretto si fondono in un unicum inestricabile che ingoia il lettore costringendolo ad una maratona di lettura dai ritmi serrati.
Una folla di nomi e visi equiparabile ad un intero reggimento viene riesumata dalla memoria del reduce e prende vita attraverso la penna di Barbero.
Uno scritto dal carattere stilistico marcato, frutto di una scelta dell'autore ponderata e voluta; intenso senza dubbio ma a tratti straniante.
Per chi saprà seguire la voce del vecchio combattente fino all'epilogo, le sembianze dell'odio prenderanno forma davanti agli occhi.
Indicazioni utili
| 1719 risultati - visualizzati 101 - 150 | « 1 2 3 4 5 6 ... 7 35 » |