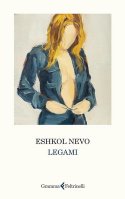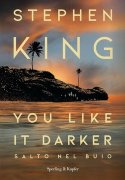Dettagli Recensione
L’anima dello shtetl...
...nei racconti di un padre della cultura yiddish
Questo prezioso volumetto della Piccola Biblioteca Adelphi propone tre racconti di un autore poco conosciuto nel nostro paese, ma che, come vedremo, ha avuto un ruolo estremamente importante per lo sviluppo della cultura ebraica nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo.
Sholem Aleykhem (la trascrizione in caratteri latini è variabile, ad esempio si trova anche Shalom Aleichem) è pseudonimo di Sholem Rabinovi?, ed in lingua ebraica significa 'la pace sia con voi' ma viene usato anche colloquialmente come espressione di saluto. Lo scrittore nacque in uno shtetl ucraino, allora parte dell’impero zarista, nel 1859, ed è considerato uno dei padri della letteratura yiddish. All’epoca lo yiddish, parlato da milioni di ebrei in tutta l’Europa centro-orientale, era considerato una sorta di vernacolo, e la letteratura ufficiale impiegava l’ebraico, la lingua alta.
Sholem Aleykhem compie, assieme a pochi altri intellettuali tra i quali bisogna citare Mendele Moicher Sforim, una autentica rivoluzione culturale, utilizzando lo yiddish per raccontare le sue storie, che hanno come protagonisti la vita dello shtetl e i suoi abitanti, visti con un occhio ironico intriso del tipico umorismo ebraico, che spesso contiene anche gli elementi di una satira sferzante. L’impiego della lingua parlata non è solo una questione formale, ma comporta, come sempre (pensiamo ad esempio a Pasolini e ai suoi 'Ragazzi di vita'), la possibilità di connotare in maniera estremamente realistica i personaggi, di evidenziarne con efficacia il carattere e di ottenere effetti comici non di rado sublimi. Purtroppo è inevitabile che molti di questi effetti dell’uso della lingua parlata vadano persi nella traduzione italiana, anche se a mio avviso i traduttori del volume Adelphi hanno compiuto uno sforzo notevole, di cui va dato loro atto, per preservare la freschezza del linguaggio di Aleykhem.
Oltre a scrivere in yiddish più di quaranta volumi di romanzi, racconti, saggi e poesie, Sholem Aleykhem fu un vero e proprio operatore culturale a tutto tondo, fondando riviste letterarie, incoraggiando giovani scrittori e partecipando attivamente ad iniziative per la diffusione della cultura yiddish. La personalità di questo autore emerge in modo plastico dal fatto che la sua prima prova letteraria, composta all’età di 15 anni, fu il dizionario alfabetico delle invettive utilizzate dalla sua matrigna.
Nonostante una vasta popolarità, non ebbe una vita facile: subì rovesci finanziari e nel 1905 fu costretto dai frequenti pogrom a lasciare l’Ucraina, vivendo tra Ginevra e New York. Morì in quest’ultima città nel 1916 e al suo funerale parteciparono più di centomila persone.
La fortuna di questo autore nel nostro paese è relativa: il suo solo romanzo tradotto, 'La storia di Tewje il lattivendolo', edito da Feltrinelli parecchi anni fa, è da tempo fuori catalogo, anche se è facilmente reperibile nel mercato dell’usato, ed oggi solo altri due volumetti della Piccola Biblioteca Adelphi oltre a questo ci permettono di conoscerlo.
Come detto, il volume ci presenta, in poco più di cento pagine, tre racconti, scritti tra il 1901 e il 1907, simili da un punto di vista formale e strutturale, anche se – come vedremo – profondamente diversi quanto a contenuto. Si tratta in tutti e tre i casi di monologhi (originariamente contenuti in una raccolta avente proprio tale nome), nei quali il personaggio principale racconta la sua storia colloquiando con un altro personaggio, che si limita ad interloquire brevemente o sta del tutto zitto. In tutti e tre i racconti, inoltre, il personaggio principale è un abitante dello shtetl, mentre l’interlocutore è in qualche modo un’autorità. Il narratore è quindi il protagonista assoluto dei racconti, e il suo modo di esprimersi, la sua prolissità e il suo continuo divagare, oltre che il contenuto delle storie che narra, creano effetti comici notevoli, soprattutto nei primi due racconti, più leggeri rispetto all’ultimo, che presenta elementi di maggiore articolazione e problematicità.
Il primo racconto è anche quello che dà il titolo al volume. In quest’unico caso la storia è raccontata dall’interlocutore, che è di fatto lo stesso scrittore. Egli, rientrato da un viaggio, viene avvertito che un giovane l’ha cercato più volte nei giorni precedenti. Ritenendo che fosse un giovane autore che volesse sottoporgli un manoscritto, si sente sollevato quando, incontrandolo, comprende che gli viene invece richiesto un consiglio, in quanto uomo istruito e di mondo.
Il giovane inizia quindi a raccontare: vive in uno shtetl vicino, ed ha sposato la figlia unica di un ebreo ricco ed avaro: in pratica è mantenuto dai suoceri. Dopo numerose divagazioni, che iniziano a spazientire l’interlocutore, giunge al punto: sospetta, anzi è certo, che la moglie lo tradisca con il bel dottore del villaggio, cosa di cui tra l’altro si mormora in tutto lo shtetl. Chiede quindi allo scrittore, che 'scrive così tanto, e che per questo deve sapere tutto', il consiglio giusto: deve divorziare? Quando lo scrittore gli risponde che sì, stando così le cose deve senz’altro divorziare, il giovane ribatte che però egli ama la moglie, ma che – soprattutto – è il principe ereditario, il genero del riccone e che tra centovent’anni (la durata della vita secondo la tradizione ebraica) 'è comunque tutto suo, vale a dire, mio'. L’interlocutore conclude che allora è meglio non divorziare e rimanere con la moglie. Il giovane allora riprende a mettere in evidenza gli elementi a favore del divorzio, al che l’interlocutore conclude che allora è meglio divorziare. Il racconto si snoda così con un ritmo che si fa sempre più serrato, mentre il giovane ogni volta sposta la sedia avvicinandosi allo scrittore sino a urlargli praticamente in faccia; ogni volta che quest’ultimo sposa una tesi o quella opposta il giovane la ribalta, sempre più freneticamente e lapidariamente, sino a che alla ennesima contestazione lo scrittore lo piglia per il collo, lo sbatte al muro e gli urla: ”Devi divorziare, bastardo! Divorziare! Divorziare! Divorziare!!!”. Ricompostisi, i due si salutano con il giovane che ringrazia per il consiglio ricevuto. La comicità del racconto è data inizialmente dalla prolissità del giovane, che esponendo il suo dilemma traccia, con innumerevoli incisi, divagazioni ed aneddoti e la ricchezza di una lingua pirotecnica, uno spaccato della vita nello shtetl e del carattere dei membri della sua famiglia allargata, facendoci capire da subito come a lui ciò che interessa è mantenere il suo status di mantenuto nullafacente. In seguito l’effetto comico è assicurato dal progressivo aumento del ritmo dell’interlocuzione tra i due, sino all’epilogo burrascoso. Oltre alla componente genuinamente comica il racconto ne contiene però anche una satirica, non meno importante. All’inizio, quando ritiene che l’importuno sia un giovane autore, lo scrittore lancia i suoi strali contro la cultura ebraica accademica, di cui in poche righe molto efficaci denuncia la vuotezza di contenuti ed il distacco dalla realtà. Ma è nel dilemma esistenziale del giovane che la satira di Aleykhem si scatena, sia contro la ristrettezza delle convenzioni sociali nella comunità dello shtetl sia contro le convenienze materiali della vita, che fanno passar sopra ogni altra considerazione.
Il racconto successivo, 'Il pentolino', è a mio avviso il meno significativo dei tre, senza nulla togliere alla forza comica del testo. Qui la narratrice è una povera vedova, di nome Yente, che si rivolge al rabbino del villaggio, per chiedergli un parere. Inizia quindi un monologo, con il rabbino che non interloquisce mai, durante il quale la vedova la prende larga, come si dice, raccontando di sé, della sua vita, di suo figlio che studia, della famiglia della sua inquilina e di come questa le abbia rotto un pentolino… dopo una ventina di pagine nelle quali il racconto ha percorso mille rivoli del tutto inconcludenti, e durante il quale periodicamente la vedova Yente, per riprendere il filo, dice: ”Già, ma com’è che siamo arrivati a parlare di questo? Ah, si, perché voi dite…”, senza che il Rabbe abbia spiccicato parola, questi sviene, completamente sopraffatto dalla ciarla della vedova. Il punto di forza del racconto è in questo caso esclusivamente la lingua, la capacità di Sholem Aleykhem di rendere l’eloquio della vedova, la garbata presa in giro della chiacchiera fine a sé stessa che costituiva sicuramente uno dei pilastri fondanti la piccola comunità dello shtetl, come avviene del resto anche nella nostra provincia.
Il racconto più lungo, ma anche a mio avviso il più complesso ed articolato, è l’ultimo, 'Tre vedove – racconto di un vecchio scapolo irascibile'. Anche in questo caso si tratta di un monologo, in cui il narratore è uno scapolo di mezza età, benestante, che narra ad un personaggio non meglio identificato, ma comunque colto e cittadino, la storia della sua vita. Da giovane frequentava la famiglia di Pynie, un giovane ricco e colto (autodidatta), e di sua moglie Paye: i maligni mormoravano che i due fossero amanti, ma il narratore nega recisamente la circostanza. Pynie muore presto, lasciando la moglie ed una figlioletta, Roze. Lo scapolo diviene di fatto il tutore della famiglia, assistendo la vedova nelle questioni pratiche e contribuendo anche economicamente alla crescita di Roze. Innamorato della vedova, è sicuro che anche ella ami lui, ma i due non riescono mai a dichiararsi. Quando Roze cresce, si fidanza con Shapiro, un bravo ragazzotto amministratore di una distilleria, sposandolo. Dopo pochi mesi, però, i padroni della distilleria – coinvolti in speculazioni azzardate – fuggono in America lasciando cambiali sottoscritte da Shapiro, che viene accusato di bancarotta fraudolenta e si suicida. Roze, incinta, partorisce una bambina, Feygele, cui lo scapolo fa da padre, accarezzando vagamente l’idea di poter sposare Roze una volta che la piccola sarà cresciuta. Giunta oltre l’adolescenza, Feygele inizia a frequentare tre giovani marxisti e rivoluzionari, sposandosi quindi con uno di questi. Egli però viene subito arrestato in quanto coinvolto in un attentato, quindi impiccato insieme ai compagni. Così, lo scapolo continua a frequentare la casa delle tre vedove, badando a loro e giocando la sera lunghe partite a carte.
Se la lingua usata e la struttura del racconto sono molto simili a quelle dei due precedenti, balza subito all’occhio una differenza sostanziale: nella trama prevalgono elementi drammatici ed anche tragici, che generano un forte contrasto con il tono ancora una volta colloquiale e comico – di una comicità data soprattutto dall’irascibilità del narratore – del racconto. Oltre a questo fatto, ed in stretta relazione con esso, è indubbio, a mio avviso, che a questo racconto Sholem Aleykhem abbia affidato un forte significato metaforico rispetto alla situazione delle comunità ebraiche dell’Europa orientale. Non dimentichiamoci che il racconto è del 1907, posteriore quindi all’ondata di pogrom del 1905 ed all’esilio dell’autore, che certo si poneva più interrogativi che in precedenza.
Analizziamo il racconto: la prima vedova ha un marito tradizionale, espressione dello shtetl, Roze sposa chi sarà vittima dell’ingordigia capitalistica e Feygele, infine, chi cadrà per le sue illusioni rivoluzionarie. Quindi, sembra dirci l’autore, la specificità ebraica – come non può sopravvivere rimanendo esclusivamente legata ai suoi valori ancestrali, così non può inquinarsi ed accettare supinamente le due ideologie dominanti i tempi nuovi, il capitalismo e il socialismo, perché ciò genera solo lutti. L’autore non ha peraltro soluzioni, perché lo scapolo, anch’egli espressione della tradizionale comunità ebraica, non riesce a dichiarare il proprio amore né a Paye né a Roze, non riesce a prendere in mano la situazione, limitandosi ad un sostegno esterno alla piccola comunità di vedove: in quel finale giocare a carte si riassume benissimo la fine di ogni illusione. E’ uno sguardo disperato, quindi, quello che l’autore rivolge ai suoi shtetl, quasi che presagisse la fine che sarebbe giunta di lì a pochi decenni. Il carattere morale che l’autore attribuisce a questo racconto è sottolineato anche dal ripetuto accenno, da parte dello scapolo, alla necessità di comprendere la realtà basandosi sulle storie vere, e non sulla psicologia.
Veramente un bel libro, quindi, questo 'Un consiglio avveduto', accompagnato da un indispensabile glossario dei numerosi termini ebraici del testo, che ci permette di assaporare i tratti di una cultura che pochi decenni dopo sarebbe stata completamente spazzata via – tanto che oggi lo yiddish è una lingua praticamente estinta – attraverso l’opera di uno dei padri di questa cultura, che meriterebbe sicuramente più attenzione da parte della nostra editoria.
Indicazioni utili
Commenti
| 1 risultati - visualizzati 1 - 1 |
Ordina
|
| 1 risultati - visualizzati 1 - 1 |


 Opinione inserita da viducoli 21 Febbraio, 2017
Opinione inserita da viducoli 21 Febbraio, 2017