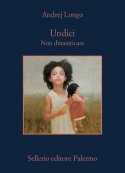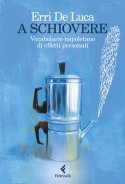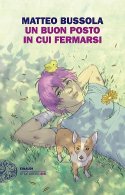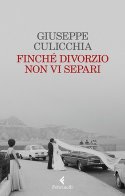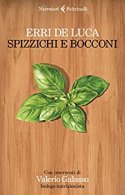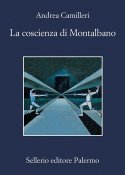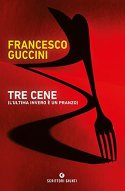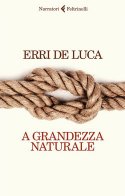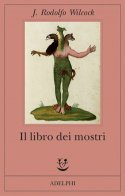Dettagli Recensione
Perdersi ma non ritrovarsi
“Il mare non bagna Napoli” altro non è che una raccolta di cinque racconti e di questi, i più godibili e apprezzabili, sono senza dubbio i primi due. Questo perché l’autrice riesce a descrivere una Napoli nel suo aspetto più autentico e non per forza bello, una Napoli che di suo è popolare e anche un po’ disagiata, una Napoli che si attacca alle tradizioni e alle consuetudini e che per questo mostra anche una visione che non rappresenta l’ideale canonico che immagiamo pensando alla realtà napoletana.
Nel quarto racconto, ancora, lo squallore della realtà descritta emerge con tutta la sua forza. Non c’è dunque da stupirsi della difficoltà dell’autrice del far ritorno a un popolo che non la vede di buon occhio, ivi comprese le rappresentanze politiche.
«Non occorreva molto per capire che qui gli affetti erano stati un culto, e proprio per questa ragione erano decaduti in vizio e follìa; infine, una razza svuotata di ogni logica e raziocinio, s'era aggrappata a questo tumulto informe di sentimenti, e l'uomo era adesso ombra, debolezza, nevrastenia, rassegnata paura e impudente allegrezza. Una miseria senza più forma, silenziosa come un ragno, disfaceva e rinnovava a modo suo quei miseri tessuti, invischiando sempre più gli strati minimi della plebe, che qui è regina. Straordinario era pensare come, in luogo di diminuire o arrestarsi, la popolazione cresceva, ed estendendosi, sempre più esangue, confondeva terribilmente le idee all'Amministrazione pubblica, mentre gonfiava di strano orgoglio e di più strane speranze il cuore degli ecclesiastici. Qui, il mare non bagnava Napoli. Ero sicura che nessuna lo avesse visto, o lo ricordava. In questa fossa oscurissima, non brillava che il fuoco del sesso, sotto il cielo nero del sovrannaturale.»
Nonostante gli intenti, così come la denuncia sottesa, possa essere di interesse per il lettore, il problema dell’opera è lo stile narrativo che, dopo un inizio tutto sommato lineare, finisce per arrovellarsi su se stesso e per perdersi in digressioni e articolazioni che sono “troppo”. Il lettore arrivato a un certo punto perde le coordinate, si perde nel quantitativo di informazioni, si perde, ancora, negli intenti che dovrebbero essere alla base dello scritto. Si tratta di un’opera di denuncia agli intellettuali napoletani dell’epoca o ancora è una reportistica dettagliata su quel che succede angolo per angolo, strada per strada, della realtà del tempo e del luogo? Questo fa sì che l’attenzione cali e con questa anche l’interesse per un’opera che, al contrario, avrebbe potuto dare molto e con molto meno.
«Ma quegli uomini e donne e bambini seminudi, e cani e gatti ed uccelli, tutte forme nere, sfiancate, svuotate, tutte gole che emettono appena un suono arido, tutti occhi pieni di una luce ossessiva, di una supplica inespressa – tutti quei viventi che si trascinavano in un moto continuo, pari all'attività di un febbricitante, a quella smania tutta nervosa che s’impadronisce di certi esseri prima di morire, per un gesto che gli sembra necessario, e non è mai il definitivo – quella grande folla di larve che cucinava all'aperto, o si pettinava, o trafficava, o amava, o dormiva, ma mai veramente dormiva, era sempre agitata, turbava la calma arcaica del paesaggio, e mescolando la decadenza umana alla immutata decenza delle cose, ne traeva quel sorriso equivoco, quel senso di una morte in atto, di vita su un piano diverso dalla vita, scaturita unicamente dalla corruzione.»
“Il mare non bagna Napoli” è uno di quei testi che vanno letti al momento giusto ma anche con la dovuta cognizione di causa. Certamente risente del tempo, certamente risente dell’impostazione che ne caratterizza la struttura, ma certamente è anche uno di quei testi che fa pensare al “sopravvalutato”. Questo anche se, come me, il lettore ci si avvicina senza aspettative.
Indicazioni utili
- sì
- no