Dettagli Recensione
c'era un paese che aveva bisogno di eroi. c'è anco
“Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale.”
Nel 1991, quando Giovanni Falcone scrive questo libro in collaborazione con la giornalista francese Marcelle Padovani, il suo nome è ben conosciuto agli addetti ai lavori, ma non abbastanza presso la società civile (perlomeno, non come lo sarà dopo i tragici fatti del 1992).
Eppure il giudice Falcone all’epoca è già un “gigante” della lotta alla mafia:
- ha istruito – insieme ai colleghi del pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto – il maxi-processo del 1986 contro Cosa nostra,
- ha dato impulso al meccanismo che – permettendo la rotazione tra le varie sezioni della Cassazione – ha impedito allo stesso processo di “fermarsi” contro la sentenza assolutoria di qualche infedele servitore dello Stato (ce ne sono nella magistratura come in tutti gli altri settori pubblici),
- ha ottenuto che le dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta costituiscano la base per l’indubitabile affermazione dell’esistenza della mafia e per la condanna all’ergastolo dei suoi più “illustri” capi.
“Il maggior risultato raggiunto dalle indagini condotte a Palermo negli ultimi dieci anni consiste proprio in questo: avere privato la mafia della sua aura di impunità e di invincibilità.”
Tutto l’impegno, tutto il lavoro di Giovanni Falcone si condensano in qualcosa che molti altri suoi colleghi non hanno raggiunto (anche per la sua intrinseca difficoltà): la conoscenza e l’esatta percezione del fenomeno mafioso.
“Cose di Cosa nostra” è ancora oggi – dopo più di venticinque anni dalla morte di Falcone e Borsellino, dopo numerosissime pubblicazioni sulla mafia – una miniera: è illuminante scoprire come, dietro frasi e considerazioni molto semplici, si celi una conoscenza così precisa del fenomeno e del “tipo” mafioso; una conoscenza che continua a valere per le mafie di oggi, nonostante lo sguardo si sposti verso i cosiddetti “colletti bianchi” (ma è poi vero che le dinamiche dell’economia e del potere mafioso non contemplavano questa categoria già ai tempi del giudice Falcone?).
“E’ la mafia a imporre le sue condizioni ai politici, e non viceversa. Essa infatti non prova, per definizione, alcuna sensibilità per un tipo di attività, quella politica, che è finalizzata alla cura di interessi generali. Ciò che importa a Cosa Nostra è la propria sopravvivenza e niente altro. Essa non ha mai pensato di prendere o di gestire il potere. Non è il suo mestiere.”
La profonda conoscenza che Giovanni Falcone aveva del fenomeno mafioso è stata alla base del successo del suo lavoro così come della sua fine. Alla conferma in Cassazione dell’esito del maxiprocesso (fine 1991), Totò Riina ha incluso nella sua lista di deliranti obiettivi due tipologie di persone: quelli che riteneva “traditori” (come Salvo Lima, ucciso nel marzo 1992), e i “nemici” (come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino).
E’ una certezza, processualmente acclarata, così come lo è il fatto che il giudice Falcone – in virtù della sua capacità di leggere il fenomeno – ne fosse pienamente consapevole.
“Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere.”
Indicazioni utili
Commenti
| 2 risultati - visualizzati 1 - 2 |
Ordina
|
Purtroppo il conto dell'Asinara riguardava entrambi i giudici (ed era ancor più una beffa per Borsellino, che dovette spostarsi con tutta la famiglia e isolare i suoi tre ragazzi per vari mesi)
| 2 risultati - visualizzati 1 - 2 |















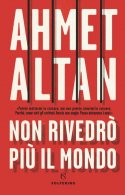

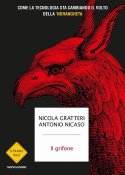

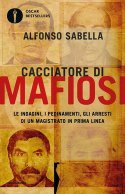










“Si muore generalmente perché si è soli" ricordo ancora il senso di sgomento che narrò ricordando il conto dell'Asinara...purtroppo non mi ricordo più dove l'ho letto e se era suo o di Borsellino.