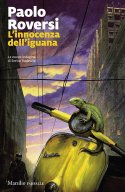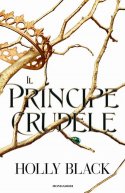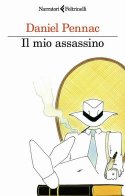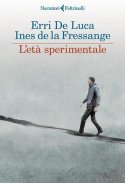Opinione scritta da Martina248
| 17 risultati - visualizzati 1 - 17 |
La porta: limite e confine
Una porta che è muro invalicabile, limite tra il mondo pubblico e l’inesplicabile privato. Una porta è, però, anche confine, fragile segmento che divide due individualità.
La porta che nasconde l’abitazione di Emerenc, una vecchia cinica travolta dalle tragedie del Novecento, cela una storia troppo difficile da raccontare, fatta di “piccole cose di pessimo gusto”, ricordi di una vita che nessuno può comprendere, una storia che non vuole raccontarsi. La dura vita di Emerenc si mostra in sacri oggetti nascosti, nei residui del dolore che ha lasciato, in un atteggiamento a tutto indifferente, incomprensibile a chi non ha vissuto quello stesso mal di vivere.
Della tragicità che il Novecento ha portato con sé non rimane ad Emerenc alcuna lezione, alcun insegnamento. La storia smette di essere magistra vitae e lascia soltanto un dolore da estirpare alla radice, in modo brusco.
L’ostilità e crudezza con cui Emerenc guarda alla vita e all’altro rimane per gran parte del romanzo incomprensibile alla narratrice, che dopo averla assunta come domestica rimane aggrovigliata nei misteri della vecchia. Lo stesso lettore è diviso tra l’umana compassione che la storia della domestica suscita e l’ostilità che genere la sua figura.
Se Emerenc è la donna della concretezza, delle cose, rifiutando spiritualità e ideali, Magda, scrittrice di successo e narratrice del romanzo, è, invece, colei che si nutre di parole, che attende con pazienza un sillabato racconto che riveli le ragioni sottese al comportamento della vecchia. Ma l’unica cosa che resta dell’attraversamento del Novecento di Emerenc è il dolore delle cose, che urlano un malessere ineffabile.
Queste due donne, pur rappresentanti di due mondi incomunicabili, si rincorreranno per tutto il romanzo, e noi con loro, cercando una comunicazione che non rompa l’ostacolo della porta ma lo attraversi.
“La porta” è allora il racconto dell’incomunicabile svelamento del grande dolore del secolo breve.
Indicazioni utili
Abituarsi all'abitudine
Poco sappiamo della protagonista di questo libro; neanche il titolo allude al suo essere ma solo al suo ruolo: ancella.
Il nome narra un destino e quello che il regime di Gilead assegna alle sue ancelle racconta l’unica sorte possibile per una donna fertile che vive a Gilead: l’appartenza ad un uomo. Ogni donna è spogliata del suo essere per divenire puro accessorio, mezzo dei potenti per perpetuare la loro specie: June viene ridotta a Of-Fred.
Il regime nasce dalle migliori intenzioni: far rifiorire un mondo oppresso da disastri ambientali, tornare a scorgere una crescita nella natalità, portare ordine in una contemporaneità dominata dal caos. Eppure, viene da chiedersi a scapito di chi tali piani si perseguano, quando anche gli stessi uomini, a capo del sistema, ne sono schiavi a loro volta. Una società che riduce la donna a oggetto, che le toglie ogni valore se non la riproduzione, nega al contempo l'umanità dell’uomo. Perché umanità è nella relazione e neanche Fred ha più diritto al dialogo che elemosina alla sua ancella.
Atwood sceglie uno stile lineare e, al tempo stesso, narrativamente ben pensato. Il salto schizofrenico tra passato e presente, il racconto frammentario di Of-Fred ben rendono lo smarrimento della protagonista.
Restano molti dubbi al lettore: come è avvenuto il passaggio dall’antico mondo a Gilead? Cosa avviene una volta che le ancella saranno ormai anziane e non più fertili? Esiste una possibilità di sovvertimento dell’ordine? Sono risposte che il lettore non ha perché neanche il suo narratore può darvi risposta. Anche noi entriamo a far parte di Gilead e della sua manipolazione.
June ci offre, però uno scenario: ciò che rende la distopia realtà è l’abituarsi all’abitudine, il lasciar scorrere senza alzare lo sguardo.
Quel che, invece, alimenta la vita, nel regno della distopia, è solo una flebile speranza in parole non totalmente comprese, a cui ci si aggrappa, quando tutto pare perduto: Nolite te bastardes carborundorum.
Indicazioni utili
"Primo atto di una commedia famigliare"
All’apparenza potrebbe sembrare un romanzetto adolescenziale; e forse per questa ragione, questo romanzo ha dovuto attendere i miei vent’anni per essere letto. Meg, Jo, Beth e Amy, invece, ci accompagnano in una storia di avventure fanciullesche, sentimenti, speranze, scoperta di sé e grande desiderio di indipendenza.
Ciò che mi ha colpito di più della storia di queste quattro ragazze (Ma non solo: come dimenticare la leziosa e tanto buona mamma March, il birbante e fedele Laurie e il caro signor Lorence, dal cuore d’oro?) è il tenero accostarsi tra i più nobili e semplici valori cristiani (L’amore fraterno, la solidarietà oltre ogni futile ira, l’apprezzamento di ciò che si ha, accogliendo i frutti della povertà, il rifiuto del peccato e il continuo lavoro interiore su di sé per combatterlo) ai più rivoluzionari desideri di quattro donne, quasi “proto-femministe” che lottano per “fare qualcosa per il proprio mantenimento” ed essere economicamente indipendenti dalla loro famiglia, che coltivano con determinazione i proprio interessi e sognano un gaio futuro di successo (Chi disegnando, chi scrivendo, chi suonando, chi governando una lussuosa casa...).
Questi tratti ben si esemplificano nella ribelle Jo, che ama riferirsi a sé con il maschile e guarda con desiderio, seppur senza invidia, la posizione di Laurie e non vede che può essere ciò che è: determinata, risoluta, decisa, senza la necessità di essere un uomo.P
Altro tratto non meno importante è il lavoro, valore primordiale per le sorelle March, oltre le fatiche quotidiane spesso lamentate. Proprio il lavoro diventa simbolo dell’indipendenza, del sapersi prendere cura di sé.
Non si può dire che questo romanzo tutto al femminile non presenti dei piccoli tratti rivoluzionari!
Ma, Piccole Donne, è anche un romanzo di formazione che parla dell’inaspettata maturazione di quattro fanciulle che si apprestano a diventare donne, lottando con i propri vizi e accogliendo le sfide che la vita propone.
Avvertendo di un piccolo spoiler, mi permetto di dire che la conclusione con l’attesa di un matrimonio ormai deciso mi ha lasciata con le stesse sensazioni di Jo. Ma, forse, è pretendere troppo, chiedere ad un’autrice di uscire dal suo tempo. E questo certo non rovina questo romanzo di cui avevo poche aspettative e che ha saputo stupirmi!
Indicazioni utili
Vola solo chi osa farlo!
Poco prima di spirare, una povera gabbianella, impregnata di petrolio, scongiura un gatto pelandrone, affidandogli il compito più importante, un compito vitale per la sua piccola cucciola, che non avrà opportunità di vedere: quello di accudirla e di insegnarle l’arte del volo. Parrebbe una beffa: un gatto che insegna a volare. Invece questo libro è una storia densa di significato: pullula di solidarietà, di incontro del diverso, ma anche di libertà e di coraggio.
Mi sono accostata a questo testo e, devo ammetterlo, a questo autore, solo ora, a vent’anni, e me ne dispiaccio perché sono convinta che questa favola moderna sarebbe tanto piaciuta alla me bambina.
Però, al tempo stesso, questi anni in più mi hanno permesso di vedere questo libretto in un’altra luce: mi hanno permesso di cogliere quei rimandi letterari in questo contesto fiabesco, tra cui il simpatico gatto Diderot, tramite cui Sepùlveda pare strizzare un occhio al lettore adulto.
E non manca nemmeno una rilettura su un tema, oggi a noi purtroppo caro: quello dell’inquinamento e degli uomini-distruttori che “Spesso con le migliori intenzioni causano i danni peggiori”. Eppure Sepùlveda lo fa senza pesantezza. Enzo Biagi diceva: “Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino”. Parafrasandolo, potremmo dire che le verità che conosciamo da bambini sono quelle che più si imprimono nel nostro essere e nella nostra forma mentis: per questo è tanto importante far conoscere la lettura fin da piccoli e, per questo, questo libro è così prezioso.
Ma ciò non preclude una rilettura da “grandi”. Leggere questo libretto, mi ha ricordato il piacere smodato per la narrazione proprio dei bambini, l’immaginazione che negli anni spesso langue. Ma mi ha anche divertito con il suo tono ironico e al tempo stesso sincero. Mi ha fatto tornare voglia di volare, proprio come la gabbianella. E non è proprio il poter tornare a volare, sognando, il proprium di ogni libro?
Consiglio di cuore questa storia a chi vuole riscoprirsi bambino, cullato dalla narrazione prima di tornare ai sogni della notte.
Indicazioni utili
L'odore delle mandorle amare...
Leggere questa recensione, richiederà qualche piccolo spoiler, che però non credo in nessun modo possa rovinare la lettura di questo libro, che non si gioca nella trama, quanto più nelle suggestioni, nei sentimenti evocati e nell’interiorità dei protagonisti.
L’incipit de “L’amore ai tempi del colera” rimarrà sempre nei miei ricordi per la sua estrema poeticità:
“Era inevitabile: l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati.”
E quello tra Fermina Daza e Florentino Ariza è certamente uno degli amori più travagliati di tutta la letteratura. Questo inizio ad effetto si apre su una vicenda estranea ai due protagonisti eppure tanto simile, il suicidio dell’esule Geremia Saint-Amour, amico intimo del dottor Juvenal Urbino, marito della nostra Fermina.
Proprio questo inizio pare essere un preludio all’accidentale morte del dottore, avvenuta lo stesso giorno, che, inaspettatamente, mostra uno spiraglio di luce a quell’amore tanto disperato di Florentino Ariza, ormai anziano, che attende l’amata da “Cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni, notti comprese”.
Il filone narrativo salta poi verso la giovinezza dei nostri protagonisti: dalle poetiche lettere del nostro amato , ai suoi nascondigli, da cui osservare l’amata in un quadro tanto poetico quanto romantico.
E’ la separazione imposta, però, che segna una svolta: le vite di Florentino e Fermina, che si svolgono nella medesima città, paiono da questo momento agli antipodi. Da una parte il matrimonio di Fermina, nato senza amore e sviluppatosi a in un affetto quotidiano tanto infelice e tedioso quanto sincero, che i giorni intessono tra un battibecco e l’altro. Dall’altra la vita vagabonda di Florentino che oscilla tra i successi alla “Compagnia fluviale dei Caraibi” e gli amori che si succedono l’uno dopo l’altro, lasciando qualche vago e lieto ricordo ma mai la traccia che ha impresso, ormai anni ed anni prima, Fermina.
Sono proprio gli eventi paralleli tra queste due vite che mostrano la loro intima inconciliabilità: la prima notte di nozze di Fermina, tanto straniante e assurda quanto intimorita, non ha nulla a che vedere col primo fuggente e quasi feroce amore di Florentino, a cui non è concesso conoscere il volto né l’identità della sua prima amante.
In un altro salto temporale, torniamo al presente, dove si gioca l’amore senile dei nostri protagonisti. Un amore denso di limiti ma anche di dolcezze che risorgono inaspettatamente in anni avanzati, tanto apprezzate proprio perché ricordato un’età giovanile ormai passata. Con tutti i suoi limiti, le sue attese, i suoi disguidi può ora sbocciare un amore compiuto eppure vissuto attimo per attimo, giorno per giorno, gustando ciò che l’amore e la vita offrono, proprio quando parevano essere volti al termine.
Di questa lettura ho amato particolarmente la parte svolta nel presente (Incipit e parte finale) mentre il flashback centrale mi è parso piuttosto lento ed eccessivamente lungo. Ciò che mi ha, invece, stupito positivamente è stata la trattazione di un amore senile, che non ricordo essere stato affrontato in molti altri classici da me letti e che conserva una sua peculiarità e una sua dolcezza. Altra nota positiva è stata lo stile dell’autore, a volte poetico, a volte ironico e divertito nel raccontare dei particolari tanto irrilevanti quanto espressivi che rendono la narrazione in un certo modo “frizzante”.
Indicazioni utili
La mia paura è la mia essenza
Emergono dalla lettura di queste dolorose pagine dei punti fissi, come labili stelle in un cupo cielo notturno. Per prima la paura, che fin dalle prime righe predomina in timide frasi in negativo (“Non sostengo naturalmente di essere divenuto quello che sono soltanto per la tua influenza”), contraddizioni intimorite che dominano il testo, accuse che vorrebbero colpire il bersaglio e che invece si ripiegano su se stesse in una colpa senza nome, né accusato. Di tale colpa, che pervade l’animo di un figlio che ha riposto la stima di sé nelle mani del padre, rimangono i resti nel suo fragile cuore, incapace di portare a termine ogni scopo di vita, abbagliato dall’onnipresente confronto con il padre.
Kafka delinea la figura di un uomo burbero, austero, ostile al prossimo eppure “misura di tutte le cose”, margine di paragone di ogni impresa, destinatario di ogni successo. E da questa lacerazione, nasce un animo tormentato, dominato dal timore che diviene elemento costitutivo del nostro fragile scrittore.
“La mia paura è la mia essenza, e probabilmente la parte migliore di me stesso”.
Ma questa paura è incompresa dal padre e anche quando egli ne domanda le cause, le parole si assopiscono di fronte all’innumerevole lista di motivi, di fronte al timore che impedisce di trovare giustificazione di sé stesso.
La lotta padre-figlio che viene a crearsi non è però combattuta l’uno di fronte all’altro, ma in lontani sguardi di disapprovazione, mancate parole di conforto che si annidano nel cuore del nostro scrittore.
Leggendo quest’opera, mi sono chiesta più volte fino a che punto avessi diritto di entrare nell’intimità del nostro Kafka, che poco prima di morire invitò il suo amico Max Brod a bruciare ogni suo scritto, quanto potessi permettermi di entrare nei meandri della sua fragilità. Non mi sono ancora data risposta; ciò nonostante, sono giunta alla conclusione che innumerevoli di quelle paure non erano solo di Kafka, ma di tutti noi, e il poter condividere con un libro i nostri dolori, è per il lettore sempre motivo di conforto.
C’è da dire poi, che questa lettera è sicuramente il punto d’incontro e il fondamento di molte altre sue opere: dal “Processo” alla ben nota “La metamorfosi”
Lettura caldamente consigliata come si può percepire dalle mie parole!
Indicazioni utili
L'esistenza priva di curiosità non è umana vita
Se ripercorressimo questa breve e intensa opera, pagina per pagina, sicuramente ci accorgeremmo che una è la parola che spicca più di tutte le altre e brilla indiscussa, la verità, meta indiscussa del nostro filosofo dell’uomo, quella verità perseguita ad ogni costo, oltre ogni diceria e ogni retorica sofistica che mette un falso vero in vetrina, con il solo scopo di persuadere la comunità.
Ma Socrate è conscio della sua missione datagli dal Dio: quella di allontanare l’uomo dalle false verità, di liberarsi e liberare dalle erronee presunzioni che ci caratterizzano, di comprendere che il nostro sapere non è che pochezza. E proprio questa consapevolezza gli impedisce di essere preda delle paure, di non addentrarsi nei rischi più profondi, in primis perché chi persegue uno scopo nobile e può essere utile agli altri non deve temere rischi, in secondo luogo perché, da uomo saggio, Socrate sa bene di non conoscere la morte e di non poter presumere nulla, non avendo una visione del tutto.
Nella sua lunga difesa, il nostro filosofo ha ben di fronte a sé la perentoria condanna, non spinge la giuria ad impietosirsi, non si scompone, anzi fino all’ultimo istante persegue la sua meta. Anche nelle ultime ore, non si stanca di mettere a nudo le presunzioni dell’uomo con il suo principio instancabile: il dialogo, che apre le strade ad una verità che è continua ricerca.
Ritornano più volte nell’opera le cause formali dell’accusa rivolta a Socrate: empietà e corruzione dei giovani. Eppure, non smettono di affiorare nel lettore le cause più profonde: la grave colpa del nostro filosofo è quella di mettere a nudo il suo interlocutore, di sgonfiare le sue certezze ostentate e mettere ogni cosa in discussione, di lasciarlo inerme di fronte alla sua limitatezza.
Nonostante i dubbi iniziali circa la difficoltà del testo, mi sono completamente ricreduta. E’ sicuramente una lettura arricchente e intensa nelle sue poche pagine, dominata da una tensione continua, che porta il lettore a sperare fino all’ultimo minuto in una assoluzione insperata e inaspettata.
Indicazioni utili
Tra ideale e grottesco
Ogni classico che si rispetti, come diceva Calvino, ha l’intrinseca caratteristica di non essere mai uguale a se stesso, di avere sempre qualcosa di nuovo da dire. Da questa sentenza non può certo esonerarsi Notre-dame de Paris, di cui darne una definizione univoca risulta arduo, al lettore e anche, aimé, al recensore.
Pensato come critica al decadimento di un’architettura parigina tanto cara al nostro Hugo, quella gotica medievale, e come lode alla stessa ma non meno come superamento di un genere (Il romanzo storico) tanto caro alla letteratura, per giungere a una fusione di più generi. Non manca tuttavia un velo personale, un tormento insito nei personaggi, vittime di un destino che non possono governare. Quegli stessi personaggi che si scoprono separati, frammentati in un eterno dualismo: quello tra il sublime e il grottesco, che li tormenta, in primis Quasimodo. Nessuno dei due però prevale sull’altro, non vi è bello ideale né cupa mostruosità. Per questo non si può che inorridire alla tetra descrizione del nostro gobbo e ai timori di Esmeralda alla sua vista e al tempo stesso intenerirsi e aver compassione della pura e docile anima di Quasimodo. E allo stesso modo non si può che provare orrore di fronte alle meschine azioni di Frollo e al tempo stesso avere pietà per il suo tragico destino, di cui non può essere padrone. Proprio da questa dicotomia nasce una nuova armonia, l’armonia dei contrari.
E non si può dimenticare di annoverare tra i protagonisti, la fervente folla, per la prima volta al centro di un romanzo e, insieme, la ville-lumière, sfondo ma anche soggetto del romanzo stesso.
Pertanto, non possiamo che ringraziare Charles Gosselin, editore del romanzo che lungamente sollecitò l’autore per la sua scrittura (e dovette attendere per ben tre anni il manoscritto dal nostro scrittore, che tanto tardò la consegna) e, chiaramente, Hugo per il suo capolavoro.
Indicazioni utili
Chi si nasconde dietro la storia
Ricordo quando, circa un anno fa, studiai la seconda guerra mondiale e l’invasione tedesca in Francia tra i banchi di scuola e, solo ora, leggendo questo libro, mi rendo conto di come mi limitai a memorizzare date e eventi di quel periodo, cercando di collegare fatti ed individuandone le cause e dimenticandomi, in ogni mio ragionamento, del fatto che dietro a quegli eventi vi erano delle persone, delle persone che soffrivano, che erano ignare del futuro e non bastava loro girare qualche pagina come noi, per sapere quando e se quella terribile guerra sarebbe finita.
Invece, la lettura di Suite francese, ha saputo farmi sentire ciò da cui il nostro studio della storia spesso prescinde: le paure, i tremori, le ansie e le speranza di quegli uomini così lontani e così simili a noi, travolte dal turbine inarrestabile della Storia.
Irène aveva in mente un grande progetto, cinque libri per un totale di mille pagine, di cui solo due ebbero il tempo di fiorire dal suo animo che presagiva la fine, ma non poteva smettere di raccontare, unico diletto in una vita di ansie.
Così, il primo libro ci porta nelle case di tre famiglie francesi e ci accompagna nel loro disperato viaggio alla ricerca di un rifugio, lontano dai bombardamenti tedeschi: i Péricant, i Michaud e i Corte. Saltando da una storia all’altra, Irène analizza ogni reazione alla catastrofe: dal tenero egoismo di una madre che vorrebbe soltanto salvare la sua famiglia, all’eroismo di un ragazzo che riscopre la guerra da dimostrazione di coraggio a spettacolo di miseria e desolazione, al cinismo di un anziano signore che vorrebbe soltanto trascorrere i suoi ultimi anni in pace.
Nel secondo libro, invece, ci ritroviamo in una piccola cittadina fuori Parigi, dove i tedeschi irrompono stabilendosi nelle case dei francesi e invadendo piccoli nidi di dispute e tenerezze familiari. E da questo incontro, c’è chi non può che odiare con tutte le sue forze quei nemici per rispetto dei propri cari combattenti e chi invece, incredulo, ritrova la sua medesima umanità negli occhi di quello che dovrebbe essere il nemico e che, invece, non è che un sofferente a sua volta poiché come dice Brecht in una sua poesia “Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente” perché nella guerra, aggiungo io, non ci sono vincitori o vinti, solo sofferenti.
Indicazioni utili
Il potere non è un mezzo, è un fine.
Indubbiamente una metafora ben riuscita, checché ne dicano i quattro editori che rifiutarono questo capolavoro ritenendolo non opportuno.
Quando l'uomo-tiranno viene cacciato, pare sia giunta la pace nella fattoria del patronato, ribattezzata fattoria degli animali, dove ogni animale, ora, lavora per il proprio bisogno e dà quanto gli è possibile, ricevendo il necessario. O almeno così pare, finché il necessario dei cavalli, delle pecore e delle galline diviene inspiegabilmente meno rispetto al necessario dei maiali, che per il loro servizio lodevole, necessitano più di altri, di qualche mela in più o del latte delle mucche.
Forse, proprio per la riuscita di questa incredibile metafora e la sua sconcertante verità che emerge dalla sola trama venne temuto, per la storia che si cela sotto ogni frase senza ombra di fraintendimenti.
L'uomo e il suo assetato desiderio di potere prendono la forma animalesca, propria di chi brama ad una libertà individuale, escludendo ogni collettività che mira al bene comune.
In un mondo dove l'io, incapace di percepire il proprio bene nella condivisione di un medesimo frutto, goduto dopo comuni sforzi, uccide, a proprio vantaggio, il noi.
Ma non possiamo meravigliarci del sorgere di un nuovo nemico, incredibilmente simile al primo poiché la bramosia ha un solo volto comune che si riconosce nell'eccesso e in un indivualismo che opprime l'altro annichilendolo.
E non dobbiamo nemmeno stupirci chiedendoci come si possa arrivare inconsapevolmente ad una situazione simile, in un mondo dove il valore della memoria si frantuma poiché anche un solo briciolo della storia, un solo dei 10 comandamenti della nuova fattoria, pagati con una dura rivoluzione, possono risvegliare quel sentimento di libertà e di comunità ormai dimenticato e solo il rammentarsi del passato in un presente deplorevole può far rinascere il desiderio di un nuovo futuro.
Consiglio di leggere la prefazione del romanzo stesso e, tra gli altri romanzi di Orwell, 1984 che riprende alcuni temi in un'altra chiave.
Buona lettura!
Indicazioni utili
L'amore? È’ una maledizione che piomba addosso.
A quale limite può un uomo assoggettarsi ad Amore? Svuotarsi di sé per lasciarsi impossessare da esso, cancellando ogni altra paura, ogni altra realtà se non quel tormento, quella maledizione che esso porta?
Questa è la storia di un uomo che l'amore fa riscoprire solo, mai cresciuto da un attimo di giovinezza mai gustato, alla ricerca di donne che possono solo intimorirlo, e può avere solo in superficie, nella loro carnalità.
E solo in Laida, nel suo malsano amore per la bella e sensuale Laide, si annida quell'amore che Antonio ha sempre desiderato e che non sa gestire, possessivo e intransigente ma anche umile e disposto a lasciare ogni dignità e amor proprio.
E a quale limite può una donna vendersi? Svuotare se stessa della sua libertà, sua stessa essenza, rinunciare a vivere per poter sopravvivere e racchiudere la sua poca vita in qualche lettera nascosta sul fondo di un armadio?
Questa è la storia di una donna che non ha altro destino se non quel presente a cui si adegua. Una donna amata per pochi piaceri effimeri e abbandonata per una migliore offerta, bramata da ogni uomo ma disdegnata e considerata inferiore da ognuno di essi.
Buzzati ci accompagna nel racconto attraverso il flusso di coscienza del protagonista che fa fremere il lettore, patteggiante ora per l'una ora per l'altra parte in un gioco senza vincitori né vinti, dove l'amore non è che una maledizione a cui non è possibile resistere.
Un libro che non pretende di raccontare l'amore ma semmai UN amore, con tutti i suoi indicibili
tormenti e i suoi vizi incurabili.
Consigliatissimo!
Indicazioni utili
Filosofando
Il libro si presenta come un viaggio nel corso della filosofia dalle sue origini fino ai giorni nostri, intervallato dall'enigmatica storia della giovane Sofia che, ricevute alcune lettere anonime, viene immersa, a sua insaputa, nel mondo della filosofia. E, inaspettatamente, sarà proprio la filosofia ad aprirle una nuova chiave interpretativa del suo mondo, non più superficiale e acritica ma consapevole e filtrata da un profondo senso critico.
Lo stile del libro è estremamente semplice e, senza pretendere di essere un manuale di filosofia, esso è sicuramente un buon mezzo per introdurre alla filosofia chi non l'ha mai studiata o anche rinfrescare la memoria a chi, ormai anni or sono, l'ha affrontata al liceo.
La storia è sicuramente intrigante e il libro, molto leggero.
Non nego, però, che nelle prime pagine la storia potrebbe sembrare banale, per poi essere sconvolta verso pagina 300 e diventare veramente coinvolgente.
Buona lettura!
Indicazioni utili
Penso che questa sera non penserò più
Un uomo. Un uomo qualsiasi, un anonimo. L'everyday man. Una madre, una moglie, una figlia e qualche ricordo sbiadito. Un crimine senza nome.
Questo, tutto ciò che basta per una condanna a morte.
Il primo Hugo, tanto giovane quanto agguerrito, attacca senza peli sulla lingua il boia, la ghigliottina, la pena di morte, cosciente del fatto che "Il castigo non deve punire per vendicarsi, deve correggere per migliorare".
Con lucidità Hugo si chiede come un uomo possa ergersi a regolatore della vita di un altro e decidere chi è degno di vivere e chi no sostituendosi a Dio poiché "Vendicarsi è dell'uomo, punire è di Dio".
Ma soprattutto, egli mette in discussione la figura del colpevole. L'assassino, a primo acchito terribile malvagio, non è altro che un uomo qualsiasi che trema di fronte alla morte e anela alla vita e, paradossalmente , egli è per Hugo un innocente "Che ignora la colpa del suo destino" poiché "Nessuno gli ha insegnato a sapere cosa faceva".
Si dispiegano nel corso del breve romanzo i disperati pensieri di un uomo in cui emerge la fragilità umana che spesso, con superficialità, si fatica a scorgere in tali figure.
Consiglio la lettura della prefazione alla quinta edizione (Marzo 1832) in cui Hugo contestualizza l'opera e mette in luce varie argomentazioni per perorare la sua causa.
Indicazioni utili
Noi non facciamo la cronaca, noi viviamo la Storia
Ogni libro cela una domanda; quelle di questo libro sono molte e ne ho amata ognuna:
La cultura ha un ruolo civile o è fine a se stessa?
È correlata al mondo o estemporanea?
Chi è l'intellettuale?
Cos'è l'anima? Ma soprattutto, è unica?
È preferibile vivere nel passato o forse nel presente?
Affascina di più la vita o la morte?
Non si può leggere questo libro e non innamorarsi della singolare figura di Pereira e del suo rispettivo opposto, Monteiro Rossi.
L'uno, anziano giornalista che, paradossalmente, ignora il presente e vive nel passato, amante di limonate e scrittori francesi, attirato dalla morte; l'altro, giovane laureato, fiducioso nel presente ed insito nella storia ma soprattutto amante della vita.
E come possono, due storie così diverse intrinsecarsi per dipendere l'una dall'altra?
Ma questo libro è anche critica ai regimi totalitari e un elogio a tutti coloro che hanno il coraggio di opporsi, di scrivere, senza remore, il proprio nome in basso a destra, alla fine di testi che parlano di verità.
Degno di nota è anche il brillante stile di Tabucchi, denso di melanconiche ripetizioni che immergono nella nostalgica figura di Pereira.
E voi? Cosa aspettate a scoprire cosa sostiene Pereira?
Indicazioni utili
La libertà è schiavitù.
Dove può portare il progresso umano? In che misura siamo liberi? Cosa definisce la nostra essenza di uomo? Abbiamo veramente allontanato il rischio dell'insorgere di una nuova dittatura?
Tra queste domande, vi sono sicuramente alcuni degli interrogativi posti da questo libro.
Insieme critica alle grandi dittature del passato e sentinella dei timori del presente, 1984, romanzo distopico per eccellenza, presenta un mondo futuro ove non vi è spazio per intimità o sentimentalismi, dove il passato è assoggettato al presente, oppresso dallo sguardo intimidatorio e onnipresente di Big Brother.
Winston Smith però sa, o almeno percepisce, che questo mondo non può essere l'unica alternativa possibile, che forse, in qualche angolo della memoria, vi sia stato un passato libero dalla dittatura del Partito e cova la timida e vana speranza che possa esserci un futuro differente, dove lui e la sua amata Julia possano amarsi lontani da occhi indiscreti.
Ma Winston sa soprattutto che la libertà è solo una ed è quella di poter dire che “due più due fa quattro” ed è per questa libertà che lotterà, con la morte già negli occhi, contro il Partito.
Orwell con questo romanzo ha creato un vero e proprio mondo, con tanto di coordinate geografiche e lingua, descritto con una minuzia tale da far interrogare il lettore sull'eredità dell'uomo dopo un secolo di violente dittature e sugli effetti di una tirannica tecnologia, che ci ha inconsciamente mutati.
Significativo è il fatto che, da una riflessione tanto ampia, sia nato un format televisivo tanto nauseante quanto “Il grande fratello”, la cui unica cura è, forse, proprio quella di leggere questo libro mentre Orwell, probabilmente, si rivolta nella tomba.
Indicazioni utili
"Mi aprivo alla tenera indifferenza del mondo"
Un libro a tratti difficile a leggersi, forse proprio perché difficile è vedere la realtà senza veli, come Mersault sa invece fare: una realtà incomprensibile, fatale, inspiegabile, ma essere uomo forse sta proprio nel riuscire a comprendere ed interiorizzare la totale indifferenza del mondo.
Mersault è un impiegato, apatico e dalle poche parole ma, più di questo, è un uomo che sa che la vita accade e basta, senza un perché. E senza un perché un giorno, Mersault uccide un arabo e da qui avrà inizio la sua inspiegabile fine.
Un libro illuminante! Suggerisco di leggere successivamente a "Lo straniero", "La peste", sempre di Camus che sviluppa e trova una risposta alla questione sorta ne "Lo straniero"
Indicazioni utili
Lode all'amicizia e non solo
Era tempo che non mi capitava eppure mi sono ritrovata a piangere come una disperata leggendo questo libretto carico di verità e di durezza velata, raccontato con una finezza estrema.
Amicizia, Storia e ingiustizia si intersecano. Un ciclone invade senza che se ne possano accorgere un'amicizia pura, sincera, limpida. La storia universale e umana, per non dire disumana, schiaccia la storia personale di due ragazzi così intrinsecamente uguali e così esteriormente diversi.
Un libro che racconta la storia vista non da lontano, come grandi avvenimenti definiti e determinati, ma da vicino, dagli occhi delle persone che hanno visto la loro vita ribaltata da un giorno all'altro, dagli occhi di chi non poteva nemmeno immaginare la crudeltà e la spietatezza del genere umano. Un libro che fa nascere la paura oggi, perchè la storia ricorda come l'uomo sbagli sempre e non impari mai dai suoi errori. Un libro che racconta quanto l'uomo sia cieco, perché il ciclone, che ci sembra tanto lontano, che ha travolto Konradin e Hans potrebbe colpire noi, oggi, sotto altre mille forme.
E se, per il suo tono tenue in contrasto con l'immensa tragedia del '900, "L'amico ritrovato" non passerà alla storia per il suo sfondo storico sarà sicuramente ricordato come la più vera e sincera storia d'amicia: di un'amicizia alta e degna, orgogliosa e sincera ma soprattutto che sa darsi in tutto e per tutto perché la vera amicizia è pronta a dare ogni cosa:
"Sono convinto che non si trattasse di un'esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto quasi con gioia".
Indicazioni utili
| 17 risultati - visualizzati 1 - 17 |