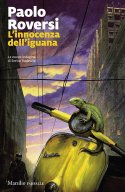Opinione scritta da Valerio91
| 447 risultati - visualizzati 1 - 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Humanity Row
Più si accumulano volumi nella biblioteca astratta delle proprie letture, più ci si rende conto che esistono diversi tipi di scrittori. Esistono quelli con una grande idea, che riesca a compensare alla mancanza di un’eccelsa qualità nella scrittura; esistono quelli eccelsi nella scrittura ma privi di idee e che dunque si attorcigliano su sé stessi… e tanti, tanti altri. Esistono, al vertice della piramide, quelli che accostano alla grandezza della propria scrittura una sensibilità fuori dal comune, una capacità di tirar fuori un racconto dal nulla o comunque da qualcosa che non ha niente di fantastico o eccezionale. Uno di questi è John Steinbeck, e “Vicolo Cannery” è proprio uno di questi romanzi.
Sì, perché in fondo questo romanzo non tratta altro che dei tipi umani che popolano una piccola stradina della città di Monterey, in California, che prende il suo nome da un conservificio di sardine e per questo motivo si chiama “Cannery Row”. Sebbene la quarta di copertina esordisca dicendo che “i suoi abitanti sono bagasce, ruffiani, giocatori e figli di mala femmina”, subito dopo corregge il tiro dicendo che guardando da un’altra prospettiva si sarebbe potuto dire che fossero “santi e angeli e martiri e uomini di Dio”; questo perché in fondo gli abitanti del Vicolo Cannery non sono nient’altro che esseri umani, coi propri lati oscuri ma che conservano in sé quel barlume di luce che alberga nell’animo di ognuno. Steinbeck dipinge questo quadro di umanità con una poeticità che mi ha ricordato un po’ “L’estate incantata” di Ray Bradbury, cercando di andare in profondità negli abissi dell’uomo non per metterne in risalto gli elementi torbidi ma quelli luminosi, che sono nascosti spesso altrettanto in profondità.
Elemento centrale del romanzo sono i personaggi, che potremmo considerare anche delle macchiette ma che proprio per questo motivo ci sembrano reali, sembrano assomigliarci e possedere pregi e difetti in cui ogni essere umano può identificarsi. Fulcro di questa piccola comunità sociale è il Dottore, uomo fuori dal comune che sembrerebbe solo dedito al lavoro al suo Istituto Biologico Occidentale, ma che è il piccolo centro umano intorno al quale ruota la vita di tutti i personaggi che popolano il Vicolo Cannery, compresa la banda di Mack e compagni, protagonista insieme a lui di questo racconto. Non è un caso, nonostante le sfortunate vicissitudini che li vedranno protagonisti, che queste due entità umane guardino l’una all’altra con rispetto e simpatia: Mack e compagni verso il Dottore come uomo colto e capace, come punto di riferimento, come uomo buono e comprensivo che è degno della più grande stima e considerazione, se non addirittura venerazione; il Dottore verso Mack e compagni come «i veri filosofi» e detentori del segreto della vita stessa, come testimonianze silenziose di come in realtà la vita andrebbe solo e soltanto goduta nelle sue piccole cose, senza affannarsi e procurandosi nei malanni nella ricerca di una scalata verso l’alto che non è altro che vanità.
In Vicolo Cannery non accade nulla di eclatante, come nella maggior parte dei libri migliori che ho letto nella mia vita. Steinbeck non ha bisogno di eventi fantastici o straordinari per stupirci, per farci riflettere. A lui basta conoscere l’uomo e mostrarcelo solo come lui sa fare.
Da leggere assolutamente.
“Mi è sempre sembrato strano. Le cose che ammiriamo negli uomini, la bontà, la generosità, la franchezza, l'onestà, la saggezza e la sensibilità, sono in noi elementi che portano alla rovina. E le caratteristiche che detestiamo, la furberia, la cupidigia, l'avarizia, la meschinità, l'egoismo, portano al successo. E mentre gli uomini ammirano le prime di queste qualità, amano il risultato delle seconde.”
Indicazioni utili
Angosciante
“Non lasciarmi” rappresenta il mio secondo approccio serio a Kazuo Ishiguro (“Crooner” è un racconto troppo breve per considerarlo tale) e devo dire che, per la seconda volta sono rimasto piacevolmente colpito. Occorre specificare che questo romanzo e l’altra opera da me letta, ovvero “Quel che resta del giorno”, sono due opere molto differenti. La loro differenza principale sta nel contesto raccontato: “Quel che resta del giorno” è strettamente ancorato alla Storia del Primo Dopoguerra e al contesto di una casa signorile inglese; “Non lasciarmi” crea invece una realtà alternativa distopica, nella quale i protagonisti sono cloni, cresciuti al preciso scopo di donare organi a esseri umani “normali”: in seguito si farà infatti riferimento a essi come ai “donatori”. È proprio a questo aspetto che è legato il motivo per il quale ho più apprezzato il romanzo: Ishiguro si rivela infatti capace di utilizzare anche espedienti narrativi fantastici o fantascientifici per raccontarci una storia che ha diverse cose da dire sulla natura umana, provando a staccare l’idea che una storia con elementi narrativi di tal sorta non possa veicolare messaggi interessanti e importanti. Certo, “Non lasciarmi” non è per me un capolavoro, perché pur suscitando una fortissima inquietudine per quello che è l’ineluttabile destino di questi ragazzi (soprattutto nell’angoscioso finale) non affronta il dilemma se non in un densissimo capitolo finale, lasciandoci intendere quanto possa essere egoista e codardo l’essere umano, che per il proprio tornaconto accetta e finge di non vedere le atrocità di cui si rende colpevole, capace di voltarsi dall’altra parte e far finta che ciò non esista. Questo libro è tuttavia un esempio di ciò che dicevo prima, e rende il Nobel vinto da Ishiguro probabilmente meritato (per il verdetto definitivo attendo di leggere altro): l’autore moderno non si pone limiti di genere, ma utilizza ciò che secondo lui meglio si adatta a trattare le tematiche su cui vuole focalizzarsi, senza limiti, e le differenze tra i due romanzi che ho citato in precedenza sono emblema di questa caratteristica dell’autore: questa poliedricità scevra di pregiudizi.
Tornando a quelli che sono i fatti narrati in “Non lasciarmi”, devo dire che un altro pregio è proprio quello di saper emozionare, di suscitare inquietudine nel lettore. Per suscitare questo tipo di emozioni, infatti, non basta raccontare fatti cupi e scabrosi, ma saperli presentare al lettore in maniera corretta, caratterizzando bene il contesto e creando dei personaggi in grado di esprimerlo al meglio. Probabilmente quella di raccontare la storia per mezzo della voce in prima persona di Kathy, la protagonista, è stata la scelta migliore, perché questo ci fa entrare appieno nel contesto descritto: che tra le mura di Hailsham (una sorta di scuola) è volutamente patinato ma che va scurendosi progressivamente, man mano che la verità (seppur possa essere avvertita fin dall’inizio) ci viene rivelata. Kathy, Ruth e Tommy sono personaggi ben sfaccettati, molto diversi tra loro, rappresentanti di approcci diversi a quella che è una vita (o, come lo chiamano loro, ciclo) il cui capolinea spaventoso è il medesimo per tutti e la cui speranza di sfuggirvi non è che un’illusione. Certo, pensandoci, questo è un po’ il destino di tutti gli esseri umani, ma Ishiguro è bravo a farci capire che non si tratta proprio della stessa cosa. I cloni sono infatti costretti a donare i propri organi nel fiore della loro vita, gli viene preclusa ogni possibilità di godere delle cose belle che la vita ci offre; l’amore, la realizzazione, sono qualcosa che i cloni non hanno il tempo di godere, stroncati prematuramente da un ciclo al quale sono assegnati dalla nascita e dal quale tentano vanamente di sottrarsi anche per breve tempo, coltivando speranze che in fondo al cuore sanno essere folli, ma sono come le nostre speranze di vita eterna, di vita oltre la morte.
Il finale è davvero un brutto colpo.
“Immagino che tu abbia ragione, Kath. Tu sei davvero una brava assistente. Saresti perfetta per me se non fossi tu. […] Continuo a pensare a un fiume da qualche parte là fuori, con l'acqua che scorre velocissima. E quelle due persone nell'acqua, che cercano di tenersi strette, piú che possono, ma alla fine devono desistere. La corrente è troppo forte. Devono mollare, separarsi. E la stessa cosa per noi. E un peccato, Kath, perché ci siamo amati per tutta la vita. Ma alla fine non possiamo rimanere insieme per sempre.”
Egli ha scrutato la vita e la morte
Una volta chiuso questo romanzo, è stato difficile per me farmene un’idea precisa. Non sapevo cosa pensare né cosa dire, e anche adesso ammetto che scriverne una recensione non è cosa semplice. La prima cosa che mi viene in mente è che “Il passeggero” non è assolutamente un romanzo facile: non è un romanzo da leggere sotto l’ombrellone, non è un romanzo da leggere se siete lettori occasionali o che si dilettano con gialli di poco conto o storie d’amore a lieto fine. E questo è in linea con tutta la produzione di Cormac McCarthy, forse uno degli ultimi autori davvero capaci di scendere a profondità che ormai gli uomini non vogliono più contemplare, perché sopraffatti dalla voglia di evadere dalle difficoltà, dai conflitti, dalla propria stessa natura. Nessuno dei romanzi di McCarthy è facile e nell’era delle “case di carta”, delle “amiche geniali” e dei commissari da quattro soldi, e a prescindere da questo il suo più grande paradosso è che pur essendo il mio autore preferito in assoluto è anche uno di quelli che non riesco mai a consigliare: per i motivi sopra citati e dunque per la mancanza di riscontro nel gusto delle masse e nella loro incapacità a poterne cogliere la grandezza, ma anche perché la sua opera è intrisa di un pessimismo apocalittico, di una crudezza spietata che si fa beffe degli stomaci dei deboli e delle paure dei pavidi. È incredibile dover rispondere alla domanda su quale sia il mio romanzo preferito (“Suttree”) e poi dover subito specificare che non sia proprio una lettura perfetta per cominciare a leggere l’autore, che magari è meglio cominciare con altro… ma cos’altro? con “Sunset Limited”, che pur nella sua meravigliosa bellezza e profondità può rivelarsi psicologicamente ed emotivamente devastante?
È anche qui che sta la grandezza di McCarthy, pace all’anima sua. La sua morte è stata un pugno nello stomaco, così come pensare che tutto ciò che abbiamo da leggere sarà tutto qui con l’uscita di “Stella Maris”, completamento di questo romanzo che ci restituisce un McCarthy puro, che né l’avanzare degli anni né l’approssimarsi della morte (che lui ha comunque sempre scrutato, senza paura, occhi negli occhi) hanno minimamente snaturato.
Seppure io abbia letto quasi tutta la sua opera, fare un’analisi di questo romanzo è un’opera mastodontica, il che suggerisce anche la fatica immane che ci sia voluta per poterla scrivere. Questo romanzo è forse uno dei più enigmatici che l’autore abbia mai scritto e che contiene in sé tante di quelle cose da lasciarci spaesati, abbandonati e vaganti all’interno di un incubo kafkiano. A cosa serve raccontare la trama di questo romanzo? Essa non è altro che un pretesto abbandonato dopo poche pagine. Un passeggero scomparso all’interno del relitto d’un aeroplano affondato nelle profondità del mare. Un incipit che fa nascere gli interrogativi succosi che tanto piacciono agli amanti dei thriller, che poi vengono brutalmente abbandonati forse proprio per farsi beffe di una generazione che riesce a concedere un po’ di tempo e concentrazione solo a storie di questo genere. Il vero passeggero è il nostro protagonista: Bobby Western, un uomo che attraversa inerme la propria vita, afflitto dal rimorso e dall’immagine di un passato che non può scrollarsi di dosso e che lo getta in un torpore senza rimedio, in una vita che non è altro che un trascinarsi da un luogo all’altro, senza stimoli di alcun tipo e che nemmeno un serio pericolo può scuotere dal suo torpore. Minacciato da figure governative che vogliono scoprire la verità sul passeggero scomparso, che fanno una vaga comparsata per poi trasformarsi in un’entità quasi metafisica, Bobby Western continua tuttavia a portare avanti la propria pseudo-vita come se nulla fosse accaduto, strisciando giorno dopo giorno nella propria grigia e piatta vita, senza lo straccio di un sogno, di un’ambizione, di un desiderio; semplicemente tormentato dal ricordo di una sorella morta, della quale era innamorato. Una ragazza di cui probabilmente approfondiremo la conoscenza in “Stella Maris” ma che già qui ci si presenta nel suo genio sregolato e nella sua follia schizofrenica.
Ancora una volta i punti di forza del romanzo di McCarthy risiedono nella sua scrittura e nelle riflessioni di cui i personaggi si fanno veicolo, rendendosi così epici, biblici, indimenticabili: in particolare Bobby Western ma soprattutto John Sheddan, i cui dialoghi col nostro protagonista sono talmente intrisi di filosofia e poesia da diventare attesi quanto lo svelamento dell’assassino in un romanzo giallo. Anche solo uno di questi dialoghi, che sono comunque intelligentemente per non dire avaramente dosati, vale il prezzo di questo libro e del tempo speso per leggerlo. John Sheddan è il veicolo del pensiero di McCarthy, di quella sua visione del mondo e delle cose che riesce a essere devastante e bellissima allo stesso tempo, dando vita a un paradosso che non si può spiegare, che ci permette di scrutare l’abisso e restarne terrorizzati e affascinati.
A volte temo di parlare con la lingua del cuore, la lingua di un uomo che da quest’autore è pienamente catturato; ma nonostante questo non posso negare i momenti in cui il romanzo non funziona, in cui si dilunga in brani di eccessiva difficoltà che potrebbero scoraggiare chiunque. A volte credo che questi siano delle prove che McCarthy semina qua e là per testare la nostra perseveranza, per mettere alla prova il nostro valore e capire se siamo degni di assistere a quanto di bello può creare con la sua profondità di pensiero e con la bellezza delle sue parole. Come se fosse un modo di non rendere questa bellezza accessibile a tutti ma solo a quelli che la meritano, così che non perda valore. Ne “Il passeggero” ci sono la vita e la morte; c’è il nostro passato, c’è il nostro mondo contemporaneo e c’è forse un pezzetto del nostro cupo futuro; c’è un nichilismo senza soluzione ma anche quella fievole speranza, che McCarthy spesso ha oggettivizzato nelle forma d’una fiamma: quella che porta il bambino ne “La strada”; quella che in “Non è un paese per vecchi” è portata dal padre dello sceriffo Bell nel suo sogno, quella che ha il colore della luna. Qui la fiamma si trasforma e con essa la speranza, che prende le forme degli occhi d'una persona amata.
Io non so dare un giudizio definitivo su questo libro, e come tutti gli altri romanzi di McCarthy non sono in grado di consigliarlo. Trovo tuttavia assurdo oltre ogni immaginazione che uno scrittore del genere non abbia vinto il premio Nobel, che meriterebbe anche soltanto per la sua scrittura che nonostante la propria grandezza non è che è una goccia nel mare delle qualità di quest’autore incredibile, che speriamo il mondo non dimentichi mai. Anche se, guardandomi intorno, temo possa essere trascinato nell’oblio della nostra ignoranza. Speriamo davvero che non sia così, e se lo fosse, McCarthy avrebbe comunque avuto ragione nel dire che la letteratura non sopravvivrà a lungo, così come l'uomo. A noi il compito di smentirlo.
“Penso che sia perché la gente sta morendo di noia. E la cosa potrebbe perfino avere un che di contagioso. Di certo ci sono mattine in cui mi sveglio e il mondo mi sembra di un grigio che prima non era cosí evidente, mi pare. È un discorso che abbiamo già fatto. Lo so. Gli orrori del passato perdono incisività, e cosí facendo ci rendono ciechi di fronte a un mondo che procede sbandando verso un'oscurità oltre le piú amare speculazioni. E sicuramente interessante. Quando l'insorgere della notte universale sarà finalmente riconosciuto come irreversibile anche il cinico piú indifferente rimarrà strabiliato dalla rapidità con cui ogni regola e restrizione che puntella questo edificio scricchiolante verrà abbandonata a favore di ogni tipo di aberrazione. Sarà sicuramente uno spettacolo notevole. Per quanto breve.”
Un rapporto complicato
Un racconto breve e che riesce a essere incisivo pur non raccontando fatti straordinari, ma mettendo in risalto come ogni gesto, ogni parola o sguardo possono avere un grosso peso nella vita delle persone che ci sono vicine.
Probabilmente in parte ispirato all’esperienza personale dell’autrice, questo breve libro racconta uno stralcio della vita giovanile di Antoinette, ragazzina adolescente che appartiene a una famiglia di parvenu, arricchitisi di recente e che decidono di fare il proprio ingresso trionfale nella società che conta organizzando un ballo.
La Nemirovsky ci descrive nei dettagli l’esagerato sfarzo di cui i coniugi Kampf si sono circondati, ma quel che emerge più di tutto è il quadro familiare tempestato di problemi il cui fulcro risiede nella figura della madre, Rosine. Donna inizialmente appartenente a un ceto molto umile, si dimostra fin dal principio come una donna che prova a darsi un tono, a vestire i panni della donna nobile e austera, dimostrando un’ossessione per le apparenze che fin dalle prime battute rasenta il ridicolo e l’irritante. La povera Antoinette è succube di questa donna priva di qualsiasi istinto materno e che, visto che si rivela incapace di far valere la propria posizione con le persone che contano, decide tiranneggiare su questa povera ragazzina che dimostrerà, ovviamente, un carattere represso.
Non si può che provare tenerezza per la protagonista, sebbene si renda colpevole di un’azione non esattamente benevola. Il modo in cui la madre si rivolge a lei, con continui e aspri rimproveri, senza concederle nemmeno una piccola e futile gioia né tantomeno dimostrandogli un qualsivoglia tipo di affetto, è abbastanza da giustificare una crescita problematica e anche un certo tipo di nevrosi.
Sebbene non credo sia il racconto perfetto, così come viene definito, “Il ballo” è comunque un gran bel racconto, il cui punto di svolta è di una semplicità disarmante eppure capace di sconvolgere la mente del lettore, che si interrogherà fino alla fine sulle possibili conseguenze delle azioni di Antoinette.
Come prima esperienza con l’autrice, direi possa definirsi ottima.ù
“Un ballo... Mio Dio, mio Dio, era mai possibile che lì, a due passi da lei, ci fosse quella cosa splendida, che lei si immaginava vagamente come un insieme confuso di musica sfrenata, di profumi inebrianti, di abiti spettacolosi... Di parole d'amore bisbigliate in un salottino appartato, oscuro e fresco come un'alcova... E che quella sera venisse messa a letto, come tutte le sere, alle nove, quasi fosse un bebè […] Eppure cosa le costava che Antoinette, anche Antoinette, avesse la sua parte di felicità su questa terra?”
Indicazioni utili
Sorprendente
“Sostiene Pereira” è uno di quei romanzi che ti orbitano intorno, che ti trovi così spesso davanti agli occhi da dire a te stesso che dovresti leggerlo, prima o poi, ma per qualche motivo finisci sempre per rimandare. Ma poi finalmente il momento arriva e, nel caso di Tabucchi, è stato una vera e propria rivelazione.
“Sostiene Pereira” è un romanzo bellissimo, che spicca su tanti altri per diversi motivi. In primis per lo stile che, seppur particolare e non semplicissimo (in certi tratti ricorda un po’ quello di Saramago, soprattutto per la gestione dei dialoghi e la scrittura “corposa”), è molto ben strutturato e si adatta perfettamente alla narrazione, ruotando intorno a Pereira e aiutandoci a percepirne i cambiamenti in maniera sensibile. È oltretutto uno stile che, se letto ad alta voce, si presenta ritmato e musicale, oltre che chiaro; vi consiglio infatti di ascoltare la versione in audiolibro letta da Sergio Rubini, davvero molto bella.
Considerazioni stilistiche a parte, “Sostiene Pereira” è un opera pregna di significato, che porta a riflessioni di diverso genere e inquadra molti dei diversi tipi d’uomo che emergono nel periodo dell’affermazione dei movimenti nazionalisti, poco prima dell’esplosione della catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Tabucchi è molto abile nel delineare tantissimi tipi di personalità proprie dell’epoca, e la sua maestria sta nel farlo anche con delle brevissime apparizioni: basti pensare a personaggi come Padre Antonio, classico appartenente al clero che non condivide le idee del Vaticano ma non osa opporsi all’autorità; il direttore del Lisboa e capo di Pereira, classico galoppino delle alte sfere ormai completamente assoggettato e influenzato dalla violenza dei suoi superiori, senza scrupoli, arrogante. Questi personaggi bucano le pagine e, in fin dei conti, non appaiono che per una o due scene. E se Tabucchi riesce a creare personaggi così interessanti in breve tempo, potrete immaginare quanto siano approfonditi e interessanti i protagonisti, in particolare il dottor Cardoso e Pereira, veri cardini su cui ruota tutta la storia.
Pereira è il prototipo dell’uomo che vive nella propria bolla, che si adagia sulle proprie convinzioni di una vita e non riesce a rendersi conto che il mondo intorno a lui sta cambiando, almeno fino a quando il mondo non lo prende a schiaffi costringendolo a una presa di coscienza, all’emergere prepotente di una delle anime della sua confederazione, che come gli dice il dottor Cardoso, smania per diventare il suo io egemone, la sua personalità portante, contro la quale non può nulla. Deve elaborare il lutto, Pereira, deve lasciarsi il passato alle spalle pur non dimenticando, così da far fronte a un mondo che sta cambiando, in peggio.
Una gradita sorpresa.
“E a quel punto a Pereira venne in mente una frase che gli diceva sempre suo zio, che era un letterato fallito, e la pronunciò. Disse: la filosofia sembra che si occupi solo della verità, ma forse dice solo fantasie, e la letteratura sembra che si occupi solo di fantasie, ma forse dice la verità. Monteiro Rossi sorrise e disse che gli sembrava una bella definizione per le due discipline.”
Indicazioni utili
Breve ma devastante
Questo di Vasilij Grossman è un reportage molto breve ma psicologicamente devastante, incentrato su quello che era uno dei tanti campi di sterminio nazisti, in Polonia. La nascita, la “crescita” e la fine di questo campo viene efficacemente descritta da Grossman con uno stile calmo ma brutale, senza risparmiarsi in alcun modo perché: «[…] chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Chiunque giri le spalle, chiuda gli occhi o passi oltre offende la memoria dei caduti». E questo è assolutamente vero: così come è importante leggerne, altrettanto importante sarebbe vedere coi propri occhi ciò che resta di queste “fabbriche della morte”, che seppur mantenendo solo un minimo dell’impressione che davano quando erano in attività, dovrebbero scuoterci e farci pensare, così da non permettere che simili bestie possano nuovamente accalappiarci con la loro retorica e i loro discorsi, i quali nascondono brutalità e devastazione, crudeltà e disumanità. Essi si reputavano più umani dell’umano, quando non erano null’altro che bestie. Grossman riesce a dipingere quelli che erano i momenti della deportazione, della separazione dai propri cari, dell’annullamento del sé prima da un punto di vista legale e mentale, e infine corporale. Leggere tra queste pagine delle malefatte tedesche (che attenzione, non vanno inquadrati come un popolo diabolico in toto) è sconcertante, ed è sconcertante soprattutto vedere come queste malefatte non generassero neanche un minimo di rimorso, anzi, permetteva a questi animali di tornarsene a casa a testa alta, convinti di aver fatto ciò per cui erano venuti al mondo. E chi parla di semplici fantocci che eseguivano degli ordini, beh, questo non sembra vero in tutti i casi: che dire dei sadici giochi perpetrati ai danni anche di donne e bambini, costretti a vedere altri poveri derelitti mentre vanno incontro alla propria crudele fine, lasciando loro la consapevolezza che una medesima li avrebbe attesi di lì a poco?
Brutale.
Questo libro andrebbe letto da tutti, bisogna rendersi realmente conto di quello di cui siamo stati capaci. Oltre ciò, cercavo un incentivo al mio proposito di approfondire l’autore con “Stalingrado” e gli altri suoi lavori. Direi che l’ho trovato.
“Che grande cosa è il dono dell'umanità! Un dono che non muore finché non muore l'uomo. E se anche sopraggiunge un'epoca storica breve ma tremenda in cui la bestia ha la meglio sull'uomo, l'uomo ucciso dalla bestia conserva comunque fino all'ultimo suo respiro forza d'animo, mente lucida e cuore ardente. Mentre la bestia trionfante che lo uccide resta comunque una bestia. Nell'immortalità dello spirito umano è insito un cupo martirio, trionfo - però - dell'uomo che muore sulla bestia che vive.”
L'ispirazione di tanti grandi autori
Sherwood Anderson e questa raccolta in particolare, sono considerati come l'inizio della letteratura americana moderna. E' infatti molto forbita la schiera di autori americani che si sperticano in complimenti e dicano di aver tratto grande ispirazione da questo autore, perlopiù sconosciuto dalle nostre parti. Qualcuno dei lettori di QLibri sarà a conoscenza della mia avversione per le marchette, ma forse quello di Sherwood Anderson è un caso particolare: non si tratta infatti di un best-seller ma di un romanzo fondamentalmente di nicchia, che non ha alte pretese di vendita né tantomeno deve essere spinto in qualche modo. Oltre ciò, se proprio non vogliamo scomodare gli autori le cui citazioni sono inserite in quarta di copertina (che comunque sono autori del calibro di Bukowski e in particolare Faulkner), posso dirvi che sono arrivato alla lettura per mezzo di un altro autore statunitense che in quest'edizione non è nemmeno citato: Ray Bradbury. Diciamo che, dunque, si può avere maggiore fiducia su quello che è l'effettivo apprezzamento da parte di alcuni grandi della letteratura nei confronti di Anderson. Quello che probabilmente ha ispirato di più questi autori è il modo in cui Anderson, in "Winesburg, Ohio", è stato in grado di raccontare un paese per mezzo dei suoi abitanti, dipingendo un ristretto contesto americano nelle sue peculiarità e facendone emergere i tipi umani caratteristici. Per chi conosce la letteratura statunitense, si renderà conto di quanto è peculiare questo modus operandi e di quanto quindi questa letteratura debba ad Anderson, a prescindere dalla bellezza dell'opera in sé. "Winesburg, Ohio" infatti cela gran parte del suo valore proprio in questo suo essere un apripista, al suo essere un modello per romanzi successivi che si riveleranno dei veri e propri capolavori: pensando a Bradbury stesso, non si può fare a meno di pensare che il suo "L'estate incantata" si ispiri fortemente alla struttura di quest'opera, scegliendo di dipingere la sua Green Town proprio come Anderson dipinge la sua Winesburg. C'è da dire, però, che il risultato prodotto da Bradbury raggiunge delle vette di poesia che Anderson non può lontanamente sognare, ma forse senza il suo lavoro non avremmo un tale capolavoro così come diversi altri (come ad esempio L'Antologia di Spoon River, che molti accostano a questo romanzo sebbene si tratti di un'opera poetica).
Quelli raccolti in "Winesburg, Ohio" possono essere considerati tanti piccoli racconti strettamente correlati tra loro, legati da un filo rappresentato dalla città di Winesburg e da alcuni suoi personaggi, in particolare il giovane cronista George Willard. George è il centro intorno al quale ruotano molte delle vite della cittadina, forse perché rappresenta quella necessità di evolversi e adattarsi al cambiamento ormai penetrata nello spirito di un luogo ancora ancorato a un passato ormai obsoleto. Non sarà un caso, infatti, che molti dei personaggi si decidano ad abbandonare le proprie radici e vedranno nell'allontanamento dalla patria un modo per trovare davvero sé stessi, per evolversi. Lo stesso George Willard, nonostante l'amore che prova per una giovane ragazza, sarà in grado di rinunciare a quest'impeto, a questa volontà di crescere e trovare un proprio posto nel mondo; un mondo che ha ormai esteso i propri confini oltre Winesburg, simbolo dei limiti e delle convenzioni di una società che ormai ha fatto il suo tempo, dalle quali i personaggi di questo affresco cercano disperatamente di fuggire, spesso senza riuscirci.
Nonostante non sia un capolavoro di bellezza, "Winesburg, Ohio" è comunque una lettura apprezzabile sia per l'influenza che ha avuto, sia per degli slanci di bellezza sparsi qua e là. Considerata la piacevolezza e la facilità di lettura, può valere la pena di dargli un'occasione.
“La mente del giovane era trascinata via dalla sua crescente passione per i sogni. A guardarlo non aveva l'aria molto in gamba. Mentre il ricordo di quelle piccole cose gli occupava la mente, chiuse gli occhi e si appoggiò allo schienale. Rimase a lungo cosí e quando si mosse, e tornò a guardare dal finestrino, il paese di Winesburg era scomparso, e tutta la sua vita in quel luogo era diventata nient' altro che uno sfondo per dipingervi sopra i sogni della sua gioventù.”
Forzato e banalotto
Piergiorgio Pulixi è uno di quegli autori che mi hanno sempre incuriosito, considerato il suo discreto successo, e di cui mi ero prefisso prima o poi di leggere qualcosa. Quel momento è arrivato e, tuttavia, la sensazione è che mi ha dato questa lettura non è delle migliori. È sicuramente un libro che si lascia leggere, che mettendosi d’impegno si potrebbe finire anche in un giorno, ma… ci sono diverse pecche che non mi sento di ignorare.
Voglio partire, come sempre, dallo stile: come ho detto la prosa di Pulixi si lascia leggere con facilità, ma a questa fluidità si accompagnano spesso delle banalità quasi da principiante, delle frasi stereotipate che sanno di scrittore esordiente. È proprio questa la sensazione che si avverte nel corso di tutto il romanzo: di avere a che fare con l’opera prima di un autore, di quelle produzioni giovanili che si rileggono dopo anni e fanno sorridere per ingenuità e inesperienza. E questo non riguarda solo lo stile, ma anche lo scarso peso che viene dato agli eventi e alle relazioni interpersonali tra i personaggi: manca tutto di profondità, di sfumature, a volte anche di senso; come se i personaggi fossero costretti ad essere bidimensionali pur di rispettare il ruolo che l’autore gli ha affidato, senza lasciare spazio alla complessità. Giusto per fare un esempio sul protagonista, Marzio Montecristo, l’autore ha deciso che debba essere a tutti i costi un uomo burbero con gli adulti e con i clienti (è proprietario di una libreria) e dunque li manda indiscriminatamente tutti a quel paese, come se fosse qualcosa di inevitabile e matematico, al preciso scopo di strappare una risata al lettore. Qualche volta ci riesce, ma spesso si avverte la forzatura, si capisce quanto Pulixi sacrifichi la credibilità del personaggio al suo scopo comico. E questo non è piacevole né limitato al solo protagonista.
Sebbene l’idea di un gruppo di lettura a tema gialli che si trasformi in una piccola squadra investigativa sia molto carina, l’ho trovata poco sviluppata. Difatti, considerate le conclusioni alle quali giunge il gruppo, anche un uomo normale con un po’ di sale in zucca avrebbe potuto avere le stesse intuizioni, gettando un’ombra sulle capacità investigative della polizia.
La trama è davvero molto semplice e sorge più di qualche dubbio riguardo ai moventi, dell’assassino e non. Evito di dire altro per evitare spoiler, ma se leggerete il romanzo capirete. Oltre ciò, il problema continua a essere il peso: quando l’assassino viene scovato, viene trattato con i guanti e quasi com benevolenza. Va bene i traumi, va bene le ingiustizie, ma questo tizio ha ucciso a sangue freddo diverse persone: possibile che nessuno si spaventi o ne sia in qualche modo disgustato? È tutto troppo buttato lì, senza un barlume di complessità, né nell’intreccio né nella psicologia dei personaggi.
Penso che oltre a qualche buona idea (che come ho già detto è però poco sviluppata) e al fatto che si legga davvero in pochissimo tempo, si fatichino a trovare altri pregi a questo giallo; che consiglio solo agli amanti del genere che hanno come unica pretesa quella di passare un pomeriggio a leggere.
Waiting for God-ot
Samuel Beckett è uno di quegli autori la cui produzione può lasciare spiazzati, e il suo "Aspettando Godot" non è certo da meno, oltre ad essere la sua opera più conosciuta. Riguardo alla rappresentazione scenica non so esprimermi (sebbene voglia al più presto vederne una), ma immagino che l'impressione disorientante generata dal testo aumenti in maniera esponenziale, tanto che risulta difficile capire cosa abbia generato a suo tempo un successo così clamoroso. Certo, parliamo del Teatro dell'Assurdo, ma le battute scambiate tra Vladimiro ed Estragone lasciano per la maggior parte del tempo perplessi e, in fondo, tutto quel che leggiamo ruota intorno a null'altro che alla fantomatica attesa di questo figuro del quale conosciamo solo il nome: Godot.
E' probabilmente la pluralità di interpretazioni che affascina e mette in moto il cervello degli spettatori, e l'impossibilità di centrarne una in particolare lascia lo spettatore-lettore in un vortice di perplessità; una perplessità particolarmente concentrata sulla figura di Godot. Viene da chiedersi: possibile che lo stesso Beckett non sapesse dargli un'identità? o è semplicemente un modo dell'autore di alimentare il suo stesso mistero? Forse "Aspettando Godot" è una di quelle opere per le quali il lettore deve solo accontentarsi della propria interpretazione. C'è tuttavia un aspetto che porta a riflettere: come mai Beckett, parlando di Godot, ha detto di non sapere chi sia ma di sapere per certo che non sia la personificazione di Dio? Ho l'impressione che la sua sia una negazione che sa di affermazione, sempre nel tentativo di allontanare i suoi spettatori da un'interpretazione definitiva. Indipendentemente dai richiami stessi presenti nel nome (God significa Dio in inglese), è impossibile non identificare nell'attesa dei due vagabondi un'attesa della venuta del Signore, della sua salvezza, della rivelazione del senso ultimo di una vita ormai vuota e particolarmente cupa, che emerge come visione beckettiana prevalente della società e del mondo contemporaneo.
Le figure di Pozzo e di Lucky sono una forte accusa alle ingiustizie causate dalla prevalenza del modello di società capitalistica, è tuttavia evidente che la sfiducia di Beckett nella vita vada oltre i sistemi che dominano il mondo, perché allo sparire dei due personaggi l'assurdità della vita e dell'attesa non scompaiono, si fanno anzi più intense non avendo nulla con cui tenersi occupati, diventando soltanto un'attesa vacua di qualcosa che, in fondo al cuore, si sa non arriverà mai. L'uomo (rappresentato da Vladimiro ed Estragone) non è tuttavia capace di smettere di attendere: vorrebbe farlo, vorrebbe finalmente ammettere a sé stesso quanto la sua presenza nel mondo sia priva di senso e priva di speranza, ma non è in grado di farlo. Vorrebbe agire, ma cosa mai dovrebbe fare? Vorrebbe andarsene, ma dove?
Non resta altro da fare che continuare ad attendere, sperando che la compagnia di altri sfortunati nostri simili possa alleviare il percorso di questa vita vuota verso il proprio esaurimento. Questo, ovviamente, nella visione pessimistica del mondo dipinta dall'autore irlandese. Condivisibile o meno che sia, è innegabile che il fascino di questa rappresentazione sia il prodotto di un autore geniale.
POZZO: “Non piange piú. (A Estragone) In un certo senso, l'ha sostituito lei. (Pensieroso) Le lacrime del mondo sono immutabili. Non appena qualcuno si mette a piangere, un altro, chi sa dove, smette. E cosí per il riso. (Ride) Non diciamo troppo male, perciò, della nostra epoca; non è piú disgraziata delle precedenti. Ma non diciamone neanche troppo bene. (Pausa). Non parliamone affatto. È vero, però, che la popolazione è aumentata.”
Anelito alla verità
Kafka non si smentisce mai, e soprattutto in alcune delle sue opere emerge il suo punto di vista estremamente surreale sulla realtà, che per quanto mi riguarda è un elemento piuttosto determinante nell'apprezzamento dei suoi lavori da parte del lettore. I racconti brevi sono forse, da questo punto di vista, le opere più emblematiche, ma anche "Il Castello" ne è un esempio lampante.
Anche qui, come ne "Il processo" e ne "La metamorfosi" ci troviamo di fronte a un intreccio surreale che ha come protagonista K., un uomo che si ritrova presso un villaggio al centro del quale si trova il Castello, edificazione la cui assenza di grazia estetica (non aspettatevi infatti il Castello di Praga) è probabilmente riflesso dell'influenza ossessiva che esso esercita sulla vita e sulla psiche degli abitanti del villaggio. Il Castello infatti è dimora della fervida attività politica e amministrativa del luogo, un'attività di cui tuttavia non verremo a sapere nulla se non tramite racconti di terzi. Il Castello e i suoi appartenenti sono entità percepite come quasi divine, irraggiungibili, parte di un ingranaggio perfetto il cui effettivo compito, tuttavia, non è chiaro.
E' proprio su questo paradosso che girano il romanzo e le conseguenti domande del lettore: cosa determina questa venerazione nei confronti del Castello e delle sue figure eminenti? Non è per niente chiaro e non è detto che Kafka volesse esserlo, anzi, è come se la considerazione ossessiva e la fama del Castello e dei suoi appartenenti, in particolare Klamm, venga alimentata dall'ossessione stessa che gli abitanti hanno per esso, e da questa ossessione viene presto contagiato anche lo stesso K. All'inizio del racconto, prima di entrare nelle dinamiche malate di questo villaggio, K. sembra condividere un po' le perplessità dello stesso lettore, ma non ci vorrà molto prima che questa realtà lo coinvolga e lo porti a comportarsi così come fanno gli altri abitanti del villaggio, con questo desiderio spasmodico di ottenere un contatto col Castello, la cui desiderabilità resta sempre un mistero per il lettore. L'amministrazione tanto osannata è infatti di una farraginosità spaventosa che viene tuttavia paradossalmente esaltata, che tiene impegnato un numero di persone che appare spropositato ma la cui mole non può essere accertata perché di questo meccanismo non vedremo nemmeno la superficie, ma solo i racconti di quei pochi che hanno avuto "l'onore" di varcare le soglie di quest'entità quasi soprannaturale. K. passerà tutto il tempo della narrazione a cercare di aprirsi una strada verso di essa, di effettuare una scalata della quale faremo tuttavia fatica a capire le motivazioni.
Non negherò che questa ricerca ossessiva da parte di K., la profusione di dettagli e la ripetizione ossessiva di concetti in certi momenti diventa pesante, sebbene questo tipo di narrazione è chiaro abbia l'intento di creare un'atmosfera e una vicenda, ovviamente, kafkiane.
Il manoscritto non è completo, e difatti si interrompe bruscamente nel bel mezzo di un periodo, ma sembra che nell'intento dell'autore gli sforzi perpetrati da K. siano destinati a sfinirlo fino a portarlo alla morte, senza aver conseguito alcun tipo di risultato. Altro elemento centrale di questo romanzo, infatti, è la vanità degli sforzi umani volti al miglioramento della propria posizione; l'anelito continuo a una realtà superiore ma che in realtà è solo edulcorata, immeritatamente esaltata, che rende frustrati con la propria irraggiungibilità e, nei rari casi in cui venga raggiunta, comunque non garantisce realizzazione e soddisfazione.
La pluralità d'interpretazione dell'opera kafkiana si conferma anche in questo romanzo, che tuttavia non è di facile lettura e in certi momenti mette a dura prova il lettore col proprio surrealismo, con la propria cripticità e con la profusione di dettagli e ripetizioni. Beh, ora sapete a cosa andate incontro ma parlando di Kafka, probabilmente lo sapevate già.
"[...] si vedeva soltanto il suo sorriso, ma non giovava a nulla, come le stelle lassù in cielo non giovano contro la bufera che infuria quaggiù."
Vade retro!
Le collaborazioni sono qualcosa che mi fa sempre storcere un po’ il naso: come faccio a capire chi ha scritto cosa? Come riescono più persone ad adattarsi l’uno allo stile dell’altro senza snaturarsi? Quando poi queste collaborazioni vengono fatte tra padri e figli (come ha fatto a suo tempo anche Stephen King) la mia perplessità si tramuta in un principio di ostilità, a causa del nepotismo latente in quella produzione. Devo dire che, purtroppo, “Non aprite quella morta” di Joe e Kasey Lansdale non ha smentito questa mia impressione, anzi, devo dire che l’ha rafforzata ulteriormente.
Occorre fare un chiarimento sulla struttura di questo libro: è una raccolta di racconti soprannaturali, la prima metà scritta da Joe R. Lansdale e con protagonista l’investigratice del “sopranormale” - sorvolerò sui milioni di volte in cui si spiega questo concetto, rendendolo noioso, quasi irritante, e inoltre con poco senso considerati i fatti raccontati - e l’altra metà con la collaborazione della figlia Kasey Lansdale che introduce il suo personaggio, Jana, che diventa la “Watson” della Dana “Holmes” di Joe. Inutile dire che dei due grandi investigatori, questi due personaggi non hanno un bel niente. Mentre i racconti di Joe Lansdale, quantomeno, possono anche intrattenere grazie al suo stile comunque coinvolgente e accurato, che crea delle immagini precise ed evocative delle vicende raccontate, i racconti in cui subentra la collaborazione di Kasey sono di qualità sensibilmente inferiore: uno stile a tratti quasi elementare, con dialoghi semplicistici e a volte quasi ridicoli, da scrittore più che novellino. Credo proprio che questi ultimi racconti non siano stati scritti in collaborazione, ma soltanto dalla penna di Kasey Lansdale… e si vede.
Oltre a questo, c’è un altro problema. Io non sono una persona che parte con dei pregiudizi di genere, dunque, pur non amando questo genere di storie mi sono cimentato in questa lettura. Come ben sapete penso che un’opera, pur appartenendo a un preciso genere, se scritta in un certo modo e con determinati contenuti possa essere degna di essere letta da chiunque e apprezzabile per i suoi contenuti che vanno oltre la trama raccontata. Non è questo il caso, purtroppo: “Non aprite quella morta” è una raccolta di racconti senza nulla a pretendere a livello letterario, che può (forse) intrattenere gli amanti del genere e poco più. La struttura dei racconti si ripete e viene riproposta in salse diverse, con avversari e contesti diversi, ma in fondo è sempre lo stesso modus operandi ripetuto nella maggior parte delle storie (se non tutte).
E niente, aspetto il prossimo libro di Lansdale, sperando che si tratti di qualcosa che contenga in sé un qualche tipo di ambizione letteraria, visto e considerato che in passato questo scrittore se ne è rivelato più che capace (per esempio con “Paradise Sky”). E, possibilmente, qualcosa scritto solo dalle sue mani; cosa ormai per nulla scontata.
P.S. Il voto allo stile è una media tra quello dei due scrittori: 4 a Joe, 2 a Kasey.
Chandler è un fuoriclasse di stile
Immagino che al terzo romanzo letto di un autore, si possa affermare se rientri nella schiera dei preferiti o meno. Bene, sono lieto di augurare il benvenuto a Raymond Chandler nella suddetta schiera, così come a Philip Marlowe tra i detective più affascinanti (se non il più affascinante) del panorama letterario e non solo. “Il lungo addio” è un romanzo che, posso dire, attendevo con ansia: era da mesi infatti che mi chiedevo quando Adelphi avrebbe (ri)pubblicato una delle indagini di Marlowe, mentre dentro di me temevo che, magari per uno scarso successo di pubblico, ciò non sarebbe accaduto. Per fortuna questo romanzo è arrivato in libreria e a questo punto, spero, sarà parte della ripubblicazione integrale dell’opera di Chandler.
Riguardo al fascino di Marlowe come personaggio, credo di essermi già espresso nelle recensioni de “Il grande sonno” e di “Addio, mia amata”: buca le pagine con la sua durezza, con la quale prova a camuffare una profonda umanità, che in un mondo “nero” come quello descritto sarebbe facilmente fagocitata da personaggi privi di ogni scrupolo. Certo, non mancano i tratti un po’ stereotipati (sebbene, secondo me, attutiti dal fatto che è stato lo stesso Marlowe, probabilmente, a creare questo stereotipo), ma il tutto è compensato da un’eccellente caratterizzazione e dall’estrema facilità con cui si empatizza col protagonista.
Ma il vero punto di forza di questo romanzo, come degli altri, è lo stile: meraviglioso, poetico, evocativo, e trovare uno stile così bello in un romanzo che nel suo essere di genere porta molti lettori superficiali a sminuirne il valore non fa altro che avvalorare la mia tesi: l’appartenenza a un genere letterario ben preciso e magari principalmente di consumo non intacca il potenziale letterario di un’opera! Ormai questa è la mia crociata e Chandler (così come Bradbury), ne è uno degli esempi cardine. La letteratura di genere è piena di spazzatura, ma lo è anche la letteratura non di genere; bisogna saper cercare.
Dopo questa piccola divagazione, va detto che Chandler non eccelleva tuttavia riguardo alla creazione di trame eccezionalmente originali: in quanto a eventi, infatti, “Il lungo addio” così come i suoi predecessori sono noir classici senza particolarità eccezionali, ma come dicevo la differenza la fanno lo stile e i personaggi, che rendono tutto vivo, coinvolgente, evocativo. Certo non mancano i colpi di scena, ma non sono cose da spaccarsi la mascella e secondo me, è meglio così. Un paradosso, penserete, e invece no: un’altra peculiarità dei romanzi di Chandler è proprio il fluire della storia, che procede come un fiume torbido ma placido, col suo ritmo compassato, in cui gli eventi procedono senza sconvolgere ma ci rapiscono, ci costringono a osservarli con attenzione, a riflettere.
È davvero una cosa difficile da spiegare, dunque non posso che pregarvi di leggere questo romanzo o quantomeno “Il grande sonno”. Parliamo di quanto di meglio il noir e il giallo hanno da offrire, credetemi.
P.S. Non vi ho parlato della trama, ma credo davvero non ce ne sia bisogno: la bellezza di questo libro sta in tutto il resto.
“Sono un romantico, Bernie. Sento delle voci che piangono di notte e corro a vedere cosa succede. Non si guadagna un soldo, così. Se hai un po' di buonsenso, chiudi le finestre e alzi il volume del televisore. O metti il piede sull'acceleratore e te ne vai il più lontano possibile. Meglio stare alla larga dai guai altrui: se ne ricava solo fango. L'ultima volta che ho visto Terry Lennox ci siamo bevuti una tazza di caffè che ho preparato io, a casa mia, e ci siamo fumati una sigaretta. Perciò, quando ho saputo che era morto, sono andato in cucina, mi sono fatto un caffè, ne ho versata una tazza anche per lui e gli ho acceso una sigaretta. E quando il caffè è diventato freddo e la sigaretta era tutta consumata, gli ho augurato la buonanotte. Non si guadagna un soldo in questo modo. Tu non lo faresti mai. E per questo che sei un bravo poliziotto e io sono un detective privato.”
Indicazioni utili
Da leggere ai propri figli
Nella prefazione, Ray Bradbury fa un parallelismo tra “Il meraviglioso mago di Oz” e “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll, asserendo che siano espressione di due diversi tipi di individui: Alice è per chi ama il freddo inverno, per chi è attratto da anfratti oscuri e personaggi folli, anche crudeli; Dorothy è invece per gli amanti della calda estate, di chi ama perdere lo sguardo in sconfinate valli illuminate dal sole, dove sebbene il male sia presente non fa poi così paura. Evitando di inoltrarci oltre in questi parallelismi, si può dire che effettivamente è questo il sentore che si avverte durante la lettura de “Il meraviglioso mago di Oz”: il mondo descritto da Baum è popolato di creature strambe ma mai raccapriccianti, dove i rappresentanti del male non sono poi così spaventosi e possono essere sconfitti senza troppi patemi e allo stesso modo possono essere superate le difficoltà, ché una via d’uscita si trova sempre.
Il mago di Oz è una ventata d’ottimismo, un segnale che tutto a questo mondo ha una soluzione. Lo stesso personaggio del mago è l’espressione principe di questo concetto: egli infatti ha un’illusione per tutto, tanto da essere in grado di far credere da anni che sia veramente un mago e permettendogli di governare sulla Città di Smeraldo, e anche una volta smascherato sarà in grado di donare un cervello allo Spaventapasseri, un cuore al Boscaiolo di Latta e il coraggio al grosso Leone, compagni di viaggio di Dorothy. Questo perché, come dando una pillola di zucchero a qualcuno che si creda malato, non sta facendo altro che illuderli, fingendo di dar loro quel che già hanno, come il lettore avrà modo di appurare seguendo le loro avventure. Spesso, dunque, i problemi che ci sembrano insuperabili in realtà non lo sono e possono essere risolti senza ricorso alle arti magiche, e ciò che crediamo di non avere è invece già presente in noi, solo che magari non ne siamo consapevoli o non siamo stati in grado di tirarlo fuori.
Questo romanzo è uno di quelli che si prestano perfettamente alla lettura ai propri figli prima di andare a letto, anche nella struttura: composto da capitoli brevi che attraggono l’attenzione senza andare troppo sul sofisticato, cercando sempre quel lieto fine che da bambini riteniamo indispensabile e che non si lascia attendere per troppe pagine. Introduzione del capitolo, si presenta la difficoltà o il conflitto, molto presto ci si rivela la soluzione: questa è la struttura della maggior parte dell’opera.
La piccola Dorothy non dovrà affrontare le difficoltà della piccola Alice, ma è una di quelle storie che accompagnano nella crescita e possono dare ai ragazzi uno scorcio della vita che si appresteranno ad affrontare. Ma la vita non è solo quella che ci presenta il Mago di Oz, ed è per questo che la sua lettura andrà accompagnata a tante altre (tra cui la nostra cara Alice) che possano darci altri punti di vista e aiutarci ad affrontare con più consapevolezza quel percorso tortuoso che è la vita.
“«Ciononostante,» disse lo Spaventapasseri, «io, invece del cuore, chiederò il cervello; perché uno sciocco non saprebbe che farsene di un cuore, se mai si trovasse ad averne uno.»
«Io prendo il cuore,» ribatté il Boscaiolo di Latta, «perché il cervello da solo non basta a farti felice e la felicità è la cosa più bella del mondo.»”
Indicazioni utili
Il ribaltamento del mito
Non è la prima volta che leggo un opera in cui Dürrenmatt si adopera a rielaborare un mito greco: ne avevo avuto prova anche ne “La morte della Pizia”, probabilmente una delle sue opere più riuscite e interessanti. Anche “Il Minotauro” è una prova di tal genere, sebbene con uno svolgimento decisamente più amaro, una rielaborazione del mito del “mezzo toro e mezzo uomo” che è probabilmente tra quelli più conosciuti della mitologia greca. Ma mentre nella storia che ci hanno sempre raccontato il punto di vista è sempre quello di coloro che sono al di fuori del labirinto, stavolta l’origine di questa ballata - perché in effetti l’opera è in versi, sebbene dia la sensazione della prosa - si ha proprio all’interno del labirinto, col primo risveglio del mostro all’interno della sua prigione intricata e psichedelica ideata da Dedalo. È al mostro che è dedicata la totale attenzione del narratore, ma ben presto sorgerà nella mente del lettore una domanda, che è secondo me è centrale in questo breve ma denso componimento: il Minotauro è davvero un mostro?
Occorre di certo considerare che il Minotauro è il risultato d’un rapporto bestiale e raccapricciante, quello tra la moglie di Minosse Pasifae e un toro bianco che il re avrebbe dovuto sacrificare agli dei. Contravvenendo a quest’ultimo comando divino, la punizione che colpisce Minosse è l’innamoramento della moglie verso questo toro e la sua passione incontrollabile placata grazie a Dedalo, la quale ha come frutto, appunto, il Minotauro. Ma quale colpa ha questa creatura per gli errori di Minosse e di Pasifae? Giudichiamo forse i figli per le colpe dei padri? Tralasciando il controverso insegnamento del giardino di Eden, possiamo dire di no. È dunque solo il suo aspetto mostruoso a renderlo malvagio, seguendo la linea di pensiero del Riccardo III shakespeariano? No, in quel caso si trattava soltanto di una giustificazione per una malvagità che aveva ben altre fonti. Dunque, analizzando bene la situazione, il Minotauro ci è presentato nel mito come una creatura bestiale, che si nutre di carne umana, alla quale vengono sacrificati dei poveri giovani che lui dilania e divora senza pietà. In quest’opera il geniale svizzero, invece, ci presenta la verosimilissima possibilità che il Minotauro altro non sia che una creatura innocente, ingenua e inconsapevole, piazzata all’interno di una prigione che manderebbe ai matti anche l’uomo più sano di questa terra. Eppure, la sua inconsapevolezza arriva al punto da impedirgli di impazzire: la sua figura che si riflette all’infinito all’interno di quegli specchi non è la sua stessa figura, per lui, ma sono altri esseri come lui che lo seguono in tutto e per tutto, in ogni suo movimento. Certo, il suo istinto animalesco non è una variabile da ignorare: la donna che troverà all’interno del labirinto sfrenerà i suoi istinti sessuali, ma non è ancora una creatura malvagia: è una creatura che segue il suo istinto perché non gli è stato dato null’altro, è una creatura ingenua e a tratti bambinesca. Danza, felice di aver trovato altri esseri come lui; danza per aver assaggiato l’idea dell’affetto e dell’amore; danza perché crede di aver trovato un amico. Ma è proprio quel che lui credeva un amico - non essendo capace di concepire la malvagità - ad aprirgli gli occhi verso quella che probabilmente è la parte davvero mostruosa di lui: quella umana. Il Minotauro non uccide se non quando viene ferito quasi a morte, e anche in seguito vedrà inizialmente nel suo carnefice, Teseo, un possibile amico, una possibile compagnia in quel mondo così strano, così pieno di figure eppure così vuoto. Teseo lo ucciderà, pur avendo percepito l’ingenuità della creatura che ha di fronte, proprio nel momento in cui il Minotauro si avvicina a lui in segno di fiducia bambinesca, una fiducia rotta brutalmente.
Avevate mai provato ad analizzare il mito da questo punto di vista? Magari sì, ma ancora una volta in pochissime pagine Dürrenmatt si rivela un autore con la A maiuscola, capace di farci riflettere e di condensare tante idee in poco spazio.
“[…] il Minotauro sognò di essere un uomo. Sognò un linguaggio, sognò fratellanza, sognò amicizia, sognò accoglienza, sognò amore, intimità, calore, eppure mentre sognava sapeva di essere un mostro cui mai sarebbe concesso un linguaggio, mai fratellanza, mai amicizia, mai accoglienza, mai amore, mai intimità, mai calore, sognò come gli esseri umani sognano gli dèi, l'uomo con la tristezza degli uomini, il minotauro con la tristezza degli animali.”
Indicazioni utili
Una sorta di pastiche fiabesco
Ormai mi sono convinto che Stephen King abbia votato se stesso alla sperimentazione di ogni sorta di genere. Con la serie di “Mr. Mercedes” si è gettato sul noir-poliziesco, con “Billy Summers” e “The Outsider” sul thriller, e adesso con “Fairy Tale” sul fantasy-fiabesco. Inutile dire che ognuna di queste produzioni è infarcita di elementi di quello che, alla fine, è il genere in cui dà il meglio di se: l’horror. Il protagonista stesso di “Fairy Tale”, una volta immerso nel mondo fantastico di Empis nel quale porterà avanti le sue avventure, capisce molto presto che quelle che sta vivendo non sono avventure fiabesche di stampo disneyano; il modello di riferimento sono infatti le fiabe classiche, in particolare quelle dei fratelli Grimm, anche nelle loro versioni più inquietanti e cruente. Chi fosse ferrato riguardo questo tipo di produzioni, infatti, saprà che le fiabe originali dalle quali spesso la Disney ha tratto i suoi grandi classici sono infarcite di violenza, terrore e sofferenza.
Il viaggio di Charlie Reade è una sorta di miscuglio di tante storie conosciutissime, e forse questo è un po’ il punto debole del romanzo: sa di già visto e ha pochi (se non nessuno) elementi davvero innovativi. Basti pensare che il concetto che fa da motore alla storia è un elemento ripreso esplicitamente da “Il popolo dell’autunno” di Ray Bradbury. Nel romanzo di Bradbury (bellissimo, leggetelo) un luna park popolato da aberranti creature contiene una giostra che, girando all’indietro, può ringiovanire chi ci sale e viceversa. Nel mondo creato da Stephen King esiste una meridiana che ha le stesse peculiarità; una meridiana che Charlie vorrà usare per ringiovanire il suo cane, e il riferimento non è nascosto bensì esplicitato chiaramente dall'autore che inserirà il romanzo tra le letture del protagonista. Sarà questo l’obiettivo primario del protagonista per una buona metà del libro, fin quando le sue avventure non lo porteranno ad affrontare orrori ben peggiori: Empis è infatti un regno oppresso da un’orrenda maledizione che colpisce la maggior parte dei suoi abitanti con un orrendo morbo, che pian piano li rende di carnagione grigia e sembra quasi cancellarne i lineamenti. Il regno, una volta ridente, è adesso governato da un uomo orrendo e senza scrupoli, il Predatore, e dai suoi scagnozzi: i soldati della notte.
Pur dando l’impressione di volersene distanziare, lo stampo strutturale dell’opera è squisitamente disneyano: il ragazzo prodigio che si ritrova improvvisamente ad essere il prescelto, il principe tanto atteso citato da un’antica leggenda, l’unica salvezza per un intero popolo e, ovviamente, coinvolto in una liason con la bella principessa. King prende questi stereotipi e prova a romperli, secondo me in maniera non abbastanza forte da creare una vera rottura o comunque una storia che possa definirsi originale. Anzi, come ho già detto, sa tutto un po’ di già visto.
Lungi da me giudicare la volontà di un artista: se King ha deciso che il suo sogno è sperimentare tanti generi diversi, è una sua scelta e la rispetto. Ma continuo a pensare che se nel corso della sua carriera si fosse preso un po’ di tempo, tra un romanzo e l’altro, avremmo tanti capolavori in più che portano la sua firma. Forse godrebbe di qualche considerazione in più nelle “alte sedi”.
Ma ognuno fa le sue scelte.
“Fairy Tale” è un romanzo abbastanza scorrevole, ma se dovessi decidere passare qualche giorno con una piacevole lettura, forse sceglierei qualcos’altro. Magari anche dello stesso autore.
“Ci si abitua alle cose più stupefacenti: tutto qui. Alle sirene e ai grandi schermi, ai giganti e ai telefoni cellulari. Se una cosa si trova nel tuo mondo, ne accetti subito l'esistenza. È meraviglioso, non trovate? Se però guardate tutte queste cose da un'altra prospettiva, sono terribili. Pensate che Gogmagog sia spaventoso? Il nostro mondo è seduto sopra un arsenale di armi nucleari che potenzialmente sarebbe in grado di distruggere il pianeta, e se non è magia nera questa, non saprei come altro definirla.”
L'impossibilità del contatto
Stanislaw Lem è uno di quegli autori sui quali ripongo grandi speranze ogni volta che comincio a leggere una loro opera, tra i rappresentanti di una fantascienza capace di inglobare in sé stessa storie coinvolgenti e tematiche importanti e interessanti, coniugando intrattenimento e contenuto. E' chiaro che anche "Il pianeta del silenzio" abbia questa struttura di base e questi obiettivi, ma devo dire che rispetto ad altre opere dell'autore polacco (come ad esempio "L'invincibile") presenta una piacevolezza di lettura sensibilmente più bassa. Questo problema è da imputare, a mia opinione, principalmente alle digressioni scientifiche di Lem: un po' come Melville fa con elementi della baleneria nel suo capolavoro "Moby Dick", l'autore si lascia qui andare a digressioni riguardanti aspetti tecnici e teorici della fisica e del volo spaziale; le descrizioni sono lunghe, spesso così difficili da non permettere all'immaginazione di fare il suo lavoro ma lasciano spazio a un pizzico di frustrazione. E' stato davvero complicato portare avanti questa lettura, per lunghi tratti piuttosto pesante.
Quel che non manca, come al solito, è la riflessione filosofica che si intreccia con la narrazione: Lem è infatti uno di quegli autori che riescono in maniera egregia a inserire tematiche universali riguardanti la natura umana in un contesto fantascientifico, inglobando in esso anche riflessioni antropologiche e religiose; la fantascienza di Lem ha al suo centro l'essere umano, che di fronte all'ignoto e al fantastico si rivela più umano che mai, rivelando le proprie complessità e le proprie contraddizioni.
Il pretesto per indagare la psiche umana e il suo approccio all'ignoto è qui usata attraverso l'espediente del contatto con una civiltà aliena, i Quintani, i quali rappresentano un'occasione più unica che rara: nell'abnorme esistenza dell'universo, infatti, le probabilità di entrare in contatto con una civiltà che sia così avanti nel suo grado di sviluppo e civilizzazione da essere in grado di comunicare con i terrestri è infatti quasi irrisoria. La missione di Mark Tempe e dell'equipaggio dell'Euridice è quello di cogliere questa opportunità tanto agognata, di stabilire questo contatto che rappresenterebbe un punto di svolta nell'esperienza umana. Quel che tutti gli studiosi hanno dimenticato di considerare è: la civiltà in questione è davvero interessata ad avere un contatto? Oltre questo, c'è un altro aspetto ancor più importante da tenere a mente: gli esseri umani sono in grado di gestire una situazione di questa portata? L'essere umano è diffidente, disposto a tutto per salvaguardare la propria sopravvivenza; il suo primo approccio all'ignoto è una prudenza che al primo segnale negativo può sfociare nella violenza. Questo sarà da subito evidente, e la missione dell'Euridice sarà chiaramente fallita prima di cominciare: ogni segnale da parte dei Quintani sarà interpretato come una minaccia accompagnata dall'immediata dimostrazione di forza, adoperata per salvaguardare sé stessi. Allo stesso modo sarà interpretato il loro silenzio.
In un modo estremamente interessante, Lem ci sbatte in faccia la realtà: per come è fatto, l'essere umano non è in grado di gestire un contatto con una civiltà lontana, non senza l'uso della violenza. Lo avesse fatto indulgendo meno a infinite e complesse descrizioni e a digressioni estremamente criptiche, potrei dire che "Il pianeta del silenzio" rientri tra i libri da leggere assolutamente da chiunque. Purtroppo questa problema è talmente preponderante da non poter essere ignorato e da restringere il campo delle persone a cui lo consiglierei a coloro che apprezzino tali peculiarità descrittive e narrative. E questo è davvero un peccato.
"L'uomo aspira a conoscere la verità ultima. Ogni mente mortale, credo, è fatta così. Ma dove si trova la verità ultima? E' alla fine della strada, dove non c'è più mistero, dove non c'è più speranza. E dove non ci sono più domande da rivolgere, perché si sono già ottenute tutte le risposte. Ma un simile posto non esiste."
Il vento è la sorte
Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, incarna quella che nel corso degli anni è stata la maggior parte della letteratura italiana: una letteratura profondamente legata al contesto autoctono (in questo caso sardo) e che mira a descriverne le peculiarità e i cambiamenti in determinati periodi storici. Il tipo di letteratura che personalmente non amo: lo dico subito, a scanso di equivoci. Sebbene la Deledda riesca abbastanza bene a scandagliare la psicologia dei suoi personaggi (soprattutto, in questo caso, del servo Efix) e offra uno stile piuttosto evocativo che in certi tratti mi ha ricordato il mio amato Cormac McCarthy (ma badate, in certi tratti), "Canne al vento" è comunque visceralmente legato alla terra in cui è ambientato e alle dinamiche che muovono il contesto sociale della campagna sarda. Questo legame, sebbene sia caratterizzante, rende l'opera molto soggetta al gusto del lettore, sebbene la Deledda abbia il pregio di andare più in profondità nell'animo umano e dare un pizzico di "universalità" al suo lavoro. Questo è probabilmente l'aspetto che più ho apprezzato del romanzo (e che probabilmente è una caratteristica dell'autrice che si è rivelata decisiva nell'assegnazione del Premio Nobel) ma in mancanza del quale ci troveremmo di fronte a una produzione che lascerebbe un po' indifferenti. Quest'universalità, tuttavia, chiama in gioco una spiritualità che al lettore moderno potrebbe apparire un po' obsoleta: ci offre uno sguardo su un lato dell'essere umano che il lettore potrebbe non sentire troppo vicino. Mentre il cammino d'un Siddhartha è pregno anche dei dilemmi e delle contraddizioni dell'uomo moderno, il cammino d'espiazione di Efix ha un carattere molto legato alla spiritualità del protagonista, una spiritualità non legatissima agli aspetti terreni, estremamente metaforico sebbene venga concretamente condotto dal servo.
Un po' invecchiato male, a mio parere; ma mai come in questo caso la percezione soggettiva è importante, dunque date alla mia opinione e alle mie parole il dovuto peso.
Al centro della storia, come abbiamo detto, c'è Efix: un servo che si occupa del "poderetto" delle sue tre padrone. In origine le sue padrone erano quattro, ma una di loro, una notte, decise di sfuggire alla rigida autorità del padre (che morì poco dopo), si sposò ed ebbe un figlio, lasciando alle sue tre sorelle "zitelle" un sentimento di rancore e abbandono. Questa donna, Lia, ai tempi del racconto è già morta e così suo marito, e infatti lo sconvolgimento che darà seguito agli eventi è proprio l'annuncio dell'arrivo di Giacinto, il figlio di Lia. Le tre sorelle reagiscono in maniera molto diversa tra loro, ed Efix ne sarà entusiasta, vedendo in quest'evento quel che potrebbe sconvolgere la vita grigia delle sue tre amate padrone. Avrà ragione, ma solo leggendo il romanzo si potrà capire in che senso.
Un romanzo che a mio parere va letto e discusso, perché sebbene non ne sia entusiasta può lasciare largo spazio al confronto e all'analisi congiunta.
"«Si, siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia. Siamo canne, e la sorte è il vento.»
«Si, va bene: ma perché questa sorte?»
«E il vento, perché? Dio solo lo sa.»"
Un padre ingombrante
John Fante è probabilmente uno degli autori americani più interessanti del panorama statunitense del Novecento, con una prosa fluida e autentica che lascia filtrare vividamente ciò che racconta, capace di focalizzarsi sulle problematiche trattate in maniera efficace e penetrante. Questo romanzo, così come "1933. Un anno terribile" e più del famoso "Chiedi alla polvere" riesce a catturare il lettore e a presentargli le dinamiche di una famiglia italo-americana, coi suoi problemi e le sue tradizioni (forse a volte un po' stereotipate) che fanno sorridere perché in certi tratti ricordano proprio le nostre famiglie italiane: la cucina come regno delle madri e come "mezzo di ricatto" nei confronti dei figli, come tentazione irresistibile per ottenere ciò che si vuole; il melodramma, l'esagerazione, l'attaccamento alla famiglia a volte altalenante, che oscilla tra amore e odio. Tuttavia è la figura del padre a essere al centro di questo romanzo, non è infatti un caso che Dostoevskij sia più volte citato: il padre ingombrante de "La confraternita dell'uva", Nick Molise, è infatti accostabile al Fedor Pavlovic Karamazov che è creatore di dissidio nella famiglia e capace di influenzare profondamente le vite di moglie e figli. Questo non porta tuttavia a un parricidio come nell'opera russa, ma a una sorta di ricerca di comprensione, alla decodificazione dei motivi, alla riscoperta di un rapporto padre-figlio che passa per il lavoro. Sebbene al centro della narrazione ci sia Henry Molise, il figlio, è comunque la figura problematica del padre Nick a essere al centro delle considerazioni dell'autore: un ubriacone, violento e tiranno con la moglie e con i figli; ogni componente della famiglia avrebbe i suoi buoni motivi per odiarlo, ma non è così facile odiare un padre, nonostante sia palesemente una persona tossica. La madre è emblema perfetto di questa controversia: tradita ripetutamente e delle volte anche picchiata, paventa sempre il divorzio ma non è in grado di darvi seguito, anzi, è quella che mostra più apprensione per la sorte di quel marito che, a parole, dipinge come un mostro. Nonostante questo, sono forse i figli ad avere il rapporto più problematico con Nick: uno di loro si è visto negare una carriera da star nel mondo del baseball, a causa dell'egoismo del suo vecchio, che si è arrogato il diritto di scegliere per lui.
La narrazione è concentrata sugli ultimi giorni di vita di questo padre incapace di accettare la vecchiaia, diviso tra una sommessa volontà di ristabilire un contatto con suo figlio Henry e la palese incapacità di rinnegare la propria natura, la cui origine possiamo solo supporre da qualche indizio che Fante sparge qua e là, senza poterne venire a capo. Nick Molise non accetta il passare degli anni, non accetta il venir meno delle proprie forze, non accetta di non essere più nelle condizioni di fare quello che ha sempre fatto egregiamente nella propria vita oltre a bere e fornicare: fare il muratore. Quello descritto in queste pagine è il suo declino finale, l'acquisizione di consapevolezza della fine e l'incapacità di accettarla; il tentativo di stabilire un contatto coi propri cari e una natura che è troppo corrotta per permetterglielo.
La dicotomia amore-odio in questo romanzo la fa da padrone, e l'attaccamento lascia spazio, a un certo punto, al sollievo dovuto alla liberazione da un peso che ci si è portati sulle spalle per tutta la vita: un peso al quale non ci si poteva sottrarre, che ci lascia le lacrime agli occhi ma che sfiacchisce, logora, distrugge.
Certe figure della nostra vita, non importa quanto care siano, delle volte possono essere dei macigni dai quali aneliamo liberarci, ma non possiamo farlo. Solo la morte potrà farlo, ma può mai desiderarsi la morte d'un padre (o di chi per lui)? Chiedetelo a Dostoevskij, o a John Fante.
“Ero anche io un padre, ma non volevo quel ruolo. Volevo tornare indietro nel tempo, quand’ero piccolo e mio padre girava per casa, forte e rumoroso. Fanculo la paternità, non ci ero tagliato. Ero nato per fare il figlio.”
Indicazioni utili
Delusione
Chi ha avuto modo di leggere alcune delle mie recensioni su opere di fantascienza sa quanto io sia amante del genere e quanto la mia lotta per valorizzarlo abbia assunto le proporzioni di una vera e propria crociata. Logico pensare che, per uno come me, leggere un romanzo di fantascienza contemporanea pubblicato da un grande editore italiano quale è Einaudi, che pubblica pochissimi romanzi di questo genere, sia per me un obbligo e sia fonte di un’enorme curiosità. Jeff Vandermeer è uno dei pochi autori di fantascienza ad avere questo privilegio ma, a mio parere, non credo lo meriti appieno. Di suo ho letto un altro romanzo sempre edito Einaudi, “Borne”, e di quel poco che ricordo riguardo a quella lettura posso dire che quantomeno aveva garantito una certa piacevolezza; mi duole ammettere che “Colibrì Salamandra” è una delusione da diversi punti di vista, compreso quest’ultimo.
Partiamo, come sono solito fare, dallo stile: lento, macchinoso, a lunghi tratti incomprensibile. Degli ambienti sono riuscito a figurarmi poco e niente, degli eventi ancor meno. Di quel poco che si comprende non si ha idea di come ci si sia arrivati perché Vandermeer, forse nel tentativo di caratterizzare la sua protagonista col racconto in prima persona, adotta un timbro particolare che tuttavia non riesce nell’intento e rende la lettura a tratti anche irritante. Tutto questo si intreccia al contenuto: per una storia che vuole evidentemente tingersi di “thriller” e puntare sul mistero, sull’indagine e sui plot twist, è davvero tutto troppo complicato. Non riusciamo a capire chi siano i personaggi che si oppongono alla protagonista, non sappiamo quali siano i loro obiettivi (in fondo, credo non si capisca nemmeno quale sia l’obiettivo della protagonista, anzi penso proprio che non lo sappia nemmeno lei fino alla fine), non sappiamo cosa ha voluto trasmetterci l’autore se non un generico ammonimento su quanto stiamo rovinando il mondo. Non sindacherò sulla poca originalità di una tematica giustamente molto in voga ai giorni nostri, perché la vera bravura dell’autore sta nello sviscerarla in maniera efficace. A parte qualche riflessione (spesso incomprensibile) c’è poco altro a riguardo, in questo romanzo: mi sembra tutto un po’ buttato lì, in una trama complicatissima che nulla ha della complessità di un prodotto science-fiction a stampo “westworldiano”, ma punta sul filone politico-economico-criminale e ne tira fuori la parte più noiosa.
Vorrei concludere con una riflessione. Non mi aspetto che Vandermeer o chi per lui raggiunga le vette di un Bradbury o di un Philip K. Dick: basterebbe solo pensare che quest’ultimo, per esempio, aveva previsto i problemi descritti in questo romanzo decenni e decenni fa, ed era talmente avanti che l’idea di un’estinzione massiva di animali che è il fulcro di quest’opera non era che il contorno, un dettaglio d’un mondo e d’una riflessione più ampia e globale. Però mi aspetto che i grandissimi strumenti forniti da un genere quale è la fantascienza siano usati a dovere, se non per sviscerare in maniera interessante una tematica, quantomeno per creare una storia che coinvolga. Seppur poco propensi all’impegno per combatterli, a capire quali sono i nostri problemi ci riusciamo tutti: il dovere dell’autore non è fornire una soluzione, ma scavare nelle loro profondità, individuarne le cause, innescare riflessioni che possano generare consapevolezza. Magari, la soluzione potrà nascere proprio da queste riflessioni, ma mi dispiace dire che “Colibrì Salamandra” non riesce nell’intento, e si configura anche come una lettura parecchio noiosa.
A malincuore, bocciato.
“«La Democrazia non basta perché non è mai davvero Democrazia. L'-ismo che risolverà tutto questo non è ancora stato scritto, perché esiste in ciò che resterà del mondo dopo di noi, ed è un linguaggio che non sappiamo interpretare. E cosí ci teniamo i nostri ragionamenti fallati, meccanici, che operano in antitesi alla natura biologica dei nostri cervelli. Abbiamo eretto tanti costrutti tossici da non riuscire piú a scorgere il reticolo. Abbiamo tirato su tanti specchi che non ci restano piú finestre da spaccare. Ma dobbiamo provarci lo stesso».”
Una passione che può infiammare chiunque
Dopo il primo approccio di lettura (piuttosto insapore) con"Nudi e crudi", eccomi di nuovo alle prese con Alan Bennett: un'esperienza decisamente più interessante e ricca di spunti, soprattutto perché poi discussa al circolo di lettura che frequento. In questo senso sono tante le riflessioni che si possono sollevare con altri appassionati, perché è proprio sul piacere del leggere che si focalizza questo breve romanzo, utilizzando la figura della Regina Elisabetta come simbolo dell'individuo che per caso scopre la bellezza del leggere, e da lì non può farne più a meno. Una figura che sento spaventosamente affine alla mia e che, per l'accuratezza con cui l'ha descritta, mi sembra non essere del tutto sconosciuta nemmeno all'autore.
Ma andiamo con ordine.
La prima riflessione interessante sollevata dal romanzo (anche se non direttamente esplicitata) è quella del modus operandi paradossale della scuola: la nostra Regina, infatti, avrà un primo approccio alla lettura abbastanza pesante, dovuto alla scelta scellerata di un romanzo che si rivela troppo ostico per un lettore alle prime armi. Dopo questa prima esperienza, infatti, non sembrerà per nulla colpita dalla letteratura e manterrà la sua fredda distanza, se non fosse che il caso gli offre un altro tentativo casuale, nel quale invece si trova tra le mani un romanzo magari più frivolo e leggero, ma che riesce ad accendere la scintilla che la porterà a volare nel suo percorso letterario, che arriverà fino alle vette di Dickens e Proust. Ecco il punto: la scuola non dovrebbe principalmente provare a instillare nei giovani la passione per la lettura, piuttosto che imporre dall'inizio autori che sono sì grandissimi, ma non adatti a un novizio che in primis non ha ancora le capacità per comprenderlo, ma potrebbe farsi un'idea nefasta dell'elemento libro? Forse andrebbero proposti libri leggeri, bisognerebbe andare per gradi, e probabilmente a quei grandissimi scrittori ci si arriverebbe da soli, con molto più piacere e consapevolezza. Ma no, continuiamo ad assegnare "Il fu Mattia Pascal" ai quindicenne al mare.
Che cosa dire invece del fatto che la lettura, oggi, sia vista quasi con sospetto? Vi è mai successo di sentirvi dire: "ma perché leggi tutti sti libri? Ma come fai?". Come se l'idea di leggere per piacere sia ormai inconcepibile, come se nei secoli passati la letteratura non rappresentasse lo svago più diffuso... e di certo al tempo si leggevano cose molto più complesse e articolate delle nostre! Un tempo era Dickens a essere mainstream, e di certo non era una lettura banale. Oggi abbiamo autori totalmente dediti all'intrattenimento, eppure il libro quasi spaventa. Il disagio provato dalla Regina allo sgomento del mondo, che improvvisamente la vede così appassionata a un qualcosa che è diventato per alcuni anacronistico, è il nostro disagio. Forse esagero... o forse no, ma sta di fatto che c'è da pensarci.
Altro interessante spunto riguarda il fatto che una lettura assidua e appassionata faccia nascere, lentamente, il germe della scrittura creativa, altra cosa che ho sperimentato sulla mia pelle. Confrontarsi con tanti autori, punti di vista idee e storie diverse allarga gli orizzonti, ti porta a un approccio critico e all'elaborazione di un tuo modo di vedere le cose, che molto spesso si sente il desiderio di esprimere. Questi sono solo alcuni degli spunti legati alla lettura forniti da questo racconto molto leggero e ironico, che secondo me vale la pena leggere soprattutto per chi è un lettore appassionato.
“Inseguendo l'amore si rivelò un'ottima scelta, a suo modo determinante. Se Sua Maestà si fosse orientata su un altro macigno, per esempio un romanzo giovanile di George Eliot o uno degli ultimi di Henry James, nella sua qualità di novizia avrebbe potuto scoraggiarsi per sempre e la faccenda si sarebbe chiusa lì. Avrebbe pensato che leggere era un lavoro.”
Indicazioni utili
Delitto e castigo in miniatura
Stefan Zweig si distingue per la sua ampia produzione di romanzi brevi, di cui questo “Paura” fa parte. Ovviamente, per poter creare opere così brevi che siano efficaci, bisogna possedere una incisività fuori dal comune, capacità che pochissimi scrittori hanno: Friedrich Dürrenmatt e Leonardo Sciascia ne sono probabilmente gli esempi più lampanti. Su Stefan Zweig ho ancora qualche dubbio: dopo il piacevole “La novella degli scacchi”, questo romanzo mi ha lasciato qualche perplessità: pur ricordandomi in certi tratti il “Delitto e castigo” dostoevskiano, il tormento di Irene non arriva potente come quello di Raskol’nikov. Certo, stiamo parlando di un capolavoro senza tempo e certo il personaggio protagonista di questo romanzo non si è macchiato di una colpa grave come quella del russo, tuttavia il focus mi sembra lo stesso e non arriva con la stessa efficacia. Anche qui, infatti, l’eventuale castigo con cui dovrebbe essere punita la colpa non è mai peggiore della paura di essere scoperti, di perdere tutto ciò che si ha e che fino a quel momento non si era apprezzato abbastanza, dei sensi di colpa nei confronti di coloro che abbiamo fatto soffrire. Eppure non siamo in grado di porre fine a questo tormento, il castigo ci spaventerà sempre di più, anche se la paura dovesse finire per consumarci a morte.
È questa la situazione di Irene, su cui è focalizzata la storia raccontata da Zweig: il nostro sguardo non si distoglierà mai da lei e, sebbene la storia non sia raccontata in prima persona, verremo a conoscenza dell’ininterrotto turbinio interiore che la coinvolgerà fin dall’inizio del romanzo. Ma cos’è che turba così tanto Irene? Non l’omicidio di una vecchia usuraia, bensì il tradimento del letto coniugale, con una relazione che sembra averla quasi rapita inerme, senza che lei facesse nulla, nemmeno troppo infelice del suo matrimonio. Irene è una borghese annoiata, che nella sua vita tranquilla si lascia trascinare in qualsiasi esperienza fuori dai binari ma senza impeto, bensì quasi per inerzia. Quando una donna scoprirà il suo tradimento e comincerà a ricattarla, allora comincerà il suo tormento: la sua persecutrice diventerà sempre più avida, suo marito sempre più sospettoso, la sua vecchia vita tanto bistrattata diverrà ai suoi occhi preziosa come l’oro e ormai irraggiungibile. Un tormento che la porterà fino alle conseguenze estreme e ad una inaspettata conclusione.
“Se non mi fa pena? mi chiedi. E io ti rispondo: no, oggi non più. Adesso che ha ricevuto il castigo sarà sollevata, anche se le sembrerà duro. Infelice, piuttosto, lo era ieri - quando il povero cavallino languiva a pezzi nella stufa, tutti in casa lo stavano cercando e, di ora in ora, cresceva in lei la paura che potessero trovarlo, che lo trovassero davvero. La paura è peggio del castigo; perché alla fine il castigo è qualcosa di determinato e, sia pesante o meno, è sempre meglio della spaventosa incertezza, della tremenda tensione che si prolunga all'infinito.”
Un caso come tanti
Se un lettore volesse star dietro a tutte le serie di romanzi che la letteratura ci propone al giorno d’oggi, non gli basterebbe un secolo per seguirle tutte. Una di queste è quella creata da Joël Dicker e il suo Marcus Goldman, che fa il proprio esordio in quel romanzo di strepitoso successo che è “La verità sul caso Harry Quebert”, che ha spammato i nostri social, le librerie e le televisioni per un tempo davvero lunghissimo. Dunque un ritorno del protagonista era assolutamente annunciato (e in fondo già avvenuto con “Il libro dei Baltimore”) ed ecco che ci si ripresenta con “Il caso Alaska Sanders”, probabilmente il secondo di una lunga serie di casi che Joël Dicker è deciso a regalare ai propri lettori.
Ma vale la pena leggere questo romanzo? Certo la narrazione scorre facilmente, è un libro che come ogni buon thriller si lascia leggere e ci porta nell’intricata rete delle indagini che hanno al centro l’omicidio di Alaska Sanders, giovane modella e aspirante attrice uccisa oltre dieci anni prima della timeline del romanzo. Goldman, in qualche modo, rivangherà questo omicidio e porterà alla luce come, probabilmente, di questo delitto siano stati puniti ben due innocenti. Fato vuole che ad occuparsi del caso, all’epoca, era Perry Galahowood: questo permette all’autore di riformare una coppia che funziona e unirla definitivamente per i casi a venire, finché morte non li separi. In certi tratti, tuttavia, ho notato più di una forzatura: i testimoni vengono interrogati tantissime volte, perché ogni volta si inventano una balla diversa e gli investigatori devono tornare da loro e dirgli di smetterla di fare i cattivi, altrimenti finisce male; molti elementi dell’indagine si incastrano troppo a fagiolo, in modo che l’intricata rete dell’assassino possa reggersi in piedi, e quando questa si sbroglia si rivelano nella loro artificiosità.
Il racconto non ha nulla di troppo originale, è un omicidio come lo si può ritrovare in tantissime altre serie thriller e questo forse influisce sulla curiosità del lettore, che seguirà sì il dipanarsi degli eventi ma sarà trascinato avanti semplicemente dalla voglia di scoprire il colpevole e senza molti altri interrogativi. Ma un omicidio è un omicidio, mi direte, cosa può inventarsi un autore a riguardo? Guardate la prima stagione di True Detective, e poi ne riparliamo. Vi dico solo una cosa: i dettagli. Quello di Alaska Sanders è una storia come tante altre, che è piacevole ma non riesce a spiccare nel panorama del genere, in cui più che distinguersi per originalità e cercare di raccontare qualcosa che possa elevarsi al di sopra degli altri sembra che gli autori si limitino a trovare la formula che funziona meglio, quella che può accalappiare il maggior numero di persone, e una volta ogni uno-due anni sfornare un libro nuovo con cui tenerli occupati. Joël Dicker non mi sembra faccia eccezione.
Sarò troppo severo? Forse lo sono. Il thriller è in fondo qualcosa con cui passare il tempo, e non è certo da biasimare un autore che decide di dedicarvisi. È vero, ma ci sono alcuni autori che riescono a trascendere il genere a cui appartengono e raggiungere vette più alte: penso a King per l’horror, a Ray Bradbury e Stanislaw Lem per la fantascienza… chi si offre per trascendere il genere del thriller? Ci è riuscito Nic Pizzolatto, ma con una serie tv… attendiamo la svolta letteraria.
“Apparenze, scrittore. Le apparenze sono il collante della nostra vita sociale. Ma nell’intimità delle nostre case, tutto crolla.”
Una perla da scovare
William Saroyan è uno di quegli scrittori ai quali arrivi quasi casualmente, leggendo libri su libri, che a volte ti guidano verso perle nascoste che difficilmente avresti scovato diversamente. Almeno, è stato così per me. La lettura de “La commedia umana” mi è stata infatti “suggerita” da Ray Bradbury, in uno dei racconti contenuti in “Ricordare Parigi”, dove la lettura dei libri di Saroyan ha un effetto benefico su uno dei protagonisti, rendendolo un uomo migliore. Ecco come sono arrivato a leggere questo libro, e la sua somiglianza - sia nella struttura che nella tipologia di racconto - con “L’estate incantata” dello stesso Bradbury, oltre ad essere una piacevole scoperta mi fa pensare che probabilmente il caro Ray abbia preso spunto proprio da Saroyan per scrivere uno dei suoi più grandi capolavori, superando il suo “maestro”. A prescindere da questo, “La commedia umana” è comunque un libro bellissimo, che nella sua semplicità riesce a regalarci tratti di grande poesia e profonda riflessione.
Così come Green Town, la Ithaca disegnata da Saroyan è popolata di personaggi meravigliosi, che riusciranno in brevissimo tempo a farsi spazio nel cuore del lettore: come resistere infatti alla muta curiosità del piccolo Ulysses? ai dubbi che delineano il passaggio all’età adulta di Homer? alla bontà e l’empatia di Spangler e alla genuinità del telegrafista, Grogan? Non si può.
Il romanzo è diviso in 39 piccoli capitoli: tutti raccontano una piccola storia, si soffermano su un breve episodio o su una particolare riflessione che poi va a comporre quello che è l’affresco di Ithaca, una cittadina che si vede privata di alcuni dei suoi giovani (partiti per combattere in guerra) mentre coloro che sono rimasti si affannano per tenere in piedi una sorta di normalità, nella speranza che “il telegramma di morte” non arrivi mai. Lo stesso Homer Macauley è una delle piccole grandi figure che si affannano per tenere in piedi la propria vita e quella dei propri cari: suo padre è morto e suo fratello Marcus è partito per la guerra, perciò a soli quattordici anni si ritrova ad essere “l’uomo di casa”, a dover badare a sua madre, sua sorella e al suo piccolo e irresistibile fratellino Ulysses. È per questo motivo che comincerà a lavorare all’ufficio del telegrafo insieme al direttore Spangler e al telegrafista Grogan, che subito noteranno le sue spiccate qualità, umane e fisiche. Homer si rivela il messaggero più veloce di Ithaca, ma spesso quei messaggi che si ritrova a portare sono messaggi di morte che, seppur “l’ambasciator non porti pegno”, lo faranno spesso sentire in colpa e finiranno per insinuare in lui un pensiero spaventoso: e se un giorno si ritrovasse tra le mani un altro di quei freddi messaggi, che tuttavia annunci la morte del suo amato fratello?
Un romanzo che riesce in certi tratti ad emozionare e contiene brani meravigliosi, da leggere e rileggere. Non siamo ai livelli de “L’estate incantata”, ma se quest’ultimo vi è piaciuto vi consiglio assolutamente di leggere anche “La commedia umana”.
Anzi, ve lo consiglio a prescindere.
“Pensavo che un ragazzo non dovrebbe piangere più, una volta cresciuto, mentre sembra quasi che sia proprio quello il momento di cominciare, perché è allora che apre gli occhi.”
Indicazioni utili
Un giallo filosofico
Friedrich Dürrenmatt è uno di quegli autori che il mondo sta riscoprendo. In Italia, in particolare, Adelphi sta pubblicando molti dei suoi lavori e ogni lettura dell’autore che mi ritrovo a fare si rivela ricca di sorprese. C’è da dire che l’autore svizzero ha tutte le peculiarità del narratore che incontra i miei gusti e anche “Il sospetto” si è rivelato per me una lettura interessante e piacevole. Questo romanzo può essere tranquillamente considerato un giallo, ma come dico spesso l’appartenenza a un genere non deve essere motivo per affibbiare un’etichetta o per partire prevenuti. “Il sospetto” è un romanzo molto interessante nel quale, con la scusa dell’indagine, si scava profondamente nell’animo umano e nel male di cui quest’ultimo può essere capace; si indagano i motivi che spingono un uomo a riporre fede in qualcosa; si riscoprono orrori che hanno fatto parte della nostra Storia e non andrebbero mai dimenticati. Messaggi e tematiche importanti, dunque, che vengono veicolati nel modo che dovrebbe essere quello più usato nel nostro secolo per creare della letteratura efficace: utilizzando una trama intrigante e coinvolgente.
“Il sospetto” racconta di un’indagine svolta in maniera atipica: il nostro protagonista è Bärlach, un commissario di polizia alle soglie della pensione che svolgerà la sua indagine da un letto di ospedale, gravemente ammalato e probabilmente destinato a morire nel giro di pochi mesi. La sua anima di poliziotto, tuttavia, è più viva che mai e nota subito la reazione sgomenta del suo medico nel vedere un’agghiacciante fotografia apparsa su una rivista, nella quale un altro medico è alle prese con un’operazione chirurgica attuata senza alcuna anestesia a un prigioniero di un campo di sterminio. Al dottore sembrerà di riconoscere una sua vecchia conoscenza e nella sua mente nascerà un sospetto che, come una malattia contagiosa, verrà trasmesso anche al commissario il quale non potrà fare a meno di seguire la sua indole di segugio, sebbene costretto forzatamente a letto e senza l’aiuto del corpo di polizia. La sua ricerca, infatti, è una vera e propria lotta personale contro un male subdolo, che abilmente è riuscito a sopravvivere in una società che ne ignora l’esistenza, anzi, che ne celebra inconsciamente i rappresentanti. Quella di Bärlach è un’indagine che verrà condotta in maniera statica (per ovvi motivi) ma che riesce comunque ad essere coinvolgente e che per mezzo dei dialoghi tra i personaggi acquisirà una dimensione profonda, filosofica, soprattutto quando il nostro commissario si troverà faccia a faccia col male che sta cercando di stanare, di fronte a personalità agghiaccianti che potrebbero apparire così crudeli da risultare inverosimili ma che proprio da questa incredulità traggono il proprio vantaggio e prosperano, come la Storia ci ha insegnato.
Il confronto tra bene e male è al centro di questo racconto che, seppur impegnato nei contenuti, si legge con piacere e non fa altro che confermare in Dürrenmatt le peculiarità del grande autore, poliedrico e capace di coniugare alta letteratura con racconti affascinanti, che possono piacere a tutti.
“Come singoli non possiamo salvare il mondo, sarebbe un'impresa disperata come quella del povero Sisifo. Il mondo non è nelle nostre mani, nemmeno nelle mani di un potente o di un popolo o in quelle del diavolo, che pure è potentissimo, bensì nelle mani di Dio, che prende da solo le sue decisioni. Noi possiamo essere d'aiuto soltanto in singoli casi, non in generale, è il limite del povero ebreo Gulliver, è il limite di tutti gli uomini. Dunque non dobbiamo cercare di salvare il mondo, ma di resistere, l'unica vera avventura che ancora ci resti in quest'epoca tarda.”
Indicazioni utili
Pregiudizi
Leggendo il nome dell’autore di questo racconto, Jonas Hassen Khemiri, non avrei mai detto che si trattasse di un autore svedese, sebbene i due nomi possano suggerirlo. Sebbene la mia sia stata un’associazione inconscia, il fatto che mi sia focalizzato sul cognome arabo rimanda al pregiudizio che l’autore stesso prova a denunciare in questa sua storia piuttosto particolare.
Come dicevo, l’autore di questo racconto è svedese, e costruisce questo racconto partendo dai pregiudizi razziali che sembrano dilagare nella nazione scandinava. Il protagonista è Amor, evidentemente di origine araba, che sperimenta una sorta di frammentazione dell’Io dovuta agli sguardi indagatori che lo circondano, resi ancor più attenti a causa dell’esplosione di un’autobomba. Amor è un individuo fragile, coi suoi problemi, e questa situazione di stress lo porta a un punto di rottura e a dubitare di sé stesso, delle sue azioni, della sua sanità mentale; tutte le sue certezze vacillano e quasi arriva a identificarsi coi suoi oppressori, a dubitare della sua innocenza, a giudicare se stesso.
Il racconto è strutturato in maniera particolare, con un mix tra dialoghi telefonici e narrazione in prima persona, creando una sorta di flusso di coscienza nel quale fanno capolino anche i pensieri delle persone con cui Amor sta dialogando. Il risultato è curioso, a volte piuttosto confusionario, ma originale: non direi che si tratta di un tipo di narrazione che incontra i miei gusti, ma certo non si può dire che sia insensata o non possa piacere a un altro tipo di lettore.
Quello che emerge, dunque, è la sensazione di continua oppressione e pregiudizio che (a quanto pare) dilaga nella nazione svedese nei confronti dei suoi abitanti di pelle scura, sempre guardati con sospetto e soggetti a pregiudizi che, a causa dell’accanimento delle forze dell’ordine, a un occhio superficiale potrebbero essere addirittura confermati: se infatti, in un auto della polizia, vediamo continuamente persone che corrispondono a certi connotati fisici, è umano sviluppare una certa idea; ma una persona riflessiva e assennata dovrebbe essere in grado di capire che, in un determinato contesto, quella tal persona può essere stata messa lì senza motivo e che dunque quel che vediamo non prova un bel niente, anzi prova soltanto la società malata che ci circonda. Questo aspetto emerge, più che dal racconto, dalla lettera che lo stesso Khemiri ha inviato al ministro della giustizia Beatrice Ask, inserita in quest’edizione Einaudi subito dopo il racconto e che, personalmente, ho trovato più interessante del racconto stesso e contribuisce a rafforzarne i contenuti.
In conclusione, si tratta di un racconto interessante che chiarisce dinamiche di una nazione che conoscevo poco e che, erroneamente, non credevo fosse scenario di tali discriminazioni. Com’è che si dice? Tutto il mondo è paese? Magari un pizzico di verità c’è, in questo luogo comune.
Un De Giovanni "fuoriserie"
Sarebbe interessante, per ogni libro che si legge che sia degno di nota, riuscire a fare anche brevemente quattro chiacchiere con l’autore: sentire la sua viva voce, scoprire da cosa hanno avuto origine certe idee e certi elementi che ci ritroviamo a incontrare all’interno del suo lavoro. Per “L’equazione del cuore” di Maurizio De Giovanni ho avuto questa fortuna, essendo lui venuto in un liceo classico della mia città per una presentazione (molto riuscita per diversi motivi, devo dire, e anche per merito dell’autore stesso). Ora, io non sono un lettore assiduo di Maurizio De Giovanni, oltre questo romanzo ho letto di suo soltanto “Il resto della settimana”, che a sua volta mi era piaciuto molto perché incentrato su come Napoli vive la passione per il calcio, cosa che mi tocca molto da vicino. Devo dire tuttavia che non mi sono accostato (almeno non ancora) alle sue serie più famose, quella dei Bastardi di Pizzofalcone e del Commissario Ricciardi, per la mia difficoltà a impegnarmi a seguire assiduamente una serie letteraria; ricordo ancora il fallimento disastroso con “La torre nera” di King, che poi non mi era nemmeno dispiaciuto. Devo dire, tuttavia, che De Giovanni ha le qualità dello scrittore di valore a cui forse la produzione seriale sta un po’ stretta e che inoltre, come lui stesso ha ammesso, soffre del pregiudizio da sempre riservato agli scrittori di genere: l’indifferenza della critica. Questo è un male che andrebbe estirpato e che getta ombre su opere letterarie di enorme valore, come quelle prodotte da un Ray Bradbury e da uno Stephen King, che pure hanno prodotto capolavori come “Cronache Marziane” e “Il miglio verde”. Un male che, da scrittore ancora accidentato, mi tocca da vicino. Mi sto dilungando, ma questo è segno di come lo stimolante confronto con un autore possa aprire a riflessioni molto ampie.
La trama de “L’equazione del cuore” si focalizza sul personaggio di Massimo De Gaudio, insegnante di matematica in pensione che alla matematica ha dedicato tutto sé stesso, e che per mezzo della matematica giudica tutto il mondo intorno a lui. Massimo è un uomo freddo, distaccato, che ha perso presto sua moglie e ha lasciato che sua figlia si trasferisse molto lontano senza opporre poi una grande resistenza, limitandosi alla “chiamata della domenica” e accontentandosi dell’ormai vuoto “tutto bene” dato in risposta all’altrettanto vuoto “come va?”. Sarà un evento tragico a mettere in discussione nuovamente tutta la vita di Massimo, che si ritroverà costretto a fare i conti con sé stesso, col suo passato, col suo modo di relazionarsi col mondo e coi suoi affetti: in particolare col suo nipotino Checco, che vede in lui un punto di riferimento nonostante la sua lontananza e la sua freddezza.
“L’equazione del cuore” è un romanzo piacevole, interessante, che può occuparvi piacevolmente un paio di giornate. Non sarà un capolavoro, ma posso dire che ci dà indicazione di quanto De Giovanni possa aspirare a qualcosa di più; che abbia in sé le capacità per staccarsi di dosso l’etichetta di autore di genere e passare a uno step successivo… sebbene la cosa più giusta sarebbe che il mondo smettesse di affibbiare un'etichetta agli autori di genere, valutandoli senza pregiudizi e ammettendo finalmente che l’appartenenza a un genere non debba necessariamente intaccare il giudizio sulla “letterarietà” di un’opera. “L’equazione del cuore” mantiene l’impronta giallistica: c’è sempre un mistero da risolvere, delle morti sospette, qualcosa che deve tenere il lettore incollato alle pagine, ma come dico sempre la vera bravura di un’autore sta nel coniugare intrattenimento e riflessione, divertimento e poesia. Questa è, come intuiva Calvino, la direzione che dovrebbe prendere la letteratura nel nuovo millennio: i lettori cambiano e devono cambiare necessariamente anche gli scrittori: lo ha capito King, lo hanno capito gli sceneggiatori come Jonathan Nolan, lo ha probabilmente capito De Giovanni, che forse deve armarsi di coraggio e mettere in stand by per un po’ le produzioni seriali, imporsi con gli editori, e cercare un’altra strada che non è detto debba essere completamente nuova, ma possa arricchirsi di nuovi elementi di valore.
“Se mi senti, capisci questo: due sistemi, come per esempio due persone, o due anime, o due mondi, se entrano in contatto, per sempre, finché esisteranno, risentiranno l'uno dell'altro. Potremmo dire che questa scoperta, fatta da un solitario e silenzioso ragazzo nel secolo scorso, sia l'equazione che ci racconta. Potremmo proprio dirlo.”
Indicazioni utili
Il pathos della distanza
Secondo romanzo della cosiddetta Trilogia degli antenati, “Il barone rampante” è probabilmente il romanzo più conosciuto dei tre, e forse tra i romanzi più famosi di Italo Calvino. Tuttavia devo dire che l’ho apprezzato meno del suo predecessore “Il visconte dimezzato”.
A parte i gusti - che sono opinabili - le vicende di Cosimo barone di Rondò hanno inizio a partire dalla sua decisione di ritirarsi sugli alberi, in seguito a un alterco familiare che ha per protagoniste le lumache cucinate da sua sorella che lui si rifiuta di mangiare. Per palesare la sua disapprovazione nei confronti di questo pasto - ma molto più probabilmente di una famiglia composta da personalità particolari, con le quali non può più convivere - Cosimo deciderà di arrampicarsi sugli alberi accanto alla tenuta: una decisione che parrà inizialmente frutto di un capriccio infantile e temporaneo, ma che finirà per trasformarsi in un proposito solido dal quale il protagonista non si staccherà mai, per alcun motivo al mondo.
Ma per quale motivo Cosimo trasforma questa sua ribellione in una specie di ideale? Perché questa presa di posizione? Difficile da dire, sta di fatto che mai il protagonista verrà meno a questa sua decisione, e nemmeno l’amore profondo per due donne - Viola e Ursula - sarà in grado di smuoverlo da questa posizione. Da questo punto di vista Cosimo è l’emblema del perfetto idealista che non scende mai a compromessi: di colui il quale sacrifica sé stesso a qualcosa e non è mai disposto a indulgere su nulla, a costo di provocare a sé stesso un’enorme sofferenza.
Nella postfazione dell’edizione Mondadori viene citato quello che Nietzsche chiama il pathos della distanza, che pone certi individui - aristocratici - a una sopraelevata distanza rispetto agli altri. Questo concetto viene applicato proprio a Cosimo il quale non solo concettualmente, ma anche letteralmente si trova a una posizione sopraelevata rispetto agli altri personaggi e pare poterli osservare meglio, oltre che risparmiarsi le brutture che una visione ravvicinata comporterebbe (metaforicamente parlando, ovviamente). A Cosimo, da questo punto di vista, si può associare la figura dell’intellettuale che, seppur possa porsi a una posizione di superiorità rispetto agli altri, deve poi fare i conti con l’alienazione che ne deriva. Cosimo, tuttavia, non si separa mai totalmente dagli altri esseri umani: non è un misantropo, anzi, lungo la sua vita ricerca sempre la presenza delle altre persone, il calore della passione, eppure non viene meno al suo proposito. Ma il distacco è sempre evidente, sempre impossibile da colmare, e sebbene Cosimo participi a tutti i grandi eventi a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, non può mai prendervi parte pienamente né giocarvi un ruolo che sia effettivamente importante, separato com’è dal resto del mondo.
Cos’è dunque Cosimo? un vincitore o un vinto, per metterla su un livello verghiano?
Tutto sta nel comprenderne i motivi… ma questo non è assolutamente semplice. Se il suo intento è una dimostrazione d’integrità, allora Cosimo è un vincitore a tutti gli effetti.
Negli altri casi, beh… il dibattito è aperto.
“- Mio fratello sostiene, - risposi, - che chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria, - e il Voltaire apprezzò molto la risposta.”
Johnny il Creosoto
Lansdale è uno di quegli autori che, nel mezzo della sua prolifica produzione, alterna diversi lavori che rappresentano un piacevole passatempo e nulla più e altri che invece riescono a distinguersi e a lasciare un segno più profondo. Anche se non ai livelli di “Paradise Sky”- che ancora considero uno dei suoi libri più riusciti - “Moon Lake” è probabilmente uno di questi. Intendiamoci, stiamo comunque parlando di un thriller votato principalmente all’intrattenimento, ma lo metterei un gradino più in alto delle produzioni seriali che potrebbe produrre un Connelly, un Deaver, o lo stesso Lansdale nei suoi romanzi che hanno come protagonisti Hap e Leonard.
Le atmosfere che ci ritroviamo davanti in questo romanzo hanno tinte molto fosche, orrorifiche (un po’ alla King), così come inquietanti e disturbanti sono le vicende che ci ritroviamo a seguire, che un po’ portano alla mente quella prima stagione di True Detective che gli amanti del genere considerano un capolavoro irraggiungibile. In realtà, è possibile che Lansdale ne abbia tratto qualche spunto. Lo stile dell’autore è quello a cui ci ha sempre abituati: diretto, coinvolgente, reso anche evocativo dall’ambientazione che ha deciso di utilizzare e dunque arricchito di un elemento in più. Lansdale non sarà McCarthy o Roth, ma nella schiera di autori tra i quali viene collocato ha un qualcosa in più che lo pone su un gradino più alto.
Ma di cosa parla “Moon Lake”? Al centro della storia c’è proprio il lago, che molti anni prima ospitava la vecchia città di Long Lincoln, nella quale i genitori del protagonista si sono conosciuti. Un giorno, non senza preavviso ma comunque con disinteresse per le vite di chi abitava la città, le dighe vengono fatte saltare e la città viene sommersa così che New Long Lincoln possa sorgere. Tuttavia, i fantasmi di coloro che sono morti (non prendetemi in maniera letterale, non del tutto) non rimarranno sul fondo di quelle acque nere e sulla città nuova aleggeranno sempre i misteri che riguardano i responsabili di questo genocidio; un genocidio che verrà arricchito da una serie di morti che, durante gli anni, diventeranno una costante ma saranno sempre avvolte dal più profondo silenzio. La narrazione avrà inizio con la decisione del padre del protagonista di caricare le valigie in auto e andar via insieme a suo figlio, salvo poi mostrare le sue vere intenzioni: gettarsi in fondo al lago e porre fine a quella vita che, da quando sua moglie è andata via, si è svuotata di senso. Il piccolo Daniel verrà salvato da Ronnie, un’adolescente di colore, e starà a casa sua per il tempo necessario ad affezionarsi alla sua famiglia e innamorarsi della ragazza. Ma New Long Lincoln è un luogo pieno di pregiudizi razziali e dunque Daniel sarà costretto a trasferirsi da una zia con la quale non ha mai intrattenuto rapporti.
Il grosso della storia, tuttavia, si incentra sul ritorno di Daniel a New Long Lincoln, da adulto. I fantasmi del passato riemergeranno ma assumeranno una consistenza, e le ombre che si celano dietro i misteri della città dei volti, i quali ruotano intorno all’inquietante figura simbolica di Johnny il Creosoto.
Chi è amante del genere, secondo me lo gradirà.
“Siamo esattamente questo. Lasciate che vi dica cosa siete voi due, invece. Due esseri insignificanti. Incastrati in una trappola di morale, etica e luoghi comuni. Una specie di vetrina addobbata della vita. E lasciate che vi dica anche cos'è la vita. La vita non è altro che sopravvivenza. Darwin non ha scoperto che l'empatia ci ha aiutati a sopravvivere, ha scoperto che i più forti e i più determinati ci hanno permesso di sopravvivere.”
L'umanità riflessa in un mostruoso specchio
Come specificato nell'appendice dal traduttore di questo classico, "I viaggi di Gulliver" è spesso classificato come un romanzo per ragazzi. A essere sincero, per molti anni avevo creduto fosse proprio così e forse inconsciamente ne ho rimandato la lettura proprio per questo motivo. Mi sbagliavo così come si sbagliano le masse: quello di Swift è un romanzo feroce e dalla fortissima impronta satirica, di cui l'autore era un vero e proprio maestro. La satira di Swift ha come bersaglio l'umanità tutta, e i viaggi del suo protagonista in mezzo a popolazioni strambe, sproporzionate e impensabili non sono altro che un espediente per poter mettere in risalto quelli che sono i nostri difetti, i nostri vizi, le deformità nostre e della società che ci siamo costruiti.
Questo, di certo un ragazzo non può arrivare a capirlo sebbene possa godersi il percorso e ridere di tutte le stramberie che il protagonista si ritroverà davanti.
Quando si pensa a Gulliver si pensa in maniera automatica a Lilliput e ai suoi abitanti, ma questo è solo uno dei diversi viaggi in cui il protagonista si troverà coinvolto, ognuno dei quali ci mostrerà società diverse e principalmente utopiche, sebbene ognuna, anche la più perfetta, presenti i suoi lati oscuri. Le virtù desiderabili di queste popolazioni, tuttavia, sono un metro di paragone spietato per giudicare e mettere in risalto le controversie e i problemi di quella che era l'Inghilterra del Settecento (e come aveva già fatto Thomas More nel suo "Utopia") ma in fondo dell'Umanità tutta: una razza che fa del vizio una virtù, che sparge sangue per motivi futili, attratta da cose senza valore e incapace di mettere a frutto quel pizzico di Ragione che la Natura gli ha donato, anzi, l'adopera per essere ancora più spietato e insensato. Eppure, almeno fino a un certo punto, Gulliver sembrerà il più accorato difensore della sua razza, dipingendo di fronte a sovrani stranieri un'immagine idilliaca dell'essere umano in maniera assolutamente candida. Queste bugie inconsapevoli, tuttavia, saranno viste sia dagli interlocutori sia dallo stesso lettore come qualcosa di straniero, come una bugia talmente grossa da portare la realtà a galla in maniera molto più forte: per mezzo di questo paradosso, per mezzo di una bugia, per mezzo di un'immagine positiva, l'essere umano emerge in tutta la sua meschinità, ingordigia, malvagità. Davvero non si può negare la bravura di Swift, in questo senso, e come il lettore si rende gradualmente conto di qual è la verità, così se ne renderà conto lo stesso protagonista, arrivando a considerare i suoi simili come bestie selvagge e mal sopportando la presenza anche di sua moglie e dei suoi figli: rappresentanti di una specie lontanissima dalla virtù mostrata dall'ultima popolazione da lui visitata, quella degli Houyhnhnm, i cavalli senzienti.
Satira, rovesciamenti, paradossi: questo è "I viaggi di Gulliver" di Swift, un romanzo che può essere letto dai ragazzi ma può essere compreso appieno soltanto da adulti.
“Quanto a voi (proseguì il Re), che avete passato la maggior parte della vita a viaggiare, sono dispostissimo a credere che finora siate forse sfuggito a tanti vizi della vostra patria. Ma da quanto ho capito dal vostro racconto, e dalle risposte che con tanta fatica vi ho strappato ed estorto, non posso se non concludere che la massa dei vostri indigeni sia la più perniciosa razza di piccoli odiosi parassiti che la Natura abbia mai tollerato strisciasse sulla faccia della terra.”
Indicazioni utili
There ain't no such thing as a free lunch
Considerato uno dei grandi della fantascienza del Novecento, la mia prima lettura di Heinlein era per questo motivo carica di aspettative. A differenza di Stanislaw Lem, Heinlein sembra essere un autore più conosciuto, tanto è vero che una persona che mi ha visto leggere il romanzo ne ha tessuto le lodi, lasciandomi stupito.
Devo essere sincero, recensire questo romanzo è molto complicato per me: non posso dire di averlo amato, per diversi motivi, ma non posso neanche dire che non appartenga a una fantascienza di livello superiore, quella che a me piace tanto leggere. Tuttavia, a mio parere, quella di Heinlein è una fantascienza più tecnico-teorica che filosofica, a differenza di quella di Lem e Bradbury, forse più vicina a quella di Asimov. Nessuna sorpresa dunque che io preferisca Ray e Stanislaw a Robert e Isaac. Ciò non toglie che questa lettura ha stimolato in me la voglia di approfondire l’autore, sebbene la lettura mi sia risultata a tratti lenta e difficoltosa: a tratti, infatti, questo romanzo sembra quasi un saggio su come condurre una Rivoluzione, sia a caratteri generali che specifici del contesto qui narrato, ovvero la Luna come colonia penale.
All’inizio l’autore ci introduce uno dei dilemmi principali della fantascienza: può una macchina essere autocoscienze? Il computer più elaborato della Luna è infatti un modello avanzatissimo, capace di calcoli che anche i calcolatori che noi oggi conosciamo potrebbero soltanto sognare, talmente avanzato da sviluppare una sorta di personalità venata di umorismo, sensibilità e irritabilità. Questo computer ha il nome di Mike, ma il dilemma riguardo la sua autocoscienza viene subito accantonato (sebbene sia palese, durante il romanzo, che lo sia) a favore del suo ruolo nella Rivoluzione che gli abitanti della Luna vogliono mettere in atto per liberarsi dal giogo dell’Ente Lunare e della terra, che lo controlla. In base ai calcoli di Mike, infatti, lasciando l’Ente al potere e non ribellandosi alla schiavitù della Terra gli abitanti della Luna finirebbero per morire di fame e stenti nel giro di sette anni. Comincia dunque, da parte di Mike, di un tecnico informatico (il protagonista), un professore e di una donna di nome Wyoming, l’organizzazione di un movimento di ribellione che porterà a quella che sarà una vera e propria guerra contro la Terra.
Questo movimento ribelle vedrà la sua nascita fin dalle prime pagine e Heinlein non tralascerà nemmeno il più piccolo dettaglio riguardo alle problematiche e alle probabili evoluzioni che questo percorso potrà presentare ai protagonisti: così come il computer da lui ideato, l’autore previene qualsiasi obiezione del lettore e non lascia nulla al caso. Questa precisione tuttavia, appesantisce un po’ la lettura sfociando in tecnicismi e dettagli che il lettore non può considerare superflui ma potrebbe trovare piuttosto pesanti e a volte troppo articolati. I momenti di azione, inevitabili dopo tanta preparazione, sono coinvolgenti e soddisfacenti ma vengono pagati a caro prezzo. Dunque, direi che “La luna è una severa maestra” è una fantascienza adatta a chi ama i suoi aspetti più tecnico-teorici, a chi ama Asimov, a chi apprezza una narrazione lineare e impregnata di logica. Chi invece ama la fantascienza che usa i propri espedienti per scandagliare l’animo umano e scrutarlo ancora più a fondo, potrebbe restarne un po’ deluso. Nonostante questo ho intenzione di leggere altro di Heinlein perché, oltre ad essere una penna meritevole, ho la sensazione che la sua produzione possa serbare qualche piacevole sorpresa.
“Dev'essere un desiderio insopprimibile dell'animo umano quello di impedire al prossimo di fare ciò che vuole. Regole, leggi... sempre per gli altri: una prerogativa misteriosa del nostro essere, che dovevamo avere prima di venire giù dagli alberi e che non ci eravamo scrollati di dosso nemmeno quando avevamo cominciato a camminare su due gambe. Nessuno dei presenti si alzava a dire: "Per piacere, approvate questa legge, in modo che io non possa fare più una certa cosa che so che non dovrei fare!". Nyet, tovarish, si trattava sempre di una cosa che non volevano che facesse il vicino. Naturalmente volevano proibirglielo per il suo bene, non perché il sostenitore della proposta sostenesse che la cosa gli dava fastidio.”
Colonialismo inglese
Uno di quei classici che, nella vita, prima o poi vanno letti; probabilmente uno dei primi romanzi d’avventura che siano stati mai scritti. Non ci si possono certo aspettare i ritmi moderni, né quei colpi di scena da mascella spalancata che piacciono tanto oggi ai fruitori di romanzi d’intrattenimento e serie tv. Robinson Crusoe è un figlio del suo tempo, di una forma romanzo ancora agli albori e che è un po’ lo specchio della società inglese in cui Daniel Defoe viveva.
All’interno del romanzo, infatti, non ci vengono descritte solo le disavventure dello sfortunato naufrago Robinson Crusoe, ma anche quella che è l’uomo del Settecento soprattutto in Inghilterra, dove il colonialismo è ormai diventato una realtà consolidata, quasi onnipresente nella vita sociale; un periodo in cui cominciano a vacillare le certezze e comincia ad affermarsi l’individualismo, la voglia dei componenti della classe medio borghese di fare un salto in alto e di affermarsi. Robinson è uno di questi “ribelli”: che rifiuta la propria condizione agiata che la sua famiglia vorrebbe regalargli per ritagliarsi uno spazio nel mondo; accantona quelli che sono i valori (soprattutto religiosi) che erano peculiari delle masse di quella specifica classe sociale e cerca, all’inizio quasi trascinato soltanto da un’irrequietezza giovanile, la propria posizione nel mondo.
Il percorso di Robinson è un percorso di redenzione, che lo porta dall’irrequietezza giovanile e alla voglia di ribellarsi, di nuovo verso quei valori dai quali era fuggito e, in particolare, alla religione e a Dio. In seguito alle sue disavventure, si pente della propria condotta e riconosce nuovamente quelli che sono i vecchi valori, i pensieri paterni, sebbene continui nel suo animo a insinuarsi il dubbio che è preludio di un cambiamento inevitabile, solo rimandato. Il naufragio non è che l’inizio di un percorso che porterà Robinson a costruire sé stesso: egli è infatti il cosiddetto self-made man, quell’uomo che si è fatto da solo. Egli è viva dimostrazione del fatto che, in condizione di estrema difficoltà, l’uomo è in grado di tirar fuori capacità che non riteneva nemmeno di avere, sebbene il nostro caro Robinson sia stato aiutato in maniera piuttosto consistente da quella che forse noi chiameremmo Fortuna ma lui identifica con la Provvidenza. Eh sì, la Provvidenza, che in Robinson Crusoe ha una centralità quasi manzoniana e che viene contemplata seriamente proprio nel momento in cui, a causa della malattia, Robinson guarda in faccia alla morte. La malattia rappresenta il momento della conversione, il momento di riconoscimento di quel Dio che fino ad allora non era stato nemmeno contemplato e che adesso sarà il vero punto di riferimento di Robinson che, bisogna dirlo, non ha altro.
Oltre all’aspetto religioso, come dicevamo, viene fuori anche quella mentalità coloniale tipica dell’Inghilterra del tempo: una volta stabilitosi in maniera sicura sull’isola, infatti, Robinson si considererà una sorta di “governatore” della stessa, considerandola come una proprietà privata. All’arrivo di colui che poi diventerà suo servitore, Venerdì, quest’aspetto si farà ancor più palese: la prima cosa che gli insegnerà sarà infatti a chiamarlo “padrone”, per poi insegnarli la lingua inglese. Infine, tenterà di convertirlo alla devozione per Gesù Cristo, concludendo il cerchio di quelle che sono le caratteristiche del colono perfetto.
Robinson Crusoe è un romanzo non semplice da leggere, carico di dettagli fin quasi a sfiancare, ma rappresenta uno di quei pilastri con i quali prima o poi un buon lettore deve confrontarsi, oltre a essere un eccellente specchio dell’epoca e della società in cui l’autore ha vissuto.
“E poi mi rimproverai la mia natura ingrata, e di aver pianto per il mio stato solitario; e ora che cosa non avrei dato per essere di nuovo a riva laggiù! Cosí noi non vediamo mai qual è il nostro vero stato finché non ci viene illuminato dal confronto con uno stato contrario; né sappiamo apprezzare il bene di cui godiamo se non quando ci manca.”
Escher
Un romanzo brevissimo, enigmatico e dalle tinte piuttosto fosche.
La frase “la casa si trasforma in un puzzle di Escher”, scritta nella trama, è bastata a convincermi a dare una possibilità a questo autore tedesco (altro punto a favore), Daniel Kehlmann, che pare sia principalmente famoso per il suo romanzo “La misura del mondo”. Nel corso della narrazione il lettore si rende conto che anche la prosa si trasforma in una sorta di puzzle, un insieme di pezzi che man mano che si procede si deformano e smettono di combaciare, così come accade nella vita del protagonista. C’è da dire che, in questo racconto, l’armonia non compare quasi mai nemmeno nella sua vita privata, che anzi paradossalmente troverà un momento di equilibrio solo quando il mondo intorno sarà deformati irrimediabilmente, non lasciando spazio ad alcuna riconciliazione.
In breve - altrimenti si finirebbe per raccontare l’intero romanzo - uno sceneggiatore decide di fare una vacanza in una casa in montagna per completare la sceneggiatura del seguito del suo film di maggiore successo - a mio avviso una mezza porcata - nella speranza di avere il tempo e la tranquillità per lavorarci seriamente. Peccato che sua moglie e sua figlia non siano granché d’accordo e già prima che la casa cominci a “dare i numeri” lo distolgano continuamente dal suo intento. A essere sincero, in più punti e in più idee si vedono le tracce e le influenze del caro Stephen King: il romanziere che si “isola” per completare il suo lavoro, il “terreno maledetto” che ci ricorda un po’ l’idea alla base del “Pet Sematary”… l’autore tedesco in questo caso sembra dovere molto all’americano.
Sebbene l’idea sia intrigante e la scelta di stile anche piuttosto azzeccata, vuoi per la brevità del racconto o per alcuni cliché, il lavoro di Kehlmann si conclude in fretta e non lascia chissà quale impressione. Purtroppo i racconti brevi devono essere particolarmente incisivi, altrimenti ti lasciano indifferente. Probabilmente Kehlmann, se non l’ha già fatto, in questo senso dovrebbe lasciarsi guidare dall’esempio di un altro autore di lingua tedesca che in quest’arte eccelleva: il mio caro Friedrich Dürrenmatt.
Ma per ora… rimandato.
“È questo posto. Non è la casa. La casa in sé è innocua, semplicemente sorge dove sarebbe stato meglio non sorgesse. Suppongo che esistano molti luoghi come questo, ma probabilmente gli altri sono irraggiungibili, in fondo al mare o all'interno di grotte in cui nessuno ha ancora messo piede. O invece qui ne esiste soltanto uno, e il prossimo è distante anni luce nell'universo infinito. Solo a pensarci c'è da impazzire - un infinito reale, non immaginario, pieno di oggetti, esseri e galassie e ammassi di galassie e ammassi di ammassi di galassie e così via, senza fine in nessuna direzione. E qua e là punti dove la materia diventa rarefatta. Parole. Non rendono l'idea di com'è veramente.”
CROCIFIGGERSI PER I PROPRI ERRORI
Kurt Vonnegut è un autore che si distingue sempre per il suo stile pregno di una sottile ironia, che riesce sempre in un modo o nell’altro a inserire nei suoi romanzi. In questo caso ci pensa il nostro protagonista, Rabo Karabekian, a portare l’ironia dell’autore all’interno di questo romanzo: “Barbablù”. Innanzitutto bisogna chiarire il titolo di questo romanzo: fa riferimento alla storia di Barbablù, uomo che ha avuto diverse mogli e che, sulle orme del Dio dell’Antico Testamento, non vieta a loro nulla se non una cosa apparentemente irrilevante: varcare la soglia di una precisa stanza della casa. Come gli Adamo ed Eva dell’Eden, finiranno tutte per caderci. Anche Rabo Karabekian ha la sua “stanza segreta”, consistente in un vecchio patataio nel quale pare racchiuda il suo più grande segreto, il commiato al mondo di un uomo che per tutta la sua vita ha sempre guardato alla grandezza da lontano, privo a detta degli altri ma anche di sé stesso di quella scintilla che sarebbe stata necessaria a renderlo grande, uno di quegli artisti che si ricordano nei secoli dei secoli.
“Barbablù” non è altro che la biografia dell’uomo raccontata dallo stesso Karabekian, in cui passato e futuro si alternano egregiamente senza mai confondere il lettore. Ciò che traspare è proprio la tendenza del protagonista a sminuirsi; a credere di non essere degno di nota, di essere un ottimo imitatore, quasi un fotografo della realtà, incapace però di mettere trasporre sulla tela quell’elemento mistico che fa di un buon imitatore un grande pittore. Ecco perché egli vivrà, seppur ben integrato nella cerchia dei grandi artisti impressionisti americani della sua epoca, sempre defilato: più un protettore che un artista, più un mecenate che in ogni modo cerca di sostenere i suoi compagni e che, alla fine, ne sarà premiato con una collezione di quadri che finiranno per valere una fortuna. Rabo Karabekian, infatti, vivrà negli agi; agi di cui tuttavia non saprà mai che farsene essendo venuto meno quel sogno che lui non formula mai esplicitamente, che sminuisce, ma che in fondo il lettore percepisce essere un qualcosa il cui mancato raggiungimento lo tormenta. Un tormento che lui prova a celare con forte autoironia a volte anche un po’ crudele, forse unico mezzo che ha trovato per non soccombere a questa frustrazione, a questo fallimento. Questo atteggiamento è “cosa da riflettere”: come reagiremmo, infatti, se uno dei nostri sogni si rivelasse troppo grande, per noi? Come reagiremmo? Ci dispereremmo o, come Rabo Karabekian, troveremmo un modo perché questo pensiero non ci tormenti tanto da farci soccombere?
Quello che il nostro novello Barbablù cela nel suo patataio rappresenta la sua rivalsa contro le ingiurie del mondo e di sé stesso, un qualcosa che ha finito per essere travolto dallo stesso giudizio inclemente che ha travolto tutto il resto della vita del protagonista; un qualcosa che avrebbe potuto mostrare agli occhi del mondo la rivincita di un uomo bistrattato per i suoi errori, ben prima della sua morte. Forse a volte bisognerebbe, indipendente da quanti errori gravi o meno si siano compiuti nella vita, cercare di essere un po’ meno duri con sé stessi: non sia mai che anche noi, novelli Barbablù, celassimo qualcosa di meraviglioso agli occhi del mondo solo per codardia.
"E che cos'è, Rabo, la letteratura, se non un bollettino parrocchiale su faccende riguardanti alcune molecole, di nessuna importanza per nessuno nell'universo, tranne che per poche molecole affette dalla malattia chiamata pensiero?"
L'esercito italiano di commissari e vicequestori
Antonio Manzini è probabilmente uno degli autori più letti d’Italia: lo deduco dal fatto che mi ritrovo ogni suo romanzo sempre in classifica, appena ne esce uno, e devo dire che Sellerio sceglie sempre le immagini di copertina con saggezza, perché restano impresse. Dunque devo dire che Manzini aveva già destato in me un po’ di curiosità, e alla fine eccomi qui, a esprimervi la mia opinione sulla sua ultima fatica: “Le ossa parlano”.
Che dire… mi è ormai ben chiaro quello che piace a gran parte del pubblico di lettori italiano: commissari, ispettori e (come nel caso del Rocco Schiavone di Manzini) vicequestori in tutte le salse. I gusti letterari (e non solo) delle masse italiche non sono poi così variegati. Tralasciando questo discorso - che richiederebbe un triste incontro di dibattito di diverse ore - bisogna che io analizzi questo romanzo slegandomi da queste considerazioni. Se devo dare un pregio principe a questo romanzo è probabilmente il suo protagonista. Molti mi diranno che è una considerazione un po’ scontata, perché un buon protagonista dovrebbe essere la conditio sine qua non per la realizzazione di una serie di romanzi di successo: vi immaginate un Chandler senza Marlowe (anche se riferendoci a Chandler parliamo di un autore dall’alto spessore letterario), un Camilleri senza Montalbano, un De Giovanni senza Ricciardi? No, ma al giorno d’oggi nulla è scontato e bisogna dire che Manzini ha disegnato un protagonista di un certo spessore: sfaccettato, tormentato, dolce e amaro, che sa strappare un sorriso ma anche innervosire per i suoi comportamenti a volte insensati e dunque umani… ovviamente pieno di donne, come il 99% dei personaggi del genere, ma sto tornando al discorso di cui sopra e mi fermo subito. Proprio parlando del genere di ironia usata da Manzini, devo dire che riesce a strappare più di un sorriso grazie alla colorita dialettica romana di Schiavone, ma anche grazie ai personaggi di contorno: divertente è infatti, per esempio, la scena della scrittura della lettera a Italo, anche se si tratta di un espediente comico molto simile a quello di napoletana memoria che ha come protagonisti Totò e Peppino De Filippo. Non ho potuto fare a meno di pensarci.
Oltre questo, la storia è incalzante e si lascia leggere: il lettore vuole procedere, sapere come andrà a finire, scoprire chi è l’assassino. Rispettata dunque la seconda conditio sine qua non del genere, sebbene manchi il fattore mascella spalancata alla scoperta dell’assassino; ma penso che ormai questo elemento sia stato esaurito dai milioni di romanzi scritti dalla nascita del genere a oggi e soprattutto grazie a quella geniaccia che era la Christie (come fai a competere con una che ti mette come assassino il narratore o tutti i maledetti personaggi della storia?). La trama - lo capirete leggendola - non è certo qualcosa di leggero da sopportare, non è adatta a chi è debole soprattutto per quanto riguarda questo tipo di argomenti, ma procede in maniera spedita e lineare, senza contraddizioni né intoppi fino alla fine.
Leggibile senza aver letto altri romanzi dell’autore che hanno come protagonista Schiavone, “Le ossa parlano” è un romanzo che ovviamente lascia diverse questioni in sospeso in modo da alimentare l’attesa per la prossima uscita dell’autore, che evidentemente ha deciso di dedicare la sua vita nel delineare quella del suo personaggio di fiction. Scelte. Un romanzo che può piacere a tutti gli appassionati del genere ai quali, tuttavia, mi arrischio a dare anche un altro consiglio: leggete Manzini, leggete Camilleri, leggete De Giovanni… ma sappiate che esiste anche altro!
“Eccheccazzo!”, aggiungerei, citando lo stesso Manzini.
“I binari dell’esistenza si incontrano e si dividono senza lasciare neanche una traccia del loro coincidere.”
Idee irresistibili e piccoli spunti
Non è un mistero per chi mi conosce quanto io preferisca i romanzi ai racconti, ma è altrettanto vero che ci sono autori dei quali amo leggere anche quelli, e tra questi c’è ovviamente quello che in fondo è il mio autore preferito insieme a Cormac McCarthy: Ray Bradbury.
Oscar Mondadori sta facendo uscire praticamente tutta la produzione di Bradbury, con mio sommo piacere, tra cui queste raccolte che contengono decine e decine di esemplari delle sue narrazioni brevi, che lui amava tanto scrivere e che spesso scriveva di getto senza neanche pensare, come rispondendo a una necessità fisica: cosa che ci tiene a precisare soprattutto riguardo questa raccolta, “Ricordare Parigi”; nella prefazione infatti scrive: “[…] questi racconti non li ho meditati. Li ho scritti seguendo l'impulso del momento, che a volte nasceva da idee irresistibili, altre da piccoli spunti che cercavo di sviluppare”. Chi ama scrivere non faticherà a capire di cosa sta parlando l’autore, di come idee improvvise e fulminanti si presentino alla mente di una mente creativa e chiedano a gran voce di vivere e di essere espresse, nella speranza che colui al quale si sono presentate non sia pigro e sia nella giusta disposizione d’animo.
Bradbury era una vera e propria fucina di idee e racconti, le metteva su carta come fosse la più importante e anche l’ultima cosa che dovesse fare nella vita. Certo anche lui era umano, e anche questa raccolta è la dimostrazione che anche una mente eccelsa, geniale e poetica possa partorire a volte qualcosa che non sia poi così sensato o degno di nota. Questo per dire che “Ricordando Parigi” contiene in sé dei racconti secondo me memorabili, ma anche qualcuno trascurabile: non stiamo parlando di “Cronache Marziane”, insomma, ma c’è da dire che in mezzo ai racconti di Bradbury si finisce sempre per scovare qualche perla che alla fine ti fa pensare che ne sia valsa la pena: penso non tanto al racconto che da titolo a questa raccolta - forse paradossalmente il più dimenticabile dei 22 - ma ad altri come “Sentieri incrociati” (meraviglioso), “Massinello Pietro”, “Padre Caninus”, “Volate verso casa” (che ci riporta su Marte) o “L’estate della pietà” (che ci riporta molto alle atmosfere de “L’estate incantata” e “Il popolo dell’autunno”). Questi racconti sono in grado di emozionare come solo Bradbury sa fare: manipolando le parole con una tale maestria da renderle indimenticabili, toccando le corde della memoria e dei sentimenti, dando vita a metafore che si materializzano istantaneamente nella mente del lettore.
Considerato il tempo che si impiega nella lettura di queste brevi storie, sempre scorrevolissime, varrà sempre la pena passare sopra al fatto che alcune di esse siano dimenticabili, pur di godere di alcuni sprazzi di pura poesia e introspezione.
“Ma non puoi prevedere certe cose. Vedi troppe persone ogni settimana, ogni anno, e la maggior parte di loro sono destinate a perdersi nell'oscurità. Tutto quello che puoi fare, dopo, è riandare con la mente alla nebbia degli anni trascorsi e cercare di ritrovare le occasioni in cui la tua vita ha incrociato quella degli altri, sfiorandola. La stessa città, lo stesso ristorante, lo stesso cibo, la stessa aria, ma con due sentieri e modi di vivere differenti, ignari l'uno dell'altro.”
[Dal racconto “Sentieri incrociati”.]
Indicazioni utili
...su questo grande presepe di pazzi
Eduardo De Filippo è una di quelle presenze che, insieme a Totò, hanno accompagnato la mia crescita, seppur da lontano: essendone mio padre un grande appassionato, sul televisore di casa mia si susseguivano spesso le immagini delle opere teatrali e cinematografiche di questo autore che, lo si può dire senza alcun timore, è probabilmente tra le personalità più grandi che la mia terra abbia mai partorito. Dico “da lontano” perché, ragazzino com’ero, probabilmente portavo in me l’erroneo pregiudizio secondo il quale ciò che piace ai nostri genitori non può che essere diverso da ciò che piace a noi: generazioni diverse, gusti diversi, un ragionamento del tutto erroneo che si potrebbe smontare con cinque minuti di riflessione che fino a poco tempo fa non m’ero mai preso. Di recente, tuttavia, sembra che anche il mondo della televisione stia riportando in auge il nome del grande Eduardo, con rifacimenti moderni delle sue opere teatrali e film incentrati su alcuni momenti della sua vita. Nonostante la mia reticenza (o forse dovremmo chiamarla pigrizia) sentivo comunque che qualcosa mi attirava verso questa grande personalità, e il recente film “I fratelli De Filippo” ha vinto le mie ultime resistenze, che comunque prima o poi avrebbero finito per cedere.
Così, ho deciso di iniziare la mia scoperta d’Eduardo.
Quel che è interessante, nel leggere su carta un’opera scritta per essere rappresentata, è che ci si possono trovare sottigliezze sulla psicologia dei personaggi che non sempre gli attori riescono a rendere appieno (anche se non è il caso di Eduardo); dettagli che a un occhio disattento (e non solo) potrebbero sfuggire. Dunque il teatro di Eduardo va letto o visto? Secondo me va sia letto che visto: ecco perché mi sono appena fatto arrivare la sua opera quasi completa, e spero di potervene parlare, poco a poco, con sempre più entusiasmo.
Ma focalizziamoci sull’opera in questione. A casa mia, nel periodo natalizio, le immagini di “Natale in casa Cupiello” sono un baluardo che non cede quanto il presepe stesso; dunque, scene come quella della letterina di Natale letta da Tommasino non giungono del tutto nuove, ma inserite nell’intero contesto raggiungono una potenza e un ilarità ancora maggiori. Quel che tuttavia è veramente grande in Eduardo De Filippo - e ora posso dirlo con cognizione di causa, seppur ancora un po’ acerba - è la sua grande capacità di cogliere quella che è la realtà della famiglia napoletana. Certo, stiamo parlando di un’opera scritta e rappresentata quasi cent’anni fa: il concetto di famiglia e i rapporti tra i suoi componenti sono nettamente cambiati, ma molte di quelle peculiarità resistono ancora oggi. È incredibile vedere come Eduardo abbia colto e messo in scena sapientemente queste caratteristiche e controversie: i momenti d’ilarità e i momenti di tensione; i litigi furiosi dimenticati un attimo dopo; le parole velenose che ci si lancia a vicenda salvo poi sbranare chiunque si permetta di dire una parola fuori posto, riguardo quegli stessi familiari che poco prima avevamo trattato in modo inclemente. Il Natale non è che un pretesto: è il momento dell’anno in cui i veri sentimenti, che sia giusto o meno, vengono maggiormente fuori; in cui le tradizioni ci costringono a metterci a nudo come magari non faremmo durante il resto dell’anno. Ed è questo ciò che accade anche in casa Cupiello, tutto ciò che è “vero” viene fuori, travolge tutti come un fiume in piena e costringe i personaggi a fare i conti con la realtà. Chi più ne farà le spese è proprio Lucariello, il nostro protagonista, che in fin dei conti è rimasto un bambino, e che trovandosi ad affrontare d’improvviso una fase della vita che richiederebbe la forza d’un adulto riceve una batosta che non riesce a sopportare. Quel presepe, che tanto vorrebbe che a Tommasino piacesse, non è altro che il simbolo di quella puerilità che non l’ha mai abbandonato e che forse non ha mai voluto abbandonare: perché visto dagli occhi di un adulto questo mondo ci appare ancor più crudele e molto più a lungo.
Infine, forse quel “Presebbio” di cui parla Lucariello non è altro che quel “great stage of fools” di cui parla il grande Bardo per mezzo della voce del suo King Lear. E in effetti, con le giuste proporzioni, il destino del nostro povero Cupiello non si rivelerà tanto diverso da quello del famigerato re shakespeariano.
“[…] te piace ‘o Presebbio?”
Indicazioni utili
Un futuro (spaventosamente) possibile
Scrittore molto meno prolifico di King, Ken Follett è tuttavia un autore che non sforna mai romanzi che abbiano meno di seicento pagine, motivo per il quale ho sempre faticato ad armarmi del coraggio necessario a leggere uno dei suoi titoli. Non essendo un amante dell’epoca medievale, il suo più grande successo “I pilastri della terra” e relativi sequel non mi hanno mai attratto, mentre ero molto più interessato alla “Century Trilogy”, che probabilmente sarà la prossima che leggerò.
La mia prima lettura dell’autore è tuttavia ricaduta su “Per niente al mondo”, suo nuovo best-seller che abbandona la storia passata e si focalizza su un tragico futuro spaventosamente possibile. È lo stesso Ken Follett, nella premessa di questo romanzo, a dire di essere rimasto stupito di come una serie di eventi che se presi singolarmente potessero risultare di scarsa importanza abbiano portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. L’autore non esclude che questo possa accadere di nuovo e, con gli armamenti devastanti di cui sono dotate le potenze mondiali al giorno d’oggi, dar vita a un conflitto che potrebbe quasi spazzar via la razza umana in un battito di ciglia. È questa la premessa su cui si basa la narrazione di questo romanzo che mette in risalto le capacità di narratore di Ken Follett, in grado di tenere le redini di diversi archi narrativi anche molto lontani con grande maestria. Con la lettura di questo romanzo la mia curiosità per la “Century Trilogy” è aumentata, sebbene non sia rimasto davvero entusiasta da “Per niente al mondo”; non so infatti se avrei voglia di leggere altre settecento pagine di un eventuale sequel, anche se non è ben chiaro se il finale lasci spazio a seguiti.
Il romanzo comincia molto lentamente, probabilmente per costruire la psicologia dei personaggi fondamentali - alcuni più riusciti (Chang Kai) di altri (Pauline Green) - e per imbastire il plot che poi porterà al precipitare di eventi sempre più catastrofici. Cosa che mi ha un po' lasciato perplesso è lo sforzo speso per imbastire l’arco narrativo e la psicologia di alcuni personaggi e poi liquidarli improvvisamente e abbandonarli a sé stessi, per concentrarsi sulle tensioni tra America e Cina. A proposito, Europa e Russia sono gli angioletti della situazione e in questa guerra immaginata da Follett se ne stanno tranquilli, senza interferire. Quello che più colpisce è il come, effettivamente, una guerra nucleare possa scoppiare da un momento all’altro senza neanche rendersene conto, a causa di una catena di eventi che poi si potrebbe rivelare inarrestabile, inizialmente a causa dell’orgoglio delle nazioni coinvolte che non vorrebbero mai apparire deboli e si ritrovano costrette a rendere continuamente pan per focaccia, fino a poi arrivare a una situazione nella quale si deve necessariamente escludere ogni tipo di approccio pacifico, perché chi colpisce per ultimo è perduto. Attualmente le armi nucleari sono considerate un deterrente, ma fino a quando sarà così? Fino a quando i potenti della terra saranno abbastanza assennati da tenere lontano il dito da quel grosso pulsante rosso? Il fatto che ormai questo sia un timore generalizzato non deve fare altro che metterci ancor più in allarme. Come so che questo è un timore generalizzato? Tempo fa - diverso tempo prima che leggessi questo romanzo - scrissi un raccontino che termina proprio con queste parole: “ […] il mondo finirà per una manciata di malintesi e bugie; per un manipolo di persone abbastanza folli da crederci e abbastanza potenti da spegnere la luce per tutti”. Sembra un po’ il leitmotiv di questo romanzo di Ken Follett.
Coincidenze? Non credo proprio.
“Da giovane aveva cercato di comprendere chi detenesse realmente il potere. Era il presidente, che era il capo dell’esercito, oppure i membri della direzione del partito nella loro collegialità? O il presidente americano, i media americani, o i miliardari? A poco a poco aveva capito che erano tutti vincolati, ognuno a suo modo. Il presidente americano era manovrato dall’opinione pubblica, quello cinese dal partito comunista. I miliardari dovevano realizzare profitti, i generali dovevano vincere le battaglie. Il potere non risiedeva in un unico luogo, ma in un sistema estremamente complesso, formato da un gruppo di persone e istituzioni chiave, senza una volontà collettiva, che premevano in direzioni diverse. E lui ne faceva parte. Quello che accadeva sarebbe stato colpa sua come di chiunque altro.”
La trasfigurazione del mondo
Che il Demian si sarebbe rivelata una lettura particolare era un qualcosa che in fondo mi aspettavo: Herman Hesse è già di per sé un autore piuttosto peculiare da affrontare, infuso di misticismo, di elementi sensoriali e spirituali, di razionale e irrazionale, di apollineo e dionisiaco. Demian è forse il romanzo che con più fatica ho apprezzato, ma nel quale più degli altri si avverte il contesto storico e sociale che Hesse e tutta l’Europa - la Germania in particolare - si trovavano ad affrontare durante e in seguito alla Prima Guerra Mondiale, in un secolo in cui le certezze vengono a mancare e regna sovrano il Relativismo; un secolo in cui l’uomo si confonde nelle masse e non riesce più a trovare sé stesso. Il fatto che Nietzsche sia apertamente citato nelle pagine del “Demian” non stupirà affatto chi conosce anche un minimo il filosofo in questione: con le sue idee “esplosive” aveva messo in evidenza come gli esseri umani fossero stati per secoli vittima delle illusioni della morale, mettendo in risalto la necessità di trovare nuove certezze che dovessero trascenderla e mettere da parte quel pilastro che era la religione, nient’altro che un’accozzaglia di dogmi che offrono all’uomo certezze illusorie e gli impediscono di “esaltare la vita”: vera soluzione al pessimismo ed essenza del nichilismo. Solo coloro che si sarebbero rivelati capaci di andare “al di là del bene e del male”, i cosiddetti Oltreuomini, sarebbero stati i pilastri sui quali una nuova società umana avrebbe potuto formarsi.
E chi sono Demian e Sinclair, se non dei potenziali Oltreuomini?
Potenziali perché in loro (soprattutto in Sinclair) questo ideale non s’è ancora realizzato e nella sua psiche si fa spazio quelli che sono i dubbi e le angosce dell’uomo moderno, che è incapace di muoversi in un mondo che sta profondamente cambiando e ha bisogno di una guida. La guida, per Sinclair, è Max Demian: compagno di scuola che rappresenterà per lui un punto di riferimento costante anche nei momenti di distacco; un ragazzo che sembra vecchio e giovane insieme, che sembra aver trasceso il tempo ed essere entrato in una dimensione tutta nuova.
Lo spauracchio della guerra è ancora vivo e così il sentimento che un profondo mutamento, nel mondo, fosse prossimo ad avvenire. Per cambiare, il mondo doveva frantumarsi, e dai suoi cocci solo quegli uomini in grado di sopravvivere all’urto avrebbero potuto determinarne il futuro.
Un romanzo che ingloba le angosce, le ansie, le sensazioni di un cambiamento imminente, le filosofie e anche le scoperte scientifiche - il romanzo è infatti infuso delle nuove scoperte freudiane che hanno al centro i sogni e l’inconscio - di un secolo che, probabilmente, è stato il più importante e assurdo della storia dell’umanità: il Novecento.
“Pensare: una comunità tutta di uomini paurosi dell'ignoto che hanno dentro! Tutti sentono che le loro leggi di vita non sono più giuste, che vivono secondo antiche tavole, che le loro religioni, la loro moralità, nulla insomma è adeguato a ciò che ci occorre. […] Questi uomini che si associano così timidamente sono pieni di paura e di cattiveria, e non c'è uno che si fidi dell'altro. Stanno attaccati a ideali che non lo sono più e lapidano chiunque ne eriga uno nuovo. So che si fanno discussioni. Verranno, credi a me, verranno presto. S'intende che non "miglioreranno" il mondo. Sia che i lavoratori ammazzino gli industriali, sia che Russia e Germania sparino l'una contro l'altra, si tratta soltanto d'un cambio di proprietario. Ma non sarà stato invano. Ciò mostrerà quanto poco valore abbiano gli ideali odierni e servirà a spazzar via gli dèi dell'età della pietra. Il mondo com'è oggi vuol perire e perirà.”
Indicazioni utili
Comfort zone
Non avevo idea dell’uscita di questo romanzo di Paolo Cognetti finché non l’ho visto sugli scaffali della libreria riservati alle novità. Dopo l’eccellente romanzo “Le otto montagne” - probabilmente ultimo vincitore davvero meritevole del Premio Strega - l’autore si cimenta nuovamente in un romanzo che ha come epicentro la montagna e tutto ciò che la circonda. Inutile dire che l’ho preso subito, considerato quanto ho apprezzato il suo precedente lavoro, ne viene fuori tuttavia - lo dico subito e senza mezzi termini - un lavoro che ha pochissimo da dire, probabilmente perché tutto è già stato detto nel famoso e fortunato predecessore… e questo un po’ mi fa rabbia.
Il caro Cognetti in questo romanzo cita il grandissimo Jack London, che lui ovviamente apprezzerà per le sue produzioni “innevate”, ma che in un breve e bellissimo saggio dedicato agli scrittori emergenti e non solo afferma che uno scrittore mette nel suo lavoro “oltre che se stesso, anche quello che non è se stesso ma che è stato lui a esaminare e a soppesare […] Ognuno di loro (gli scrittori) ha tratto la propria filosofia operativa da una scorta personale di idee ed esperienze” e che all’inizio essi sono come neonati ma alla fine hanno “acquisito dal mondo qualcosa che i loro simili non hanno acquisito. E si trattava né più né meno che di qualcosa da dire. E allora tu, giovane scrittore, hai qualcosa da dire, o credi soltanto di avere qualcosa da dire?”. Perché questa lunga citazione per riferirsi a “La felicità del lupo” di Paolo Cognetti? Perché Cognetti qualcosa da dire ce l’aveva, ma in qualche modo s’è in gran parte esaurito nel suo romanzo più celebre, almeno per quel che riguarda il tema e l’ambientazione della montagna. Questo fa rabbia per due motivi: il primo è che, almeno a mio avviso, Cognetti era uno dei pochi scrittori italiani che potesse davvero definirsi degno di nota e che, probabilmente, ha ceduto alle pressioni - probabilmente anche di sé stesso - e ha prodotto un nuovo lavoro incentrato su qualcosa la cui fonte d’ispirazione è palesemente esaurita, almeno per ora. Sebbene si apprezzino le sue descrizioni molto evocative, ci rimangono quelle e poco altro: la storia narrata è scialba e manca della profondità che avevamo apprezzato in passato, popolata da personaggi con cui non si riesce a empatizzare. Certo un uomo che ha fatto della montagna la sua vita, come Cognetti, non potrà mai discostarsene del tutto e nella sua produzione non potrà fare a meno di soffermarvisi sempre… ma non basta proporci descrizioni e riflessioni che sanno di già sentito. Forse il problema è che gli scrittori sono spesso costretti a ripercorrere i sentieri che li hanno portati al successo… tuttavia questo è un approccio che poco ha a che fare con la letteratura. Uno scrittore dovrebbe scrivere quando ha qualcosa da dire, proprio come dice London: quel qualcosa può anche ripercorrere un sentiero già tracciato - chi può dire, infatti, che “Il richiamo della foresta” e “Zanna bianca” non siano entrambi capolavori? - ma quel sentiero deve presentarci nuovi spunti, vestirsi d’un manto diverso e rinnovare quella meraviglia che aveva destato in noi. Altrimenti non è altro che una minestra riscaldata, magari con ingredienti più scadenti.
A margine, anche volendoci soffermare sul dettaglio più sciocco… persino la copertina somiglia in maniera spropositata a “Le otto montagne”, il che sembra quasi gridare al lettore il suo scopo… un grido che io non ho voluto ascoltare.
Di sicuro sono un po’ troppo severo con l’autore e probabilmente lui non arriverà mai a leggere questa mia umilissima opinione; ma se le mie parole possono apparire taglienti è perché riponevo in Cognetti e nella sua scrittura una speranza: era per me un lumicino in quelle tenebre dilaganti che sono la letteratura italiana contemporanea. Se anche lui finisce per cedere e starsene lì, nella sua comfort zone, allora non ci sono davvero speranze e dovremo rassegnarci ai Volo e agli influencer che si improvvisano scrittori.
Rimane, comunque, una mia personalissima opinione: probabilmente qualcun altro ci avrà visto più di quel che ci ho visto io.
“[…] come poteva sciogliersi a quel ritmo e restare sempre uguale? Allora credeva che il ghiacciaio fosse eterno e immutabile, una parte della montagna che avrebbe sempre ritrovato lí tra la roccia e il cielo. Suo padre invece aveva capito cosa stava succedendo: qualcosa scompare e qualcos'altro prenderà il suo posto, gli disse. Cosí va il mondo, sai? Siamo noi che abbiamo sempre nostalgia di quello che c'era prima.”
A scanner darkly
Forse uno dei romanzi - almeno tra quelli che ho letto - che più testimoniano l’esperienza diretta di Philip K. Dick col mondo della droga. Molto indicativa in questo senso è anche la nota dell’autore al termine della storia, nella quale si fa un’inquietante elenco di nomi di persone care a Dick che hanno condiviso con lui questo “gioco” al quale non hanno saputo più sottrarsi, affiancati dal loro inquietante destino che, nella maggior parte dei casi, conduce alla morte. La sensazione di smarrimento, la percezione d’un mondo sfocato e dai contorni indistinti è un qualcosa che si percepisce fortemente durante la lettura di questo romanzo che ha elementi del poliziesco, del distopico e della fantascienza, sebbene lo stesso Dick non volesse posizionarlo all’interno d’un genere preciso, considerati i temi trattati. Come dargli torto considerato che ancora oggi, per un romanzo, essere collocato all’interno di un genere equivale a un’etichetta di “bassezza” letteraria? Ma forse, più che cercare di evitare che il suo interessante romanzo fosse identificato come fantascienza, Dick avrebbe avuto la forza di sollevare una questione cruciale, ovvero quanto un’opera letteraria appartenente a un preciso genere (magari spesso associato a intrattenimento) possa esprimere valore letterario parimenti o anche in misura maggiore di altre opere non collocabili. Ma questa è un’altra lunga storia.
Per quanto riguarda “Un oscuro scrutare”, invece, al centro del racconto abbiamo Bob Arctor/Fred, che conduce una vita doppia come infiltrato della Narcotici in una Los Angeles sfocata e apparentemente distopica, sebbene i suoi contorni politici non siano perfettamente delineati. In questo contesto, tantissime persone sono soggette alla dipendenza dalla Sostanza M, una droga potentissima che può portare il cervello a deteriorarsi irrimediabilmente, rendendo necessaria una disintossicazione presso dei centri specializzati quali il Nuovo Sentiero. Il percorso di Bob Arctor lo porterà sempre più a una frammentazione dell’Io tipicamente novecentesca, in questo caso causata dall’assunzione coatta (?) della Sostanza M. Non poche saranno le riflessioni che verranno portate all’attenzione del lettore durante questo percorso, in una prosa probabilmente tra le migliori nei romanzi Dickiani.
Probabilmente una delle opere più interessanti dell’autore, dalla quale è stato anche tratto un film con Keanu Reeves e Robert Downey Jr.
“Può una passiva telecamera a luci infrarosse, come quelle in uso un tempo, o un’olocamera tridimensionale, del tipo che si usa oggi, l’ultimo tipo, vedere fin dentro di me, fin dentro di noi, in modo chiaro? O in un modo confuso, oscuro? Io spero possa, pensò, vedere con chiarezza, perché io non riesco a vedermi dentro oramai. Io vedo solo tenebre. Tenebre tutt’intorno, tenebre dentro. Spero, per il bene di ciascuno, che le olocamere facciano meglio. Perché, pensò, se alle olocamere è dato solo un oscuro vedere, nel modo in cui a me è dato, allora nostra è la maledizione, e ancora siamo maledetti, come lo siamo sempre stati, e così saremo tutti spinti verso la morte, conoscendo poco o nulla, e quel poco, e quel nulla, conoscendolo male.”
Indicazioni utili
Bello, ma non un capolavoro
Stephen King ci riprova col thriller, abbandonando per un attimo quello che da sempre è il genere in cui rende meglio, ovvero quello orrorifico fantastico. C'è da dire che i suoi romanzi che preferisco - "Il miglio verde" e "22/11/'63" - sebbene presentino importanti espedienti narrativi fantastici, hanno un tono realistico simile alle sue prove thrilleristiche. Tuttavia, in questo genere il Re ha anche avuto dei grossi strafalcioni, principalmente rappresentati dalla trilogia che ha come capostipite il romanzo "Mr. Mercedes", di certo non il suo lavoro meglio riuscito.
"Billy Summers" si infila in mezzo a questi capolavori e sfondoni, risultando un romanzo piacevole da leggere e in certi tratti avvicente, ma lontano dal rivelarsi davvero indimenticabile.
A livello stilistico è il King di sempre, scorrevole, anche se forse meno evocativo del solito, ma questo è ovviamente dovuto al genere di appartenenza del romanzo. La struttura narrativa presenta un elemento interessante e innovativo - oltre che sorprendente nel finale - che permette all'autore di intrecciare il main plot con una storia secondaria che fa al tempo stesso luce su quello che è il passato del protagonista; un espediente apprezzabile soprattutto da chi è appassionato di scrittura, seppure ben lontano dall'essere considerato come un qualcosa di accostabile al saggio-biografia "On writing", come fanno in una delle immancabili ed esagerate marchette in quarta di copertina.
La storia si concentra su Billy Summers, cecchino reduce della guerra in Iraq, che al suo rientro decide di diventare un sicario che, tuttavia, accondiscende ad eliminare soltanto gli obiettivi che siano degli "uomini cattivi". Forse un idea un po' banale per addolcire e generare empatia per la figura del protagonista, ma tant'è. L'incarico per il quale verrà chiamato e che sarà al centro dell'intreccio di questo romanzo è anche quello meglio remunerato e pericoloso, oltre che l'ultimo che Billy vorrà intraprendere prima di ritirarsi definitivamente dalle scene. L'elevato premio per il conseguimento di questo compito non è dovuto all'importanza sociale dell'obiettivo da eliminare - che in fondo è un assassino da quattro soldi - ma per le informazioni che quest'ultimo dice di possedere, che possono mettere nei guai alcuni pezzi grossi. Oltretutto, Billy dovrà assumere un'identità di copertura per diversi mesi: dovrà fingersi uno scrittore impegnato nella scrittura di un romanzo, che ha il suo ufficio in un grosso edificio che affaccia proprio sul tribunale in cui, in un giorno imprecisato, l'obiettivo dovrà essere condotto. Per rendere più credibile la copertura, Billy questo romanzo dovrà scriverlo davvero e per lui, che si è sempre finto tonto di fronte ai suoi referenti della malavita ma è in realtà un amante della bella letteratura e in particolare di Émile Zola, è qualcosa di incredibilmente eccitante.
Si dedicherà dunque a questo "roman à clef" che prende spunto dalla sua biografia, che rappresenterà l'espediente narrativo di cui parlavamo prima e che darà vita a un interessante colpo di scena, probabilmente il punto più interessante e intelligente del romanzo.
Un libro che sa intrattenere, ma è ovviamente lontano dai capolavori del passato.
“Ecco che cos'ho imparato nella Casa della Ripittura Eterna: che non esistono solo 2 categorie di persone, i buoni e i cattivi, come pensavo quando ero un ragazzino che prendeva quasi tutte le sue idee dal modo in cui si comportava la gente in televisione. Ce ne sono 3, invece. Il terzo tipo di persone si adatta e tira a campare, come mi aveva detto di fare l'agente F.W.S. Malkin. Rappresenta la maggioranza, e io credo che il suo colore sia il grigio. È gente che non ti farà mai del male (almeno, di proposito), ma che non ti darà mai neppure una mano. Ti dirà sempre fai quel che vuoi e che Dio ti aiuti.”
Una profusione di dettagli
Stanislaw Lem è un autore che sta tornando alla ribalta: Sellerio sta lentamente pubblicando diversi dei suoi romanzi, e ho appena scoperto dell’imminente uscita di un grosso tomo Mondadori, in cui è raccolta la sua narrativa breve. Non potrei esserne più contento, perché lo reputo un autore degno di considerazione, capace di portare alta la bandiera della fantascienza letteraria. Tuttavia devo ammettere che “Ritorno dall’universo” non è all’altezza dei primi due romanzi pubblicati da Sellerio, “Solaris” e “L’invincibile”, e credo che il problema principale sia da ricondursi all’infinita profusione di dettagli descrittivi che l’autore ci pone dinanzi soprattutto nella prima metà del romanzo: sebbene il ritorno del protagonista da un viaggio interspaziale su una Terra che è andata avanti di oltre un secolo mentre lui è poco più che invecchiato sia probabilmente il punto centrale del romanzo, le descrizioni sono davvero troppe e finiscono addirittura per perdere di efficacia. In questo romanzo sono descritte talmente tante cose che sono riuscito, paradossalmente, a immaginare ben poco, e la terra descritta da Lem mi è sembrata poco più di un ambiente buio tempestato di neon. La seconda parte del romanzo è probabilmente quella che vede emergere il Lem che più ho imparato ad apprezzare: l’autore riflessivo, dagli spunti filosofeggianti, che riesce a coniugare intrattenimento e letteratura impegnata; ma per arrivarci il cammino si rivela troppo ostico e può portare il lettore meno paziente a lasciar perdere.
Come dicevo, il tutto è incentrato sul “ritorno” del nostro protagonista Hal dall’universo: egli era infatti pilota sull’astronave Prometeo, partita verso le stelle per raccogliere campioni su altri pianeti e, sebbene con poche speranze, incontrare altre forme di vita. Al suo rientro tutto è cambiato, la terra non ha più nulla di quel che aveva prima della sua partenza e lui e i suoi compagni, che erano partiti da eroi, tornano accolti dalla più completa indifferenza riguardo alla loro missione, e con stupore riguardo alla loro statura superiore alla media. Quando Hal cerca di capire quelli che sono stati i progressi dell’umanità durante la sua assenza, si accorge che è stata introdotta una pratica detta “betrizzazione”, che ha reso l’essere umano biologicamente incapace di uccidere. Loro, che non sono stati betrizzati, rappresentano per i terrestri una minaccia paradossalmente affascinante. Ma ciò che più turba Hal è la scoperta di come gli scienziati dell’epoca, mentre loro rischiavano la vita nella loro missione interplanetaria, abbiano finito per considerare i viaggi spaziali come un qualcosa di totalmente inutile. Per cos’erano partiti, dunque? La brama umana di perseguire le stelle è un correre dietro al vento, un qualcosa che non porta a nulla? Questo è il punto centrale sul quale Lem si focalizza soprattutto nell’ultima parte del romanzo, che secondo me è la più bella e interessante e senza la quale il voto sarebbe stato ben più basso di questo.
Lem resta comunque un autore dallo stile pregevole e dal pensiero acuto e profondo.
“Non avevo bisogno di stelle. Ero stato un pazzo, un folle, quando avevo lottato per prender parte alla spedizione, quando mi ero lasciato ridurre a un sacco che schizzava sangue nei gravirotor, a che mi era servito, perché, perché non sapevo che si deve essere uomini comuni, i più comuni possibile, perché altrimenti è impossibile vivere e neanche vale la pena.”
Le porte di un passato scomparso
Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre fanno una prova: posso dire che il terzo romanzo da me letto di questo scrittore tedesco lo consacra definitivamente, concedendogli un posto d’onore tra i miei scrittori preferiti.
Non c’è nulla che non mi sia piaciuto di questo “La via del ritorno”. Lo stile è quello tipico dell’autore: poetico, evocativo, riflessivo, capace di scuotere mente e cuore allo stesso tempo, come Neri Pozza non fa a meno di mettere in risalto con la marchetta presa dal New York Times che piazza sul retro di ogni sua opera. C’è da dire, però, che trattasi di una delle poche marchette che forse non rendono neanche abbastanza giustizia alla grandezza di un autore probabilmente troppo poco conosciuto a discapito di altri che nemmeno accostabili.
Riguardo ai contenuti, beh, inutile negare che la guerra è la principale tematica intorno alla quale ruotano le opere di Remarque, o almeno quelle che mi sono trovato a leggere finora; ma chi crede che il massimo contributo dell’autore ci sia venuto dal famigerato - ma, ribadisco, non famoso quanto meriterebbe - “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, è invitato a leggere questo romanzo per rimanerne piacevolmente stupito. Certo, vengono riproposte problematiche già affrontate (e tornano anche nomi conosciuti), ma Remarque ha la capacità di affrontarle in modo sempre interessante, profondo, a tratti sublime.
Ma qual è il punto centrale del romanzo?
Il punto centrale è l’idea di patria; un ideale che si dimostra come un qualcosa di totalmente astratto, come un inganno perpetrato dai potenti per portare i deboli a sacrificare la vita in nome dei loro interessi, a cui hanno dato il nome, appunto, di patria. Un concetto che perderà di ogni significato e si paleserà come l’inganno a causa del quale innumerevoli vite sono state stroncate: sui campi di battaglia, ma anche sulla via del ritorno. E un altro punto focale è è proprio la via del ritorno, che una generazione di giovani innocenti si ritrova a percorrere dopo una guerra estenuante, illudendosi che la pace possa riportarli a ciò che erano, solo per rendersi conto che la guerra ha cambiato ogni cosa: tutto può sembrare uguale a uno sguardo superficiale, ma nella sostanza ogni cosa è mutata; o meglio, la guerra ha mutato la percezione di coloro che son tornati indietro, nei quali si sgretola l’illusione di poter bussare alle porte della propria giovinezza e ricominciare da dove avevano interrotto. Nessuno gli aprirà, perché ricominciare non si può: le immagini di quel passato cruento, di quell’intervallo di tempo in cui le licenze non erano altro che “intervalli tra orrore e orrore, tra morte e morte”, non faranno altro che perseguitarli giorno e notte, annullando per molti qualsiasi possibilità di ripartire. Straziante è il destino di coloro che non ce la fanno; di coloro che sono riusciti miracolosamente a non soccombere alle raffiche di spari, alle granate, e che poi non possono che cedere alla follia o al desiderio di morte in mezzo a una pace esteriore che non dà pace interiore. Quella che ci ritroviamo davanti è una generazione distrutta, e solo pochi riescono a trovare quella “via del ritorno” che in fondo è una via del tutto nuova in cui il passato non si dimentica ma si deve affrontarlo ogni giorno, permettendo alla vita di fluire e andare avanti, pur inciampando.
“È passato, penso, tutto è finito. Non perché Adele se la intenda con quel coso nero o con Karl Bröger, non perché mi trovi stucchevole, non perché si sia trasformata, no, ma vedo che io non ho più uno scopo al mondo. Ho girato e girato, ho bussato a tutte le porte della mia giovinezza, desideroso di rientrare, e pensavo che mi dovessero accogliere di nuovo, perché sono ancora giovane e perché ho desiderato dimenticare. Ma la mia giovinezza mi è sgusciata via come una fata morgana, si è infranta senza rumore, si è dissolta come l’esca quando l’ho toccata; non ho saputo raccapezzarmi, qui almeno doveva essere rimasto qualcosa, e ho tentato e mi sono sentito ridicolo e ora sono pieno di tristezza. Ma ora mi accorgo che anche in questo paese della memoria si è scatenata una guerra sorda e silenziosa, e che sarebbe stolto se volessi cercare ancora. Il tempo si è messo di mezzo come un abisso spalancato, non posso tornare indietro, non c’è altro scampo, devo andare avanti; marciare, chissà verso dove, poiché non ho ancora una meta.”
Indicazioni utili
Uomini scimmia moderni
Cosa succede se mettiamo un pezzo della mentalità dell’uomo moderno nei corpi e nel contesto degli uomini scimmia del Pleistocene? La risposta potrete trovarla un questo romanzo di Roy Lewis che, sebbene forse non sia “uno dei romanzi più divertenti degli ultimi cinquecentomila anni” come dice Terry Pratchett, vi strapperà comunque più di una risata e anche qualche riflessione su quelle ambiguità umane di cui probabilmente non ci libereremo nemmeno nel corso di decine di ere geologiche.
Il tutto si focalizza sulla figura, per l’appunto, del più grande uomo scimmia del Pleistocene: padre del nostro narratore e protagonista e che potrebbe incarnare la figura moderna dello scienziato, così come gli altri personaggi sono un pò i precursori di altre figure che saranno il fondamento dell’epoca moderna: dal filosofo (il nostro protagonista) al militare, dal cacciatore all’addestratore di animali. È interessante e divertente vedere come figure piazzate così lontane nel tempo mostrino pensieri e modi di fare così simili a noi e vedere come la scoperta del fuoco e la sua diffusione possa accostarsi a invenzioni e pericoli moderni quali la polvere da sparo oppure, peggio ancora, il matrimonio. Ed è proprio il “grande uomo scimmia” a canalizzare l’attenzione del lettore con la sua inventiva, la sua voglia di scoprire, la sua consapevolezza che la sopravvivenza dell’uomo risiede nelle capacità cognitive e non solo nella forza bruta, spesso di molto inferiore a quella di altri animali. È infatti solo con l’ausilio della mente che l’uomo è riuscito a sfrattare orsi e tigri dalle loro caverne e a dar vita a quello che chiameremo il nostro focolare. L’uomo come lo conosciamo oggi è frutto delle sue facoltà intellettive, della sua inventiva, senza la quale probabilmente non sarebbe certo quel che è ora (coi suoi pro e i suoi contro).
Una narrazione che, dunque, porta il passato nel presente e il presente nel passato; che può permetterci di riflettere sulle origini, sul come l’uomo ha tracciato il suo percorso nei secoli dalla scoperta del fuoco ad oggi (per chi ovviamente creda nella teoria evoluzionistica), ed è effettivamente divertente.
Di certo non un capolavoro, ma comunque un romanzo godibile.
Racconti taglienti
Una serie di racconti affilati di cui quello più interessante è certamente quello che dà il titolo alla raccolta, ovvero “La lotteria”. La peculiarità di questo racconto in particolare è il sovvertimento delle aspettative, il cambio di tono che avviene lentamente, sotto traccia, svelando gradualmente al lettore una realtà inizialmente imperscrutabile e che quest’ultimo finirà per afferrare solo un momento prima dello svelamento definitivo, che risulterà comunque scioccante. Mentre all’inizio non si sospetta di nulla, lentamente cominceremo a renderci conto che qualcosa non va: le atmosfere si incupiscono e le vicende prendono una tinta macabra. Ed è probabilmente questo l’effetto che Shirley Jackson ha voluto generare con questi suoi brevissimi racconti: disorientamento, shock, inquietudine; riuscendoci oltretutto con una gran quantità di dialoghi e pochissima narrazione.
L’effetto si ripete anche nel secondo racconto, “Lo sposo”, che ci immerge nella stranissima situazione della protagonista: una donna che nel giorno del suo matrimonio attende con ansia (probabilmente arricchita da qualche sfumatura patologica) l’arrivo del suo sposo, che tuttavia non darà il minimo segnale di vita. L’attesa nel suo appartamento comincia a farsi snervante e i già strani comportamenti della donna cominciano a farsi piuttosto inquietanti, tanto da condurla a una sorta di indagine che la porterà a un’ambigua scoperta, magari non del tutto veritiera.
Sono probabilmente i primi due racconti quelli davvero interessanti, in cui lo stile della Jackson si mostra in grande spolvero, riuscendo in un numero limitatissimo di pagine a suscitare una vasta gamma di emozioni, tendenti soprattutto all’inquietudine e al disorientamento.
Da leggere, considerato anche l’esiguo quantitativo di tempo necessario.
Indicazioni utili
Passione vs. Ragione
Considerato uno dei più grandi romanzi del Novecento tedesco (e probabilmente di tutta la relativa letteratura), “I Buddenbrook” è un romanzo che volevo leggere da tantissimo tempo ma che ho affrontato solo di recente, nella preparazione del primo esame di letteratura tedesca.
Che dire, è un romanzo che risponde propriamente ai canoni naturalisti: carico di dettagli, che descrive ambienti e personaggi nei minimi dettagli, mettendone soprattutto in risalto determinate peculiarità che aiuteranno a identificarli e rappresenteranno un leitmotiv, in pieno stile wagneriano. Questa profusione di dettagli, a volte, può rendere la lettura meno scorrevole, più lenta, sebbene di una lentezza diversa rispetto a quella riscontrata per esempio ne “La morte a Venezia”, in cui la lentezza è dovuta a un’elevata complessità e al ricorrente simbolismo. Qui la realtà è descritta nei minimi dettagli, con assoluta precisione e concretezza, e questo mi ha portato a pensare a come Thomas Mann sia un autore stilisticamente molto versatile, sebbene tra me e lui non sia ancora scoccata la scintilla.
Parlando dei Buddenbrook in particolare, è un romanzo che si focalizza sulla decadenza di questa famiglia alto-borghese: una decadenza del tutto incentrata su motivazioni psicologiche: la decadenza dei Buddenbrook sta infatti nella “decadenza psicologica” delle generazioni che si susseguiranno (ben quattro). Centrale è infatti il contrasto tra passione e ragione, che molto deve alla contrapposizione apollineo-dionisiaca di Nietzsche. I discendenti del nonno Johann Buddenbrook - di stampo umanista e illuminista, uomo che incarna il perfetto equilibrio psicologico che tiene in piedi le sorti della famiglia - sono personaggi che cominciano a mostrare inclinazioni che non riescono a mantenersi equidistanti tra gli eccessi di razionalità (rappresentati da Thomas) e irrazionalità (Christian) e dunque generano una serie di eventi che porteranno la ditta familiare a una graduale decadenza, che praticamente coinciderà con la fine vera e propria della famiglia. Molto interessante è considerare come a questo decadimento sociale corrisponda perfettamente il decadimento psicologico dei protagonisti, in un senso o nell’altro.
Tuttavia, se devo esprimere un parere del tutto personale, è un romanzo che non è riuscito a farmi innamorare di Thomas Mann e molto probabilmente mi ha permesso di apprezzarlo un pochino in più solo per mezzo dell’analisi necessaria allo svolgimento dell’esame. Potrebbe anche essere vero il contrario, ovvero che una lettura più spensierata e slegata dallo studio mi avrebbe fornito una maggiore soddisfazione, ma il fatto che io ne abbia apprezzato più l’analisi letteraria credo sia piuttosto indicativo. C’è da aggiungere che i romanzi familiari non sono i miei preferiti e che quindi il tutto è un po’ inquinato dalle mie preferenze letterarie, che nulla tolgono al grande valore dell’opera né alla mia volontà d’approfondire l’autore.
“La montagna incantata” e “Tonio Kröger” sono già lì che mi aspettano.
“Ho tanto pregustato queste gioie, ma come sempre, l’immaginarsele è stata la parte migliore, perché il bene arriva sempre troppo tardi, diventa realtà troppo tardi, quando non si è più capaci di goderne.”
Indicazioni utili
La verità sotto il mantello
Dramma in quindici scene, "Vita di Galileo" riprende un pezzo della vita di Galilei - in particolare dal momento della "scoperta" del telescopio e della conseguente conferma della teoria copernicana, e di tutto ciò che ne consegue - con lo scopo di scandagliare la figura dello scienziato: un uomo che deve combattere con l'atavica riluttanza (per usare un eufemismo) dell'uomo nell'accettare il cambiamento, guidato in questo senso dall'interesse o dalla paura.
Certo l’uomo si è evoluto, nel corso degli anni; non ci troviamo nella stessa condizione in cui si trovava Galileo, in un mondo dove gli uomini di scienza erano costretti a celare le proprie scoperte per non irritare i potenti (la Chiesa, in questo caso). Ma è interessante riflettere su quanto la storia narrata da Brecht fosse un modo per rappresentare tempi ben più recenti: Galileo è, infatti, oltre che simbolo supremo della figura dello scienziato e dei suoi conflitti, anche rappresentazione di quei tedeschi costretti ad “abiurare” le proprie idee politiche, artistiche e intellettuali durante l’orrore nazionalsocialista, nella Germania dal ’33 in poi. Quando Brecht, per bocca del suo protagonista, afferma: “Quando attraversi la Germania, riponi la verità sotto il mantello”, non si può non riconoscere in queste parole un avvertimento che trascende i secoli e scorre fino a quell’epoca oscura, così lontana eppure così vicina, a noi e a Galileo. Lo scienziato fiorentino ci pone di fronte lo stesso dilemma di quei tedeschi della cui esistenza forse non ci siamo mai curati, quei tedeschi che pur di non perdere la vita hanno dovuto adattarsi, sottomettersi; col nostro sguardo freddo distante decenni da loro, spesso pensiamo che avrebbero dovuto comportarsi da eroi, opporsi all’orrore in cui erano immersi, morire per una giusta causa; così come gli allievi di Galileo s’aspettavano che questi accettasse l’esecuzione per “mantenere il punto”, per dare il via alla rivoluzione, per dimostrare che l’uomo che è nel giusto non si piega. Ma chi garantisce che la rivoluzione avvenga e che la morte non sarà invano?
Oltretutto, chi può dire quale sarebbe la nostra reazione di fronte agli strumenti di tortura? Magari anche noi ci saremmo trasformati in farabutti, pur conoscendo la verità e avendo la consapevolezza che, nel mondo intorno, ci sia qualcosa di profondamente sbagliato. Magari saremmo pronti ad accettare nuovamente il cosmo tolemaico, o annuiremmo con convinzione quando qualcuno, con una lama puntata alla nostra gola, cercherà di persuaderci che la terra è piatta.
La storia di Galileo era attuale al tempo di Brecht ma lo è anche ora: perché l’uomo non cambia mai, è sempre soggetto alle stesse imperfezioni e si rende colpevole degli stessi errori: sempre “bisognosa di eroi” e dunque perennemente in lotta per scrollarsi di dosso la propria miseria.
“Statemi a sentire: chi non conosce la verità è soltanto uno sciocco; ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un malfattore!”
Indicazioni utili
Dark comedy
"Il mercante di Venezia" è probabilmente una delle produzioni più problematiche del Bardo. Questo a partire dalla sua collocazione di genere: in teoria è considerata tra le commedie, sebbene i suoi toni cupi siano più simili a quelli di una tragedia. Non essendoci tuttavia alcun morto viene definita una dark comedy, una definizione che già tradisce la sua natura un po' ambigua; un'ambiguità che si rivela soprattutto nel personaggio di Shylock l'ebreo. Sappiamo che ai tempi di Shakespeare (e già da diversi secoli) lo stereotipo dell'ebreo usuraio era parecchio sfruttato, si pensi al Barabas de "L'ebreo di Malta" di Christopher Marlowe, personaggio dal quale sembra che Shakespeare abbia preso ispirazione per Shylock stesso. Considerato come uno dei villain per eccellenza, una volta letta integralmente la commedia non si può fare a meno di riflettere: l'ebreo non può infatti essere considerato come un cattivo a 360 gradi. Shylock è il personaggio a cui vengono affidate le battute più profonde e interessanti, mentre gli altri personaggi (a parte Porzia, in certi tratti) risultano piuttosto semplici.
Shylock è oggetto della discriminazione incondizionata che, a sentir parlare i personaggi, è del tutto giustificata; tuttavia la decisione di lasciare al discriminato i momenti di verità più profonda e toccante (tra cui i famosi versi "[...] se ci ferite non sanguiniamo? [...]), fa riflettere su quelle che potevano essere le idee di Shakespeare a riguardo. Come voleva dipingere il suo Shylock? Il destino finale di Shylock fa pendere la bilancia verso una connotazione del tutto negativa, che tuttavia non può, nel lettore accorto, lasciar sfumare l'idea che questo personaggio non possa essere condannato senza riserve.
Sebbene la richiesta della sua libbra di carne sia di spropositata crudeltà, crudele è anche il trattamento riservatogli da quei cristiani che si considerano tanto puri e superiori.
Per quanto riguarda il dramma in sé, devo dire che non lo trovo di bellezza paragonabile a grandi tragedie quali "Amleto" oppure "Otello", ed è anzi infarcito di momenti piuttosto frivoli. E' probabilmente per questo, e non per la mancanza di morti, che non la si è considerata tra le tragedie, bensì tra le commedie.
“Un ebreo, non ha occhi?, non ha mani, un ebreo, membra, corpo, sensi, sentimenti, passioni?, non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, soggetto alle stesse malattie, guarito dalle stesse medicine, scaldato e gelato dalla stessa estate e inverno di un cristiano? Se ci pungete, non sanguiniamo? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci fate torto, non ci vendicheremo? Se siamo come voi in tutto il resto, vi somiglieremo anche in questo. Se un ebreo fa torto a un cristiano, che fa il mite cristiano? Vendetta! E se un cristiano fa torto ad un ebreo, che farà, secondo l’esempio cristiano, l’ebreo paziente? Vendetta! Metterò in pratica la malvagità che mi insegnate, e sarà difficile che non superi i maestri.”
Indicazioni utili
La società "perfetta"
Trattato politico in forma dialogica, “Utopia” di Thomas More deve molto alla “Repubblica” di Platone che, insieme a molti altri autori greci, stava influenzando fortemente l’Umanesimo inglese. Lettura scorrevole appunto perché scritto in forma di dialogo (sebbene in certi tratti sia, in fondo, un monologo) sarà un testo che oltre a influenzare il pensiero politico del tempo darà origine al termine stesso di utopia - fino ad allora inesistente - e in seguito alla letteratura utopica e distopica con la quale ancora oggi ci dilettiamo.
Diviso in due libri, nella prima parte More si focalizza principalmente su quelli che sono i problemi sociali e politici dell’Inghilterra del tempo - la sottrazione di terra alla coltivazione per dedicarla all’allevamento, lo squilibrio tra delitti e relative pene, la disuguaglianza tra ricchi e poveri - mentre nella seconda ci si focalizza sulla descrizione territoriale, sociale e politica di Utopia, isola (ovviamente inesistente, essendo che il termine utopia stessa significa “non luogo”) visitata dal navigatore Raffaele Itlodeo, che ne illustra le peculiarità ai suoi due interlocutori: Tommaso Moro e Peter Giles.
Sorvolando sulla descrizione territoriale, Utopia si distingue per la centralità che, nel suo governo, ha l’uguaglianza tra gli uomini e l’espressione della loro virtù. L’uguaglianza è perseguita principalmente tramite l’abolizione della proprietà privata e con l’occupazione degli abitanti nel medesimo lavoro per un numero ridotto di ore al giorno. La “burocrazia” è gestita da un gruppo di oligarchi eletti secondo merito e i quali non possiedono particolari privilegi rispetto ai normali cittadini, facendosi semplicemente garanti del normale funzionamento della realtà utopistica dell’isola. L’ambizione e l’individualità sono completamente annullate, per lasciare il posto a una vita vissuta accontentandosi di soddisfare i propri bisogni primari, considerati come gli unici davvero necessari all’uomo. Di conseguenza oro e argento non sono di nessun valore, sono anzi posti in un ottica dispregiativa e usati per incatenare i prigionieri e gli schiavi (che neanche se la passano proprio male), o al meglio adoperati per pagare mercenari assoldati per eventuali guerre a scopo di difesa dell’isola o dei suoi alleati; la rarità di questi metalli non è infatti, agli occhi degli Utopiani, nient’altro che un modo che la Natura ha avuto per comunicarci la loro inutilità, mentre ci ha posto sotto agli occhi, in modo che sia facilmente reperibile, tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Una società proto-comunista esposta da More per mettere in risalto i problemi dell’Inghilterra del XVI secolo, e per porre all’uomo un’altra questione centrale del periodo umanista: i filosofi e i pensatori dovrebbero prestare il loro intelletto alla vita pubblica, facendo da consiglieri ai sovrani? Sarebbero disposti a barattare la purezza delle proprie idee (che incontaminate sarebbero viste da persone dedite al proprio interesse come eresie) per il compromesso del “male minore”, o finirebbero per imparare a zoppicare?
Una domanda a cui More non dà risposta, come probabilmente non ci è ancora riuscito nessuno.
“E che dire di coloro che accumulano beni superflui non per farne un qualche uso ma solo per compiacersi del contemplarli: è davvero un piacere quello che ne traggono o è soltanto immaginario? […] Eppure tu, sepolto che tu abbia il tuo tesoro, esulti come se finalmente fossi libero da qualsiasi pensiero? Ma se qualcuno te l’avesse rubato e tu, senza esserne a conoscenza, morissi dieci anni dopo, in tutti i dieci anni nei quali sei sopravvissuto al fatto, che differenza fa se esso ti è stato effettivamente sottratto o è rimasto al suo posto? In entrambi i casi te n’è venuto lo stesso vantaggio, né più né meno.”
Frammenti
Un vero peccato che Franz abbia deciso di dare alle fiamme buona parte della sua produzione letteraria. Questa triste decisione è quantomai evidente nella lettura di questa raccolta (edita Mondadori) di tutti i suoi racconti arrivati fino a noi; o meglio, di ciò che di essi è rimasto. Sì, perché quelli raccolti all’interno di questo libro - soprattutto all’inizio - sono molto spesso dei semplici frammenti che potrebbero appassionare un profondo studioso dello scrittore praghese, ma frustrare chi al loro interno voglia cogliere un senso. Di per sé, Kafka non è già uno scrittore semplice da affrontare, figurarsi quanto sia difficile seguire racconti spezzettati o senza conclusione. Devo ammettere che soprattutto la lettura della prima metà è quasi frustrante, tra racconti complessi e surreali fino all’eccesso (forse anche frutto di una scrittura ancora giovanile) e altri spezzettati e dunque incomprensibili.
La boccata d’aria si ha con “La metamorfosi”, che per la sua profondità personalmente considero non un racconto bensì un romanzo vero e proprio. Sebbene i racconti si facciano, col proseguire delle pagine, sempre più “integri”, devo dire che probabilmente Kafka dà il meglio di sé nei romanzi e nei racconti lunghi. Le storie lunghe una pagina o poco più sono per la maggior parte fine a sé stessi, senza una specifica profondità - a volte, non vorrei dire una blasfemia, addirittura senza senso - mentre quelli più lunghi permettono allo scrittore di sfoggiare tutta la maestria e la complessità di pensiero che lo hanno reso uno scrittore unico e inimitabile. Sono proprio queste produzioni, tra cui mi sento di citare “Nella colonia penale” e “Indagini di un cane”, a rendere questa raccolta di racconti degna di essere letta, anche se personalmente mi fionderei direttamente su queste storie e poche altre. La scrittura di Kafka è ostica, criptica, surreale, con un utilizzo scarsissimo di dialoghi che la rendono più lenta e difficoltosa (un esempio lampante di questo è il racconto “La tana”) ma estremamente soddisfacente quando se ne riescono a cogliere le sfumature di significato.
Ervino Pocar, nella quarta di copertina di questa raccolta, afferma: “I racconti stanno non solo a uguale livello, ma superano i romanzi: non esito a dire che un racconto come La metamorfosi vale certo Il castello”. Usare come metro di paragone un capolavoro come “La metamorfosi” non è proprio un gioco leale: non basta quello a risollevare tutto il resto. I racconti vanno considerati nel loro valore singolo, e mentre ce ne sono alcuni davvero degni di nota e dall’alto valore letterario, ce ne sono altri che lo sono molto meno. E se proprio volessimo indulgere in paragoni tra romanzi e racconti, quale di questi varrebbe un capolavoro come “Il processo”?
“Negli ultimi tempi ripenso sempre più alla mia vita, cerco l’errore decisivo, colpa di tutto, che potrei aver commesso, e non riesco a trovarlo. Eppure devo averlo commesso perché, se così non fosse e, nonostante ciò, con l’onesta fatica di una lunga vita, non avessi raggiunto ciò che volevo, avrei la prova che ciò che volevo era impossibile e ne seguirebbe il crollo di tutte le speranze.”
| 447 risultati - visualizzati 1 - 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |