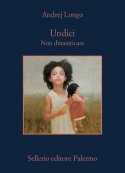Opinione scritta da Mian88
| 1516 risultati - visualizzati 401 - 450 | « 1 ... 6 7 8 9 10 11 ... 12 31 » |
Piranesi e L'Altro
Piranesi sa di essere solo nella Casa. Questo è un luogo dai mille volti e le mille sfaccettature, è un luogo caratterizzato da ambienti particolari che vanno da Sale e Muri ma anche a Statue di Morti che puntualmente il nostro protagonista visita e omaggia.
«La sua Schiuma aveva il colore bianco delle vecchie lische di pesce e i suoi gorghi profondi erano color peltro. In pochi secondi, le sue Acque sono arrivate all’altezza della Vita delle Statue del Primo Livello. Per ultima è arrivata la Marea dai Saloni Settentrionali. Si è scaraventata su per la Scalinata centrale, riempiendo il Vestibolo con un’esplosione di luccicante Schiuma bianco ghiaccio. Ne sono stato inzuppato e accecato. Quando sono riuscito a vedere di nuovo, le Acque scorrevano come cascate lungo le Statue. È stato allora che mi sono reso conto di aver commesso un errore nel calcolare il volume della Seconda e della Terza Marea. Una gigantesca Torre d’Acqua si è riservata sulla scalinata fino al punto in cui ero accovacciato. Un’enorme Mano d’Acqua si è protesa per strapparmi via dalla Parete. Ho gettato le braccia intorno alle Gambe della Donna che sorregge un Alveare e ho pregato la Casa di proteggermi. Le Acque mi hanno ricoperto, e per un istante, sono stato circondato dallo strano silenzio che arriva quando il Mare ti sommerge e soffoca i suoi stessi suoni. Ho pensato che stavo per morire; oppure che sarei stato trascinato via nei Saloni Sconosciuti, lontano dal fragore e dal ronzio delle Maree Note. Mi sono aggrappato con forza. Poi, bruscamente com’era iniziato, tutto è finito.»
Unica sua compagnia, o meglio contatto, è con “L’altro”, un uomo dalla corporatura slanciata, alto circa un metro e ottantotto centimetri, tra i cinquanta e i sessant’anni, la pelle olivastra, capelli e baffi marroni e barba brizzolata che incontra il martedì e il venerdì con cadenza mensile. Questo è il detentore della Conoscenza, colui che più la ricerca insieme a Piranesi. Lo stesso nome del nostro narratore è suo frutto, quest’ultimo infatti non gli è proprio e anche per questo egli si auto-appella Myself.
La narrazione dell’opera ha luogo con i pensieri della voce narrante che ci conducono in questo labirinto che è la Casa e con questo mistero che ruota attorno a tredici persone che un tempo l’hanno abitata e che lui non perde occasione di omaggiare. Ma cosa ricordi davvero Piranesi? È questa la domanda che gli viene posta da L’altro.
«“Ora Dimmi. Cosa ricordi?”
“Cosa ricordo?”, chiesi confuso.
“Sì.”
“Come domanda manca di specificità,” dissi.
“Non importa,” disse lui. “Prova a rispondere.”
“Beh,” dissi. “Suppongo che la risposta sia tutto. Ricordo tutto.”»
Ma quale volto si cela dietro questi mondi e labirinti alternativi che conosciamo? Cosa nasconde la casa e chi sono i morti? Perché Piranesi deve temere il sopraggiungere di quel tanto atteso visitatore che ormai è certo sopraggiungere?
«La Casa è preziosa perché è la Casa. È abbastanza in e di Se Stessa.»
Ha inizio da queste brevi premesse “Piranesi”, fantasy tanto atteso che si dimostra essere originale in particolare per quella capacità di suscitare al contempo smarrimento ma anche curiosità per i fatti che si sviluppano. Il lettore è spronato a ricomporre il puzzle ed è affascinato da elementi allegorici, in particolare nella seconda parte quando l’opera prende anche delle tinte di “giallo”.
I personaggi sono tutti perfettamente delineati seppur con tratti semplici e apparentemente approssimativi. Se Piranesi è la mente scientifica che è incuriosito dalla Casa, L’Altro ne odia ogni aspetto tanto da sviluppare verso questa un vero e proprio astio.
L’elaborato proposto da Susanna Clarke tutto è tranne che un classico titolo del genere fantastico, è un rebus vero e proprio da risolvere che conquista sia i lettori più avvezzi che meno. Sorprende altresì per le tematiche filosofiche e la ricerca dell’Io e di se stessi che vengono affrontati tra le pagine. Non indimenticabile ma una piacevole scoperta.
Indicazioni utili
Paul, John, Del, Mr. Jingles: le anime del Miglio
«Certe volte a un uomo prende il bisogno di conoscere una cosa e se ne fa un tormento che è peggio di una maledizione, e così fu per me allora. Mi abbassai su un ginocchio e cominciai a slacciarmi una scarpa.»
Correva l’anno 1996 quando “Il miglio verde” fece la sua prima apparizione quale romanzo a puntate su una rivista per riscuotere un successo inaspettato capace di catapultarlo in un volume unico nell’anno 1997. E non stupisce nemmeno che dal titolo sia stato poi tratto anche un grande adattamento cinematografico estremamente fedele alla parola scritta se non per alcuni piccoli dettagli probabilmente dovuti a esigenze di pubblico.
Due le assi temporali con le quali Paul Edgecombe ricompone la storia. Da un lato conosciamo la sua terza età, lo riscopriamo in una casa di riposo ove è stato ricoverato dai nipoti, dall’altro torniamo con lui a quel 1932 e a quando il suo compito era quello di guidare le guardie del braccio della morte, il blocco E, nel carcere di Cold Mountain e di accompagnare i condannati per quel del Miglio Verde, il loro ultimo cammino da vivi. È una calda estate e Paul è affetto da una maledetta infezione alle vie urinarie che non gli offre tregua alcuna. Mentre il dolore ne attanaglia la lucidità sopraggiunge un nuovo detenuto nel luogo di detenzione, un uomo che subito spicca per il suo colore della pelle non bianco e per la sua mole enorme: John Coffey. Quest’ultimo è accusato di un efferato omicidio post violenza sessuale a danno di due bambine sorelle di nove anni. La colpa ricade immediatamente su di lui perché viene rinvenuto nello stringere i loro deturpati corpi privi di alito di vita e in preda a una crisi isterica. L’unica cosa che riesce a dire è di aver provato a rimediare ma senza successo. Affermazione, quest’ultima, che conferma ancor più la sua colpevolezza agli occhi dei sopraggiunti. Ma siamo davvero certi che sia lui l’artefice del duplice omicidio e del doppio stupro? Molti sono i dettagli che iniziano sempre più a non combaciare con la ricostruzione del fatto nonché le misteriose capacità delle quali egli è capace. Tra i detenuti del braccio in quei giorni spicca Delacroix, detto Del, che farà amicizia con il delizioso Mr Jingles, Wharton che nulla teme perché più che la sedia niente può essergli fatto e una guardia, Percy, per niente rassicurante con il suo fregiarsi di alte amicizie e i suoi comportamenti malvagi e schizofrenici.
Le vicende proseguiranno all’interno del carcere in modo regolare, i lassi temporali si altereranno con perfetta sintonia e piano piano la storia prenderà sempre più forma e sempre più carattere.
«La vita reale costa di più e la maggior parte delle risposte che ti dà sono diverse.»
All’interno dell’opera tante sono le tematiche che vengono affrontare con grande asciuttezza e meticolosità da King. Si parla tanto di bullismo quanto di misticismo quanto di giustizia e corresponsione proporzionale della pena in particolare relativamente alla pena di morte che al tempo del libro e all’interno della sua storia esisteva e veniva praticata con la formula della sedia elettrica. E sono tante, in tal senso, le scene riportate che suscitano riflessione e sono capaci di agghiacciare il lettore. Sia quelle antecedenti all’esecuzione con le prove “tecniche” che quelle successive, sia quelle relative a queste anime che hanno compiuto gesti efferati ma che non riescono a vedersi dall’interno in quel male mietuto e che vengono per questo osservate in modo completamente diverso dalle guardie che le riscoprono nel non crimine. Si parla ancora di proporzione della pena, ci si interroga sul quanto sia corretta la pena capitale soprattutto quando il rischio di condannare un innocente è alto e anche quando il vero reo rischia di essere ricoverato in una cella limitrofa.
Oltre alle problematiche che vengono affrontante in questo scritto altro suo elemento peculiare è lo stile narrativo che si presenta al lettore con grande lucidità, non tanto per erudizione quanto per capacità evocativa. La scrittura di King è in queste pagine ancora più una sceneggiatura che di norma e questo la rende vivida. Ogni scena è impressa nella mente del lettore ma è anche resa in modo chiaro quasi come se fosse dipinta immagine per immagine.
Un titolo che tocca il cuore, che incuriosisce anche se si è visto il film, che solletica la curiosità. Da leggere per riflettere.
«Il fatto semplice è che il mondo gira. Puoi sederti e girare con il mondo o puoi alzarti in piedi per protestare e venire catapultato fuori.»
Indicazioni utili
Hill House
«La paura» disse il professore «è la rinuncia alla logica, l’abbandono volontario di ogni schema razionale. O ci arrendiamo alla paura o la combattiamo; non possiamo andarle incontro a metà strada.»
“Hill House” inquieta con la sua vista sin dalla lontananza più remota. Ergendosi sola contro le colline essa appare chiusa intorno al buio e dal buio, quasi come se fosse risucchiata da questo e da questo incatenata. Tante le stranezze che la caratterizzano così come quel mito che attorno a essa si racchiude e che la vede protagonista di dicerie paesane e terrore condiviso. Quando la giovane Eleanor Vance, trentaduenne, giunge in quel della sua nuova dimora, non è pienamente consapevole del dove ella abbia accettato di andare. Dopo una giovinezza passata – ultimi undici anni – ad accudire la madre e a essere schiacciata dalla sorella che in lei non ripone fiducia decide di scappare, prendere la macchina sulla quale è stato imposto il veto all’utilizzo e accettare l’invito del professor Montague a risiedere in quel della casa maledetta. Lì giunta la sua presenza sarà accomiatata da Theodora, detta Theo, che al contrario di lei è emancipata, abituata a vivere nel lusso e a essere fortemente sicura di sé. Al duo si aggiunge Luke, un imbroglione erede di Mrs. Sanderson, proprietaria di Hill House perché almeno un membro della famiglia doveva essere presente all’esperimento. A concludere i volti umani i due governanti, Mr. e Mrs. Dudley, che si palesano esclusivamente durante il giorno, con orari ferri e per espletare le mansioni delle quali sono stati incaricati. Eh sì, perché il professor Montague, antropologo ha deciso di indagare sui fenomeni paranormali ed è proprio attorno a questi che ruota la vicenda ideata dalla Jackson e che si compone attorno al più grande dei cliché: la casa infestata. Un racconto dell’orrore? Un titolo con il quale tremare dalla prima all’ultima pagina? Assolutamente no. Pertanto, se deciderete di avvicinarvi a questo scritto non aspettatevi le ambientazioni spettrali da serie televisiva o chissà quale brivido da horror e/o splatter del genere. L’opera va contestualizzata ai giorni nostri e se un tempo poteva risultare inquietante, a mio modesto avviso, non lo è certo per porte che sbattono o per i misteri che ruotano attorno alle vicende che si articolano.
E se i candidati sono tutti stati scelti in funzione di uno specifico motivo e di una vicinanza al paranormale (vedi Eleanor che ha assistito a una manifestazione di poltergeist o Theo che ha facoltà di telepatia e premonizione), lo stesso fenomeno del paranormale non tarda a palesarsi e a colorare le pagine portando alla luce ogni più intima fragilità dei protagonisti.
E sono infatti queste paure più profonde e radicate a essere i veri fantasmi che abitano Hill House. Il passato tornerà ad affiorare, i conti in sospeso non mancheranno di mietere altro dolore, i ricordi a pulsare nella mente. Nessuna delle voci narranti resterà indifferente anche se, certamente, quella che più risentirà di questo dolore tornato alla luce sarà Eleanor che tra tutte ha un vissuto più doloroso e sacrificato.
Risentirà della mancanza di radici, di legami, di quella madre che ha accudito, di quella sorella che non la comprende e da qui, e per mezzo della sua voce, avrà inizio un vero e proprio viaggio nella psiche umana e nei suoi retroscena più intimi.
Il tutto per mezzo di una penna precisa, minuziosa, descrittiva ed evocativa, talvolta lenta, a cui si sommano dialoghi serrati e una forte introspezione. È un romanzo che suscita da un lato attrazione e che dall’altro respinge, un titolo che inizia con lentezza e che nella sua prima parte rappresenta il cliché dei cliché tanto che è soltanto nella sua seconda prende davvero forma e arriva nel suo contenuto che lascia un retrogusto amaro. Una lettura alla quale avvicinarsi con la consapevolezza di non essere di fronte a un horror quanto a un elaborato capace di guardare nell’io umano.
«Non sappiamo mai da dove ci venga il coraggio.»
Indicazioni utili
Mattia
«Sono diventato grande da piccolo, quando un virus mi costrinse a chiudermi in casa con una persona che detestavo. In una storia degna di questo nome, l’eroe si allontana dal suo ambiente naturale per avventurarsi in un mondo sconosciuto, dove combatte il mostro che ha dentro finché non lo uccide o viene ucciso da lui. Ho compiuto quel viaggio a nove anni, senza mai oltrepassare il portone del mio condominio. Non ero solo. Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare. Qualcun altro non ci riuscì.»
Mattia ha soltanto nove anni quando il mondo che lo circonda e che da sempre è stato la sua quotidianità crolla. Lui e il suo amico Puff e il nuovo venuto felino dalle striature d’oro chiamato Piccipò si ritrovano a dover vivere una vita completamente diversa e soprattutto a dover affrontare la presenza ingombrante di quel padre che non vive più con loro e che si scorda anche le cose basilari dell’esistenza di suo figlio. Eppure, da adesso dovrà sopportarlo, dovrà accettare le sue frasi, il suo dormire accampato in quella stanza che un tempo era soltanto la zona giorno/cucina. E dire che questa situazione avrebbe potuto essere il Paradiso per lui! E che Paradiso! Niente scuola e soprattutto niente compagni di classe che lo prendono in giro per le merendine biologiche che la mamma di soppiatto gli infila nello zaino.
Cosa è successo? È successo che è scoppiata la pandemia per quella malattia chiamata covid-19, è successo che suo padre non può tornare a Roma dalla nuova fidanzata e così, dopo anni, i suoi genitori separati si ritrovano a condividere lo stesso tetto, è successo che non ci possiamo più abbracciare e che ogni contatto umano può essere pericolosissimo, è successo che il mondo è cambiato, gli adulti hanno dovuto rivedere le loro certezze e abitudini e i giovani hanno dovuto fare i conti con una crescita anticipata e repentina. Anche i bambini.
E hanno inizio così quei giorni di convivenza forzata che sembrano essere un passato remoto in un tempo sospeso, inizia così a essere rivalutata la realtà e a essere ricalibrata su nuove abitudini. Ed è ancora da qui che hanno inizio le riflessioni. Riflessioni sugli eroi in corsia, sulla gentilezza, sul coraggio, sulla brevità della vita. Riflessioni su suoni che avevamo dimenticato o che semplicemente non eravamo più abituati ad ascoltare. Inizia così una ricerca di se stessi, una ricerca di nuovi confini. Il tutto avviene con la prospettiva di un bambino che osserva da fuori, impara per osmosi, che cerca di capire quel che non capisce e di trovare risposte in quello che non conosce.
“C’era una volta adesso” è uno scritto raccontato in chiave fiabesca e nella prospettiva di un bambino, al tempo, che ritorna al momento dei fatti da adulto, nel presente, e che con dolcezza e premura ci riporta ai momenti del primo Lockdown e a tutto quello sconvolgere che ne è determinato. È un libro di rapida lettura, fluente e magnetico. Uno di quei libri che si leggono per ricordare e rivivere ma che non appesantiscono l’animo nonostante il tema. Un Gramellini che torna con tutta la sua prosa poetica in un argomento che di poetico ha ben poco.
«L’amore, Matti, è una danza. E la vita è un’orchestra che suona canzoni sempre diverse. I due ballerini devono adeguarsi ai cambi di ritmo senza pestarsi i piedi e cercando un Perché che dia loro la forza di continuare a ballare.»
Indicazioni utili
Generazioni a confronto
Il nuovo protagonista di Gaetano Savatteri è un giovane giornalista disoccupato dal nome di Saverio Lamanna. Siamo in Sicilia, una Sicilia che assomiglia alla Siberia essendo radicate le avventure in quel delle Madonie e più precisamente nella città di Castelbuono. Fidanzato con Suleima, l’uomo si trova ad indagare sulla morte di Steve Parker deceduto in un burrone. Che si sia trattato di un omicidio o sia stata mera fatalità? Ma chi era davvero Parker? Un manager milionario che amava le Madonie e cos’altro? Chi altro?
All’indagine tradizionale si somma il tema del conflitto generazionale tra più giovani e dimensione dei più anziani.
Tante le domande che si susseguono in questo breve testo che si presta a una lettura gradevole e rapida. Con una penna fluida e una prosa ricca, “Il lusso della giovinezza” è uno scritto che si esaurisce in poche ore e che ha la gran bella caratteristica di essere intriso di elementi e riferimenti della nostra quotidianità (perfino il settimanale “Robinson” di Repubblica) che non mancano di suscitare interesse ed empatia nel lettore. Un titolo da scoprire, dove il giallo è sulle retrovie e in prima linea al contempo e con quel giusto grado di riflessione.
Indicazioni utili
Memoria e dolore
«Non hanno inventato nessuna parola per una sorella rimasta senza sorella.»
Margherita è scomparsa prematuramente, Margherita è stata colpita da quel male incurabile che l’ha portata via con sé in quell’anno 2016 che ha spaccato i cuori e lacerato le anime. Ognuno ha reagito alla perdita in modo diverso ma tra tutte, colei che più ne ha percepito il dolore è stata Marcela, colei che cerca di esorcizzarlo, quel male che sente dentro, con l’isolamento ma soprattutto con la scrittura.
Ricordi, parole, immagini, memoria, perdita. In un prima e in un dopo Margherita, in quel di un legame tra sorelle conflittuale quanto profondo, ma che non deve essere dimenticato ecco perché va esorcizzato ma senza smettere di soffrire perché smettere di sentire il dolore equivarrebbe a dimenticarla.
Ricomincia a fumare, Marcela, dopo dieci mesi di assoluto e rigido rigore nell’intento di smettere. Ricomincia a ricordare. E verga, annota, scrive, prende appunti. Compone e compone. Ci fa destinatari di questo quaderno di appunti e pensieri in cui è il legame tra quelle due donne adesso separate da un confine mortale a rendere ancora possibile quel che non è più possibile.
«Negare la morte? Il mondo è dei vivi e di come si affratellano, di come si legano con i morti. L’ unica cosa importante è lei tra i viventi, la sua memoria. La morte, dove sta la morte? Dov’è la sua vittoria? Non regalerò la vittoria alla morte, continuerò a scrivere.»
E pur non negando la morte, pur non negando la vita, pur non negando il lutto prende forma e corpo “Il mantello” opera di grande intensità a firma di Marcela Serrano. Sembra quasi di trovarsi di fronte a un quaderno di pensieri e aforismi; eppure, in queste pagine c’è dolore, sentimento, c’è la traccia di un legame che mai verrà mancando.
Tutto ha luogo nell’intimità più profonda del ricordare e dell’animo, in uno scrivere che è catarsi e catena. Buona lettura!
«Ho letto qualcosa poco tempo fa, non ricordo dove, sulle creature rammendate.
I sofferenti non sono altro che questo, gli afflitti.
Rammendati.»
Indicazioni utili
Plectrude
Il nome è spesso sinonimo di radice ma anche di destino. Chi lo porta ne rappresenta l’essenza, il cuore, l’anima. E questo, Plectrude, lo sa molto bene. Lei che sarà una donna fuori dagli schemi e che ha un percorso di vita estremamente difficile essendo nata in quel di un carcere da Lucette, una madre uxoricida e suicida dopo la nascita, che le imprime sulla pelle un nome che è un peso non indifferente. Adottata dalla sorella della madre e con già due figlie, ella cresce in un ambiente dove non è semplice sopravvivere alle pressioni.
Seppur sia immancabile quel tocco tipico della penna di Amélie Nothomb in questo scritto quel che viene trattato è un tema molto forte e reale che porta l’autrice ad abbandonare quei toni un po’ più ironici e dissacranti a cui ci siamo abituati nelle letture dei suoi scritti. Perché se da un lato ritroviamo temi cari e già affrontati che vanno dal passaggio dall’adolescenza all’età adulta (che ritroveremo anche in “Antichrista”, per citare un titolo), la narratrice non si risparmia di parlarci di anoressia. Plectrude ama danzare, fa di questo la sua ragione di vita, vi si dedica anima e corpo tanto da cadere in questa malattia così irrefrenabile e inarrestabile. Si chiuderà in uno scrigno le cui chiavi sono andate perdute esattamente come tanti di quei rapporti umani e sentimenti che precedentemente aveva e provava.
E se la linea narrativa stupisce per le descrizioni minuziose di quegli allenamenti, e se da un lato non ritroviamo quel sarcasmo proprio della romanziera, ecco che siamo sbaragliati dai contenuti e anche dal vero. Perché con questa opera Amélie Nothomb racconta la storia della cantante Robert per la quale ha scritto molte canzoni ma ci racconta anche una parte di sé perché è stata lei per prima colpita dalla malattia.
Si potrebbe dire tanto ancora su questo titolo ma credo sia opportuno non andare oltre perché la storia ha molto da offrire dall’inizio alla fine, sino a quell’epilogo che spiazza e che ci riporta a quella componente surreale fedele e onnipresente e chiede semplicemente di essere ascoltata.
Indicazioni utili
Gli Stati-Civiltà
Cos’è la civiltà? Quale concetto può essere a essa attribuito? Perché nonostante sia una delle parole più importanti del nostro lessico culturale i suoi confini sono così vacui, indefiniti? Cosa questa ci fa davvero venire in mente? E soprattutto perché pensando a essa siamo soliti riferirla alla cultura occidentale e più precisamente a quella culla del passato in cui hanno trovato sede i nostri principali insegnamenti? Tuttavia, per quanto non sia semplice circoscriverne un significato univoco è istintivo, nella nostra mente, ricollegarla a concetti familiari un po’ come accade per il dogma Stato-Nazione. Quest’ultimo è un altro concetto che siamo soliti riconoscere sotto la pelle, che sentiamo nostro anche se non sempre riusciamo a identificarci in questo. Altro cliché è quello di associare il dogma Stato-Nazione alla società occidentale perché caratterizzata da uomini istruiti, industrializzati, ricchi, democratici. Ma è davvero così? È giusta questa affermazione e questa associazione naturale? In parte lo è e più precisamente lo è per quanto concerne il dato culturale e quindi quell’ulteriore passetto che possiamo compiere nell’analisi e che ci porta a ricercarne una definizione stessa.
«Certo che ce lo ricordiamo e ridiamo di gusto; e lo sconosciuto imprevisto a cui capita di trovarsi lì con noi si sente come un pesce fuor d’acqua. Bene, questa è (nella sua dimensione sociale) la Cultura. Quando noialtri della grande Famiglia della Cultura ci incontriamo, ci scambiamo ricordi di nonno Omero, del terribile vecchio dottor Johnson, della zia Saffo e del povero Johnny Keats.»
Oggi come oggi, nella società degli anni duemila, molte cose sono cambiate così come sono mutati molti di quei pilastri che abbiamo sempre riconosciuto quali improcrastinabili e immutabili. Le variabili economiche, i dati storici, le lotte di potere, i nuovi giochi di potere che sono propri di quegli Stati rivali da sempre e che sembra che stiano giocando una partita a scacchi, hanno rotto gli equilibri e per questo, seppur sia possibile identificare un denominatore comune di partenza, tante sono le peculiarità a cui dobbiamo prestare la nostra attenzione e tante ancora sono le domande alle quali dobbiamo trovare una risposta, anche se non semplice.
“Lo scontro degli stati-civiltà” di Cristopher Coker tratta del modo in cui i governi e i movimenti non occidentali utilizzano la valuta della civiltà per i propri obiettivi, per i propri fini politici, per quegli scopi che vanno oltre l’interesse della collettività perché riferibili anche a presunzioni personali e/o statuali che esulano dal termine proprio. Oltre a ciò, l’opera, si prefigge anche di trattare quelle ragioni per le quali il mondo occidentale sta affrontando una delle più grandi, se non la più grande, crisi di tutta la sua storia; cerca ancora di trovare spiegazioni a quelle sinistre ossessionate da politiche identitarie nei confronti di quegli oratori dissenzienti e di dare spiegazione a quelle destre che, dal loro canto, sono sempre più dedite alle negazione dell’ovvio, che rifiutano le civiltà liberali, che perdono dei valori più universali e che tendono ad una altrettanta deriva.
Un titolo forte, provocatorio, dal retrogusto ironico e sarcastico ma dagli obiettivi chiari è “Lo scontro degli stati-civiltà. Caratterizzato, ancora, da uno stile pungente che nulla risparmia al lettore, Coker dona al suo pubblico un elaborato affatto scontato e che tra analisi del presente e del passato si prefigge obiettivi importanti che portano il lettore alla riflessione.
“Lo scontro degli stati-ciiviltà” è un saggio di grande attualità, ben costruito, solido, che sa approfondire e che dona al suo conoscitore un bagaglio di temi sui quali soffermarsi. Da leggere.
Indicazioni utili
Scienza e letteratura
«A partire dallo studio empirico di Aristotele sulla biologia marina della laguna di Pirra sull’isola di Lesbo intorno al 344 a. C., per giungere fino a noi attraverso Banks, Faradey, Tyndall, Gauss, Cajal, Einstein, Heisenberg, la tradizione letteraria scientifica è vasta, ricca e plurilinguistica.
[…] È una letteratura che dovrebbe appartenere a tutti, non solo a chi esercita una professione scientifica.»
Da sempre McEwan è noto per la sua predilezione alle scienze, passione che sovente ha riportato anche nei suoi stessi romanzi e nelle più variegate forme. Con la letteratura, ci ricorda lo scrittore, il contatto è diretto sin dalla prima frase perché da questa percepiamo una presenza, percepiamo le qualità di una determinata mente, cogliamo i frutti del lavoro che c’è dietro e delle riflessioni che hanno anteceduto l’opera del narratore. Con la scienza le cose cambiano, la prospettiva muta. Perché la scienza si pone domande diverse e cerca risposte diverse.
«Perché in segno di affetto i gatti inarcano la schiena? Un’emozione, sostiene, è uno stato fisiologico, l’espressione diretta di un cambiamento fisiologico. Nel cercare una risposta a queste domande, Darwin si concede numerose piacevoli digressioni e osservazioni. […] Dietro questa profusione di dettagli ci sono domande più basilari. Impariamo a sorridere quando siamo felici, oppure il sorriso è innato? In altre parole, le espressioni sono universali in tutte le culture e le razze, oppure sono culturalmente specifiche?»
Cinque i saggi contenuti in “Invito alla meraviglia. Per un incontro ravvicinato con la scienza”, mediante i quali McEwan riesce nel suo intento di dimostrare ai suoi lettori quanto in questa non sia insito soltanto sacrificio e fallimento, ispirazione e obiettivi quanto anche una falsa distanza con il mondo circostante. È infatti attraverso un excursus nelle vite degli scienziati che questo coglie l’emozione della scoperta e dimostra a chi legge che non c’è lontananza tra scienza e letteratura, tra scienza e umanità, tra scienza e quotidianità. E se da un lato siamo affascinati da Charles Darwin e i suoi viaggi, dall’altro siamo intrigati dalle teorie sull’origine della specie. E se da un lato incontriamo Darwin, dall’altro non manca all’appello Einstein con la sua teoria della relatività. Cinque saggi per cinque voci che hanno fatto parte della nostra storia e del nostro presente.
A ciò si somma una analisi sulla narrazione, sulle tecniche narrative, sugli stili letterari e sul come la parola muti in funzione del mutare del tempo e dello spazio che la circonda.
«Joyce e Virginia Woolf hanno trovato nuovi mezzi per rappresentare il flusso di coscienza, mezzi che oggi sono comunemente usati, persino nei libri per l’infanzia.»
Non mancano, infine, spunti di riflessione sulla religione, sulla laicità, sulla salvezza e l’apocalisse e l’io. L’essere, l’individualità, la rappresentazione del sé, la relazione con l’altro.
Un titolo di appena 113 pagine che non manca di solleticare le corde del lettore e di invitarlo ad aprire gli occhi su quelle meraviglie che ci circondano e che fanno parte della nostra vita anche quando non ce ne rendiamo conto.
Per amanti dei saggi e non solo.
«Come ormai dovrebbe essere chiaro, io penso che l’esercizio dell’immaginazione e dell’ingegnosità espresso nella letteratura confermi la visione di Darwin. Non sarebbe possibile leggere e apprezzare la letteratura di un tempo per noi remoto, o di una cultura profondamente diversa dalla nostra, se non condividessimo con lo scrittore un terreno emotivo comune, un vasto serbatoio di presupposti. Un’edizione annotata che chiarisca alcune circostanze storiche o peculiarità linguistiche o usanze locali è sempre utile, ma non è mai indispensabile alla lettura. Quel che tutti abbiamo in comune è a suo modo altrettanto straordinario delle nostre esotiche differenze.»
Indicazioni utili
Onore, vendetta, riscatto.
Torna in libreria Wilbur Smith con “Il richiamo del corvo” opera con la quale l’autore ci invita a riflettere sul destino e la brutalità della natura umana in particolare soffermando la propria attenzione su quel che è stato lo schiavismo in America e sulla potenza dei sentimenti. Sono proprio i sentimenti a far da padroni fra queste pagine, sentimenti ed emozioni che possono distruggerci oppure farci crescere.
Tutto ha inizio quando Mungo St John è costretto a far ritorno a casa dall’università a causa della morte del padre. Mungo ha sempre dato per scontata la sua condizione di agio e benessere. Per lui era un qualcosa di improcrastinabile e di naturale essendo da sempre abituato a non dover far altro che desiderare un qualcosa per appagarlo. Eppure, quando torna a casa, scopre che il suo destino sta per prendere, anzi ha già preso, una direzione diversa perché ha perso tutto. Tutto quello che determinava il suo status benestante non esiste più. Chester Marion, l’avvocato al servizio della famiglia, che si è occupato della proprietà dei St John, li ha mandati in rovina e per mezzo di un subdolo inganno è riuscito a intascarsi l’eredità dell’erede legittimo. Schiavi compresi, compresa la sua Camilla la giovane serva di cui Mungo è innamorato da sempre, compresa quella serva che adesso è resa l’amante del suo nuovo padrone.
Da qui Mungo giura vendetta, giura di riappropriarsi di quel che gli spetta e di liberare quella donna che tanto ama. Le strade in un certo senso si dividono perché mentre lei è costretta a piegarsi alla realtà della schiavitù, egli dovrà fare i conti con una serie di avversità che mai ha dovuto fronteggiare e decidere se spingersi oltre i limiti.
«Una professione magnifica e nobile» sottolineò Mungo, «ma se mai riuscirete a eliminare il traffico di schiavi resterete senza lavoro, quindi è nel vostro interesse garantire che prosegua.»
Fairchild lo fissò orripilato. «Discutere con voi è come discutere con il diavolo in persona» si lamentò. «Il bianco è nero e il nero è bianco.»
Con una penna rapida e fluida, Wilbur Smith dona ai suoi lettori un romanzo d’avventura dalle tinte storiche che non manca di coinvolgere nelle vicende e arrivare a un pubblico vasto. L’opera che contiene al suo interno i tratti tipici dell’avventura, della storia, dell’amore, dell’inganno, del riscatto, della possibilità di salvezza, della ricerca di una nuova strada da poter intraprendere, della schiavitù, dell’odio, della vendetta, della passione e del sentimento, si presta alla lettura di lettori molto eterogenei tra loro. Smith a quarant’anni dalla pubblicazione di “Quando vola il falco”, il primo romanzo della serie dei Ballantyne, torna a proporci un nuovo episodio avente come protagonista uno dei personaggi più amati e più odiati per il suo essere al contempo sia Dr Jekyll che Mr Hyde.
Il titolo non può definirsi il miglior lavoro dello scrittore soprattutto per chi ha letto i suoi lavori più famosi e di successo ma rappresenta comunque una lettura con un suo perché e con qualcosa da dire in particolare proprio sull’aspetto relativo alla schiavitù che pagina dopo pagina emerge con un quadro vivido e ben delineato.
Lineare nella sua costruzione, logico nel suo sviluppo, “Il richiamo del corvo” è una lettura rapida che si conclude in un paio di giorni e che è adatta a chi ama questa tipologia di romanzi a prescindere dall’aver letto i libri precedenti ma anche a chi cerca un elaborato non troppo impegnativo con cui trascorrere ore liete e staccare la spina ma con un componimento intelligente e che nulla lascia al caso.
Godibile, piacevole, di intrattenimento.
Indicazioni utili
3 marzo 1944
È il 3 marzo del 1944, il treno 8017 è fermo nel bel mezzo della galleria di Balvano. Partito con il suo carico di anime, di uomini, donne e bambini clandestini da Napoli per quel di Potenza, luogo ove la guerra altro non è che un ricordo lontano e la fame non esiste non mancando per nessuno il cibo, è adesso il palcoscenico dove è la morte a regnare sovrana. Corpi su corpi si intravedono nel suo ammasso dolente e fermo, sembra che stiano dormendo eppure alcun alito di vita è più presente in loro. Ma cosa è successo? Cosa è davvero accaduto a quel convoglio e ai suoi passeggeri? E perché quel mistero si è celato così a lungo negli anni quasi come se fosse un fatto dimenticato, un qualcosa di appartenente ad un’altra vita ad un altro mondo?
Ma facciamo un passo indietro di qualche mese. Brando Carenza è chiuso nel suo fortino di silenzio, un silenzio spesso come un muro ed eretto per proteggersi da quei pensieri, lui che deve farsi carico della famiglia anche se è appena un ragazzo. Un giovane uomo che è una delle tre voci narranti dell’opera.
«Brando non ha pianto. Lui non lo fa mai. Lui osserva, ascolta, pensa e chiude tutto nella cassaforte del suo silenzio.»
Conosciamo così anche Nora Moscati, anch’essa giovanissima, che conosce soltanto un sonno fatto di leggerezza, un velo sottile dal quale è sovente destata. È tormentata da quelle Malombre che la terrorizzano e che sono al contempo anche premonitrici che le si palesano innanzi agli occhi. Da una spilla a forma di farfalla mai si separa, è quanto le è rimasto del fratello Pietro, al fronte.
E conosciamo infine Rocco Saturno piccolo grande uomo che ha imparato che la guerra non fa distinzioni tra grandi e piccini, che nessuno risparmia.
«Pure la misura del tempo fallisce durante la guerra. […] La memoria può essere veleno […] perché se si permette alla paura di tornare travestita da ricordo, quella piglia tutto.»
Tre voci, le loro, che si incontrano e che ricostruiscono il mistero che ci riporta agli anni del Secondo conflitto mondiale, a quei giorni di auspicata sopravvivenza.
È con uno stile fluido e magnetico che Manlio Castagna trattiene il suo lettore destinandolo di una storia che sorprende per autenticità e trasporto, che conquista pagina dopo pagina e in cui sono racchiusi messaggi importanti tanto che non fatica a restare nel cuore anche a distanza di tempo dalla lettura. Allo stile pulito ma minuzioso, evocativo e pungente del narratore, si aggiungono ricostruzioni storiche curate in ogni dettaglio, sia nelle ambientazioni che proprio nel dato di quello che fu. L’opera non manca di far riflettere il conoscitore e nella finzione del narrato riporta alla luce anche elementi di verità perché le ragioni che si celano dietro quelle morti, quel treno fermo, riguardano un nemico silenzioso che ha sorpreso i nostri viaggiatori che altro non desideravano che credere in un futuro, appigliarsi a una speranza del domani tanto da rinunciare anche alla propria identità. Perché il destino ha sempre modi beffardi per manifestarsi.
Castagna ben mixa finzione e realtà, ci offre un titolo succoso, empatico e intriso di emozione che si lascia divorare e che riporta all’attenzione un fatto troppo a lungo (e da troppi) dimenticato. Una lettura per grandi e per piccini, una lettura che resta.
«Ci sono cicatrici così profonde che il tempo non riesce nemmeno a scolorire, figurarsi a cancellare.»
«Quando perdi le radici, il vento ci mette un attimo a portarti via.»
Indicazioni utili
Penelope Spada
«La nonna diceva che le cose più stupide le fanno le persone più intelligenti. Le persone molto intelligenti fanno errori catastrofici non nonostante la loro intelligenza, ma proprio a causa della loro intelligenza.»
E questo Penelope Spada lo sa molto bene, lei che in un’altra vita è stata Pubblico Ministero, lei che proprio per un misterioso fatto del passato ha perso tutto e trascorre le sue mattinate milanesi tra caffè corretti con Jack Daniel’s dopo nottate perse con uomini sconosciuti e che mai più incontrerà. Quando Zanardi, giornalista con il quale ha collaborato spesso negli anni dei tribunali, manda al suo cospetto Mario Rossi, ella sa che le sue giornate prenderanno una piega inaspettata. Perché tra sigarette, uomini e drink con cui anestetizzare la mente, quel caso solleticherà la sua curiosità, la porterà ad indagare. Quell’uomo, indagato per la morte della moglie Giuliana Baldi e di poi scagionato con una archiviazione, vuole che a suo carico non esista alcun dubbio di possibile colpevolezza non tanto per se stesso quanto per sua figlia adesso piccola ma che un giorno sarà grande e vorrà conoscere dell’omicidio della madre e non dovrà avere dubbio alcuno sulla possibilità di un coinvolgimento del padre.
«Lo so benissimo che i sogni ci sono comunque, anche se uno non se li ricorda. Ma si può dire che una cosa esiste se nessuno la percepisce e nessuno la ricorda? Soprattutto se non è una cosa ma solo una fugace rappresentazione della mente che dorme? Non lo so, ho molti dubbi.»
Tutto ha avuto inizio in quel 13 ottobre 2016 quando Giuliana, istruttrice di fitness e personal trainer, non aveva fatto rientro a casa. La denuncia in questura era valsa a poco; il corpo della donna era stato rinvenuto il giorno seguente, nel pomeriggio, alla periferia di Rozzano. Il cadavere, rinvenuto da un pensionato che stava portando il cane a fare una passeggiata, presentava un colpo d’arma da fuoco alla testa e tanto era chiaro che quello non era il luogo del delitto essendovi la stessa stata trasportata, tanto era chiaro che la ratio della morte era proprio quel colpo di pistola calibro 38. Unico sospettato, il marito. Il caso era stato archiviato con la motivazione che non sussistevano motivi per procedere ma che comunque a suo carico sussistevano “inquietanti” sospetti a causa, appunto, di mancanza di ipotesi alternative. È questo “inquietanti sospetti” che non offre tregua all’uomo che non vuole che un domani la figlia possa anche solo lontanamente pensare che sia stato lui a privarla della madre. Da qui la richiesta di aiuto a Penny preceduta sempre dal suo intuito e impiegata in alcune investigazioni private in ambito coniugale. Ed è ovvio che la sua curiosità è forte, troppe sono le incongruenze evidenziate negli atti, il non fatto. L’indagine ha inizio e porterà alla risoluzione di un buon arcano che non mancherà di solleticare le corde dei lettori appassionati di gialli giudiziari e di Gianrico Carofiglio.
«Quella lucidità avrebbe dovuto infastidirmi o peggio. Invece no. Forse perché non sembrava, come in tanti altri casi del passato, freddezza e oscena insensibilità. Piuttosto una manifestazione dello spirito di sopravvivenza, di adattabilità istintiva agli eventi. Una cosa certamente non morale, ma nemmeno immorale. Sopravvivenza.»
Un titolo rapido è l’ultima opera a firma Carofiglio, uno scritto che si legge in pochissime ore e che si presenta quale il primo episodio di una nuova serie con una nuova protagonista. Ed è proprio Penelope il punto di forza o di debolezza del libro perché o la si ama, o la si odia. La dottoressa Spada è una antieroina, non è l’eroe per eccellenza retto e puro a cui siamo abituati nei romanzi. Sbaglia, è una figura contraddittoria (mangia sano e bio, fuma e beve come se non ci fosse un domani), non riesce a dimenticare quel che è stato, non riesce a farci i conti, è un’anima dolente. Da un lato attrae, dall’altro può respingere. Il suo temperamento e il suo carattere sono le maglie principali che spingono la storia.
Lo stile narrativo è rapido, fluido, diretto. Non mancano i riferimenti giuridici e le canoniche delineazioni in ambito legale, spiccano le emozioni e arriva l’umanità della figura della prima attrice. L’elaborato è in un crescendo, l’asticella sale e ben regge anche nell’epilogo che non delude le aspettative perché lineare e in asse con il narrato che lo precede. Non forse il capolavoro dello scrittore ma certamente un giallo piacevole e con un protagonista diverso dai soliti del romanziere con il quale trascorrere ore liete.
Adatto a chi cerca letture non impegnative, da esaurire in poco tempo, ma che abbiano qualcosa da dire e personaggi che parlano da soli. A conclusione della lettura resta la curiosità del sapere come si evolverà la figura della Spada
Indicazioni utili
Il silenzio che è presenza.
«Ma la felicità può ridursi a un singolo atto insensato e per nulla gratificante, se guardato solo con gli occhi degli altri.»
Un sogno, un sogno che fa tantissima paura. Un sogno in cui Chiara canta e conta, conta e canta ma che eppure non sembra proprio volerla abbandonare. È terrorizzata, la bambina. Così impaurita da chiedere l’aiuto dei genitori che a loro volta si rivolgono a Teresa Battaglia scortata dall’ispettore Massimo Marini e il suo scetticismo. Perché alla fine, sembra volerle dire, si tratta soltanto del sogno di una bambina di quasi nove anni emarginata e sola per quella malattia così rara che la obbliga a vivere soltanto la notte.
Ma Teresa lo sa, lo sente che non è così e che dietro le apparenze vi è altro, che il sogno non è soltanto un sogno, che l’istinto si è risvegliato e chiede di essere appagato. Cerca prima un contatto con Chiara, non è semplice creare quel ponte con un’anima dell’oscurità e della solitudine e dopo averlo trovato non si ferma. Non si ferma perché lei sa che la bambina dice il vero, che qualcosa è successo e deve scoprirlo.
«Riempiva quella stanza – la casa – in un modo che non avrebbe mai potuto comprendere, troppo giovane per aver sperimentato il silenzio in cui lei invece poteva sentire l’eco di ogni gesto, che non includeva mai qualcun altro, quando si chiudeva la porta di casa alle spalle.»
Ha inizio da queste brevi premesse l’ultimo romanzo a firma Ilaria Tuti intitolato “Luce della Notte” e terzo capitolo dedicato alle avventure del commissario che l’ha resa celebre. La lettura è rapida, si esaurisce in nemmeno una giornata. Incuriosisce il lettore e più che sul giallo muove interamente sul sentimento e l’emozione.
Se da un lato il mistero ruota attorno alla scomparsa di un bambino e a un passato radicato tra il 1995 e il 1996, tra guerre, anime alla ricerca di salvezza e disperate vie di fuga diventate forme di schiavitù senza spiraglio per il futuro, dall’altro è l’empatia quel che maggiormente trattiene e avvince. Se da un lato il lettore desidera scoprire dell’arcano, dall’altro è affascinato dal quanto scopre su Teresa e Marini, protagonisti indiscussi e su quel passato altrettanto celato che li riguarda. Un po’ debole e tirato via il finale che richiede ed esaudisce le preghiere di un lieto fine.
Una lettura piacevole, che dimostra una crescita stilistica dell’autrice, che non mancherà di conquistare il cuore dei lettori che già amano il personaggio della Battaglia e che si dimostra essere un perfetto romanzo con il quale staccare qualche ora in modo lieto.
Per chi non lo sapesse i proventi di questo titolo dell’autrice saranno completamente devoluti al centro di riferimento oncologico di Aviano a favore della ricerca sul sarcoma Ewing.
«Elaborare la vecchiaia comporta attraversare un lutto, significa fare i conti con tante perdite, ultima quella della vita. E una delle prime fasi del lutto è la rabbia. Molte persone, piene di questa rabbia, desiderano far soffrire chi sopravvive, rovinare vite. Pensa ai genitori che si rifiutano di riconciliarsi con i figli in punto di morte, o viceversa. […] Si era sentito tradito dalla comunità, forse. Rifiutato, messo da parte come un oggetto vecchio e rotto, ma lui di quella comunità conosceva molti segreti scomodi.»
Indicazioni utili
La prima indagine di Takeshi James Nishida
«È a dir poco curioso come, a volte, il destino ci leghi nella maniera più strana. In questo caso, tramite un ombrello.»
A prima vista non è altro che un anonimo oggetto realizzato con cura e dedizione per il dettaglio, quella stessa cura e dedizione che è propria alla realtà nipponica. Eppure, è proprio quell’oggetto, quell’ombrello all’apparenza così innocuo a essere l’arma del delitto utilizzata per determinare la morte di Yuki Funagawa, nato il 2 dicembre 1986. È un particolare insolito, quell’ombrello. Uno di quelli con la copertura in plastica trasparente, un modello molto comune, di taglia grande, con le stecche di una settantina di centimetri. Questo si trova chiuso sul pavimento accanto alla vittima, il bianco della punta è completamente nascosto dal sangue rappreso e da tracce di bulbo oculare destro del deceduto. Un comunissimo bene contraddistinto, per l’occhio più acuto dell’osservatore, soltanto da un puntino rosso, a prima vista un adesivo o un simbolo dipinto situato sul manico di plastica bianca. È questo dettaglio che colpisce l’ispettore Takeshi James Nishida della squadra Omicidi della Polizia di Tokyo e soprannominato Boss dai colleghi per quella grande dipendenza da caffeina in latina della omonima marca. Takeshi è un hafu ovvero un mezzosangue di madre americana e padre giapponese. È anche per questo condannato a non salirci ai piani alti; in Giappone vige la religione dei protocolli, religione di cui Nishida non è un seguace: egli appartiene alla strada. E Takeshi ha anche ereditato i tratti caratteriali della realtà occidentale, tratti che lo rendono spesso impulsivo, poco accomodante e disincantato verso quella dimensione che lo circonda e che lo vorrebbe esattamente al suo contrario.
«Negli ultimi vent’anni si era fatto un nome risolvendo casi complicati e mettendo dentro non pochi delinquenti, nonostante a volte per ottenere risultati avesse dovuto usare metodi poco ortodossi. Il che purtroppo, unito alla sua abitudine estremamente non giapponese di dire in faccia alla gente come la pensava, non andava molto a genio ai suoi superiori. Anzi, ai suoi superiori non andava a genio per niente.»
Bastano pochi rilievi per appurare che oltretutto quell’ombrello appartiene alla persona più impensabile: l’Imperatore. Ma com’è possibile? E a chi appartiene quell’altro piccolo tratto di impronta digitale che dalle analisi risulta essere presente sullo stesso? Per il Tommy Lee Jones che è Takeshi, che sovente è stato paragonato a questo personaggio stante i suoi tratti particolari che lo rendono molto avvenente, avrà inizio una indagine atta a cercare di scoprire la verità in quella che è una morte tutt’altro che chiara.
A far da sfondo una Tokyo che non dorme mai e che ci viene proposta in una serie di tinte e retroscena, luci e ombre, che per mezzo di un protagonista che per il suo sangue misto riesce a far da ponte, scopriamo in modo completamente diverso. Tra le pagine dell’opera, inoltre, oltre all’indagine verrà quindi ritratta una perfetta fotografia della società giapponese a cui si affiancherà anche la trattazione di una serie di tematiche molto attuali e a noi vicine che non anticipo essendo collegate alla risoluzione dell’enigma che ci accompagna nel giallo.
«L’ispettore ne aveva viste abbastanza da sapere che la più grande oscurità è spesso nascosta alla luce del sole, ma in quel caso gli risultava difficile credere di avere di fronte un assassino.»
Quello di Tommaso Scotti è un esordio molto interessante che propone al lettore un protagonista che entra subito nelle sue simpatie e che con rapidità coinvolge e trattiene. Il conoscitore è incuriosito dalle vicende, affascinato dalla cultura nipponica e da questa figura dai tratti fisici appena tratteggiati eppure così vivida nella mente per carattere e determinazione. L’opera è inoltre ben strutturata. Parte da presupposti ben elaborati e a questi ne aggiunge altrettanti che rendono la narrazione più stratificata e l’enigma più articolato da risolvere.
Lo stile è fluido, rapido, limpido. Accompagna per mano, conduce senza difficoltà.
Un esordio, “L’ombrello dell’imperatore” che ci presenta un autore che tornerà ancora a far parlare di sé, che non vedo l’ora di rileggere e che sarà un piacere approfondire ulteriormente.
«C’è la nostra anima qui dentro, ed è un’anima di acciaio. Questa vite è il nostro testamento imperituro in un mondo usa e getta.»
Indicazioni utili
Gaspard e Lula
«Essere un sognatore da combattimento, vivere a pieno ritmo per non sprecare nemmeno un briciolo di secondo. Smania da stella cadente. Aveva una sensibilità più spiccata degli altri. Poteva essere al tempo stesso l’uomo più felice e più triste del mondo. “Troppo” era la sua via di mezzo. Burn-in per evitare il burn-out.»
Quella pioggia che si abbatte su Parigi non risparmia alcuno. L’atmosfera sembra quasi essere apocalittica tanto la Senna è in piena e l’atmosfera surreale. Il numero dei dispersi sale sempre più, eppure, Gaspard Snow mai si sarebbe immaginato di incontrare lei tra tutti quegli oggetti trascinati dalla corrente e le anime in cerca dei propri cari; una sirena. È ferita, non sa che fare. Il suo canto è ammaliante tuttavia, almeno in principio, su di lui non sembra avere effetto. Deve aiutarla, ma come? Portarla al pronto soccorso? E poi? Dopo questa prima tappa ricoverarla a casa? Alloggiarla tra le sue mura, in quella vasca di salvataggio e in compagnia del suo amico felino Johnny Cash dal manto nero e gli occhi gialli? Con quell’amico che silente sembrava esser dotato di parola? Con quell’amico che aveva preso il posto di Carolina nel suo petto? Perché Gaspard ha il cuore spezzato, non è più capace di amare.
«C’era un’unica differenza: in quel mausoleo Gaspard doveva affrontare il fantasma di una persona viva.»
Da quando la relazione con la donna è giunta al termine egli ha infatti chiuso il suo cuore, il suo cuore è già stato spaccato. Ecco perché pensa che il canto della sirena non abbia effetto su di lui, che non possa in alcun modo ferirlo. Il suo nome è Lula ed è una creatura misteriosa e affascinante del quale ben presto si invaghisce e che desidera proteggere. A prescindere da tutti i problemi, a prescindere da tutto. Deve ricondurla all’acqua prima che siano trascorse due albe altrimenti sarà la fine, non ci sarà più scampo. Ma come separarsi da lei?
«Si dice che gli sbadati abbiano la testa fra le nuvole, ma a volte lui si perdeva fra i ghiacci di Plutone, e dopo la fine della sua storia d’amore trascorreva sempre più tempo lassù.»
Con uno stile narrativo dai toni fiabeschi e leggeri, Mathias Malzieu fa destinatari i suoi lettori di un titolo di facile lettura che non mancherà di conquistare il cuore dei romantici e dei sognatori. Tra queste pagine c’è tutto, dall’amore, alla favola, alla fantasia, al lieto fine. Il titolo giunge a conclusione in tempi brevi, è consigliato a chi cerca un libro con il quale trascorrere qualche ora lieta e con il quale staccare dalla realtà.
Vi lascio qualche citazione.
«Non lasciarsi abbattere. Imparare a ricominciare. Riprendere lo slancio.»
«Saccheggiava i ricordi, si riempiva dell’ultimo luogo in cui aveva visto Lula. Scrutava l’orizzonte. Da sempre vedeva ciò che credeva anziché credere in ciò che vedeva. Allora aspettava impaziente un cenno da parte di Lula.»
Indicazioni utili
Doppi volti
«Al mondo non c’è niente di più comprensibile dei volti, o meglio, di certi volti: un insieme di tratti e di sguardi che d’improvviso diventano sola realtà, l’enigma più importante dell’universo, che si guarda con sete e con fame, come se vi fosse inciso un messaggio supremo.»
Due corpi, due voci, due opposti che si attraggono come i poli di una calamita. Un aeroporto, una sala d’attesa, un volo in ritardo. Questi sono gli ingredienti che caratterizzano “Cosmetica del nemico”, opera di 102 pagine classe 2001, con cui Amélie Nothomb si ripropone ai suoi lettori con un titolo che ne ripresenta le caratteristiche peculiari e costanti negli altri precedenti scritti e che eppure se ne distanzia e compie quel passo in più.
Altra caratteristica da non sottovalutare è la capacità di esporre i fatti e di creare l’ossatura di un romanzo in quella che è apparentemente una staticità di fondo essendo le vicende interamente incentrate in un unico luogo e in una unica linea evolutiva dettata da un serrarsi ininterrotto di botta e risposta tra queste due persone incontrate per caso. O questo almeno siamo indotti a credere.
Eppure, già dopo le prime battute il lettore si rende conto che qualcosa non torna, che qualcosa sfugge alla sua vista, che qualcosa è oltre quel che legge e che vede e che per questo non può soffermarsi soltanto alla parola che ha davanti, deve entrare in simbiosi con il narrato. E lo fa, senza quasi rendersene conto.
Prima è colto dalla curiosità, poi è costretto a porsi domande perché la Nothomb solleva sempre questioni che toccano il profondo, infine è costretto a mettere in dubbio ogni certezza.
«E che paradosso: non era il criminale a essere ricercato, ma la vittima.»
E allora ha inizio il viaggio. Il viaggio nell’io, nell’introspezione più totale che però non si ferma a questo perché trova conferma nel reale, distrugge gli ormeggi, travalica i confini.
Ed è proprio nella dimensione del circostante che i toni un po’ macabri, la vicenda paradossale e bizzarra, la confessione che è come una morsa al cuore, i temi filosofi prendono forma e ritrovano i loro contorni. Non c’è possibilità di fuga, non c’è possibilità di salvezza. È quella follia che spiega la vita del quotidiano, è quella pazzia che spesso giustifica anche ciò a cui normalmente non riusciamo a dare giustificazione, è la colpa ingiustificata, ingiustificabile, impossibile da concepire, che ci viene sbattuta davanti. E quando ancora pensiamo di aver capito ecco che la narratrice ci sbatte in faccia la verità e ci porta a chiederci chi siamo veramente.
«Chi sei tu veramente? Che cosa hai fatto davvero? Sei proprio sicuro di quello che credi?»
Filosofia, psicologia, psicoanalisi. Un libro complesso, stratificato, forte, intriso di significati, con tante domande sottese e risposte non sempre piacevoli che ci fanno riflettere sulla duplicità umana e su quell’oscurità che è radicata nel profondo.
Indicazioni utili
Mina
Con “Troppo freddo per settembre” torniamo a scoprire delle avventure di Gelsomina Settembre, detta Mina, protagonista nata dalla penna di Maurizio de Giovanni e già conosciuta con “Dodici rose a settembre”. Per scelta di vita assistente sociale, Mina si accontenta del suo stipendio che non le consente di staccarsi dalla casa materna, si strugge per il bel ginecologo Domenico, il bellone alla Kevin Costner la cui fila fuori dalla porta tutto è tranne che determinata dalle sue qualità mediche e si trova a non riuscire a rifiutare un appello d’aiuto quale quello della donna che si affaccia alla sua porta in quella fredda mattina di gennaio. Durante la notte un anziano ex docente è stato rinvenuto privo di vita a causa delle esalazioni provenienti da una stufa che utilizzava per riscaldarsi in quella soffitta dove era solito prendere sonno. A macchiare la sua carriera il fatto di aver denunciato un suo studente fresco di maturità per una rapina a mano armata. Quest’ultimo è stato condannato e si è fatto molti anni di galera. Il caso vuole che sia stato scagionato proprio in prossimità della morte dell’ex docente e che sia ancora invischiato e legato a personalità della malavita che sarebbe meglio evitare. La donna che bussa alla porta di Mina altro non è che sua madre. Può forse rifiutarle il suo aiuto?
Seconda avventura con protagonista Gelsomina il volume è caratterizzato da un buon giallo, atmosfere ben delineate e una trama ben costruita e che ripercorre passo passo esattamente quella che è la metrica narrativa a cui lo scrittore ci ha abituato negli anni. Non nascondo però di aver faticato, a differenza che con il primo episodio, un po’ nella lettura tanto da aver pensato di abbandonarlo. Questo è stato dato dal fatto che ho trovato le vicende abbastanza prevedibili ma anche dal fatto che non ho ritrovato quel mordente e quel fascino che generalmente, seppur in modo diverso, caratterizza le opere del napoletano. Per quanto la protagonista sia piacevole e le avventure interessanti perché comunque concentrate su quel male e quelle oscurità che si celano dietro la facciata del perbenismo, ho trovato il titolo intriso di molti cliché, un po’ scontato e facilmente intuibile anche e proprio per come costruito. Chi conosce l’autore ne riconosce il marchio ma se ha letto tanto o tutto di lui ne è anche stancato, sente di aver bisogno di qualcosa di diverso, di una innovazione. Cosa che non c’è o almeno non si può ottenere solo cambiando di volta in volta protagonista.
L’elaborato si presta a una lettura di intrattenimento, manca dell’emozione, strappa un sorriso innanzi alle situazioni simpatiche ma non grasse risate e non riesce a tenere incollati tra le pagine. Non convince pienamente.
Indicazioni utili
- sì
- no
Bea&Elisa
«Ma cos’è un’amicizia? Non avevo vincoli di sangue né giuridici, diritti e doveri, ero semplicemente lì con lei su quella panchina a franare. La abbraccia più forte che potevo. Le asciugai le lacrime, provai a contenere la sua disperazione mentre si ribellava […] tentai di rassicurarla, consapevole di mentire. Perché le parole a questo servono: a sperare, ingannare, abbellire e migliorare, ma la realtà è un’altra e se ne frega dei nostri desideri.»
Bea ed Elisa sono come il giorno e la notte, distanti e diverse, un universo parallelo che non si sa per quale gioco del destino o regola matematica violata, giungono a incrociare le loro strade e a vivere gli anni più intensi della loro vita insieme sino al sopraggiungere di quello che sappiamo già dalle prime pagine essere un punto di rottura che come le ha unite le porterà a separarsi.
Siamo a T una fatiscente cittadina di periferia situata in Toscana, nei pressi di Livorno, con vista panoramica sulle isole dell’arcipelago. Elisa è la straniera, la forestiera. È giunta da Biella con la madre e il fratello con sempre più gravi problemi di droga, per tornare a vivere con il padre che non vede se non in occasioni ben prefissate essendo i genitori separati. Non si ama, non spicca per bellezza nonostante i suoi capelli rossi e quelle lentiggini che le solcano il viso. È presa in giro dai compagni, sbeffeggiata. Vive di parole ed è grazie alle parole e alla biblioteca che vede per la prima volta Lorenzo, coetaneo compagno di liceo del quale si invaghisce. Ed è ancora tra le mura di questo complesso che il suo rapporto con Bea passa dall’essere quello di derisione a quello di amicizia. Lei che è la più bella, che è già famosa per i suoi servizi fotografici, che mai può permettersi di prendere un chilo o di avere un ricciolo libero da quella chioma rigorosamente piastrata, diventa la sua migliore amica.
Passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni. Siamo a cavallo degli anni duemila e con questi passano le vecchie abitudini del vecchio mondo e arrivano le nuove dettate da quella cosa chiamata internet ancora sconosciuta e perfino denigrata. Il padre di Elisa è un ingegnere e subito ne resta affascinato, ci si tuffa a capofitto e propone alle ragazze anche di aprire un blog. Erano tempi diversi, erano i primi spiragli di quello che sarebbe diventato il mondo e se Elisa è reticente, Bea ha già fiutato l’occasione e iniziato a perpetrare la sua strada. Si impone come la bella, viene denigrata e definitiva frivola per questo, eppure questo suo essere la porterà a fatturare 50 milioni di euro l’anno quando non sarà più Beatrice ma la Rossetti e di anni ne saranno passati almeno quindici. Perché la Rossetti ci ha visto lungo e adesso tutto è cambiato, tutto ha uno spessore diverso. Anche la loro amicizia, un’amicizia che viene rivissuta per mezzo di diari di scuola e poi stesa su wordin un giorno con un altro in prossimità della Vigilia di Natale…
«Per quanto oggi possa suonare incredibile quando cominciarono a diffondersi i blog erano territorio di conquista non per quelle come Bea, ma per quelle come me. A chi navigava nel 2003 non fregava nulla di bellezza o di vestiti: erano aspiranti scrittori, oppure “amanti di qualcosa” come mio padre, che desideravano condividere la propria passione, persone in vena di esplorazioni e amicizie. L’imperativo era scoprire, non mostrarsi.»
Ma cosa ne è stato di Beatrice e di Elisa? Perché la loro amicizia è giunta alla fine? Cosa è successo? Silvia Avallone torna in libreria con “Un’amicizia”, opera che riporta l’attenzione del lettore a riflettere su un tempo che ormai ci sembra lontano anni luce ma che in realtà non lo è. Ci porta a guardarci indietro, a chiederci cosa è stato e cosa è, ci chiede di dare uno sguardo al nostro essere stati e al mondo che ci circonda. E ci chiede, ancora, se tutto questo, è davvero necessario, se una vita per essere vissuta ha davvero bisogno di essere raccontata.
Tanti sono i temi che affronta, senza paura e senza nulla risparmiare al conoscitore. C’è tanta filosofia, inoltre, tra queste pagine e c’è anche tanta introspezione. Lo stile narrativo è rapido, pungente, trattiene. Accelera per poi leggermente rallentare nella seconda parte quando è proprio la vicenda che ti chiede di diminuire la marcia della lettura per afferrare quei concetti, quei sottesi che chiedono di emergere tra le fila. La storia è interamente narrata da Elisa e il conoscitore è catapultato nella sua mente, nei suoi pensieri.
Un libro attuale, che chiede di essere letto, che parla di una storia che riguarda tutti noi e che semplicemente resta.
«La vita ha davvero bisogno di essere raccontata, per esistere?»
Indicazioni utili
Donne nel tempo
Con “Donne dell’anima mia” ripercorriamo il percorso di vita di Isabel Allende dai tempi dell’infanzia sino ai giorni nostri in particolare soffermandoci sul suo essere da sempre femminista. Ella, infatti, sin dalle prime battute di questo titolo di appena 174 pagine e capitoli brevi composti da un paio di pagine ciascuno, si afferma tale sin dall’asilo, sin dalla più tenera età e dunque in netta contrapposizione con quel machismo che le ruotava attorno. Un componimento, dunque, autobiografico e il cui tema è chiaro sin da subito, pertanto, se non siete lettori amanti di questa tematica, suddetto scritto non potrà solleticare particolarmente le vostre corde e le vostre curiosità anche perché non esente da cliché. Se al contrario siete amanti della problematica potrà essere un buono spunto per arricchire il vostro bagaglio o comunque per avvicinarvici.
La Allende non ci risparmia di confessioni, non ci risparmia di riflessioni. La sua penna è rapida, informale, diretta. La pillola non viene resa più indolore, l’anima è messa a nudo per quello che è e per quello che può offrire. Nel suo bene e nel suo male.
Ecco perché può dividere. “Donne dell’anima mia” è un volume dove la protagonista è Isabel Allende e il suo femminismo. Non c’è spazio per storie di tempi che furono o per una prosa poetica ed evocativa come nelle sue opere del passato più celebri e famose. Non è oggetto del lavoro proposto e del suo essere scritto. Quindi se questo cercate, ne resterete delusi.
Se viceversa cercate una biografia, un testo che non è altro che una confessione, un memoir dell’essere passato e presente, una sorta di vademecum di valore e principi in cui credere, una lettera a cuore aperto, ecco allora che farà per voi. Certamente questo non è il libro con cui cominciare a leggere l’autrice per conoscerla nell’aspetto di scrittrice. Buona lettura!
Indicazioni utili
- sì
- no
No = a chi non ha mai letto niente di lei, non ama il tema e non ama le autobiografie.
Astolfo Malinverno
«Osserva sempre la gente con attenzione, Astolfo, fissa i particolari, che ognuno, la sua storia vera, non la porta stampata sulla faccia ma nascosta dentro pieghe invisibili della pelle.»
Astolfo Malinverno sin da quando ha memoria, ha memoria delle parole. Articolate dalla madre, narrate dalle voci, lette dai libri. Parole che sono balsamo per il cuore, moto per vivere la vita con quell’emozione mancata, sentimento, verità. Un po’ come lo stesso ricordo di quella madre che tenendolo stretto al petto oltre che a insegnargli ad ascoltare i battiti del cuore, gli insegnava a osservare le esistenze vicine e lontane. È nato con un difetto alla gamba, leggermente più corta, eppure, è proprio questo difetto che gli consente da adulto di diventare il bibliotecario di Timpamara e inaspettatamente, poi, anche il custode di quelle anime accomiatate nel suo cimitero.
«Con la bocca di mia madre che narrava e animava il mondo, come se il mondo esistesse solo nella parola e con la parola, conobbi la vita e imparai ad amare i racconti e a capire presto che uomini e libri narrano in fondo le stesse storie.»
Ed è dal momento in cui viene incaricato di prendersi cura anche di quel luogo ove sono custodite le spoglie mortali dei cari degli abitanti del paese, che la sua vita cambia. Seppur all’inizio egli prenda con confusione l’incarico attribuitogli, ne rimanga perplesso, sorpreso, stranito, di poi si rende conto che al contrario quel luogo è una casa esattamente come la biblioteca e che, come nelle più inaspettate delle sorprese, lo sente suo. È durante uno dei suoi giri di perlustrazione iniziali che l’occhio gli cade sulla tomba di una donna dai lineamenti magnetici, dall’assenza di alcun riferimento sulla nascita, la morte, il nome, le origini. Ella è un’anima che lo ha chiamato e da allora lui la chiamerà Emma come la Emma di “Madame Bovary” di Flaubert. I giorni passeranno tra sogno, immaginazione, desiderio di conoscere il vero e tanta introspezione perché Malinverno per mezzo di questa donna del ritratto comincerà a interrogarsi sul suo vissuto, sul suo essere, sui suoi legami. E tutta quella quotidianità ostinatamente e minuziosamente costruita negli anni verrà ulteriormente infranta da un’altra figura che subentrerà nella sua vita con un mistero a farle da cappotto.
«Ci sottovalutiamo. Pensiamo di non essere capaci di affrontare certi dolori ma poi, alla prova dei fatti, dai meandri inesplorati del nostro organismo emergono minute molecole di sopportazione che si mischiano alle piastrine del sangue e irrobustiscono il corpo e ci fanno sopravvivere, malgrado ogni tentazione di arrendevolezza, come se Natura sapesse quanti dolori può distribuire, conoscesse la portata d’ognuno e mandasse il dolore giusto, quello che colma le misure senza affondarle, che noi nemmeno sapevamo di essere così resistenti ma Natura sì, Natura sapeva.»
Ha inizio da questi brevi assunti l’ultimo lavoro di Domenico Dara, testo quello presentato, che è intriso di una malinconica dolcezza e che con grande sensibilità e semplicità ci porta a guardarci dentro, a porci a nostra volta delle domande. È un libro intriso anche di nostalgia ma anche di tanta umanità, una umanità che trasuda da ogni pagina per mezzo della voce non solo del protagonista ma anche per mezzo delle voci di tutti gli abitanti del paese. A far da cornice e a esser parte portante dello scritto è ancora la letteratura, prevalentemente – ma non esclusivamente – classica che passando dal Don Chisciotte a Moby Dick ricompone quello che è l’io di Astolfo. Quest’ultimo è un protagonista che naturalmente suscita empatia nel lettore, che entra nelle sue grazie, in parte per la sua sensibilità, dolcezza e gentilezza, in parte per la grande immedesimazione che suscita. Ancora, ad impreziosire vi è la curiosità di far luce sull’arcano, un arcano a mio modesto parere intuibile ma la cui intuibilità non inficia sul proseguimento della lettura perché a prevalere è il viaggio posto in essere dal lettore per mezzo della voce di Malinverno.
L’opera scorre tra le mani del conoscitore con ritmi diversi. Accelera, rallenta, accelera ancora. Scuote per quel carattere malinconico che la caratterizza, per quell’aspetto nostalgico di cui è impressa, arriva per quella dolcezza sottesa che l’accompagna eppure può suscitare due reazioni diverse in chi legge: può trattenerlo o può respingerlo. E questo a causa della prosa narrativa di cui è caratterizzato. Questo continuo riferimento alla letteratura è uno degli aspetti forti del titolo ma anche più deboli perché rischia di far perdere di vista quello che è il filone centrale della narrazione e rischia altresì di far scemare l’interesse che se all’inizio è onnipresente ed è mosso anche da questo carattere, a lungo andare ne risente, affaticando e appesantendo l’avventura. Ancora, a rischiare di respingere il lettore vi è il tema che viene trattato che non è dei più semplici e nemmeno dei più allegri. Se queste ambientazioni e queste argomentazioni non sono di vostro interesse, infatti, il volume non riuscirà a colpirvi.
Ultimo nemico è la logica. Logica e riscontro nella verità che può rendere fallace alcuni passaggi nodali dell’evoluzione delle vicende, soprattutto se nel corso della vita si è vissuto almeno una parte di quell’esperienza che è la realtà della separazione da un legame e la realtà cimiteriale. Ecco perché consiglio la lettura di “Malinverno” staccandosi dalla logica, staccandosi dal dato del vero a ogni costo.
“Malinverno” è una storia che va letta lasciandosi trasportare dalle parole, facendosi condurre per mano da Dara, senza porsi troppe domande e senza cercare troppe risposte. È un viaggio introspettivo e come tale va vissuto. E allora sì che arriverà con tutta la sua forza e tutto il suo contenuto. Viceversa, potrà subire delle battute d’arresto, essere vissuto come farraginoso.
Infine, lo stile. Domenico Dara è dotato di una prosa magnetica, evocativa, musicale. Incuriosisce, trascina, trattiene ma rischia anche di “andare fuori rotta” per le digressioni continue che possono portarlo a essere un po’ troppo prolisso. Il libro conta 329 pagine ma sarebbe arrivato anche con una cinquantina di queste in meno, o comunque con qualche piccolo taglio o limatura. Ciò rischia di renderlo un autore non per tutti. Cosa che non deve essere necessariamente considerata come un difetto, anzi.
Leggere “Malinverno” è una esperienza sensoriale. Lascia tanto e arriva durante la lettura ma soprattutto dopo questa, a distanza di tempo. Commuove, emoziona, palpita.
«Perché se il destino dei libri è morire come esseri viventi, anche gli uomini, quando smettono di respirare, non diventano che storie.»
Indicazioni utili
Voci della Spagna franchista
È il 1954 quando Germàn Velazquez Martìn, psichiatra da molti anni in esilio in Svizzera grazie al padre medico della medesima professione perseguitato dai franchisti che a ridosso della caduta della Repubblica riesce a farlo fuggire, torna a casa in Spagna. Negli anni ha condotto importanti studi di sperimentazione farmaceutica e per questo gli viene offerto un posto nel manicomio femminile di Ciempozuelos, luogo ove ritrova Aurora Rodrìguez Carballeira, paziente del genitore che lo ha aiutato anni prima a raggiungere la libertà. La donna soffre di una particolare patologia paranoica che l’ha condotta, a compiere l’omicidio della figlia Hildegart; ella vive da allora in uno stato di apatia costante che viene interrotto da brevi momenti di quasi lucidità e da pupazzi di stoffa fabbricati con forme inquietanti. Da qui ha inizio un viaggio nella mente della donna, nei suoi pensieri più intricati, sul suo sguardo rivolto al mondo. Ad aiutarlo l’infermiera Marìa che trascorre lunghi pomeriggi con la paziente e che con la sua voce consente di completare il quadro storico e sociale ricostruito dalla Grandes.
«Avrei saputo dire perfettamente cosa accadde fino a quel momento. Avrei potuto ricostruire una sequenza di azioni concrete, esatte, vincolate al tempo che segnano gli orologi e che avanza sulle caselle del calendario. […] Da molti anni non succedeva niente mia vita che mi riportasse il sapore dello zabaione. Accadde quella mattina, però, e il ricordo di quel sapore bastò a spiegarmi tutto.»
Almudena Grandes torna in libreria con un titolo che ha la grande capacità di ricostruire il volto di una nazione in quelli che sono stati gli anni più bui della sua storia e vi riesce grazie a queste tre voci che con le rispettive esperienze ricomporranno l’arazzo. A ciò si aggiunga che l’autrice, con la sua opera, si sofferma su tematiche molto interessanti tra le quali, oltre che alla condizione sociale, alla condizione dei malati psichiatrici, dei manicomi, tocca anche la condizione femminile. Viene posto l’accento sul dogma dittatoriale da questo la lente si focalizza sul come le donne fossero relegate a una condizione marginale, superflua.
Un titolo evocativo, corposo, che non manca di solleticare la curiosità degli amanti del romanzo storico e dei romanzi con carattere introspettivo e che non deve spaventare per la mole. Va assaporato, anche a piccole dosi, anche intervallandolo con altri titoli, ma la sua essenza arriva semplicemente tutta.
Indicazioni utili
Werther
«La solitudine è per la mia anima un balsamo prezioso in questo paesaggio paradisiaco, e la stagione della giovinezza mi riscalda con il suo rigoglio il cuore spesso attraversato da brividi. Ogni albero, ogni siepe, è un mazzo di fiori, e si vorrebbe tramutarsi in maggiolini per poter fluttuare in questo mare di profumi e trarre da esso tutto il proprio nutrimento.»
Scritto nella forma epistolare, “I dolori del giovane Werther” è un titolo che ci presenta un protagonista innamorato dell’amore. È l’innamorato romantico per eccellenza, è l’innamorato della corrente preromantica per eccellenza. Classe 1774 il testo è uno scritto giovanile di Goethe che può considerarsi il simbolo dello Sturm und Drang (“Tempesta e impeto”), movimento che si sviluppa in Germania tra il 1770 e il 1785 e che condurrà a quei temi che saranno poi propri del romanticismo tedesco e che ritroveremo anche nei suoi futuri lavori. Molteplici le critiche circa possibili legami tra le due correnti e in particolare anche con l’Illuminismo.
Ed è così che conosciamo il nostro protagonista, che ne seguiamo le avventure, la crescita, le riflessioni in un mutare costante e in un evolversi lineare e logico. Perché Werther è un uomo intelligente ma scostante, è un uomo che all’inizio dell’opera giunge al lettore per quella profonda voglia e gioia di vivere che poi muta sino all’epilogo più che noto. Ed è ancora molto attuale come componimento, sia per tematiche trattate che per temi psicologici individuali che lo caratterizzano e delineano.
A questa prima e più immediata anima del volume caratterizzata dal sentimento dell’amore che giunge sin dalle prime pagine e che ne permea l’essenza, segue l’altro elemento romantico della Natura che qui viene recuperato nella concezione di Spinoza con il quale condivide il panteismo, non a caso si giunge ad affermare che natura e Dio sono congiunti e che la natura altro non è che “l’abito vivente della divinità”. La natura non è dunque oggetto immobile quanto forza primordiale, animata e vivida ma è anche il luogo in cui l’anima può esprimersi nella sua massima libertà e in tutte le sue tinte (malinconiche, gioiose, nelle ispirazioni, nell’arte, nella comprensione, nella ricerca e molto altro ancora). È altresì lo strumento che armonizza, che crea unione e fusione, che fonde e costruisce il volto più complesso intrinseco nell’elaborato stesso.
Lo stile è inoltre fluido, erudito ed evocativo tanto che riesce a far estraniare il lettore dal mondo circostante e a farlo concentrare su quello che invece sono le vicende. Goethe riesce inoltre in un’impresa non semplice stante la forma narrativa dell’epistola che per definizione tende ad allontanare il conoscitore, a respingerlo. Imprime in queste pagine il massimo del sentimentalismo tanto che chi ama il genere non resterà immune. È un libro che merita di far parte del bagaglio culturale di ogni lettore e che ha molto da offrire per la sua formazione. Tuttavia, l’opera tende a risentire del tempo che passa. Un po’ come ho ravvisato in “Frankenstein”, gli anni passati hanno influito sulla percezione del contenuto portando il lettore moderno a sentire quali lontani anche argomenti ancora attuali e in un certo senso vicini.
Un titolo a cui torno dopo una quindicina d’anni dal primo conoscersi, che mantiene l’emozione dei suoi contenuti, che scava nell’animo umano e che è espressione di una corrente che non manca di solleticare le corde più intime.
«Ma cosa è mai l’uomo, per poter lagnarsi di se stesso? Caro amico, te lo prometto, voglio diventare migliore, non voglio più rimuginare, come ho sempre fatto, su quel poco di male che il destino ci pone dinanzi; voglio godere il presente e lasciar passare il passato.»
Indicazioni utili
Lee Elizabeth Miller
«Ma Elizabeth ora possiede la misteriosa forza delle persone fragili che non si ritirano mai al cospetto di una tempesta e si sentono vive solo sfidando i propri limiti.»
Prinzregentenplatz 16, Monaco, 30 aprile 1945. Le mattonelle del bagno sono ghiacciate, l’ambiente è completamente e perfettamente pulito. Gli asciugamani sono bianchi e disposti al loro posto secondo un meticoloso ordine di grandezza e utilizzo in quelli che sono i rispettivi sostegni. È il luogo dove lui, A.H., come da monogramma sull’argenteria che ne svela l’identità, ha avvolto e protetto il suo corpo, ha vissuto negli anni e un tempo anche con la nipote Geli, un tempo che risale a quel 18 settembre 1931 quando della donna non fu che ritrovato proprio in quell’appartamento il corpo privo di vita apparentemente per morte suicida. Una morte, quella della giovane, che avrebbe potuto cambiare la Storia, una morte sospetta e sulla quale si è celato e ancora oggi si cela il mistero. Sappiamo solo, quale dato certo, che l’attaccamento del Fuhrer alla nipote, andava ben oltre quello relativo a un legame parentale di uno zio. E lo stesso Göring come molti degli altri esponenti del partito dell’epoca ci confermano quanto questa donna abbia influito e influisse su colui che ha governato la Germania nazista.
«Al processo di Norimberga, Herman Göring dichiarò che “la morte di Geli ebbe su Hitler un effetto devastante, cambiando totalmente il suo modo di relazionarsi con gli esseri umani”.»
Ma torniamo a quella stanza. Una stanza da bagno dove osserviamo un’altra donna che si trova in Europa perché aggregata nell’esercito degli Stati Uniti durante il Secondo conflitto mondiale, perché fotografa di quei luoghi di morte e desolazione quali Dachau e Buchenwald. E adesso è proprio lei che osserviamo, Lee Elizabeth Miller. Si è appena immersa in quella che è stata la vasca del Fuhrer, e quell’istantanea datata 30 aprile 1945 ed è scattata dal suo compagno di allora e altrettanto fotografo di guerra.
«Lo stermino della bellezza è l’arma preferita di ogni propaganda che si rispetti; e Lee Miller, infilandosi nuda in quella vasca, compie un personale esorcismo per scongiurare il male, una vendetta artistica contro la brutalità del potere.»
Ma chi era Lee Miller? Dalla bellezza ed eleganza mozzafiato, modella e volto della rivista Vogue, conosciamo Elizabeth in quel della realtà provinciale di Poughkeepsie, scopriamo della violenza subita a nemmeno dieci anni da un uomo amico di famiglia, la osserviamo mentre viene immortalata sempre bambina nuda dal padre in pose provocatorie per il tempo, la riscopriamo ancora modella, musa, artista, fotografa, giornalista, cuoca, madre e anche amante. Una vita che ne racchiude mille, è la sua. Eppure questa foto che così ben rappresenta una prova di quel che è stato, lei che era appena entrata in quel campo di Dachau dove era entrata con pochi altri giornalisti e dove era rimasta colpita dall’odoro della carne bruciata, dalla puzza dei corpi magrissimi ammassati al sole, perché tutti potessero ricordare e non negare negli anni che sarebbero seguiti, una traccia come quelle tracce di fango che ella stessa lascia su quelle piastrelle intonse del bagno del capo del Terzo Reich, è rimasta chiusa per anni in quella soffitta che sino a che ella è stata in vita ha occultato le prove di quel che era stato. Perché ciò?
E così la lettura prende corpo, campo e forza. Ci mostra il volto di una donna che travalica quelli che erano i dogmi del suo tempo, che va oltre i dettami imposti, che segue il suo pensiero senza farsi influenzare da usi e costumi e che ci mostra una prima forma di emancipazione. Scopriamo delle sue avventure, del suo essere la regina del caso, scopriamo del suo esser musa di Man Ray e del suo matrimonio con un miliardario egiziano che la porta al Cairo e ancora tanto tanto altro.
Intervalliamo aneddoti di vita tra presente e passato sino a giungere nella sezione finale del libro dove attraversiamo le strade di una Germania appena libera, con tutto quel che questo significa. Il libro ha una grande forza contenutiva, è caratterizzato da una protagonista che affascina e conquista, è spinto da una narratrice meticolosa che come il figlio Antony vuole scavare e ricostruire, tornare a dare tanti volti a quella donna che per tutta la sua esistenza li ha tenuti celati, li ha nascosti in quel luogo dimenticato e segreto quasi come se fosse consapevole che quel tempo casalingo avrebbe custodito quel passato per il giusto futuro, per il necessario divenire. Ed è in Lee Miller che si racchiude tutta l’essenza di questo libro/biografia che incuriosisce e affascina il lettore. Unica pecca che ho ravvisato è nella impostazione narrativa adottata. Serena Dandini, già riletta in passato, è una narratrice attenta, accurata, precisa e sempre capace di trasportare e di lasciare un messaggio prezioso ai suoi lettori. In quest’opera si sente il suo trasporto per il tema e, come la definisce lei, la sua “ossessione” per quella foto e quella storia che dal momento della scoperta l’ha a sua volta rapita e conquistata. Bilanciare le tante cose, il dato storico, i buchi per ricostruire, la foto e l’emozione non è stato certo facile e personalmente riconosco i meriti del suo lavoro in quello che è uno scritto del quale a tutti consiglio la lettura, ma, come può accadere, l’aspetto descrittivo può prendere il sopravvento e rischiare di spiegare troppo, intervallandosi alla voce di Lee, rischiando di confondere il conoscitore che deve destreggiarsi tra una doppia voce Elizabeth/Serena. A ciò si aggiunga che per porre in essere questa necessaria opera di ricostruzione, la Dandini si allontana da quello che è l’obiettivo e il fulcro della narrazione per tornarvi sul finale in quella Germania che torna a vedere la luce dopo la liberazione e che è anche la parte più attesa e bramata di tutto lo scritto e che ahimé viene liquidata in poche pagine. Pagine bellissime, pagine che restano, pagine che si divorano ma che lasciano quel senso di “avrei voluto di più”. Ciò ha fatto perdere in parte di quell’emozione altrimenti sempre vivida e presente nel lettore.
Nel complesso un buon titolo, di gran approfondimento, curiosità e di piacevole lettura.
«C’è sempre un pezzo fuori posto che impedisce la visione d’insieme, il disegno perde i contorni e sfugge alla comprensione.»
Indicazioni utili
Quanti, filosofia e attualità
«Ma questa è la scienza: un’esplosione di nuovi modi per pensare il mondo. È la capacità che abbiamo di rimettere costantemente in discussione i nostri concetti. È la forza visionaria di un pensiero ribelle e critico capace di modificare le sue stesse basi concettuali, capace di ridisegnare il mondo da zero.»
Ancora una volta Carlo Rovelli torna in libreria con un titolo capace di affascinare e catturare l’attenzione del lettore e dell’appassionato di scienza. Questa volta è di meccanica quantistica ciò di cui ci parla in questo saggio e tutto, per questo motivo, parte dalle ricerche sui “quanti”, e cioè quei valori minimi, finiti e indivisibili in una grandezza fisica in ambito di struttura dell’atomo. E chissà che questi davvero non riescano a dare una risposta al comportamento di tutto, al tutto nella sua semplicità. Siamo a Helgoland, sperduta isola del mare del Nord, quando il fisico Werner Heisenberg, in quel del 1925, comincia a teorizzare la sua teoria in merito. È da qui che riparte Rovelli ovvero dalle radici, dalle origini che hanno visto protagonisti i “quanti”. Il saggio, dunque, in tutta la sua prima parte si concentra sul concetto di elettroni, sulle onde, la cd “sovrapposizione quantistica” e chi più ne ha più ne metta sino a giungere alla conclusione che le cose nel loro essere non sono uniche e irrevocabili quanto il risultato di più influenze tra loro determinanti. Nelle sezioni successive seguono approfondimenti e analisi filosofiche, storiche e letterarie che conducono all’ultima parte ove Rovelli si interroga sulla nostra realtà attuale e su quelle interazioni che caratterizzano il nostro mondo, la nostra quotidianità e i suoi collegamenti impliciti ed espliciti con la filosofia occidentale.
Anche quest’ultima fatica dello studioso è dunque appagante ed esaustiva per il curioso conoscitore ma rispetto ai precedenti lavori rappresenta qualche maggiore difficoltà di lettura e richiede da un lato l’alternarsi con altri titoli per assaporarne gli aspetti a piccole dosi, riflettervi e farli veramente propri e al contempo di porre in essere anche approfondimenti personali in quanto alcuni caratteri, definizioni o principi vengono dati per scontati un po’ come se lo scritto fosse destinato sì ai non addetti ai lavori ma pensato, nel concreto, per questi ultimi. In ogni caso un elaborato corposo, soddisfacente, esauriente e con cui contentare le proprie curiosità e meditare su nozioni anche sconosciute.
Vi lascio con l’avvertimento di Rovelli stesso.
«L’abisso di quello che non sappiamo è sempre magnetico e vertiginoso. Ma prendere sul serio la meccanica quantistica, riflettere sulle sue implicazioni, è un’esperienza quasi psichedelica: ci chiede di rinunciare, in un modo o nell’altro, a qualcosa di quanto ci sembrava solido e inattaccabile nella nostra comprensione del mondo. Ci chiede di accettare che la realtà sia profondamente diversa da quanto immaginavamo. Di tuffare lo sguardo in quell’abisso, senza temere di sprofondare nell’insondabile.»
Indicazioni utili
A volte è nel meno che sta il più
«Ci sono momenti in cui con tutti gli atomi del nostro corpo intuiamo che c’è qualcosa di sbagliato.»
Tutto ha inizio con una telefonata in piena notte. È il commissario dalla carenza linguistica finlandese Joona Linna al ricevitore in quel di quell’otto di dicembre; un delitto efferato richiede la sua competenza, richiede la presenza di Erik Maria Bark, colui che sino a dieci anni prima era considerato il miglior ipnotista della Svezia. È necessario un suo intervento, è necessario mettere sotto ipnosi Josef Ek, quindicenne, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia brutalmente uccisa da uno spietato killer. È necessario sottoporlo a ipnosi nonostante le sue precarie condizioni e gravi ferite perché sua sorella maggiore, non presente al momento delle uccisioni, in casa è ancora viva e in un luogo sconosciuto. Che possa essere stata lei l’artefice delle morti? Che possa trovarsi a sua volta in pericolo? Che l’omicida possa essere sulle sue tracce ed essere dunque lei la prossima vittima? Tanti gli interrogativi e tante le perplessità che ruotano attorno a questi decessi che portano Joona Linna a richiedere l’intervento di Erik ed Erik a rompere la sua promessa e a procedere con quella ipnosi che non pratica più da un decennio. Tuttavia, ciò che viene a scoprire va ben oltre le aspettative e soprattutto il preventivabile perché talvolta vittima e carnefice possono anche essere la stessa persona, e in questi casi, la situazione può prendere pieghe inaspettate. Erik lo scoprirà a sue spese quando, nel bel mezzo di una crisi coniugale con la moglie Simone, dovrà mettersi alla ricerca insieme al commissario, di Benjamin, suo figlio adolescente emofiliaco che verrà rapito durante la notte in casa sua. Da qui l’indagine del presente si ricollegherà al passato e avrà inizio un lungo excursus nei ricordi dell’ipnotista e al contempo scopriremo le ragioni che lo hanno portato a smettere di esercitare nonché alla frattura del suo matrimonio.
Che dire, i presupposti per riuscire ci sarebbero stati tutti se la coppia Lars Kepler non avesse teso a esagerare sotto alcuni aspetti. In primo luogo la parte relativa alla vicenda dell’uccisione della famiglia si snoda per oltre 240 pagine e quando arriva a comprendere anche la sparizione di Ben, il lettore è sfiancato. Sfiancato da un continuo protrarsi di una inchiesta che sembra ruotare su se stessa ma che ha già dato i suoi frutti e spiegato i suoi perché. Oltretutto alcune scene sono semplicemente inverosimili, vedi tra tutte e a titolo di esempio quelle relative a un adolescente con ferite multiple, shock cardiaco e una grave lesione al fegato che si rimette in piedi nell’arco di una manciata di giorni. Ma a prescindere da ciò, che può essere anche la scelta di un artifizio narrativo, a risultare forzato è pure ciò che accade nella seconda metà dell’opera. Si noti bene che quando si giunge alla sparizione del figlio non siamo ancora alla metà dello scritto. Da qui inizia una doppia indagine nella doppia indagine: perché se in una prima battuta abbiamo un primo omicida da trovare, qui abbiamo un secondo possibile rapitore che può combaciare o meno con il primo omicida ma che riporta al passato e che porta i protagonisti a un’altra indagine ancora portata avanti da una doppia voce e cioè da un lato da Joona e Erik e dall’altro da Simone e il padre. Un po’ troppo, a mio avviso, per non appesantire una narrazione con già un buon numero di elementi del thriller.
A ciò, ancora, si aggiunge una violenza disseminata e gratuita che permea tutto il componimento: dai giovani adolescenti filonazisti o comunque rabbiosi che a ogni angolo sembrano essere appostati e capaci di incutere terrore, a stalker e maniaci sessuali incontrati sulla metro o in visita nei luoghi di lavoro, a una macabra violenza che si propone anche nel modus operandi in cui le uccisioni hanno luogo. Nel finale, in particolar modo, si eccede a dismisura con ciò e se anche tutto questo è giustificato dai soggetti agenti e dalla loro particolare condizione, il risultato è quello di un’asticella spinta troppo e che fatica a essere apprezzata.
Al tutto si somma ancora uno stile narrativo estremamente descrittivo, tecnica narrativa già riutilizzata dagli stessi autori e da altri contemporanei che però fatica a suscitare empatia e anzi sfianca, nonché una ripetizione esasperante di alcuni comportamenti dei protagonisti che non convince. Se da un lato abbiamo un medico con una forte dipendenza da farmaci non riconosciuta, dall’altro abbiamo una donna che con questa mancanza di fiducia, per quanto plausibile e comprensibile nel reale, tende a respingere il lettore.
In conclusione, il thriller ha una buona potenzialità ma nel voler stupire e uscire dalla moltitudine di quel che oggi è uno dei generi più gettonati in assoluto, i due autori hanno forzato troppo danneggiando la piacevolezza di uno scritto che se più corto (conta esattamente 585 pagine in edizione Tea) e snellito avrebbe davvero potuto tenere con il fiato sospeso gli amanti del genere. Purtroppo, la ridondanza, la trama troppo caricata, le eccessive descrizioni e il voler far troppo ne hanno influito sulla piacevolezza. Di questo risentono anche i personaggi che perdono nelle loro caratteristiche peculiari quali ad esempio Linna nella sua ironia, tratto che lo aveva reso appetibile alla conoscenza. Ed è un peccato perché ho letto altre opere di questi scrittori molto più bilanciate e attente anche a tematiche attuali quali lo sfruttamento o la violenza su minori e donne.
A volte è nella linearità e nella semplicità che vi è la formula di un buon e indimenticabile libro. A volte è nel meno che ci sta il più.
Indicazioni utili
- sì
- no
No = a chi ama altri generi o ha letto altre opere dei coniugi.
Potenziale inespresso
«Voglio scrivere di quello che abbiamo scoperto insieme, e credo che vi interesserà, perché siamo tutti nella tempesta, alla ricerca di un porto tranquillo. Bisogna però prima distruggere la cattedrale che abbiamo eretto intorno all’amore. Poi forse si potrà ricostruirla, una chiesa di dimensioni più contenute, sulla porta un cartello: lavori in corso.»
C’è un amore nel nostro vivere che per quanto possa giungere al termine nel suo decorso mai davvero ci abbandona restando al nostro fianco, sedimentandosi nel nostro cuore e animo anche a distanza di anni e anni dal suo esaurirsi. Ed è questo sentimento, è questa storia che giunge al suo termine, l’oggetto della narrazione di “L’altra donna”, ultimo lavoro di Cristina Comencini ed edito da Einaudi. Come viene narrato questo amore? Viene narrato per voce di Elena, al tempo dei fatti una giovane contabile innamorata del suo ex professore di economia, Pietro, di trent’anni più vecchio, con figli ed ex moglie al seguito. Ed è proprio quest’ultima a irrompere nella sua vita con uno stratagemma; una falsa identità su Facebook, confessioni e conversazioni che si perpetrano per un anno sino quando, Maria, l’ex moglie, in arte Sara, si palesa alla nostra protagonista mostrandole un’altra faccia della verità. Perché se Elena aveva creduto a un amore puro e semplice, aveva scelto di non darsi pensiero o cercare spiegazioni di quel passato e di quella vita precedente dell’uomo che aveva al suo fianco, Maria, cattura la sua attenzione e le chiede se davvero si può conoscere anche senza sapere, anche senza voler sapere di un’altra vita. È l’altra donna a irrompere con questo pensiero che permea l’intero romanzo.
L’opera ultima della Comencini è ambientata a circa una decina d’anni dalla relazione, osserva con distacco, mette a confronto le due donne, scava nel profondo e ci dona un romanzo introspettivo e capace di far riflettere per cercare quelle risposte alle tante domande, per capire. Tuttavia, per quanto gli intenti siano ravvisabili nei risultati, la lettura sembra non decollare mai, a tratti è lenta e farraginosa come se stesse arrovellandosi su se stessa, chiede di essere sospesa e ripresa a piccole dosi e con intervalli con altri libri, manca di quell’intensità e di quell’emozione capace di trasportare che ci si attende da uno scritto di questa tipologia. La sensazione è quella di un componimento che non è riuscito a esprimersi completamente nel suo potenziale e nel suo essere essendo invece rimasto in una fase acerba, immatura, inespressa.
In ogni caso, una storia non per tutti. Un titolo molto particolare, con un suo messaggio ma che può respingere il lettore che non ama questo filone di storie.
«Dopo una distruzione, si ha nostalgia del tempo passato, sembra perfetto e felice, si cerca di rimetterlo in piedi, sembra possibile ma non lo è, bisogna andare avanti verso l’ignoto.»
Indicazioni utili
- sì
- no
Il capitan della barzelletta
«Ma nel corso degli anni questo concetto era arrivato a significare che qualunque imbecille poteva decidere di diventare capitano un certo lunedì, e martedì, senz’averne la capacità, quello stesso imbecille poteva prendere il comando di un vascello di trecentomila tonnellate e assumersi la responsabilità delle migliaia di vite che c’erano dentro.»
Una favola/satira dal retrogusto amaro è quella proposta da Dave Eggers, una fiaba in chiave moderna destinata all’elettore americano medio e forse, proprio per questo, a questo adattata. Chiunque leggendo detto componimento e conoscendo di quel Capitano dalla piuma gialla, le cui gesta eroiche sono riferibili a riviste porno con le quali ha allietato quei giorni in cui gli altri suoi rivali e grandi Capitani venivan torturati nell’intento e nella speranza di poter salvare il popolo da una minaccia, non faticherà a dargli un nome e un volto e a rivedere nel suo comportamento personalità di grande attualità.
Quel che accade tra queste pagine è molto semplice: un uomo, un nullafacente, un individuo dall’assenza di valori, dalla scarsa istruzione, incompetente, rancoroso, geloso del successo altrui e timoroso del non conosciuto ma troppo limitato, orgoglioso, supponente e poco umile per dedicarsi all’apprendimento per colmare quelle proprie lacune che non vede, viene eletto nuovo capitano della nave dei mari. Non ha gli strumenti e le capacità per governarla, si affida a una bocchetta dell’aria per prendere qualsiasi decisione, non ammette la propria incapacità, fa promesse vane che ovviamente non mantiene, illude i suoi viaggiatori, punisce senza un motivo anche con la morte per puro piacere di farlo o anche meramente per volontà di destare timore in chi lo segue anche se di fatto si crea solo una mera e bieca abnegazione e abitudine a quei comportamenti, getta i libri e qualsiasi oggetto di cultura perché li teme e ne teme il contenuto così come teme tutto quello che potrebbe essere più dotto perché non capace di reggere il confronto, scarica la colpa sul diverso e il richiedente aiuto magari mezzo annegato in una scialuppa di fortuna e alla fine finisce anche con l’essere spodestato da quei pirati che compresa della sua inettitudine se ne fanno anche beffa. Questo e molto molto altro è ciò che scaturisce da quei comportamenti inadeguati e folli.
«Però era anche vero, pensò il Capitano, che la nave poteva essere piena, perché nulla di ciò che sembra vero era mai proprio vero, dato che tutte le verità erano menzogne elitiste perpetuate da coloro che non amavano il Capitano. E nella voce della bocchetta c’era qualcosa di stridulo e invisibile, e colmo di sospetto e di rancore, che era più intrinsecamente affidabile di qualunque documento fosse stato consegnato al Capitano, o dei suoi stessi occhi.»
Eggers calca molto la mano, esagera, la porta ai massimi estremi volutamente. Disturba e fa riflettere, con sarcasmo, satira e ironia; caratteristiche che gli sono proprie. Adatta il suo stile e il suo scritto allo stesso elettore del capitano dalla piuma gialla e se vogliamo fa una denuncia in piena regola di quel che accade.
Non posso definire questo libro il mio preferito di questo autore che seguo sempre con curiosità e interesse, ma certo è che nel suo intento riesce e seppur un lungo racconto di appena 110 pagine, “Il Capitano e la Gloria” non passa inosservato.
Indicazioni utili
Filosofia, fisica e metafisica
«La forza d’inerzia, questa è la potenza del larvale. Quando un popolo rifiuta un progresso facile da raggiungere, quando un veicolo, spinto da dieci uomini, rimane inchiodato sul posto, quando un bambino si abbruttisce davanti al televisore per ore, quando un’idea di cui è stata dimostrata l’inutilità continua a nuocere, allora si scopre, con stupore, lo spaventoso potere dell’immobile. Era questo il potere del tubo.»
Un tubo, il Dio tubo a voler essere precisi. Uno scritto che concentra la sua attenzione nei primi tre anni di vita di Amélie Nothomb e che narra di questo suo passato in cui altro non era che un oggetto immobile, apatico, vuoto e insensibile proprio come quel tubo di cui al titolo. Poi, come se un qualcosa avesse preso campo, ecco che la molla della parola prende il sopravvento portandoci ad attraversare un viaggio in cui non c’è più soltanto il nulla dell’oggetto inanimato quanto anche il pensiero che prende forma e si articola. Anche rimarcando l’idioma nipponico che da sempre la caratterizza e l’accompagna nei meandri della sua vita.
Ma quanto c’è di vero e quanto di inventato in questo scritto? E soprattutto, cosa vuole davvero dirci Amélie? Certo è che da una prima interpretazione potrebbe pensarsi che ella abbia voluto destinarci soltanto di un titolo autobiografico che, come con “Stupore e tremori”, è un dono che fa ai suoi lettori, ma “Metafisica dei tubi”, non è soltanto questo, è filosofia pura. Filosofia mixata a metafisica e a fisica, è riflessione sottesa e analisi che si insinua nella mente del lettore alternando prima uno stato di confusione che lo disorienta facendogli perdere l’orientamento e di poi facendolo girare su se stesso per poi nuovamente ancora ritrovare le coordinate e riuscire a orientarsi nell’articolato disegno architettato.
Altra grande peculiarità dell’opera è lo stile narrativo che dimostra la grande capacità narrativa dell’autrice: chi legge è catapultato completamente nella mente di una bambina di tre anni. Al tempo ci regala un percorso a trecentosessantacinque gradi nella filosofia morale ed etica.
E tanto altro potrebbe dirsi sul titolo ma volontariamente mi fermo perché il modo migliore per scoprirlo, farlo proprio e carpirne ogni sfumatura è leggerlo. Un viaggio che arricchisce e incuriosisce.
«Diventano sempre più stupidi, il che li conferma nella convinzione di essere brillanti – e sì, perché non c’è niente di meglio della stupidità per credersi intelligenti.»
Indicazioni utili
Leo, Tom, Kevin e... Vienna.
«Se c'è una cosa su cui continuo a riflettere e per la quale faticherei a ricredermi, è che siamo noi i peggiori nemici di noi stessi. Non avrei altro da aggiungere, a meno che questo non bastasse a mettermi in croce per tutti gli errori che ho commesso.»
Tre volti quelli di Leo, Kevin e Tom, originari di Trieste, la città del vento, la città caleidoscopio di culture e popoli che si intrecciano tra loro, la città del molo Audace che di audace ha tutto nel suo volto che si apre ed estende nell’immenso, che si riuniscono in quell’atmosfera viennese fatta di Storia che si respira a ogni angolo, fatta di magnetismo e di tempo che passa ma che sembra restato immutato, grazie a una idea di Tom. È trascorso molto tempo dal loro ultimo incontro ed è proprio tramite un invito in quel di Vienna per prendere parte a un progetto avente ad oggetto una galleria dedicata alla Pop Art che i tre si ricongiungono.
La scena muta e si apre a casa di Tom, un luogo dove il lusso regna sovrano e che ben si presta a quei prestigiosi incontri che dovranno tenersi con le personalità di spicco del settore e sovente caratterizzati da quei pregiudizi e da quello snobismo proprio della casta.
«La continua frequentazione alla ricerca ossessiva del divertimento e del piacere finì per intorpidire le nostre aspirazioni e alimentare il più grande desiderio dell'uomo: il non fare assolutamente nulla.»
E se da un lato all’inizio siamo respinti da Leo, vera voce dell’opera che arriva con il suo vivere l’attimo e approfittare del momento, qualunque esso sia, rifuggendo al pensiero del domani e rischiando talvolta di risultare arrogante e supponente con questo suo atteggiamento che tende a farlo porre sopra gli altri, poi ne siamo attratti tanto che naturale è l’empatia con il suo ruolo e il suo personaggio. Alberti riesce perfettamente in questa caratterizzazione tanto che nel lettore suscita emozioni tra loro contrastanti permettendogli di assaporarne ogni caratteristica. Kevin è al contrario il personaggio silente, colui che ha un grande cuore ma che resta più nelle retrovie arrivando con la sua presenza e non con le sue azioni (ciò lo rende anche oggetto di derisione), infine, Tom, che giunge al conoscitore che si avventura tra queste pagine grazie a quel suo desiderio di arrivare sotteso ma in particolar modo grazie ai toni sarcastici che ne denotano l’indole. Tre personalità, quelle delineate dal narratore, che costruiscono un volto corale che può essere scisso in singole identità. Chi legge riscontra in ciascuno di essi elementi veritieri e tangibili, si rispecchia in maggiore o minore parte, ne apprezza le sfumature.
A conquistare però non è soltanto la storia gradevolissima, originale e al contempo una boccata d’aria fresca nel settore letteratura contemporaneo, è anche lo stile che spicca con tutta la sua dirompenza. Massimiliano Alberti ci destina di un elaborato caratterizzato da uno stile elegante, pregiato, prezioso che accarezza l’occhio per appagarne anche l’anima. Uno stile che rispecchia le multi-facce triestine e che è altrettanto evocativo per l’ambientazione viennese che giunge con tutta la sua raffinatezza, maestosità e imperiosità.
Romanzo d’esordio, quello di Alberti, che non passa inosservato e che solletica il palato del lettore con curiosità, brio, umorismo e quella stessa essenza propria della pop art.
«La vita è troppo corta per essere vissuta cinicamente. Una buona mediocre paghetta per farsi qualche regalino ogni tanto, non ripaga il vuoto che sia nell’animo. Aspirine! – dissi cucinandomi a lei con fremito -, sono solo aspirine temporanee, che servono ad abbassare il grado di generica insoddisfazione nei confronti della propria esistenza. Ma il fatto di sentirsi importanti per qualcuno o di sfidare le sorti del proprio destino, beh questa è la medicina che ci può salvare dalla malattia della rassegnazione. Per farla corta, però – conclusi tornando sui miei passi-, L’essere umano ha bisogno di sognare.»
Indicazioni utili
Maude Sterne e il mistero del 1913
«Non spiegò mai perché l’avesse fatto e non c’era alcuna ostilità tra lui e la vittima: si era limitato a uccidere la prima persona a capitargli a tiro. La polizia gli trovò nelle tasche frammenti di vetro verde identici a quelli incastrati nei bulbi oculari, nelle orecchie e nella lingua del cadavere, oltre a quattro foglie di una pianta chiamata “sigillo di Salomone”. Altre tre foglie come quelle erano infilate nella gola della vittima.»
Siamo nel 1966 eppure tutto sembra essersi fermato a quel 1913 a Wake’s End, un maniero dai tetti dissestati spruzzati di licheni arancioni che sorge a Wakenhyrst. È un luogo fuori dal tempo che il tempo stesso ha reso ancor più imperscrutabile e selvaggio. Qui nel 1913 è stato perpetrato un orribile delitto a mano di un uomo, Edmund Stearne, ricco proprietario terriero e stimato storico alle prese con una importantissima traduzione ed esegesi, che viveva nella tenuta con la figlia Maude, al tempo sedicenne, armato di un punteruolo da ghiaccio e un martello da geologo. A seguito dell’omicidio del frutteto, il proprietario terriero fu internato in manicomio dove dedicò il resto della sua vita alla creazione di indecifrabili e magnifici dipinti. Ma è stato davvero lui a commettere l’omicidio? C’è chi pensa che al contrario possa essere stata la figlia Maude, a oggi sessantanovenne in condizioni di forte indigenza e dall’aspetto di una fattucchiera, o perché no, qualcun altro ancora, ad averlo commesso scaricando poi la colpa sulla figura maschile? Che sia davvero andata così? Maude per oltre cinquant’anni ha mantenuto il silenzio su quanto accaduto ma forse è giunta l’ora di rivelare la verità, di rendere pubblica la sua storia…
«Sapeva che Chiacchierino non le voleva bene, il che era giusto, dato che era selvatico. Ma sapeva anche che per tre giorni lei era stata importante per lui, perché l’aveva nutrito e tenuto al sicuro. Adesso era tutto finito e lei era nuovamente sola. Solo che stavolta era peggio, perché la gazza le era stata davvero vicina e adesso se ne era andata.»
E torniamo allora indietro nel tempo, torniamo a quegli anni in cui Maude era soltanto una bambina innamorata della figura materna troppo spesso malata a causa di quei “congiungimenti” obbligati e provata da quei figli nati morti o deceduti poco dopo il parto, e ancora intimorita e poi incantata da quella figura paterna di cui negli anni cerca di conquistare, seppur fallendo, le grazie. Maude cresce sola, cresce in un ambiente dove l’affetto è centellinato e dove la vita è sondata da regole improcrastinabili. Vi è inoltre un luogo in cui non può assolutamente entrare: la palude. A causa degli spiritelli, a causa della scaramanzia, a causa del fatto che lei è una signorotta e non può “sporcarsi” in luoghi non degni. Tuttavia, mai davvero conosce l’affetto. I suoi fratelli al trattano da essere inferiore perché femmina, la madre è troppo dedita a servire il marito per dedicarle il suo amore sino a che a furia di assecondarlo non pagherà il più caro dei prezzi e infine Edmund non farà altro che denigrare la figura della giovane perché scialba e sgraziata perché donna e dunque essere di non pari livello seppur riconoscendone una degna intelligenza rispetto alla progenie maschile. Ci saranno momenti di verità, un mistero che si infittisce, un enigmatico testo da tradurre, tanta superstizione, tanto sentimento in questa storia che prende sempre più forma e campo ne “I demoni di Wakenhyrst”.
Il lettore è affascinato e incuriosito da quel che si cela dietro la realtà e ogni tassello che viene aggiunto alla narrazione permette di ricomporre un puzzle più grande che si sviluppa anche grazie a quel taccuino dello storico con cui veniamo a conoscenza dei pensieri e degli avvenimenti che colpirono la tenuta. Al tutto si somma uno stile narrativo fluido, accattivante, pregiato e ben descrittivo che consente di rendere vivide le immagini. Altrettanto degna di nota è altresì la ricostruzione storica posta in essere dalla Michel Paver che è minuziosa, pregna di particolari e perfettamente cristallina.
Il risultato è quello di uno scritto che cattura, trattiene e che si fa divorare. Unica pecca è un certo rallentamento, dovuto, nella seconda metà della narrazione. Dovuto perché è uno dei tasselli che porta in essere la ricostruzione e chiarificazione del mistero e che se da un lato risolve e appaga il lettore, dall’altro lato tende a sfiancarlo un poco. La lettura resta comunque intensa e si conclude in un arco di tempo anche troppo breve.
Gotico, esaustivo, gaudente. Una scrittrice da leggere e da tenere d’occhio per il futuro.
«La gente di solito non va nella palude di notte, per paura degli spiritelli e compagnia, ma Jubal sa che sono tutte scempiaggini. Sa che ci sono cose peggiori che infestano la palude. E in estate, al crepuscolo, quando l’odore dell’olmaria è soffocante e i rondoni lanciano versi striduli in cielo, quelle grida gli entrano dentro […]. Per questo Jubal fa in modo di avere sempre con sé una bella presa di tabacco e una fiaschetta di infuso di papavero, più forte è, meglio è. Ma non è mai abbastanza forte da fermare le grida che gli rimbombano dentro.»
Indicazioni utili
Amélie torna in Giappone
«Avevo trovato la mia vocazione. Il mio spirito sbocciava con quel lavoro semplice, utile, umano e propizio alla contemplazione. Mi sarebbe piaciuto farlo tutta la vita.»
Con “Stupore e tremori” conosciamo una Amélie Nothomb ventiduenne e alle prime prese con il mondo del lavoro e in particolare nipponico. Con massimo rispetto e riserbo, la giovane donna, tornata a vivere in Giappone, luogo ove è nata e cresciuta sino all’età di cinque anni, riesce a realizzare il suo sogno di poter prestare il suo impegno presso una società giapponese che la assume con un contratto di dodici mesi. Il sogno, tuttavia, ben presto si rivela essere ben diverso dalle aspettative e la realtà con la quale ella trova a doversi confrontare è tutto fuorché semplice o rosea. Amélie viene destinata ai lavori più degradanti e umili sino a raggiungere quello che è l’apice dell’avvilente. Non si abbatte, però. Comprende le ragioni di quelle decisioni che vengono prese nei suoi confronti e ha verso di loro, così come verso i suoi superiori, un atteggiamento di massimo e profondo rispetto, caratteristica questa che mai in lei viene meno. E se da un lato a una prima analisi l’attenzione si sofferma su quel che è l’aspetto proprio delle condizioni lavorative giapponesi, a una analisi più precisa, minuziosa e anche introspettiva, l’occhio si spinge oltre arrivando a prendere consapevolezza di quell’aspetto più intimo e umano che invece caratterizza la donna.
«Ogni esistenza vive, un giorno, quel trauma primordiale che divide la sua vita in un prima e in un dopo e il cui ricordo anche furtivo basta a creare un terrore irrazionale, inumano e inguaribile.»
È in questo, a mio modesto avviso, che si snoda l’intero componimento. Ella ci consente di entrare maggiormente in sintonia con quello che è il suo mondo e quella che è la sua psiche, gioca con il “vero” e non vero tanto che chi legge è chiamato a chiedersi quanto effettivamente ci sia di verità e quanto non in quel che ha tra le mani eppure, al contempo, resta affascinato proprio dagli occhi con i quali si guarda al lavoro e alla vita. C’è inoltre tanta filosofia in questo scritto. Tanta filosofia e tanto tanto di letteratura classica e classica contemporanea. Se da un lato ho potuto ravvisare aspetti inerenti a “Il processo” di Kafka, non sono mancate altresì riflessioni suscitate da quelli riportati alla mente da similitudini con “La metamorfosi”. E molti altri ancora sono gli spunti letterari e psicologici che la scrittrice belga porta in superficie.
«Questa constatazione mi richiamò alla mente il detto di André Maurois: “Non dire troppo male di te stesso: finiranno per crederci”.»
Non mi sento di definire questo titolo un elaborato di denuncia sociale come ho letto su altre recensioni online, non ne ha l’impostazione, per me. Per quanto i tratti siano crudi e duri verso i giapponesi, il modo in cui sono esposti fanno evincere quanto effettivamente essi siano riportati all’attenzione quali elementi per ricostruire i tratti salienti di un mondo a noi fortemente lontano e per mezzo dei quali ridar vita a una dimensione che possa essere tridimensionale. Lo stesso titolo, ha un suo significato più intimo che arriva, resta e che spiega molto di quel che poi ne sarà il contenuto.
Una autrice a cui mi sto avvicinando piano piano e che sino ad oggi è riuscita a sorprendermi. Un titolo di cui consiglio la lettura perché intenso per temi e contenuti ma a cui credo sia meglio avvicinarsi dopo aver meglio conosciuto la Nothomb.
Indicazioni utili
Alberto e Flavia
«Eravamo precipitati nella realtà, adesso, in quella terra ruvida che chiamiamo vita.»
Il suo nome è Alberto, è un uomo di mezza età, medico, con un figlio ereditato da un vecchio matrimonio e con il quale ha un rapporto sfilacciato, a causa della distanza, a causa degli eventi. Quando meno se lo aspetta scopre di quella diagnosi dalla quale non vi è possibilità di fuga: un tumore ormai in stato avanzato è pronto a portarselo via senza lasciare spazio ad alcuna possibilità di cura. A un primo momento di smarrimento segue la consapevolezza e la voglia di lasciar andare quel che è stato per abbracciare quel che verrà. Alberto, preda di emozioni contrastanti, si finge cieco e si rifugia in un parco che pian piano diventerà la sua casa e quella degli incontri con una donna, Flavia. Così diversa da lui, così spaventata, così preda di quell’uomo con cui ha concepito suo figlio e il cui comportamento ha tutti i tratti tipici di una possibile violenza domestica.
«Esiste solo il tempo e il modo in cui lo puoi accelerare o rallentare.»
I due si incontrano per caso una volta in questo scenario caratterizzato da una panchina e una vista sull’orizzonte, eppure, quel primo ritrovarsi diventa quasi una consuetudine tanto consolidata quanto attesa a cui segue un aprirsi del cuore e della mente e di confidenze che si affacciano e sedimentano. Tuttavia, un giorno come un altro, questi rendez-vous si interrompono. Flavia non si presenta più al parco e lo stesso Alberto smette di andarvi. Perché? Cosa è successo?
«Soprattutto, dopo che è mancato, tutti abbiamo bisogno del ricordo di un padre forte.»
Con una penna evocativa e una storia che si apre con un diario che introduce le vicende per poi lasciar loro prendere campo e che in fine le conclude, come un libro nel libro, come un perfetto cerchio, Marco Franzoso dona al suo lettore un elaborato che tocca temi importanti e in particolar modo la malattia, quella malattia che non lascia spazio a possibilità o alternative, quella malattia che quando sopraggiunge ti porta a interrogarti sul tuo passato, sul tuo vissuto, sul tuo percorso. Spingendoti a riflettere, spingendoti a cercare legami e punti di comunicazione e incontro talvolta proprio con quelle persone sconosciute con cui intavoli un rapporto perché in loro semplicemente ti riconosci.
«Ciascuna parola era una scoperta, ma anche una ferita che le parole slargavano e un istante dopo rimarginavano. […] Perché abbiamo vissuto. Quella era vita, tutta vita e solo vita. Il nostro appuntamento era quello, e noi per una volta ci siamo fatti trovare. Questo mi ripaga di tutto. Fanne tesoro anche tu.»
Sai di aver trovato in loro una casa, sai di aver trovato in loro un porto sicuro, sai di non aver mancato quell’appuntamento con la vita e con il vivere che troppo spesso saltiamo perdendo quel treno che passa una volta sola. Si crea come un legame magico, intriso di un qualcosa di ineguagliabile e di emotivamente indimenticabile.
La vicenda scorre rapida tra le mani del lettore ma non è una storia per tutti. È una storia che è caratterizzata da un ritmo narrativo ben cadenzato ma che talvolta può risultare essere troppo descrittivo, al contempo trattando di problematiche forti richiede sintonia soprattutto per l’aspetto che riguarda non tanto la malattia ove a prevalere è il dato empatico e riflessivo quanto, per il legame che si crea tra l’uomo e la donna che è avvolto da un misticismo e una magia che possono non conquistare tutti.
Una lettura che consiglio agli amanti del genere e a chi cerca un libro con cui e su cui riflettere.
Indicazioni utili
- sì
- no
No = a chi non ama queste tematiche e/o i romanzi di questa tipologia.
Padri, figli e una gatta.
«Tutti, chi più chi meno, avranno probabilmente un’esperienza dolorosa che non possono dimenticare, o che non riescono a esprimere a parole, e se la porteranno nella tomba.»
Torna in libreria Haruki Murakami con “Abbandonare un gatto”, opera avvalorata da preziose illustrazioni a firma Emiliano Ponzi. Il titolo che ci propone questa volta il noto autore giapponese non è altro che un lungo e intenso racconto che parte dall’aneddoto di questa gatta che non si sa bene per quale ragione il padre del nostro protagonista/scrittore bambino decise di abbandonare. Per tutti gli amanti dei gatti, c’è un risvolto positivo che qui non svelo ma, per il piccolo quell’episodio fu alquanto strano e incomprensibile perché la famiglia Murakami abitava in una casa con giardino ed era solita ospitare in questo mici randagi. Un remoto episodio dal quale ha inizio un flusso di ricordi che ruota attorno alla figura del padre. Nato il 1° dicembre 1917, secondo figlio del priore del tempio Anyoji, nella municipalità di Sakyo-Ku, quartiere di Awataguchi, egli ha fatto parte di una generazione sfortunata. Quando questo aveva soltanto pochi anni giunse al termine quell’epoca di pace e democrazia vigente in Oriente, epoca che stava portando il Giappone incontro a una grave crisi economica e a quello che sarebbe stato il pantano della guerra con la Cina e alla tragedia del conflitto mondiale. Il padre di Murakami era riuscito a sopravvivere alla confusione e alla povertà del secondo dopoguerra ma per arrivare a questo aveva dovuto passare anni di ristrettezze economiche, fame e ostilità.
«Una volta, da bambino, gli chiesi per chi pregasse. “Per le anime di chi è morto in guerra”, mi rispose. Per i soldati giapponesi, ma anche per i cinesi, che erano i nostri nemici.»
Eh sì, perché seppur al tempo fosse studente, fu richiamato alle armi e fu costretto, come molti altri suoi coetanei a partire e ad assistere a massacri e ad avvenimenti infausti e particolarmente dolorosi. Quando fece il suo ritorno, in due tempi, a casa, era ormai una persona profondamente cambiata e turbata da quel che era accaduto.
«È così che funzionano le relazioni umane, è così che funziona la storia.»
Haruki, nato nel 1949, ha risentito particolarmente di quanto occorso e ha sempre avuto un rapporto particolare con questa figura paterna, una figura con la quale è riuscito a riappacificarsi soltanto al culmine degli ultimi anni di questa.
«È un ricordo della mia infanzia che mi ha lasciato una forte impressione. Inoltre mi ha insegnato una cosa importante: nella vita, scendere è molto più difficile che salire. In termini più generali, spesso il risultato va al di là dello scopo e lo rende inutile. A volte è un gatto a restare ucciso, a volte un essere umano.»
Ha riflettuto, si è interrogato, ha rivissuto quel tempo e in queste pagine ce ne rende partecipi, ci destina della sua memoria e di quelle riflessioni che sopraggiungono con il passare degli anni, quando hai abbastanza esistenza alle spalle da poter fare dei bilanci, inizi a vederne una fine e al contempo puoi valutare davvero il risvolto del tuo vivere.
«È ovvio che dopo aver superato una certa età, ho capito che ogni persona è fatta a modo suo, ma quando ero adolescente non mi sentivo a mio agio nell’ambiente famigliare. Mi portavo dietro un vago senso di colpa.»
Il risultato è quello di uno scritto breve di appena settanta pagine ma intenso, un elaborato che arriva semplicemente con tutta la sua forza e che invita alla ponderazione il conoscitore che ne è rapito e conquistato. La lettura è rapida, le pagine si susseguono alle immagini, eppure il contenuto è indelebile e intriso anche un velo di malinconia che non manca di ricordarci chi siamo e cosa siamo. Perché siamo alla fine niente più che l’accumulo del nostro essere stati, l’accumulo del nostro aver vissuto, del nostro essere caduti e del nostro esserci rialzati.
«È l’accumularsi di queste piccole cose che mi ha formato, che mi ha reso la persona che sono ora.»
Introspettivo, magnetico, riflessivo. Da leggere e gustare poco alla volta.
«In altre parole, ognuno di noi è una delle innumerevoli, anonime gocce di pioggia che cadono su una vasta pianura. Una goccia che ha una sua individualità, ma è sostituibile. Eppure quella goccia di pioggia ha i suoi pensieri, ha la sua storia e il dovere di continuarla. Non lo dobbiamo dimenticare. Anche se si perde la propria individualità per essere inglobati e annullati in qualche massa. Anzi, dovrei dire “proprio perché si è inglobati in una massa”.»
Indicazioni utili
Alessandro Gordiani e i crimini di sangue
«Tanto era lenta e impacciata la giustizia dei tribunali, tanto era feroce e inesorabile quella in vigore da sempre in quelle terre. […] La vendetta era lenta ad arrivare, doveva percorrere lunghe distanze e si muoveva sopra un carro trainato da buoi, quindi il più delle volte poteva impiegare molto tempo per raggiungere la destinazione finale. Ma arrivava sempre, puntuale e implacabile come la morte, con cui viaggiava a braccetto.»
Fonni, alta Sardegna, tra le alture e il silenzio dei suoi abitanti, tra le usanze e i codici non scritti. È qui che viene applicato il codice barbaricino, un codice silente, una consuetudine non scritta che permette di attuare anche la vendetta più severa per il torto che è stato subito. E questo lo sanno bene le famiglie Rutzu e Serra, rivali da generazioni e destinatarie nonché prime adottatrici di questa forma di rivendicazione che fin troppo le ha viste protagoniste.
Ed è proprio in questo contesto che nasce l’ennesimo pretesto per la vendetta, che nasce l’ennesimo pretesto di lite. Perché Davide, il figlio maggiore di Vittorio Rutzu con un gesto spropositato mette a repentaglio la quiete della famiglia e desta nuovamente le ire della rivale. Vittorio e la moglie sono preoccupati, temono ritorsioni e quando il figlio minore Gregorio viene rinvenuto privo di vita a seguito di un colpo d’arma da fuoco in pieno petto, ecco che la storia sembra ripetersi quasi come se si stesse mettendo in scena una tragedia shakespeariana. Ad aggravare la situazione il fatto che il figlio Davide, fratello maggiore del defunto, dichiari di aver visto allontanare dal luogo del delitto un uomo caratterizzato da una zoppia fin troppo nota nel paese. Stante la dichiarata amenità tra famiglie e le precedenti minacce a seguito dell’affronto del figlio più grande, i sospetti si tramutano in un arresto nei confronti di Serra, recidivo e senza ombra di dubbio il più plausibile dei colpevoli. Che sia stato davvero lui? Che i sospetti siano davvero fondati? Che sia stato applicato il codice barbaricino anche nei confronti di un così giovane uomo?
Della difesa di questo viene incaricato Alessandro Gordiani che in quel della sua Roma stava già pregustandosi le prossime ferie agostine. Avvocato penalista di gran fama e capacità, egli appartiene a quella cerchia di legali che ben seleziona i suoi clienti rifiutando di assumere la difesa di coloro che sono per definizione indifendibili. Ecco perché accettare questo caso è per lui così difficile: non è solito assumere la difesa di chi uccide a sangue freddo ragazzi e bambini. È il dubbio a convincerlo. Il dubbio scaturito da quelle investigazioni portate avanti in parallelo con quelle della polizia, è la scoperta del fatto che forse qualcun altro potrebbe aver avuto interesse a mietere questa morte per difendere il proprio onore e nome.
Con una penna rapida e fluida Michele Navarra destina il suo pubblico di lettori di un giallo giudiziario costituito da una trama solida e capace di incuriosire il conoscitore. L’opera giunge al suo destinatario senza difficoltà grazie in particolare a uno stile narrativo che per sua definizione è evocativo e particolarmente empatico. Se da un lato è la storia a incuriosire, dall’altro è il clima quel che più giunge al lettore, un clima di omertà, paura, silenzi ed eppure consapevolezza che permea l’atmosfera del paesino rurale in quella certezza di poter da un momento all’altro dire o fare qualcosa di sbagliato.
Ottima inoltre la contestualizzazione giuridica nonché quella inerente al codice barbaricino che nulla risparmia. Un titolo che giunge a un epilogo che funziona e che ci ricorda che non sempre esistono vinti e vincitori perché talvolta a perderci sono semplicemente tutti.
«Eppure, lui paura ne aveva, eccome. Quella sensazione d’inquietudine di fondo, quel senso di turbamento che fino ad allora si era manifestato in forma quasi indefinita, come un fantasma privo di contorni reali e tangibili, aveva preso corpo, si era improvvisamente materializzato accanto a lui nel momento in cui Serra lo aveva guardato e, anzi, l’aveva addirittura fissato con quella che gli era sembrata una strana mistura di malevolenza e rassegnazione.»
Indicazioni utili
Famiglie, verità e disillusioni
Secondo capitolo della saga che ha avuto inizio nel 2016 - sempre per Feltrinelli - con “Caffè amaro”, “Piano Nobile” ci riporta in Sicilia, in quel di una Palermo del 1942. La guerra è in corso, i soldati italiani sono consapevoli che questa è persa in partenza e nel mentre Enrico Sorci, nel suo più lucido delirio dal letto di morte, vede passare davanti a sé tutta la sua vita. Questa prende luogo dai torti subiti e dai torti arrecati, dalle donne amate a quelle rifiutate e tradite per mero piacere della carne o usate per mera necessità e volontà propria ma non esclude nemmeno quella famiglia a cui tanti torti sono stati da lui compiuti. Le sue spoglie ancora vive e mortali abitano quella camera che, escluso per la tappezzeria britannica, è interamente espressione del volto siciliano e ancor più di Rosaria Lupino Stassi, la moglie sottomessa e docile venuta a mancare prima del tempo e fin troppo sottovalutata, la moglie che aveva portato in dote i beni dello zio e che al Sorci ha donato quattro figli maschi e che eppure mai è stata davvero rimpianta rispetto a quelle donne di più blanda compagnia con le quali era solito appagarsi. Non l’ha mai amata, sua moglie, eppure è adesso che essa torna alla sua mente e il suo “valore è emerso come una statua perfettamente conservata dal fondo del mare, rivelando la sua bellezza”. Ed è forse anche giunta l’ora del chiedere perdono?
In un lasso di tempo che oscilla tra il 1942 e gli anni Cinquanta del miracolo economico italiano, “Piano nobile” si apre tra le mani del lettore per mezzo della voce di questa famiglia siciliana composta da personaggi vividi che creano un concerto a più voci. È per mezzo di loro che osserviamo concludersi un mondo e nascerne un altro, è per mezzo di loro e delle loro memorie e testimonianze che ricreiamo la loro storia e la nostra storia, che riviviamo le loro emozioni fatte di passioni, amori, ripicche, vendette, gioie e soddisfazioni, cadute e gelosie.
Un romanzo questo a firma Simonetta Agnello Hornby che parte con un ritmo più lento e che piano piano accelera conducendo per mano il lettore tra le vie di un viaggio introspettivo ed empatico che non delude le aspettative e che appaga non solo gli appassionati della sua prosa quanto anche chi la conosce meno e desidera avvicinarvisi nonché tutti gli appassionati di storia, di saghe famigliari, di rapporti umani e legami fatti sentimenti contrastanti e talvolta anche contraddittori.
“Da tempo sono qui, più ospite che padrone. La questione ereditaria è dura a risolversi, ma mio padre ha fatto in modo che io stessi nel palazzo, proprio per avere Elio al mio servizio, come se il nonno fosse ancora qui e le consuetudini fossero quelle di sempre, e come sempre rispettate. Fuori il mondo trema. Le forze nemiche continuano a bombardare lo Stretto, Reggio e Messina. Si sentono talmente certi di vincere che colpiscono anche di giorno.”
Indicazioni utili
Tra le maglie dell'infinito
«Adorava danzare, e dopo che le avevano dato anche una parte da solista per il pubblico olandese perché era molto brava, tanto più brava dei ragazzi che all’inizio l’avevano derisa, lasciò la compagnia per andare in cerca delle risposte che neppure la danza poteva darle.»
Nonostante le poderose dimensioni “L’ottava vita” di Nino Haratischwili è un romanzo che sorprende per la tutto sommato rapidità con il quale si fa leggere e per la facilità con il quale trattiene il suo lettore tra le pagine. Non è una lettura semplice perché tanti sono i fili che si susseguono nella narrazione e che arrivano a ricomporre un disegno più articolato di quel che si può pensare, ma in tutto questo, essa scorre veloce e non si fa temere per quelle oltre mille pagine che la caratterizzano. È un titolo che suscita emozioni diverse man mano che prosegue, sa essere dolce ed emotivo ma anche tagliente come una lama, sa essere appagante e soddisfacente ma sa anche essere magico perché il confine tra incanto, finzione e realtà è minimo e sa confondersi e dipanarsi con la estemporaneità di un temporale estivo. È una lettura, ancora, che è un piacere gustare un poco alla volta magari alternandola anche con altri elaborati, simbolicamente suddividendola, appunto, in vite.
Cominciamo la scoperta dei protagonisti dell’opera per mezzo del volto di Niza, il cui nome in lingua georgiana significa “cielo” e che ci introduce nelle danze di questa esistenza che spesso ha lasciato un retrogusto amaro e tanta sfiducia nel divenire. Pian piano, a questo primo personaggio se ne aggiungeranno altri e quello che verrà a ricomporsi è un puzzle che va dal 1903 agli anni 2000, ovvero, sino all’ottava generazione, sinonimo altresì di infinito, con Brilka quale portavoce. Tanto ancora potrebbe dirsi sulla trama ma credo sia più opportuno non andare oltre, per evitare involontari spoiler ma soprattutto per non guastare il gusto della sorpresa proprio di quei libri più succosi.
Attraversiamo storia, finzione narrativa, legami, affetti, perdite e tanto tanto altro ancora sino a giungere a quello che è un epilogo che non delude le aspettative.
L’opera sa conquistare, sa affascinare, sa coinvolgere. Non può definirsi un capolavoro ma resta e fa riflettere. Merita di essere letta e dona un viaggio dai tratti finiti ma dalle aspettative infinite.
Indicazioni utili
Jorge e Norama Tripe
«Ma siccome la vita è molto distraente, noi camminiamo in molti luoghi, ci dedichiamo al continuo spostamento. Diciamo pure che benché inclini allo scavo preferiamo che a scavarci la fossa siano gli altri a cose fatte.»
Quando arrivò a Siviglia, il padre di Norama Tripe, il trattore lo abbandonò all’angolo della strada e da allora di questo non ebbe più memoria, quasi come se mai fosse esistito. Trovato lavoro come magazziniere in un antro buio e lungo, fece di quello stesso luogo la sua casa. Qui si chiuse in un magnetico viaggio fatto di libri e letture, appunti e riflessioni sino a che, «dopo aver tirato un sospiro lungo che pareva trapassarlo in chissà quale altro mondo, disse: “E ora scrivo io.” E così cominciò a scrivere un libro sulla tragedia ilare del vivere, e trascorse anni nella affossata scanalatura di un linguaggio che inventava ricordando il meglio del linguaggio altrui». Da qui nacque la sua opera la “Tragica ilarità del mondo” che in quel 1965 lo destinò a riempiere le pagine dei giornali ma anche a lei, sua figlia. Perché Jorge andatosene a bordo di quel trattore lascia alle sue spalle una figlia di appena due anni e una consorte ormai rassegnata a quell’uomo così imprevedibile, sconsiderato ed egoriferito. Eppure quella figlia vuole avere contezza di quel padre mai conosciuto e visto per la prima volta su una rivista e decide allora di partire, per incontrarlo e scoprire delle sue radici.
«Ebbe paura della disparità che l’avrebbe attesa l’indomani. Avrebbe dovuto fronteggiare chi per età non poteva certo aver dimenticato i ricordi. Eppure era lei che lo cercava. Naturale, certo che era lei.»
L’uomo che si trova innanzi è un uomo di una quarantina d’anni, grasso e trasandato che dimostra molto più della sua età e che trasuda vecchiaia e decadimento a ogni sguardo. È un uomo, Jorge Tripe, che ha un’amica, Dolores, con la quale talvolta condivide il letto, un editore che lo foraggia con uno stipendio fisso e un luogo ove vivere ma è anche un uomo che fa delle parole la sua unica ragione di vita. L’allontana, la respinge, rifiuta la presenza di quella giovane donna carne della sua carne quasi come se questa si fosse decisa a incontrarlo esclusivamente per privarlo di quel verbo suo proprio. Riuscirà ella a farsi amare dal padre o comunque a farsi accettare nella sua vita?
Ed ecco che quella furia di cui al titolo ribolle e trasuda in un romanzo metaletterario che con una prosa dai toni carezzevoli quasi una fiaba giunge con tutta la sua imponderabile forza emotiva. Provocatorio ma anche riflessivo è “Cuore di furia” che sin dalle prime battute invita ad andare oltre le apparenze proprio scindendo da quel primo giudizio verso la figura di Jorge che istintivamente sviene da associare a un uomo egoista e irresponsabile.
Da qui una curiosità che è in realtà alle origini perché sotto le mentite spoglie di Jorge Tripe si cela Giorgio Manganelli, padre putativo di Romana Petri che a sua volta si cela dietro l’anagramma di Norama Tripe, figlia invece di sangue del protagonista dell’opera de qua. Una figura centrale attorno alla quale ruotano quella della ragazza ma anche quella di Dolores, la donna che lo ama e che vorrebbe condividere con lui un poco di normalità.
Il tutto è avvalorato da uno stile prezioso e minuzioso, erudito e magnetico che rappresenta il pregio dell’opera attraverso toni sia carezzevoli che forti, dialoghi serrati e distesi, porta alla delineazione di personaggi robusti e corposi, ben tratteggiati e facilmente riconoscibili.
Un buon titolo che non teme di trattare tematiche importanti e attuali, che non teme di solleticare le corde e le curiosità più intime del lettore e che al contempo conferma la maestria narrativa di Romana Petri.
«Come non si sa? È mai possibile che tu debba ogni volta svegliarti in piena notte per andarti a finire il sonno in magazzino?»
«Evidentemente sì» le rispose lui. «Ognuno sa star bene a modo suo.»
Indicazioni utili
Il vero messaggio
Titolo conclusivo della trilogia di Gesù che ha avuto inizio con “L’infanzia di Gesù” (2013) e che è proseguita con “I giorni di scuola di Gesù” (2016), “La morte di Gesù” (2020) è un elaborato che esattamente come nei due precedenti lavori scuote e sorprende il lettore e che risente chiaramente delle influenze del percorso letterario dell’autore e in particolar modo del postmodernismo ma anche dell’apartheid anni ’70. Esattamente come in altre sue opere anche in questo caso vengono affrontati temi esistenzialisti quali la morte, la malattia, il privilegio, i legami e rapporti tra padri e figli, la politica negli aspetti sociali, il terrorismo, il veganismo e anche il desiderio e/o la colpa. E seppur la sua opera possa essere suddivisa in più gruppi composti da romanzi sperimentali, realisti, autobiografici e anche saggi ed epistole, la Trilogia di Gesù esula dal poter rientrare in alcuno di questi.
Partiamo con la conoscenza di un bambino giunto all’improvviso nel primo scritto della serie, proseguiamo con quelli che sono i suoi anni scolastici e concludiamo con quella che ne è la dipartita. Si noti bene che mai è esplicito il riferimento di Gesù a David, cosa questa, che fa riflettere e interrogare sul chi sia davvero il primo. Che sia il caso di interpretarlo in senso metaforico e astratto? Che esso rappresenti l’imprevedibilità e l’imponderatezza? Che sia ancora quella forza atta a sovvertire le strutture canoniche che attribuiamo al mondo? Che la trilogia sia dunque da leggere in chiave filosofica e che quindi la stessa si snodi sulle diverse forme che è possibile dare al mondo che ci circonda? E che ruolo ha l’educazione, l’apprendimento tema centrale nel secondo titolo ma che per effetto si ricollega anche al volume conclusivo? E di quale messaggio David è davvero portatore? Sappiamo bene che il messaggio in questione non è mai chiaro e che mai è direttamente svelato eppure prende forma e si insinua nella mente di chi legge che per mezzo dei personaggi e delle vicende si interroga, si domanda, cerca risposte e offre interpretazioni.
Ed è forse quest’ultima la giusta chiave di lettura: l’interpretazione. Quando il confine tra finzione e realtà si confonde è a questa che dobbiamo appellarci per dissipare la nebbia che si è insinuata in noi, circostanza questa che proprio nelle pagine finali viene lasciata nelle nostre mani per mezzo dell’analisi metaletteria che ci chiede di farci interpreti e che per effetto sembra chiederci di farci veri scrittori di quello che ne è l’epilogo.
Una trilogia stratificata e succosa, che sprona il conoscitore ad andare oltre le apparenze; un titolo complesso e completo che non mancherà di solleticare la curiosità dei cuori più avventurieri. Da leggere.
Indicazioni utili
Arrivederci, Mr. Sacks
«La maggior parte era ispirata a un senso di gratitudine: gratitudine per quanto avevo ricevuto dagli altri, ma anche per essere riuscito a dare qualcosa in cambio.»
Fu nel 2005 che Sacks apprese di un particolare melanoma a un occhio ma fu soltanto nel 2013 che quel particolare tipo di cancro, con il 50% di possibilità di metastatizzare o meno, intaccò anche il suo fegato e altre parti del suo organismo. Fu per questo che in un lasso di appena pochi giorni scrisse il saggio “La mia vita”, uno scritto dal quale emergeva la sua profonda gratitudine per questa vita e per quanto avuto durante questa. Sacks riuscì a godere di buona salute ancora per un paio d’anni e chissà, forse è anche per questo che non pubblicò immediatamente questo saggio ma attese. Attese quel tempo necessario ad analizzare, fare bilanci, ringraziare, riflettere su un percorso esistenziale così lungo che adesso poteva finalmente vedere nella sua interezza.
«A ottant’anni, i segni del declino sono fin troppo visibili. Le reazioni diventano un po’ più lente, spesso i nomi sfuggono, e le energie vanno dosate; nondimeno capita spesso di sentirsi pieni di vita e di energie, niente affatto “vecchi”. […] Morì a ottantotto anni, ancora coinvolto appieno nel suo lavoro estremamente creativo. […] Uno ha avuto una lunga esperienza della vita, non solo della propria, ma anche di quella altrui. Ha assistito a trionfi e tragedie, espansioni e contrazioni, guerre e rivoluzioni, grandi affermazioni e profonde ambiguità. Ha assistito all’ascesa di splendide teorie, solo per vederle cadere sotto il peso di inesorabili dati di fatto. Vi è una maggior consapevolezza della transitorietà e, forse, della bellezza. Adesso riesco a immaginare che cosa sia un secolo, riesco a sentirmelo nelle ossa; quando avevo quaranta o sessant’anni non potevo fare altrettanto. Non penso alla vecchiaia come a un’età sempre più triste che in un modo o nell’altro va sopportata facendo buon viso a cattivo gioco, ma come a un periodo di libertà senza impegni, svincolato dalle artificiose urgenze del passato, in cui sono libero di esplorare quello che voglio e di legare tra loro i pensieri e i sentimenti di tutta una vita. Non vedo l’ora di compiere ottant’anni.» pp. 20-22
Quattro i saggi contenuti in questa raccolta intitolata “Gratitudine” e che prendono il nome di: “Mercurio” come quell’argento vivo in movimento verso l’alto e il basso che è l’elemento numero 80 come gli anni che sta per compiere nel momento in cui scrive, “La mia vita” composta da un lungo viaggio fatto di scoperte e auto-scoperte, “La mia tavola periodica” perché per ogni elemento vi è un numero e per ogni numero un anno e per ogni anno un ricordo e infine “Shabbat” per quei tempi che furono e per quelle radici che sono e che conducono a quello che è il giorno del riposo.
È così che Oliver Sacks si congeda dai suoi lettori e dalla sua vita, con un titolo intriso e permeato in ogni battuta e pagina di “gratitudine”, una gratitudine che arriva con forza disarmante e con grande empatia nel conoscitore che è chiamato a interrogarsi e che di fatto si interroga. Ogni parola, ogni saggio è una carezza che ci viene dedicata e che custodiamo nel cuore. Perché forse, alla fine, non esiste davvero un epilogo, perché forse, alla fine, siamo condotti da quel lungo filo conduttore che ci trattiene e fa sorridere. Un congedo che arriva al cuore.
“Scopro che i miei pensieri vanno allo Shabbat, il giorno del riposo, il settimo giorno della settimana e forse anche della propria vita, quando uno sente d’aver fatto la sua parte e può, in coscienza, abbandonarsi al riposo.” p.54
Indicazioni utili
Un viaggio nelle cose che capitano di nascosto
«Allora questa sera ai miei amici immaginari, prima di scriverti, ho detto che può succedere che non ci si veda più. E uno di loro mi ha detto che dobbiamo essere sempre pronti a tutto, come Actarus che è sempre pronto a guidare il suo Goldrake per distruggere i cattivi. Anche se Jeeg Robot non lo batte nessuno. Ma credo siano amici, Jeeg Robot e Goldrake.»
Il suo nome è Fabio e ha dieci anni. È un bambino timido, introverso, silenzioso ma ha anche una fantasia unica e innata che ben si mixa con tutte quelle curiosità che lo caratterizzano e che spaziano tra i fossili, i libri e il sognare e immaginare liberamente su quel che lo circonda. È l’estate del 1979 quando i genitori gli comunicano senza possibilità d’appello che avrebbe trascorso le imminenti vacanze in colonia. All’inizio non è molto d’accordo su questa vacanza che durerà sei settimane, quarantacinque giorni lunghissimi, e su questo viaggio che gli viene proposto ma vuoi perché non sarà solo ma con l’amico più grande di tredici anni Davide, vuoi perché avrà con sé il suo diario su cui appuntare tutto, si lascia convincere ad andare. Sua principale attività sarà quella di scoprire il mondo reale mixandolo con il mondo inventato e annotare tutto quel che accade e che lo circonda sul suo taccuino. Perché Fabio tende a dimenticare le cose, tende ad avere dei vuoti. È certo per questo che se scriverà tutto sul suo quaderno sicuramente non dimenticherà più nulla.
«Questa giornata è stata come il mare che, quando sei sulla spiaggia, non ne vedi la fine. Ma un mare vuoto.»
I giorni scorrono in un susseguirsi lineare nella colonia, le regole sono ferree e sin da subito viene separato dalla sua guida tredicenne, Davide. Rapidamente, però, si rende conto che dell’adolescente non c’è traccia: perché non riesce a trovarlo? Perché è come se fosse scomparso nel nulla? Tuttavia, Fabio riesce a far amicizia con altri bambini con i quali si difende da quei bulli che lo hanno preso di mira proprio per quello sguardo con cui il nostro protagonista si guarda attorno e che è ben diverso da quello dei suoi coetanei essendo intriso di profonda sensibilità e acume. Ad aiutarlo, ancora, ad affrontare quei giorni funesti vi è Sara, uno di quegli adulti che non sembrano essere sordi a quel che accade e che, come lui alla sua età, aveva degli amici immaginari.
Ma perché Fabio non ricorda? Perché Fabio che è così meticoloso nell’appuntare e tratteggiare quelle che sono le sue giornate convive con dei vuoti che non riescono a trovare dei pieni? E cosa ne è stato di quei bambini, oltre a Davide, che sono scomparsi davanti ai suoi occhi in un silenzio che si è perpetrato nei giorni di quella estate del 1979? Perché anche i grandi, talvolta, non hanno risposte a quelle così importanti domande? E quali sono, davvero, le cose che ti capitano di nascosto?
«Ci sono domande, Fabio, a cui nemmeno i grandi sanno dare risposte. Gli adulti non hanno sempre una risposta per tutto, come voi bambini credete. Lo so, è brutto ma è così.»
Attraverso la forma del diario Antonino Geraci costruisce una storia complessa che va oltre le apparenze. Perché quel di cui ci parla Antonino non è soltanto la facciata, quel che vediamo e osserviamo in una prima e superficiale lettura. Dietro la punta dell’iceberg c’è molto altro e il lettore è chiamato a ricomporre quel che ha davanti e ad andare più in là. È chiamato a ricongiungere i pezzi di quel puzzle che sembrano non voler combaciare, è chiamato a entrare in sintonia con Fabio e con quel suo modo di osservare il vivere che nel nostro 2020 sembra essere così lontano, remoto. L’avventuriero è ancora chiamato a tornare ai suoi dieci anni, a rievocare una memoria trascorsa ma ancora vivida nel percorso individuale di ciascuno di noi.
Lo stile che caratterizza il testo è curato, pulito, preciso e minuzioso. Ha una grande forza empatica ed evocativa che conduce per ogni passaggio sino a quello che è un epilogo mai scontato e completamente da scoprire.
Un viaggio intenso, magnetico e capace di trattenere pagina dopo pagina senza difficoltà perché ci sono cose che capitano di nascosto ma che non si dimenticano.
«Le due conchiglie le sono rotolate fuori dagli occhi e io glie le ho fermate con le labbra.
Non ha detto niente, mentre le portavo via le lacrime.
E sentivo il gusto del mare.»
Indicazioni utili
Topo bianco
«Quante persone c'erano nascoste in quel momento fra le rovine e le case ancora in piedi? Gente troppo spaventata per muoversi e che si limitava ad ascoltare in silenzio. Forse stavano pregando anche loro. Forse tutte quelle preghiere sarebbero servite a qualcosa. O forse no.»
Il suo nome è Nancy Wake ma tutti la conoscono come Topo Bianco. Di origine australiana, vissuta nel Nuovo Mondo e approdata a Marsiglia dopo un'infanzia e una adolescenza travagliate, ella è sposata con Henri Fiocca, un importante uomo d'affari a capo dell'azienda di famiglia da una decina d'anni, uomo che è consapevole della sua attività segreta e che non manca mai di appoggiarla. Siamo a Marsiglia, è il 1943 e Nancy è parte attiva della resistenza, non può proprio tollerarli, i nazisti, e ogni suo respiro è dedito a questa battaglia senza fine perché non può rinunciare alla democrazia, perché non può rinunciare alla libertà, perché non può tollerare quella violenza gratuita e quelle vessazioni su quegli innocenti che vengono perseguitati. Ed è proprio la Gestapo a cercarla con maggior fervore, il suo ruolo nella lotta al nazismo è troppo centrale per passare inosservato. Per quanto pensi di essere al sicuro e di non aver destato sospetti in realtà le sue azioni e i continui movimenti economici del marito per finanziarla non sono passati inosservati, sarà proprio l'uomo colui che per primo dovrà fronteggiare il nemico tedesco: verrà interrogato, torturato e le sue sorti non saranno delle più rosee ma Nancy non lo scoprirà subito. Non potrà.
«Così presto? È strano come a volte ci sorprenda quello che in cuor nostro ci aspettavamo da tempo. La sua reputazione e quella della famiglia dovevano pur valere ancora qualcosa a Marsiglia. Henri provò a resistere. [...] I loro sguardi si incontrarono e Henri si sentì gelare il sangue nelle vene. In quell'istante capì che né la legge, né i soldi o l'influenza della sua famiglia gli avrebbero offerto la protezione d cui aveva disperatamente bisogno.»
Non potrà perché Nancy dovrà fuggire, dovrà rifugiarsi in Gran Bretagna dove, unitasi agli agenti segreti inglesi, pianificherà il rientro in Francia per combattere insieme ai combattenti della Resistenza nell'Avernia. Riuscirà a riabbracciare suo marito? Riuscirà a portare avanti la lotta per la salvezza contro la Germania?
Quello che ci presentano Darby Kealey e Imogen Robertson è un romanzo storico ispirato a fatti realmente accaduti e che vedono protagonista Nancy Grace Augusta Wake, classe 1912, Nuova Zelanda, e personaggio realmente attivo nel periodo della resistenza francese. Sono vere azioni che ritroviamo tra queste pagine, è vera la relazione amorosa che ella ha avuto con il ricco industriale Fiocca con la quale si è sposata il 30 novembre 1939, è veritiera anche la caratterizzazione del suo personaggio che, pagina dopo pagina, arriva al lettore con tutto il suo carisma e il suo spirito indomito. Non nego che in alcuni passaggi quel che viene narrato sembra troppo, che la linea narrativa tra finzione e realtà è portata ai massimi e che talvolta il lettore tende a chiedersi quanto sia il vero di quel che sta assaporando ma la nota storica finale dei due autori è alquanto esaustiva e chiara nell'esplicare e nel chiarire dove è l'artifizio narrativo e dove questo non vi è.
Unica pecca che ho ravvisato nella lettura è stata una penna un po' troppo prolissa e descrittiva che ha teso a farne perdere di intensità e a rallentarne lo scorrimento.
Nancy è stata una donna coraggiosa, è stata una donna che ha lottato per fare la differenza, che ha contribuito per la lotta di quelli che erano i suoi ideali e che ci ha insegnato a credere sempre in questi, portandoli avanti con coraggio e determinazione, senza mai arrendersi.
Apprenderemo insieme a lei di quel che è stato, saremo catturati in vicende anche rocambolesche ma saremo anche chiamati a interrogarci su tanti elementi e su un passato che non deve essere dimenticato mai.
Perdersi e ritrovarsi
«Mi ha lasciato. Quest'ultimo colpo, il più tremendo di tutti, mi ha messo al tappeto. Non riesco a soffermarmi su questo pensiero abbastanza a lungo da farmi un'idea pur vaga del perché sia accaduto. Era innamorata di me – ne sono certo – oppure si trattava di semplice attrazione sessuale? Credevo che la mia considerevole esperienza in fatto di donne – in fondo ho più di sessant'anni – mi avesse insegnato quanto siano incredibilmente diverse dalla maggior parte degli uomini. Mi escludo dalla maggioranza di essi perché ritengo di aver sempre posseduto una comprensione intuitiva delle donne di cui mi sono innamorato. Sono relativamente poche, ma le ho conosciute meglio di quanto esse stesse si conoscessero. Adesso ritengo che, se ho sempre fatto fatica ad andare d'accordo con gli uomini, è perché ciò che so sul loro conto l'ho appreso principalmente dalle donne. Dalle loro confidenze, a volte semplicemente da come reagiscono, ho capito già molti anni fa con quanta poca cura siano trattate, come la precoce e affascinante consapevolezza della loro sessualità e delle loro inclinazioni romantiche sia troppo spesso soffocata sul nascere.»
Siamo nel 1995 quando Elizabeth Jane Howard decide di scrivere “Perdersi”. Ha da poco superato i sessant'anni, ha una vita caratterizzata da una situazione sentimentale complessa, un lavoro che ormai l'ha consolidata nel panorama letterario eppure anche una grande solitudine dentro. È in questo scenario che la Howard si innamora, si innamora di un uomo dal quale ha tanto da perdere e poco da guadagnare ma, come spesso accade, il sentimento è più forte di ogni ragione ed è inarrestabile.
“Perdersi” trae origine da un fatto realmente occorso, si può definire la trasposizione su carta di una vicenda emozionale che ha colpito la sua ideatrice da vicino e che tra realtà e finzione funge da catarsi, da cura per il dolore e quel sentimento di vuoto che sa affliggere e buttare giù.
Ad aprire la storia è Henry Kent, un uomo dall'esistenza sfortunata, ormai ultra sessantenne e che vive su una barca di amici. È un uomo abituato a vivere di espedienti, abituato ad arrangiarsi. Quando incontra Daisy, protagonista alter ego della Howard, che nella vita si occupa di commedie e divorziata dall'attore più giovane di lei Jason, non fatica a entrare nelle sue grazie dapprima come giardiniere poi come ben altro. La donna ha lasciato Londra per un delizioso cottage con giardino e adesso, quel di cui ha bisogno, è proprio un bravo giardiniere. All'inizio tra i due non vi è altro che un breve scambio di poche parole fatto da rapidi e saltuari incontri, poi, una lunga convalescenza dovuta a un incidente obbliga la commediografa a restare a casa. Questa sarà l'occasione perfetta per l'uomo per catturare la sua preda. Daisy cederà alle lusinghe dell'uomo nonostante tutte le raccomandazioni, l'attrazione sessuale sarà sempre maggiore e sarà un qualcosa di impossibile a cui resistere.
Tuttavia, il lettore è condotto per mano da una prospettiva particolare: voce narrante non è la donna quanto Henry, per definizione un bugiardo patologico con il vizio del bere e del vivere abusando dei mezzi altrui. Vive su una barca di conoscenti che in verità lo hanno incaricato di venderà, ha sempre tirato avanti grazie a truffe e sotterfugi e all'abilità di circuire il prossimo.
Dal titolo originale “Falling”, “Perdersi” è un romanzo intimo e introspettivo che funge da mezzo di cura per la Howard ma anche quale strumento per entrare nel profondo della psiche umana, tanto dell'eroina che cade nelle trame dell'uomo quanto di quest'ultimo e della sua psicologia contorta e negativa.
L’opera della Howard è ancora un libro che non risparmia il conoscitore in alcun dettaglio, né dal punto di vista dei sentimenti che da quello delle ambientazioni che sono minuziose e precise, reali e concrete per l'immaginazione. Chi legge, nonostante sia consapevole delle circostanze e dei fatti grazie all'io narratore, si fa travolgere da quello stesso amore, diventa un unicum con questo, ne è intrigato e coinvolto pagina dopo pagina, battuta dopo battuta.
Al tutto si somma uno stile narrativo prezioso, articolato, magnetico ma anche fluido e fruibile ad ogni tipologia di lettore. La Howard ha avuto molto coraggio nel mettersi a nudo con questo scritto ma è stata anche estremamente brava nel riuscire ad entrare nella psiche anche dei suoi destinatari.
“Perdersi” è un elaborato completo sia dal punto di vista narrativo che da quello stilistico, non fa dubitare mai delle qualità e capacità della narratrice e al contempo non delude le aspettative di chi ha letto le sue altre opere e in particolare “I Cazalet”. Per chi non li avesse letti e fosse al primo approccio con la penna, “Perdersi” è altrettanto accattivante e un degno titolo dal quale cominciare la conoscenza. Se nel primo caso, infatti, la sensazione è quella di sentirsi “a casa” seppur con un elaborato diverso e più intimo dai precedenti, nel secondo la sensazione è quella di averla travata, una casa. Da leggere e custodire nel cuore.
Indicazioni utili
Anita
Dopo la conclusione della serie dedicata alle avventure di Vani Sarca siamo pronti per la conoscenza, con “Il morso della vipera”, di quella che sarà una nuova saga a firma Alice Basso. Siamo nel 1935, la parola d’ordine è italianizzare, il fascismo è in atto e l’atmosfera tutto è tranne che serena e pronta ad aprirsi al futuro roseo e non dittatoriale.
Due le voci che conosciamo sin dalle prime pagine: Anita, la femme fatale civettuola e dagli attributi consistenti che sente della mancanza di libertà e Clara la voce erudita e intelligente che ama studiare e che vorrebbe poter leggere senza censure. Innanzi alla proposta di matrimonio di Corrado, Anita, che tanto aveva architettato per riceverla e conquistare la sua preda maschile, chiede di poter lavorare per sei mesi. Un bisogno di libertà, questo che la porterà a trovare lavoro nel mondo dell’editoria come dattilografa per una rivista di particolari racconti provenienti dal nuovo continente.
Tuttavia, Anita, che mai ha brillato a scuola e che mai ha avuto una predilezione innata per i libri, con questo lavoro scopre un mondo, un mondo che la porta a interrogarsi sulla bellezza di quelle storie e che la porta anche a comprendere il perché della predilezione verso queste dei lettori. Nasce un amore tanto inatteso quanto bramato, quello verso la lettura, e forse, non solo questo.
Con “Il morso della vipera” conosciamo un nuovo personaggio che suscita simpatia e che nel corso dell’opera cresce e matura arrivando a staccarsi da quella che è la prima immagine che abbiamo di lei nelle pagine iniziali. L’idea della Basso è originale e per chi ha amato i suoi titoli anche questo non mancherà di conquistare i cuori, devo però confessare che, per quanto la storia sia briosa e simpatica, non sono riuscita a farmi completamente coinvolgere. Ho risentito in parte dello stile dell’autrice che per quanto mordace e arguto, alla lunga tende a sfiancare un po’. Probabilmente questa impressione deriva da una certa saturazione raggiunta già con la serie dedicata a Vani ma è mancata quell’empatia totale che al contrario è propria della sua penna. Forse, semplicemente, oltre che ad una evoluzione della protagonista e a una nuova vicenda, era dal mio subconscio auspicata anche una maturazione dello stile narrativo? Non so, me lo chiedo con sincera curiosità.
Ad ogni modo la lettura è piacevole, non manca di strappare sorrisi e di incuriosire il lettore amante del genere. Un titolo ottimo con cui staccare qualche ora ma da leggere senza troppe pretese.
Indicazioni utili
La speranza di quel cerchio non chiuso
«[…] Ma quando un pensiero nasce, come si fa a dimenticarlo? Quando il dubbio inizia a erodere la fiducia, come puoi fidarti ancora? E se non puoi fidarti della donna che dorme insieme a te, della donna che giace al tuo fianco quando sei più indifeso, di chi mai potrai fidarti?»
Monty credeva di farla franca, credeva di aver trovato la giusta strada per fare soldi facili e avere il suo posto nel mondo con la consapevolezza di essere. Pusher, frequentatore di locali alla moda e di bande criminali, fidanzato con la bella Naturelle e padrone di un cane che mai lo abbandona sin dal loro primo incontro, è stato però scoperto dalle autorità e adesso non ha altro che ventiquattro ore prima di essere trasferito in quel carcere che lo ospiterà per ben sette anni. Tuttavia, egli sa bene che in realtà quello che dovrà pagare sarà un prezzo molto ma molto più alto. Perché quei sette anni, almeno, in una struttura detentiva saranno costellati da umiliazioni, soprusi, violenze e quando uscirà, se uscirà, non sarà più lo stesso. La vita che ha conosciuto non sarà più la stessa, il Monty che è sempre stato non sarà più lo stesso. Scappare non ha senso, la sua fuga sarebbe pagata dal padre e da quell’attività che da anni porta avanti. Cosa fare di questo poco tempo che gli viene concesso prima della pena che dovrà espiare? Cosa fare se non trascorrere quella lunga notte con Slattery, un agente di borsa che conosce un unico Dio, il denaro, e Jakob Elinsky, ventiseienne docente di letteratura insoddisfatto sia della sua vita professionale che lavorativa? Cosa fare se non godere per l’ultima volta della sua Naturelle, compagna portoricana amata come poche, e del suo cane?
A far da cornice, New York, un luogo che fa da sfondo ma anche da coprotagonista donando alle avventure narrate nel romanzo un carattere ulteriore che trascende dal mero e semplice aspetto relativo alle vicende dell’antieroe creato da Benioff.
«Il potere ti aiuta a far soldi e i soldi danno potere, ma il potere non dipende dai soldi. Potere vuol dire entrare in un negozio sapendo che puoi comperare tutto quello che c’è sugli scaffali, certo, ma vuol dire anche che il commesso ti fa entrare dopo l’orario di chiusura così che tu e la tua ragazza possiate gironzolare indisturbati fra i banconi; potere è quando il commesso apre per te il retro del negozio per mostrarti gli ultimi arrivi, ancora fasciati nei sacchi di plastica; potere è il commesso che rimane in un angolo in silenzio, mentre tu frughi fra la sua merce, e non si lamenta se palpi i vestiti o baci la tua ragazza per un’ora intera, perché ti conosce e non vuole mettersi nei guai. Potere è telefonare in mattinata e ottenere i posti migliori al Madison Square Garden per lo spettacolo della sera. Potere è entrare in un night-club dalla porta di servizio, in modo da evitare il metal detector. Potere è fissare negli occhi un agente travestito nella metropolitana: tu sai cos’è lui e lui sa cosa sei tu, e tu gli fai l’occhiolino, perché lui guida una Buick scassata e tu una Corvette, e lui non può neanche toccarti.»
È questo quel che voleva Monty. Non tanto i soldi quanto il potere. Il potere di essere qualcuno, il potere di essere considerato qualcuno, il potere di essere rispettato perché sei qualcuno. Ma ciò non sempre è possibile o realizzabile e così ecco che Monty diventa l’emblema dell’America stessa, con tutte le sue paure, incongruenze e fragilità, con tutta la sua sordità. Perché tra queste pagine vi è anche una denuncia sociale a quell’anima del Nuovo Mondo che sembra aver perso i suoi confini, i suoi valori, i suoi ideali, che sembra aver dimenticato le sue promesse.
E così come la venticinquesima ora diventa metafora della salvezza della possibilità, alla speranza di quel domani forse non ancora perduto, ecco che il cane che ha sofferto, ha patito, è stato ferito e salvato da Monty stesso, diventa l’emblema del tramandare, dell’affidare, del filo conduttore con il futuro prossimo. Deve vivere e così ci sarà la possibilità per tutti di vivere ancora una nuova vita.
Doloroso, riflessivo, veritiero. Intenso nel suo scorrimento, intenso nel suo messaggio. Da leggere.
Indicazioni utili
"Finché si è vivi [...] niente è definitivo."
«Non andartene, docile, in quella buona notte: ma non è ancora notte, santo cielo! Non è neanche l’ora del tè. Combatti per la tua vita. Combatti per il tuo matrimonio. Combatti per il tuo lavoro. Combatti per essere meno infelice, cavolo!»
Tom e Louise sono in una profonda crisi coniugale. La molla che ha fatto scatenare il tutto è stato il tradimento di lei ma in verità la crepa che ha solcato il loro legame ha radici più profonde e antiche. Che fare? Separarsi definitivamente o riprovarci magari rivolgendosi a un consulente matrimoniale? Dalla scelta di questa seconda opzione hanno inizio una serie di incontri al bar fatti di serrati dibattiti fatti di pungenti dialoghi e da osservazioni costanti di un’altra coppia che scrociano volta volta e sulla quale fantasticano le vicissitudini. È tramite l’osservazione e il dialogo che riconsiderano quelli che sono i contenuti di quel rapporto che li ha portati ad essere sposati. Tuttavia, sono cresciuti in modo diverso, i due. Diverso come diversa è la loro visione del mondo e così come diversa è la loro condizione lavorativa e sociale. Diverso come la loro opinione sul sesso e su quella consapevolezza/inconsapevolezza della noia sessuale. Ma cosa vogliono realmente? Cosa fare di quel matrimonio? Quale strada intraprendere? Si può tornare indietro nel tempo? Si può tornare al passato? Si può ricucire la ferita?
«Il problema» prosegue lui «è che il matrimonio è come un computer. Lo puoi smontare per vedere che cosa c’è dentro, ma poi ti ritrovi con un milione di pezzi»
“Lo stato dell’unione” è un elaborato rapido, incalzante, fluido, uno di quei titoli che si leggono tutto d’un fiato in nemmeno un’ora ma che lasciano il segno nella loro piccola mole e gran contenuto. È uno scritto che sa far sorridere, che sa trasmettere quel pizzico di malinconia, che lascia anche quel pizzico di amarezza e di consapevolezza sui legami, gli affetti, i rapporti, il vivere quotidiano nel bene e nel male di anime che si sono scelte. È uno volume che con tono ironico affronta la stanchezza e le insoddisfazioni ma anche le difficoltà di comunicazione tra coniugi quando il rapporto è involuto o semplicemente ha raggiunto un punto di non ritorno.
Ma è anche un componimento con un finale aperto, un finale volutamente da scrivere. Perché forse è possibile ritrovare la strada, da soli o in coppia, in separazione o in matrimonio, ma pur sempre la propria strada.
«Perché vuol dire che non si è ancora arresa?»
«Esatto. Dimostra che finché si è vivi si è aperti alle novità. Niente è definitivo. Questo mi piace.»
Indicazioni utili
Il vuoto e il desiderio del mal d'amore.
«Del resto la nonna diceva sempre che la sua vita si divideva in due parti: prima e dopo le cure termali, come se l’acqua che le aveva fatto espellere i calcoli fosse stata miracolosa in tutti i sensi.»
E lei lo sa. Lo sa che la sua vita non potrà più essere quella che è stata in passato, non potrà più essere quella del prima, del prima dell’incontro con il Reduce e la sua gamba amputata. Lei, la nonna, è qui che ha conosciuto il grande amore, è qui che per la prima volta ha sorriso dal cuore e ha sentito di essere apprezzata e amata per quel che è sempre stata e per quel che è e non anche per quel pregiudizio che da sempre la addita quale folle, quale matta per quel dolore che lacera l’anima e si ripercuote e manifesta sul corpo. Lei che è stata data in moglie a un uomo che voleva sdebitarsi per l’accoglienza ricevuta, lei che solo curando quei calcoli renali, il mal di pietre, che le impedivano di restare incinta, ha scoperto anche il mal d’amore.
Un quadernetto nero con il bordo rosso, una lettera ingiallita, luci e ombre di quegli anni così a ridosso con il Secondo conflitto mondiale in quel di Cagliari, così ancora dolorosi e bui. A narrarci di questo viaggio in continente, a narrarci di questo amore che si è perpetrato negli anni e sedimentato nel cuore, è la nipote che ricostruisce il nesso, che ricostruisce la storia con pennellate fatte di parole e ricordi. Perché alla fine, la nonna, cosa desiderava se non tanto il lasciarsi andare a quel sentimento che pulsava dentro come un richiamo spasmodico? Da qui il bisogno, l’immaginazione, il rimpianto per quell’amore non realizzato ma così cercato, la scrittura di giovani e adulte memorie su un quadernetto fatto di segreti, manchevolezze, sogni e speranze.
«Il Reduce scoppiò a piangere e si vergognava da morire perché da bambino gli avevano insegnato a non mostrare il dolore. Allora anche la nonna si mise a piangere dicendo che invece a lei avevano insegnato a non mostrare la gioia e forse avevano ragione perché l’unica cosa che le era andata bene, essersi sposata con nonno, le era stata indifferente e non aveva capito perché quei pretendenti fuggissero tutti via, ma del resto cosa ne sappiamo noi davvero degli altri, cosa ne sapeva il Reduce.»
È nella nonna che è racchiuso il perno di quella figura che mantiene l’equilibrio della famiglia e delle persone che ha al fianco anche quando il mondo sembra tirar su una barriera atta a barricare. Ed è ancora colei che ci insegna cosa sia l’amore. Sì, lei che lo ha ricercato e immaginato per tutta la vita, lei che ne ha fatto parola e confidenza, lei che si è affidata alla magia e alla non regola per coglierne ogni sfumatura.
«Perché in fondo, forse, nell’amore, alla fine bisogna affidarsi alla magia, perché non è che riesci a vedere una regola, qualcosa da seguire per far andare le cose bene.»
Il risultato è quello di un racconto piccolo nella sua mole, enorme nel suo contenuto. Uno scritto intriso di introspezione e riflessione, una perfetta armonia che ci invita a soffermarci su quel mal d’amore ma anche su quell’amore al contrario forse avuto accanto ma mai riconosciuto. Ed ecco che ancora la parola scritta torna ad avere il suo senso, torna a curare, torna a solleticare cuore, mente e animo. Con delicatezza, con pacatezza eppure con grande incisività.
«Non smetta di immaginare. Non è matta. Mai più creda a chi le dice questa cosa ingiusta e malvagia. Scriva.»
Indicazioni utili
Padri e figli, il legame infinito spezzato
«Portare i fiori sopra la tomba di un figlio è contro natura. Piangere sulla tomba di un figlio è contro natura. Vivere al posto di un figlio è anche peggio.»
Se c’è una cosa che un genitore mai si augura e mai è pronto ad affrontare è il sopravvivere a quel figlio che è stato messo al mondo e che, per circostanze spesso imprevedibili o nefaste, è venuto a mancare. Ed è proprio questa la circostanza dalla quale prende avvio “Gli ultimi giorni di quiete”, opera che ci propone un Antonio Manzini diverso da quello che abbiamo conosciuto con la serie dedicata ad Antonio Schiavone e sicuramente invece più vicino, per tematica e sensibilizzazione, a quello che abbiamo incontrato in “Orfani bianchi”. E cosa, ancora, ci chiede tra le righe l’autore, proviamo quando non solo nostro figlio è morto, presuntivamente ha avuto giustizia ed eppure dopo pochi anni quel reo, quel colpevole che si è macchiato di quel sangue e si è reso artefice di quella dipartita prematura e inaspettata, ha nuovamente ottenuto la sua libertà mentre la vittima ha pagato con una pena più cara di un ergastolo?
Un viaggio in treno, una donna, una madre ferita che sopravvive perché deve, lo vede, quell’uomo. Lo ha davanti in quel viaggio, lo segue quando scende, lo riconosce senza ombra di dubbio. La confessione a quel marito che sembra pronto a tutto pur di mettere la parola fine su quel dolore radicato nel cuore e su quell’ingiustizia e infine quel colpevole che negli anni si è ricostruito una vita alla quale non vuole rinunciare.
Tre voci, tre prospettive, tre diversi dolori per tre diversi punti di vista. Manzini ha il grande merito di riuscire a trattare un tema di grande attualità con una analisi che tocca ogni voce e che abbraccia ogni aspetto e sfumatura del tema trattato. E vi riesce senza mezzi termini e senza nulla risparmiare al lettore che, pagina dopo pagina, è chiamato a riflettere e a interrogarsi sulle questioni introdotte ma senza mai cadere nello scontato nel patetico, bensì toccando le corde più intime del conoscitore.
Non c’è altro da dire, c’è solo da leggere. Un titolo che arriva e che raggiunge il suo obiettivo.
«Nicò, una ferita per riaprirsi prima deve richiudersi.»
Indicazioni utili
Un thriller di grande attualità
«Il tempo ha la capacità di assottigliare il dolore, rendendolo trasparente. Un po’ alla volta si impara ad accettare i cambiamenti e si capisce che la vita continua anche se non più come la si desiderava.»
Il suo nome è Jenny Lind ed è una studentessa bella e diversa, una studentessa con una inclinazione artistica che la porta ad approfondire l’arte del fotografare e a custodire una innata passione per la lettura. Come tutti i giovani vive nel suo mondo e nella sua realtà fatta di piccole quotidianità, quotidianità che vengono spezzate, recise di netto un giorno come un altro mentre sta tornando a casa da scuola. Perché Jenny non farà mai ritorno a casa, di lei si perderà ogni traccia, di lei si saprà, solo che è stata caricata di forza sopra a un furgone da un uomo molto violento, nulla più.
Al contempo, Martin e Pamela stanno per vivere l’evento più nefasto della loro vita, stanno per perdere la figlia di lei, Alice. Dopo questo tragico avvenimento le loro esistenze si sfalderanno e se Pamela troppo spesso troverà conforto nell’alcol, Martin dovrà fronteggiare i fantasmi della mente e quel terrore dettato dal senso di responsabilità per la morte della ragazza.
Sono ormai trascorsi cinque anni dalle vicende che riguardano la liceale rapita e il lutto della famiglia per la perdita di Alice che il corpo di Jenny Lind viene rinvenuto privo di vita in un parco: è chiaro sin dal principio che si tratta di una esecuzione in piena regola atta, forse, a essere una dimostrazione o chissà anche un avvertimento. Ma una dimostrazione per chi? Un avvertimento rivolto a chi? E se invece fosse stato anche un modo per punire Jenny stessa e far da esempio a qualcun altro?
Joona Linna fa di tutto per essere investito del caso, ha capito che dietro la morte della liceale vi è ben altro oltre che alle apparenze ma soprattutto, ha individuato un collegamento tra presente e passato, un collegamento che potrebbe far supporre della presenza di un omicida seriale, di un serial killer che ha già agito nel tempo trascorso e che potrebbe tornare nuovamente ad agire. Va fermato e lui non può sottrarsi al suo dovere di agente del reparto operativo nazionale.
«Aron non ascolta con attenzione, non capisce che le parole sono solo una parte di quel che viene detto.»
È da questi brevi assunti che ha inizio l’ultimo titolo a firma Lars Kepler, opera che premetto può essere letta anche a prescindere dalla conoscenza dei precedenti capitoli della saga e ciò perché il duo di coniugi non manca di colmare quelle lacune che potrebbero sorgere nel lettore novizio alla serie.
Fin dai primi capitoli l’avventuriero viene catapultato in un enigma costruito su una perfetta sequenza di incastri che battuta dopo battuta sono intrisi di suspense e scene che non mancano di toccare le corde più intime del suo animo. Sia i personaggi principali che quelli più marginali vengono delineati con cura, dotati di una loro ragion d’essere, instradati in quella che sarà la loro funzione narrativa. L’arcano viene ricostruito tassello dopo tassello, il mistero è tale che incuriosisce nella lettura in un costante crescendo che non subisce sbavature e che tiene avvinta in una solida morsa la curiosità del conoscitore. Gli scrittori prendono per mano il loro pubblico e con linearità e logicità conducono a quello che è un epilogo che offre le risposte sperate e non delude le aspettative. Il ritmo è sempre rapido e costante nel proseguire, alcuni possibili cliché vengono altrettanto rapidamente disattesi dal proseguire dell’avventura e con l’evolversi della storia.
«Joona pensa a quel che ha scritto il filosofo Michel Foucault, che la verità non fa parte dell’ordine del potere, ma è imparentata con la verità.»
Ma la vera maestria del duo di romanzieri è quella di essere riusciti a costruire un thriller solido e succulento per appassionati del genere e non, un titolo che tratta di tematiche attuali e forti. Non stupisce, infatti, ed è anzi altamente plausibile che il loro modus operandi, come recentemente avvalorato anche in una sostanziosa recensione al titolo a firma Fabiano Massimi su “Il libraio” della quale vi invito alla lettura laddove siate curiosi di conoscere di un’altra impressione più tecnica, metrica ed esaustiva dell’opera, che i medesimi abbiano costruito il romanzo attorno alla problematica di cui anteriormente avevano deciso di trattare.
In queste pagine non solo vi ritroverete di fronte a un titolo con una componente psicologica fortissima e dalla componente thrilleristica ineccepibile ma vi troverete di fronte a uno scritto che parla di donne, che parla di donne scomparse nel nulla, che parla di violenza domestica, violenza psicologica e fisica, violenza sessuale, che parla di legami spezzati, che parla di malattia nel corpo e nella mente, che parla di famiglia, che parla di attualità. Perché il genere del thriller è sì un’opera di intrattenimento ma è anche un potente luogo di riflessione sui rapporti umani e sul nostro presente.
Indicazioni utili
Bo bo
«Esistono diverse ragioni per tacere, ho imparato da U Ba. Una può essere la paura. O la vergogna. L’ignoranza. La vigliaccheria. A volte si vuole punire l’interlocutore. Esiste anche la felicità che ti lascia senza parole. La gioia silenziosa.»
Il giovane Bo bo è un bambino curioso, amante della lingua inglese e che nella sua classe di studio è costretto a fronteggiare insegnanti che non conoscono la materia di cui sono titolari e che spesso lo puniscono per le correzioni che il dodicenne non è in grado di trattenere. Siamo in Birmania e il piccolo adolescente vive con lo zio U Ba, uomo che ha fatto della restaurazione dei libri la sua arte, uomo che lo ha istruito alla conoscenza. Una volta l’anno l’ometto riceve la visita di Thar Thar, suo padre nonché marito di Julia, la protagonista che abbiamo conosciuto in “L’arte di ascoltare i battiti del cuore”, seguito da “Gli accordi del cuore”.
Bo bo ha un dono particolare: riesce a comprendere le emozioni delle persone e da questo evince il loro stato d’animo, evince se mentono o sono sincere o se al contrario nascondono qualcosa. Al suo dono ci sono però delle eccezioni. Radicato è il gran desiderio di conoscenza di un passato sfuggente e di un legame con i suoi genitori venuto meno per ragioni inspiegabili. Della stessa madre, Julia Win, ha solo il vago ricordo di un sorriso e la percezione di una malattia. Arriverà il momento in cui però il bisogno di sapere avrà la maggiore e U Ba non potrà sottrarsi al rivelare al nipote quanto accaduto in quello che sarà un racconto nel racconto e che ci porterà, ancora una volta, ad assaporare una storia che si dipana tra Stati Uniti e Oriente.
«E chi una volta è stato amato e ha perso questo amore non porta in sé solo questo amore, ma anche la paura di perderlo di nuovo.»
Anche questa volta Philipp K. Sendker destina il lettore di un romanzo che sa destare l’interesse e toccarne le corde più intime. La voce narrante è quella di un protagonista puro, cristallino e che per questo conquista senza troppe difficoltà e incuriosisce. La figura, ancora, dello zio, è il perno centrale tanto che se chi legge è attratto dal dono o dalla personalità e dalla giusta e naturale volontà di conoscere la verità del ragazzo, dall’altro è affascinato e trattenuto in una spirale magnetica detenuta da questo uomo adulto che cela nel silenzio e nel cuore un grande dolore e una storia che non sa come raccontare, una storia che ancor più teme di raccontare.
Tuttavia, questa volta, la narrazione è più lenta. Troppo lenta. Lo stile narrativo è sempre curato e minuzioso, i dialoghi calzanti ma il ritmo per tutto il primo terzo del libro (98 pagine su 313) non decolla. Si ruota sempre attorno a questo mistero celato, a questa quotidianità in cui il duo vive ma senza riuscire ad approfondire ulteriormente, nemmeno in occasione della visita del padre e del palesarsi dei primi segnali un po’ più concreti della malattia di Julia. A seguito della seconda sezione il ritmo accelera, si scuote e con esso la vicenda riprende di quell’interesse che era venuto scemando in quel primo terzo e conduce a quello che sarà l’epilogo dell’opera che soddisfa in buona dose l’appetito del lettore.
In conclusione, “La memoria del cuore” è un titolo piacevole ma non indimenticabile, una degna conclusione delle vicende ma eccede un po’ troppo nella prolissità e in una storia che arriva con scoppio ritardato e con qualche ostacolo nella lettura disseminato. Non mancano tante belle citazioni, non mancano le tante parole con le quali Sendker arriva immancabilmente al suo pubblico (anche troppe, a voler essere sinceri, tanto da rischiare di rasentare la “frase fatta”). Nel complesso è un volume necessario alla conclusione degli eventi ma che lascia quel retrogusto di non completa soddisfazione.
«Dopo aveva dovuto imparare che l’amore non conosce giustizia. Obbedisce alle proprie leggi.»
Indicazioni utili
Il mostro di carta
«E perché non dovrebbe? Sono arrivato tanto lontano, tracciando una via sicura attraverso mari ignoti; le stelle stesse sono state testimoni e spettatrici del mio trionfo. Perché, allora, non procedere oltre sull’elemento indomito ma obbediente? Che cosa potrà mai fermare il cuore risoluto e la volontà ferma dell’uomo?»
Chi non conosce anche solo per fama la storia del Dottor Frankenstein, celebre personaggio nato dalla penna di Mary Shelley quasi per gioco avendo questo preso forma in occasione di una competizione letteraria tra amici nel 1816 per ingannare il tempo inclemente? Pubblicato prima anonimamente nel 1818 con una prefazione del marito e una dedica al padre e di poi nel 1823 in Francia con firma dell’autrice, l’opera è ben presto diventata uno dei titoli più acclamati a suo nome nonché un classico intramontabile.
Quello costruito dalla narratrice è un romanzo che si incentra sulla superbia umana che senza troppe remore si ribella alle leggi stesse della natura e ai vincoli dalla medesima imposti. Appassionato sin dalla giovane età di scienza e di filosofia naturale, il nostro eroe vuol svelare al mondo i misteri della creazione. Resta affascinato, in particolare, da quello studioso che proprio in età adolescenziale inizia a studiare con maniacale ossessione e di cui nel tempo, poi, scoprirà essere in verità fallaci gli esperimenti e le teorie. A compimento di tutto questo percorso, che si estende pure all’applicazione di macabre cuciture sui cadaveri, vi è la creazione del Mostro. Quest’ultimo imparerà a vivere per riflesso dopo essere stato cacciato per il suo aspetto e per il ribrezzo generato dal suo semplice esistere.
Imparerà osservando una famiglia a parlare, a vivere come un essere umano e sì, anche ad amare. Lui che è il più solo, lui che vive a stretto contatto con quella che è la sofferenza determinata dalla sua condizione di individuo reietto dalla società, proverà la forza di questo sentimento.
A una trama ben articolata si affianca una struttura narrativa che emerge per il suo pregio stilistico. La storia è un crescendo, le vicende partono da una serie di missive che il capitano Robert Walton destina alla sorella e che ci permettono di delineare i primi tratti salienti dell’elaborato e si spostano passo dopo passo verso quello che è il fulcro dello scritto e il conseguente e casuale incontro con Frankenstein.
Tuttavia, nonostante gli intenti e il contenuto con un messaggio sotteso, il componimento – per me rilettura dopo gli anni di studio – pecca di una serie di rallentamenti che tendono a sfiancare il conoscitore e che intaccano la piacevolezza della lettura che risulta essere purtroppo poco avvincente.
“Frankenstein” resta indiscutibilmente un volume necessario alla formazione di ogni lettore e resta indubbiamente un elaborato con una sua riflessione forte, attuale e con tematiche coraggiose per l'epoca in cui fu creato e ancora oggi di grande interesse ma inevitabilmente risente del tempo trascorso e può deludere le aspettative del lettore che vi si avvicina con troppe pretese date dalla immancabile e conclamata fama. Soprattutto se in prima lettura.
«Un uomo come lui vive due vite: soffre nella disgrazia ed è sopraffatto dalle delusioni, eppure, una volta rinchiuso in se stesso, si trasforma in uno spirito celeste, circonfuso di un alone nel cui cerchio né dolore né follia osano entrare.»
| 1516 risultati - visualizzati 401 - 450 | « 1 ... 6 7 8 9 10 11 ... 12 31 » |