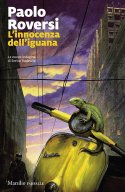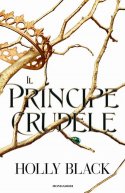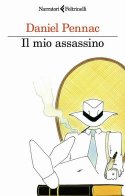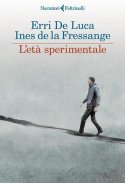Opinione scritta da Renzo Montagnoli
| 1070 risultati - visualizzati 301 - 350 | « 1 ... 4 5 6 7 8 9 ... 10 22 » |
Il consolidamento del fascismo
La catena completa in modo impeccabile la trilogia con cui Emilio Lussu dapprima ha parlato con Un anno sull’altipiano della Grande Guerra, conflitto dal forte impulso nazionalistico e quindi, in un certo senso, propedeutico del fascismo, quindi dell’avvento dello stesso con Marcia su Roma e dintorni e infine del consolidamento della dittatura proprio con l’opera di cui mi accingo a scrivere.
In ogni caso si tratta sempre di esperienze dirette, di vita vissuta, ma mentre il romanzo che si svolge sull’altopiano di Asiago e che è senz’altro uno dei libri di più forte impatto nel denunciare l’insensatezza e l’inutilità della guerra lascia più spazio alla creatività, i due successivi finiscono con il diventare la disamina storica di un periodo che si concluderà, dopo tanti lutti e tragedie, nel 1945.
Mussolini, raggiunto il potere, avverte la necessità di consolidarlo, diventando il padrone assoluto e, come in tutti i regimi totalitari, instaurando il principio secondo il quale o si è con il dittatore, o si è un nemico, da isolare, da rendere inoffensivo tanto da annientarlo. E’ di questa fase che parla Emilo Lussu con La catena e che va dall’assalto alla casa dello scrittore di un centinaio di fascisti, a cui lui cercherà di opporsi uccidendone uno, al successivo processo, all’assoluzione combattuta e grazie a giudici onesti, ai provvedimenti del Tribunale Speciale grazie ai quali fu confinato a Lipari, da cui, insieme a Carlo Rosselli e Francesco Nitti riuscì a riparare in Francia con una rocambolesca fuga, che ebbe grande rilievo internazionale e che fu uno smacco per il regime.
Le azioni poste in essere da Mussolini per consolidare la sua posizione, come per esempio alcuni attentati alla sua persona armati dalla sua stessa mano, le nuove leggi che di fatto impedivano qualsiasi opposizione, il funzionamento dei Tribunali Speciali, la difficile esistenza dei confinati, dei loro familiari e dei loro amici danno vita a un quadro talmente orrendo che è lecito chiedersi come oggi ci sia ancora gente che crede nella bontà del fascismo (come del resto, in contrapposizione, ci sono quelli che ancora sognano un ritorno al comunismo staliniano). Il tutto è raccontato in modo notevolmente efficace, perché si è trattato di esperienza diretta e l’atmosfera fosca, cupa che aleggia in quelle pagine e che può intimorire oltre misura il lettore è saggiamente stemperata da una sempre presente ironia, anche se amara.
Senza retorica, senza esaltazione dei propri meriti, Lussu ci ha lasciato una testimonianza indispensabile per comprendere tante cose, anche per capire come per circa un ventennio una intera nazionale, fra partecipazione e più spesso indifferenza, si sia lasciata abbindolare da un uomo che voleva essere il padrone del mondo , ma che era senza qualità e che dal trono su cui si era issato finì appeso per i piedi alle strutture di un distributore di benzina a Milano.
Da leggere, quindi, e magari da inserire nei programmi scolastici.
Indicazioni utili
Un racconto vale tutto il libro
Di Isabella Bossi Fedrigotti mi sono sempre piaciuti lo stile della scrittura, lineare, scorrevole, mai greve, e l’oggetto delle sue opere, che affonda sempre nella memoria della sua famiglia e di quell’ambiente, montanaro e agricolo al tempo stesso, tanto da costituire un piacevole ritorno alla natura e a cose vecchie, ma che suscitano interesse.. Negli ultimi anni, però, o per una precisa scelta, o perché l’autore non riesce a trovare in epoche passate materiale da costituire una valida trama per un romanzo, Isabella Bossi Fedrigotti ha provato a scrivere d’altre cose, più attuali e meno frutto di esperienze dirette. Ed è questo il caso di I vestiti delle donne, quattro racconti con un titolo che è un po’ fuorviante, visto che di abiti si parla solo nel primo (organza arancione). Devo purtroppo dire che i primi tre, benché ben scritti e anche piacevoli da leggere, mi hanno un po’ deluso, perché ho riscontrato una certa banalità che non è propria dell’autore. Donne sull’orlo di una crisi di nervi, donne sole che non sanno come trascorrere il Natale e anche un uomo, di una certa età, scapolo – ma che si atteggia a macho – che spia la vicina forse disponibile, ma che potrebbe rivelarsi una fin troppo facile conquista sono i personaggi che animano i primi tre racconti, di cui, se non è possibile definirsi soddisfatti, però nemmeno stizziti, insomma si lasciano leggere, senza che rimanga dentro qualcosa. La raccolta è salvata come qualità dall’ultimo (Giù in strada) che, guarda caso, pesca ad ampie mani nella memoria, con i ricordi di una Isabella bambina, a cui non è permesso uscire di casa, e che pertanto è costretta ad ascoltare i rumori della strada, a guardare dalla finestra, e così scopriamo un mondo che non è poi così vecchio, ma che oggi appare antico: le donne che a maggio vanno al rosario, i carri, con i frutti della vendemmia, che trainati dai buoi s’avviano alla cantina, un quadro quasi bucolico che stride con l’epoca attuale, dove lungo la via corrono le auto così veloci che spesso non si riesce a coglierne neppure il colore. Questo racconto è una piccola sinfonia, un lento adagio in cui immagini e sensazioni sono espresse in modo più che convincente, con quell’abilità che ho potuto apprezzare nelle sue opere migliori ( Magazzino vita, Il primo figlio, Casa di guerra, Di buona famiglia, Amore mio uccidi Garibaldi).
Da leggere, pertanto.
Indicazioni utili
Un mondo parallelo
La realtà è ciò che vediamo o esiste un altro mondo, parallelo al nostro, di cui non sappiamo nulla? Come fare per verificare se la seconda ipotesi non è una pura invenzione? A questo provvede il Dr. Raymond con un intervento chirurgico che, modificando la struttura del cranio di una giovane volontaria, innesta un terzo occhio al fine di poter vedere questo mondo nascosto. L’intervento riesce e la ragazza resta scioccata, terrorizzata per quello che ha visto. Questo si potrebbe definire l’antefatto, ma il romanzo fornisce uno sviluppo della trama, teso a trasmettere al lettore quel fremito misto di paura e di curiosità che è proprio del genere horror che non è certo fra i miei preferiti. Tuttavia, di fronte a qualcosa che non ha solo lo scopo di stupire, ma di rintracciare in noi quella perversità che è propria della bestia ho continuato a leggere, ammetto con un certo piacere.
Senza descrivere altro della vicenda, a tutto beneficio del lettore, ritengo opportuno fare alcune considerazioni..
Siamo nell’epoca del famoso Dr. Jekyll e Mr Hyde e non è un caso se nell’Inghilterra vittoriana sorgono simili opere, volte anche a smascherare quell’aspetto di puritanesimo degli anni della Regina Vittoria. Non c’è di peggio, infatti, che nascondere o non far vedere, per incuriosire chi osserva, per fargli pensare che il mondo non è così, ma che dietro le convenzioni c’è ben altro e magari qualcosa di violento ed estremamente trasgressivo. Il Dio Pan – così il Dr. Raymond chiama questa realtà parallela – era una divinità pagana con tendenze orgiastiche che non mancano nel libro di Machen e che suscitarono all’epoca grande scandalo. Peraltro, l’aspetto trascendente dell’opera è riscontrabile anche nel concetto che il nostro mondo è solo illusione e che la verità autentica va ben oltre, in un orrore cosmico che vede presenti divinità naturali, esistenti ancor prima che comparisse l’uomo, divinità di cui Pan è l’ambasciatore, il messaggero o il rappresentante supremo, comunque vogliamo chiamarlo, perché ha dentro di sé il significato di ogni cosa, ogni istinto umano, l’anima e il respiro della natura. È una visione ben contrapposta a quello del Dio della nostra religione, nel senso anche che a certe condizioni è tangibile, come accade con l’esperimento del terzo occhio. E questa compenetrazione in lui di istinti umani e di essenza della natura ne fa un essere a cui inconsciamente somigliamo, soprattutto quando diamo libero sfogo a pulsioni soffocate da quel mondo di parvenza che ci siamo costruiti.
Non è un romanzo per tutti, nel senso che dobbiamo, per leggerlo, aprire un terzo occhio virtuale guardando dentro di noi, andando a cogliere quanto più di nascosto e di innominabile celiamo. Così come il mistico si abbandona al crescente pulsare della fede, per vedere il nostro Dio Pan dobbiamo dimenticare dove siamo e quel che siamo; é ovvio che non è strettamente necessario un simile esercizio per leggere il libro, ma è indispensabile per trarne i frutti una volta terminato.
Poi ognuno può apprezzare lo sviluppo della vicenda, appagarsi anche con le scene orgiastiche, ma questo non era il fine di Machen che voleva invece che ognuno potesse vedere il suo Dio Pan.
Il romanzo è di per sé abbastanza breve, ma nell’edizione in mio possesso (Tre Editori, Roma, 2016) c’è una corposa seconda parte intitolata Appunti su alcune fonti di Arthur Machen, curata da Alessandro Zabini, di grande aiuto per la comprensione dell’opera, così come propedeutici alla stessa ed egualmente utili sono la prefazione dell’autore e un breve articolo (Arthur Machen e la paura cosmica) scritto da Howard Phillips Lovecraft. Ma non è finita, perche questa edizione è di notevole completezza, ricomprendendo un ragguardevole saggio (Il risveglio della selva) di Susan Johnston Graf e una breve, ma completa antologia panica, in cui sono presenti altri saggi, prose e poesie di diversi autori, ma tutti nomi noti, perché si va da Plutarco a Pessoa, a Pascoli, tanto per citarne alcuni. È quindi evidente che l’argomento ha sempre interessato, dall’antichità a oggi, e del resto Pan c’è sempre stato e sempre ci sarà.
Da leggere, senza dubbio.
Indicazioni utili
Missione spaziale ottocentesca
È stata una lettura giovanile, forse uno dei primi romanzi che ho divorato nrl periodo delle scuole medie inferiori, ma rammento ancora come ne fui favorevolmente impressionato e come con la mia fantasia anch’io, pagina dopo pagina, fui partecipe di questa straordinaria avventura.
Oggi che la Luna non è più un mistero, che gli uomini vi hanno già messo piede con ben altri mezzi e non certo con una sorta di proiettile sparato da un gigantesco cannone, se mi metto un po’ a riflettere giungo alla conclusione che spazio per sognare da un po’ di tempo ne è rimasto ben poco.
La spedizione raccontata nel libro ha quasi il sapore di una favola, così lontana da diverse leggi della fisica e dalla ferrea razionalità che è propria del mondo attuale.
Ricordo che fui rapito da questa ingegnosa costruzione, benché già fossero stati lanciati nello spazio dei satelliti, quello con la famosa cagnetta Laika e quello con Gagarin. Il lancio del proiettile non permise agli astronauti di Verne di mettere piede sul nostro satellite e anzi si risolse quasi in una tragedia, poiché la particolare navicella, entrata nell’orbita lunare, comincio a girare intorno e solo grazie all’ingegno umano si poterono salvare e far ritorno sul nostro pianeta.
Oggi viene da sorridere per le soluzioni escogitate dal grande scrittore francese, ma non erano del tutto prive di fondamento e, per le conoscenze dell’epoca, erano le uniche possibili. Peraltro, occorre riconoscere a Jules Verne, oltre a una spiccata creatività, anche una genialità che è possibile riscontrare in altre sue opere, come, per esempio, Ventimila leghe sotto i mari. Possiamo in sostanza dire che per certi aspetti precorse i nostri tempi, così tecnologici, ed è questo un merito che non ne fa un autore visionario, ma una mente che sapeva vedere nel futuro.
Per quanto ho evidenziato il libro è più che meritevole di essere letto e non solo dai bambini, ma anche dagli adulti, per tornare un po’ a sognare, per andare a ritroso fino a un tempo in cui, con la fantasia e solo con quella, tutto era possibile.
Indicazioni utili
Morire per amore
La vita di Claretta Petacci non avrebbe avuto risalto storico se non avesse condiviso la tragica fine con Benito Mussolini, l’uomo di cui era innamorata; infatti lei sarebbe stata solo una delle tante amanti del duce, ma quell’averlo seguito nella sua disperata fuga verso la Svizzera, quando avrebbe potuto mettersi in salvo con la famiglia in Spagna e pur consapevole dei gravi rischi a cui sarebbe andata incontro seguendo il suo uomo, la pongono in una luce diversa, in quella di una innamorata a tal punto da non abbandonare nel momento del più grave pericolo la persona che ama. Se l’esecuzione di Benito Mussolini ha un fondamento (già il CLN ne aveva decretato la messa a morte) quella di Claretta non sembra trovare una concreta spiegazione e forse è il caso di dire che pure lei è stata uccisa, perché si è trovata nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Poi, il suo corpo fu appeso a un distributore a Milano in piazzale Loreto, insieme con quello del suo Ben (così chiamava affettuosamente Mussolini) per poi essere addirittura sepolto sotto falso nome nel Cimitero Maggiore sempre di Milano. Ci vollero poi diversi anni perché il governo italiano autorizzasse la traslazione della salma a Roma nella tomba di famiglia sita al Verano.
Ma chi era veramente Claretta Petacci? Chi era mai questa donna che si innamorò di un uomo che avrebbe potuto essere suo padre? Alla risposta, necessariamente incompleta, ma comunque assai prossima alla verità risponde Roberto Gervaso con quella coscienziosità che gli è propria, quella professionalità di storico teso, per quanto possibile, ad avvicinarsi almeno a quella che fu la realtà. Il lavoro non deve essere stato facile, perché Claretta è un personaggio del più puro romanticismo: sposata, conosce il duce e si innamora, si divide dal marito e starà a lungo e nell’ombra accanto a Mussolini, ben sapendo che lui non chiederà mai la separazione alla moglie Rachele e che le infedeltà continuerano, perché sono uno dei vizi di un uomo di bocca buona in fatto di donne, che vanno dalle prostitute alle attrici. Infatuazione, si potrebbe definire forse, nel senso che lei ama più il duce che l’uomo Mussolini e così forse anche si spiegherebbe perché non tentò di salvarsi. Resta il farro, che lungi dal farla passare per un eroina, è una donna che merita rispetto ed è la stessa opinione di Gervaso, questa volta meno disponibile all’ironia, ma più animato nello stendere questa biografia da un autentico senso di pietà.
Mi pare superfluo aggiungere che la lettura è indubbiamente consigliata.
Indicazioni utili
Deludente
La Grancontessa Matilde di Canossa (Mantova, marzo 1046 – Bondeno di Roncore, 24 luglio 1115) è stata indubbiamente un personaggio di rilievo nella sua epoca e per certi versi sorprendente, a maggior ragione in un periodo storico che vedeva le donne relegate a semplici custodi del focolare domestico. Seguace dell’abate di Cluny che si batteva per un rinnovamento della chiesa, che in pratica era un ritorno alle origini, quando l’ideale cristiano era scevro da influenze esterne e si cercava di seguire il pensiero del Cristo in tutto e per tutto, era quindi avversa alla dilagante corruzione vigente in larga parte del clero e soprattutto era fermamente intenzionata a eliminare il diritto dell’imperatore di nominare vescovi e papi. In questo contesto è più conosciuta per aver sanato il dissidio fra il Pontefice Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, di cui era vassalla e che sospettava fosse il mandante dell’omicidio del padre, quest’ultimo tanto potente da costituire un problema per le sorti dell’impero. Enrico IV, che era stato colpito dalla scomunica, nel gennaio del 1077 rimase tre giorni e tre notti inginocchiato, con il capo cosparso di cenere, davanti al castello di Canossa, dove, ospite di Matilde, stava appunto il papa. Alla fine fu ricevuto e a capo chino, dopo un lungo faccia a faccia, Gregorio VII revocò la scomunica, ma non la decadenza dal trono. Da qui il famoso detto andare a Canossa, cioè sottomettersi all’altrui volontà. Con una donna così protagonista del suo tempo (fra l’altro donò tutti i suoi ampi possedimenti al pontefice, in chiaro dispregio dell’autorità imperiale) ci sarebbe stato da aspettarsi da Edgarda Ferri una grande biografia, una di quelle memorabili, e invece purtroppo è uscito dalla penna dell’autore un polpettone insipido, che presenta contemporaneamente le caratteristiche del saggio e del romanzo storico, ma non ben amalgamate, senza gli approfondimenti che sarebbero stati necessari e con largo sfoggio di creatività a volte quasi pedante. È facile perdersi nella lettura, frastornati da descrizioni di abbigliamenti, da episodi a volte di trascurabile interesse, tanto che alla fine non si riesce ad aver chiara l’idea di chi sia stata veramente Matilde di Canossa. L’impressione che ho ricavato è che Edgarda Ferri abbia avuto la presunzione di essere una storica competente senza in effetti esserlo: troppe le invenzioni e il sentito dire. Se avesse avuto la pretesa di scrivere solo un romanzo storico, forse poteva andare bene, a parte la lentezza del ritmo e la pesantezza dell’esposizione. La storia è un’altra cosa, non si improvvisa, è frutto di anni di ricerche e della consapevolezza che si cerca di avvicinarsi a una verità, senza mai poterla raggiungere. Sono caratteristiche assenti in questa biografia, tanto che io, avido di sapere cose nuove, mi sono ritrovato alla fine con un pugno di mosche in mano e anche indispettito per aver dedicato tanto tempo a un lavoro che non lo meritava.
Il libro quindi non mi è piaciuto e non mi sento di consigliarlo, rimandando tuttavia un giudizio sull’autore alla lettura di altre sue biografie, atteso che le sue due opere che avevo letto in precedenza (Guanti bianchi e La casa di Barbara) mi avevano favorevolmente impressionato e nella speranza che nel percorso letterario della Ferri La Grancontessa sia solo un risultato negativo del tutto occasionale.
Indicazioni utili
Analogie storiche
"Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo interno, ma forte di un'amministrazione stabile e di un'economia integrata; all'esterno, popoli costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che sempre più spesso chiedono di entrare; una frontiera militarizzata per filtrare profughi e immigrati; e autorità di governo che debbono decidere volta per volta il comportamento da tenere verso queste emergenze, con una gamma di opzioni che va dall'allontanamento forzato all'accoglienza in massa, dalla fissazione di quote d'ingresso all'offerta di aiuti umanitari e posti di lavoro. Potrebbe sembrare una descrizione del nostro mondo, e invece è la situazione in cui si trovò per secoli l'impero romano di fronte ai barbari."
Inizia così questo interessante saggio storico e subito ci si accorge di una straordinaria analogia con l’epoca attuale, caratterizzata da flussi migratori che ogni giorno che passa paiono sempre di più incontrollabili. Il motivo per cui l’Europa non riesce a contrastare queste masse di fuggiaschi è in pratica lo stesso che è andato a cercare Barbero per lo stesso fenomeno, non certo di ieri, ma di parecchi secoli fa- L’impero romano, giunto alla sua massima espansione, non aveva in animo di continuare le conquiste con nuove guerre, ma nuove guerre vittoriose significavano schiavi, cioè mano d’opera a basso costo; in uno stato come quello, pur in presenza di forti disuguaglianze sociali, nessuno moriva di fame, grazie proprio all’opera degli schiavi. Togliete gli schiavi e i campi non daranno più messi, dalle miniere non verranno estratti più minerali, oppure, in alternativa, sarebbe stato necessario remunerare adeguatamente i “liberi” che avessero voluto diventare salariati e operai. E allora perché non approfittare delle condizioni di estrema necessitò di popoli che fuggivano la fame o le guerre? Aggiungo che essendo questi immigrati non schiavi potevano andare a ingrossare le legioni che servivano sempre più numerose per difendere i confini da nemici vecchi, ma soprattutto nuovi;le reclute, così assoldate, erano simili a truppe mercenarie, sulla cui fedeltà non c’era poi da far tanto conto.
Non è quindi un caso se i nostri politici dicono che gli immigrati sono una ricchezza, che la nostra agricoltura e industria ne hanno estremo bisogno. Solo che un flusso incontrollato e crescente finisce con il rompere equilibri che parevano consolidati, per minare strutture che sembravano non scalfibili.
Anche allora ci furono, senza essere risolti, i problemi di integrazione che ci sono adesso, insomma è il caso di dire che all’origine di tutto c’è sempre il dio denaro, a cui si piega qualsiasi volontà, senza tener conto del dopo, perché c’è sempre un dopo e questo può essere peggiore, assai peggiore, della soluzione dell’originario problema. L’impero romano si sfaldò e si precipitò in un oscuro medioevo; speriamo che il ricorso storico non sia simile anche nelle conclusioni.
A Barbero va dato il merito di aver affrontato il problema con la consueta correttezza e serietà, con un occhio rivolto ai giorni nostri, realizzando così un libro il cui contenuto dall’epoca imperiale romana pare proiettarsi sinistramente nel XXI secolo.
Indicazioni utili
Le guerre fasciste
Dal 3 ottobre 1935, data in cui iniziarono le operazioni militari contro l’Etiopia, al 2 maggio 1945 l’Italia fu sempre in guerra, un triste primato nella nostra storia e, quel che è peggio, non fu dovuto a un incolpevole coinvolgimento, perché si trattò di conflitti avviati da noi, con formali dichiarazioni di guerra in alcuni casi e in altri con improvvise aggressioni. I teatri operativi furono i più vari e gli esiti non sempre fortunati, per una nostra cronica deficienza di mezzi adeguati e per una perniciosa e costante impreparazione non solo sul campo, ma anche in sede progettuale. La guerra d’Etiopia, quella di Spagna, nel Mediterraneo, nei Balcani, in Africa settentrionale e in Russia furono volute da Mussolini, un uomo la cui vanità lo portò a sottovalutare gli altri e a sopravvalutare se stesso, la stessa vanità che lo indusse a costituire la Repubblica Sociale Italiana , con il risultato di avviare una sanguinosa e devastante guerra civile. Già ho scritto, in altre occasioni, che il capo del fascismo, oltre ad avere quasi nessuna qualità, era succube del suo stesso mito e, man mano che passavano gli anni, pur ridimensionando il suo ruolo, aveva un’ambizione mai soddisfatta w tale da offuscargli quel poco cervello che gli era proprio. Al riguardo basti pensare a quanto ebbe a dire orgogliosamente al suo segretario nel 1944, al ritorno da una visita in Germania all’amico e padrone Adolf Hitler:“ Una volta finita vittoriosamente questa guerra, tutta l’Italia settentrionale, fino al Po, sarà annessa al Reich. Il resto diventerà una colonia, di cui io sarò il viceré”. Da padrone del mondo a viceré, da padre ideologico di Hitler a succube dello stesso, una parabola discendente che si chiuse con la sua esecuzione. Di queste guerre, promosse esclusivamente dal duce, parla questo libro di Rochat, noto storico militare, e in effetti viene trattato proprio il loro aspetto strategico, dimostrando, senza ombra di dubbio, che lo sforzo massiccio in Etiopia e poi in Spagna depauperò il nostro esercito, rendendo di fatto impossibile, per almeno un decennio, la partecipazione ad altri conflitti, e invece Benito Mussolini, pur ben consapevole, non ne tenne conto, giocando d’azzardo, contando sulle vittorie degli alleati e su un po’ di fortuna, con conseguenze disastrose. Come il suo alter ego Hitler era convinto di essere un grande stratega e che avesse un senso la politica anche in campo militare; sbagliava e l’Italia conobbe i dolori e gli orrori della guerra. Mussolini non fu sfortunato, poiché nulla fece per preparare adeguatamente i suoi progetti di conquista, fu semplicemente un folle che ancor oggi trova un certo seguito in gente che non vuole vederlo per quello che era: incapace, feroce e pavido.
La trattazione di Rochat è molto puntuale, infarcita da innumerevoli dati sulla consistenza dei nostri mezzi e di quelli dei nostri avversari, sulla condotta delle campagne e sui loro esiti. Purtroppo questa sovrabbondanza di elementi di valutazione se da un lato si commenta da sé, dall’altro appesantisce non poco il discorso, rendendo poco gradevole la lettura. Non ho nulla da obiettare sulle capacità di Rochat, storico assai stimato, ma credo che se fosse riuscito a introdurre – e le occasioni non mancavano – qualche spunto di ironia la piacevolezza ne avrebbe beneficiato non poco. Lo stile invece è incolore, accademico, più da testo universitario che da libro di amena e istruttiva lettura.
Comunque, per chi volesse documentarsi sulle guerre italiane e di come nacquero e si svolsero il volume mi sembra di grande utilità e interesse, per cui la lettura è senz’altro consigliata.
Indicazioni utili
Un libro banale
Da un po’ di tempo non mi ritrovo con Andrea Camilleri; prima ho dovuto lamentare quel suo marcato ricorso a un siciliano italianizzato che mi ha reso ben poco comprensibile la raccolta di racconti Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigata, ora esco scontento dalla lettura di quella che un po’ impropriamente si può definite un’altra silloge di narrativa, cioè Donne. Questa volta sulla facilità di capire non esiste il problema, poiché il libro è scritto in italiano, ma quello che non mi ha soddisfatto è il contenuto. Cercherà di spiegarmi meglio: Camilleri ha fornito il ritratto di 39 donne, alcune realmente vissute e credo invece altre solo immaginate. Si va da dall’eroina dell’Orlando furioso a Giovanna d’Arco, da infatuazioni giovanili alla Desdemona dell’Otello. In tutti i casi lamento una certa banalità che non è mai stata propria dell’autore e che invece nel caso specifico è dominante. Non vorrei che valesse anche per Camilleri quanto a suo tempo accadde a Jack London, che fece a lungo la miseria, vedendosi respinti i manoscritti dagli editori e che quando finalmente incontrò il successo lamentò che gli avrebbero pubblicato qualsiasi cosa, anche la più scadente. Ora, non ho nulla da dire sugli intenti dell’opera in questione, ma sulla sua realizzazione, perché mostrare l’universo femminile non è certo facile e avrebbe pertanto meritato ben altra attenzione. Invece si ha l’impressioni di trovarsi di fronte a dei temini ben confezionati, che però di artistico hanno ben poco o addirittura nulla. Francamente, in questo profluvio di Elvire, di Nefertiti e di Ramona, invece di accelerare la lettura per scoprire piacevolmente nuove protagoniste, mi sono affrettato, in preda alla noia, per arrivare al termine.
È un peccato che questo scrittore, che ho tanto amato, si accommiati da me lasciandomi l’amaro in bocca. Vorrà dire che mi sforzerò di dimenticare queste due ultime letture, al fine di mantenere un più che positivo ricordo di tanti altri suoi libri che ho letto invece con vero piacere.
Indicazioni utili
La signora con due bande bianche sui capelli
Mi corre l’obbligo di una opportuna premessa: se avete visto, nel corso di una gita a Mantova, la famosa Camera degli sposi o Camera picta, che si trova nel Castello di San Giorgio, imponente fortezza adiacente il celebre Palazzo Ducale, oltre a rimanere stupiti per la straordinaria bellezza dell’affresco di Andrea Mantegna, forse vi sarete chiesti chi sono i personaggi ritratti e che occasione, del tutto particolare, il grande pittore aveva voluto celebrare
A queste domande risponde Edgarda Ferri con La casa di Barbara, uno strano romanzo storico che ha più della storia narrata che della prosa, per quanto, considerando alcuni aspetti, fra i quali la fluidità del racconto, la capacità di sondare interiormente i personaggi e un pizzico, ma è solo un pizzico, di creatività, tutto sommato si è indotti giustamente a pensare che non è un vero e proprio saggio.
Visto che il titolo è La casa di Barbara, la Ferri ha voluto ripercorrere, almeno fin dal momento del suo arrivo a Mantova, la vita di Barbara di Brandeburgo, nipote dell’imperatore Sigismondo, promessa in sposa quando aveva solo dieci anni, al diciannovenne Ludovico, figlio ed erede del Marchese Gianfrancesco Gonzaga. Il matrimonio fu celebrato un po’ più tardi, ma lei era ancora poco più di una bambina. Fu un matrimonio combinato come si usava fra nobili, con tanto di prezzo della sposa, che costò ai Gonzaga ben 25.000 fiorini. Eppure l’unione fra questa fanciulla non bella e che all’inizio non sapeva una parola d’italiano, e Ludovico, che pure non era certo un adone, fu uno di quelli rari in cui la coppia combinata da altri visse d’amore e d’accordo. Barbara era una donna intelligente, colta (parlava quattro lingue), tenera, ma anche decisa; lui, spesso assente per le guerre, finì con il trovare in lei quel porto sicuro a cui ritornare. Di figli non ne nacquero pochi, ma purtroppo tutti con il segno della tara ereditata dalla madre di Lodovico, Paola Malatesta. Infatti, sia i maschi che le femmine, chi più chi meno, portavano sulla schiena quella gibbosità che è più conosciuta con il nome di gobba. Se era meno difficile trovare una moglie per i figli maschi, era quasi impossibile che qualche nobile accettasse di sposare una femmina con quella protuberanza, come accadde con Dorotea, promessa a Gian Galeazzo Visconti, che però poi rifiutò decisamente di unirsi a una deforme. Dorotea per il dolore morirà giovane, gettando un’ombra di perenne mestizia sui genitori. Barbara è un personaggio straordinario, una donna che sa governare, ma che conosce la pietà e rifulge fra tutte quelle figure che sembrano messe lì apposta affinchè i visitatori le ammirino, desiderando di sapere i loro nomi e le loro vite. Le mani prodigiose e la mente fuor del comune di un pur tignoso Andrea Mantegna li hanno consegnati ai posteri, dando loro una presenza anche dopo la morte.
La capacità di narrare dell’autore ci porta a conoscerli, ad ammirarli o a coprirli di disistima, ma in ogni caso a renderci partecipi di vite che hanno brillato tanti secoli fa. Senza per forza cercare di indulgere alla commozione, la Ferri ha saputo toccare le corde giuste e, pur rigorosamente attenta ai fatti storici, è riuscita a suo modo a realizzare anche lei un dipinto, con mano ferma, ma lieve, senza ricorrere alla retorica e arrivando anche a vette sublimi.
Leggetelo, perché è imperdibile, e poi magari venite a Mantova, andate a vedere la Camera degli sposi e vi sembrerà di trovarvi di fronte ai ritratti di vecchi amici.
Indicazioni utili
La storia siamo noi
Raccontare la storia attraverso le vicende di chi, senza determinare direttamente i grandi eventi, ne è non di rado inconsapevolmente partecipe, è un sistema accattivante e che in genere è accolto favorevolmente dai lettori. Di esempi ce ne sono parecchi, da Via col vento di Margaret Mitchell a La marcia di Radetzky di Josepk Roth, da Il ponte sulla Drina di Ivo Andric a I promessi sposi, di Alessandro Manzoni, e, più recentemente, Cuore di pietra di Sebastiano Vassalli. La melodia di Vienna può essere fatta rientrare giustamente in questo filone e, per certi aspetti (periodo storico e luoghi) è paragonabile a La marcia di Radetzky. Si tratta della narrazione dell’esistenza di tre generazioni (gli Alt) in un arco di tempo cruciale per la storia d’Europa che, dopo la restaurazione ottocentesca e la cristallizzazione di quattro imperi, vede l’inarrestabile declino degli stessi, che verranno spazzati via dalla Grande guerra. Diciamolo francamente: il romanzo di Lothar ha un fascino del tutto particolare derivante dall’attività familiare di fabbricazione di pianoforti, che erano forse i migliori del mondo, e dall’ubicazione della trama, quella Vienna imperiale che si culla nell’illusione di essere perpetua, con i balli di corte sulle note del Bel Danubio blu, e che non si accorge, o non vuole accorgersi, che il mondo sta cambiando, che è percorso da fremiti di rivolta sociale e di aspirazioni irredentiste. L’impero asburgico è sì un colosso, ma che si va lentamente sgretolando, e se le crepe all’inizio sono piccole, da esse deriverà il collasso con il grande conflitto del 1914 – 1918. E queste tre generazioni saranno le testimoni e le partecipi di questo evento epocale, pur vivendo ognuna nel suo tempo che finisce però con il diventare un unico lungo periodo propedeutico alla fine. Nel corso della loro vita capiterà di tutto, dagli intrighi di corte a una relazione dell’erede al trono con una delle Alt, Henriette, rapporto che si concluderà tragicamente con il suicidio del primo, da ripetuti tradimenti a figli illegittimi che si amano molto di più di quelli legittimi, che francamente sono detestati, e infine le guerre, quelle del XIX secolo, la Grande Guerra e gli inizi di quella successiva. Come è possibile comprendere, c’è tanta carne al fuoco e quindi il rischio di bruciarla, ma l’abilità, l’equilibrio dell’autore tiene lontana l’opera da questo pericolo, anzi non rasenta neppure un momento il feuilleton, riuscendo a mantenere un apprezzabile distacco in un’armonica composizione che se avvince il lettore lo porta anche a meditare, a comprendere il perché di certi fatti, gli consente di arrivare a capire come fu possibile che la dinastia degli Asburgo, che per così tanto tempo aveva regnato, si sia pressoché di colpo dissolta. È un romanzo che riesce a essere al tempo stesso toccante e profondo, un affresco stupefacente di un’epoca che è stata e che mai più ritornerà e se si vuole darne una definizione in poche parole non trovo di meglio che il giudizio della stessa, unanimemente attribuitole: capolavoro.
Mi permetto solo di aggiungere che alla lettura piacevolissima di tutte le pagine si accompagnerà alla fine una struggente malinconia, nella consapevolezza che in fondo tutti siamo pedine della storia e che per tutti c’è un tempo che mai più ritornerà.
Indicazioni utili
Povero Arcieri!
È invecchiato il colonnello Arcieri, anzi ex colonnello, giacchè è andato in pensione, ma la sua vita è ben altro che tranquilla, in quanto c’è chi trama, proprio nei servizi segreti di cui a lungo ha fatto parte, per toglierlo di mezzo.
Un tentativo di ammazzarlo, sabotando lo sterzo della sua Alfa,. è quasi andato a buon fine, ma, nonostante il volo in un burrone e le numerose fratture, lui ne è venuto fuori, fuggendo in Francia, braccato dai sicari. È un uomo che sente il peso dell’età, che ha paura e che, nonostante l’esperienza, commette numerosi sbagli, di cui per mera fortuna non paga le conseguenze. Ritorna in Italia, stanco di scappare, per affrontare il suo anonimo nemico e, manco a dirlo, ci riesce, ma perdendo alcuni dei suoi collaboratori più fidati, uccisi per fargli intorno terra bruciata.
Il ritorno del colonnello Arcieri è una storia di Servizi deviati, di moti studenteschi (quelli del ’68), del cambiamento dello spirito di un uomo che vuole ancora cogliere il succo della vita, ma è anche un gran pastrocchio, con incongruenze, stereotipi di sessantottini, una attesa e definitiva soluzione che sta poco in piedi, un romanzo di tanti personaggi, fra i quali l’ex fidanzata Elena Contini, che appare come per miracolo all’improvviso e che pare la persona giusta per toglierlo dai guai (viene il sospetto che faccia parte del Mossad) e che poi celermente svanisce, un’autentica meteora. Pur fra alti e bassi di ritmo (il romanzo alterna appunto fasi di stanca ad altre di notevole dinamismo, quest’ultimo crescente mano a mano ci si avvicina alla fine) si lascia leggere. Nel complesso si arriva in fondo più che altro per scoprire chi sia il capo delle trame oscure e come riuscirà Arcieri a venirne fuori; però non è una lettura particolarmente gradevole, ma nemmeno sonnacchiosa, nonostante l’autore abbia cercato di addormentare il lettore con una prima parte, che si svolge a Parigi, di un centinaio di pagine, quando la metà sarebbe stata più che sufficiente, e infarcendo la narrazione di divagazioni sull’abilità culinaria di Arcieri, con descrizioni particolareggiate di ricette che non fanno altro che annoiare. In tutto sono 354 pagine e secondo me ce ne sono almeno un centinaio di troppo, ma avrei chiuso un occhio se non fossi incappato in un finale buonista, del tipo “e tutti vissero felici e contenti”. Una conclusione così non è stata la classica ciliegina sulla torta, ma un cocomero messo su un pastone mal manipolato, e questo proprio non mi è andato giù. Purtroppo sono passati, sia per l’autore che per Arcieri, i tempi in cui il colonnello era ancora capitano e nel clima del ventennio, pur muovendosi fra spie, risolveva i casi più complessi con ferrea logica, come in Il passaggio e in Nero di Maggio. In verità mi era piaciuto anche in L’angelo del fango, ambientato durante l’alluvione di Firenze, ma temo che sia stato il canto del cigno, perché, se Arcieri in pensione è un uomo con poca lucidità, tanto che vien da dire che era proprio il caso che si mettesse a riposo, anche l’autore pare un pensionato dalle idee poco chiare, visto che è riuscito, pur a fronte di uno spunto originale, a scrivere un’opera che non vale di più di un libro che, al massimo, consente di ingannare il tempo per alcune ore. Dopo non resta proprio niente, se non l’osservazione, che mi è venuta spontanea e che si traduce in poche parole: Povero Arcieri, come eri bravo quando investigavi nel ventennio. Anche per te il tempo è passato ed è venuta l’ora che tu faccia una vita esclusivamente da pensionato.
Insomma, il tempo trascorre per tutti, anche per Bruno Arcieri.
Indicazioni utili
L’arte di ricordare
Piero Chiara è stato un narratore di eccelsa qualità, capace di portare alla luce, nei suoi difetti, ma anche nelle sue qualità, quel piccolo mondo dei paesi di una provincia di cui, con il tempo, si sarebbe persa sicuramente la memoria. Grazie a lui abbiamo potuto conoscere una galleria di personaggi indimenticabili (il tombeur de femmes Emerenziano Paronzini di La spartizione, il cornificatore Augusto Vanghetta di Il pretore di Cuvio, lo straordinario Anselmo Bordigoni di Il balordo e il Camola e il Tolini di Il piatto piange, solo per citare i più famosi). Si tratta di prose lunghe, cioè di romanzi, ma Chiara eccelleva anche con i racconti, la cui raccolta più famosa è forse L’uovo al cianuro. L’autore ha una straordinaria abilità affabulatrice, tanto che nel leggere si ha l’impressione di averlo davanti mentre lui ci racconta, dote che doveva avere anche suo padre quando la sera riuniva la famiglia e iniziava a narrare con queste parole: Ora ti conto un fatto. E Ora ti conto un fatto è appunto il titolo di questa raccolta di prose brevi, che presenta alcuni racconti già usciti in altri volumi, come appunto L’uovo al cianuro, mentre diversi risultano inediti. La caratteristica che li accomuna è che non sono frutto di pura invenzione, ma derivano da fatti in cui Chiara è stato partecipe o testimone, oppure di cui lui ha sentito parlare da altri; ovviamente, poi, la sua creatività li amplia e arricchisce, ma comunque sono tutte storie vere, come del resto i suoi romanzi.
Si tratta in tutto di 23 racconti, scritti in un arco di tempo ampio, che va dagli anni ’30 al dopoguerra e, come sempre accade, in presenza di numerose prose ce ne sono di più riuscite e altre meno, ma il livello medio resta sempre piuttosto alto. Se si crede che ci siano numerose occasioni per ridere dico subito che queste sono poche, anche perché l’intento dell’autore era quello di fissare la memoria del suo trascorso. Prevale quindi una natura intimistica in cui le opportunità per riflettere non mancano di certo e al riguardo mi permetto di segnalare gli ultimi tre: Il paolotto, con un avventuroso viaggio in Alto Adige nell’autunno del 1945, Tra i pargoli innocenti, che prende spunto da una visita al camposanto e che finisce con il diventare un pacato approfondimento della natura dell’esistenza, ed E’ stato il freddo, in cui il clima rigido, oltre che protagonista, assume sembianze quasi umane. Ma anche i primi della raccolta, con l’infanzia da discolo, hanno una valenza che va ben oltre il ricordo e alternano momenti quasi comici ad altri idilliaci, con descrizioni del lago e dei suoi monti che lasciano stupefatti perché, oltre che perfette, fotografiche, riescono a ricreare , in modo semplice, ma incisivo, l’atmosfera.
Quindi non posso che consigliarne la lettura, mai affaticante, anzi sempre più che gradevole.
Indicazioni utili
Livido come un plumbeo autunno
Quando Giuseppe Dessì scrisse nel 1955 I passeri, aveva già dato alle stampe un romanzo di intensa umanità e anche di speranza come Michele Boschino, un’opera in cui è presente un’accentuata identità fra l’uomo e la natura in cui vive. Ebbene I passeri è tutta un’altra cosa, racchiuso fra i muri di una vecchia casa, tanto che sembra che gli esterni non esistano, che quei mattoni costituiscano, al contempo, un rifugio e una prigione per chi vi abita, in un autunno livido che si scioglie in un inverno per nulla radioso. È un romanzo di lancinanti solitudini, di personaggi che vivono senza la speranza di un domani, stretti nell’abito cucito loro addosso dal destino e da cui nemmeno cercano di uscire o di ribellarsi a una condizione a cui, tutto sommato, sono indifferenti. Viziato da una trama complessa che non di rado mette a disagio il lettore e con uno stile che non sembra quello dei romanzi di Dessì che ho già letto sono rimasto francamente un po’ sconcertato, perchè sembra il risultato di un’opera concepita in un periodo di depressione, scura com’è, uno sfogo disperato a uno stato di sofferenza interiore che non sempre il lettore si sente di accettare. A scanso d’equivoci, non è che I passeri sia sconsigliabile, ma per l’impostazione, i toni, l’intricata vicenda, la staticità credo non si possa far rientrare fra i libri più riusciti di Giuseppe Dessì. È un peccato, perché mi ero abituato bene con le opere di questo autore e quello che mi auguro è che si tratti di un caso isolato, di un momento poco propizio e infelice nella sua produzione, almeno per quanto riguarda i romanzi che ho già letto (Paese d’ombre, Il disertore e Michele Boschino).
Indicazioni utili
- sì
- no
Gli italiani e le guerre
Che Mario Isnenghi sia un grande storico è sicuramente fuor di dubbio, ma che sappia raccontare la storia non solo per gli studenti degli atenei, ma anche per una vasta ed eterogenea platea è un’altra cosa, una qualità che, secondo me, non gli è propria. Di suo avevo già letto La Grande Guerra, opera per certi versi interessante, ma viziata da un tono accademico che di certo non consente al lettore di appassionarsi e di sentirsi partecipe. Anche questo libro (Le guerre degli italiani Parole, immagini, ricordi 1848 – 1945, presenta il medesimo difetto che, pertanto, deve ritenersi congenito; non si pretende che abbia il carisma di Denis Mack Smith o le capacità di attrarre di Alessandro Barbero, ma resta il fatto che fra il sapere e il diffondere questo sapere spesso resta un abisso; nella circostanza, poi, l’impostazione dell’opera, che pure è interessante, appare dispersiva, perché raccontare dei conflitti che hanno caratterizzato l’Italia di circa un secolo non avviene secondo un ordine cronologico, bensì sulla base delle tipologie delle testimonianze storiche, e cioè, e solo ler citarne alcune, i proclami, i quotidiani, la corrispondenza dei militari e i nomi delle vie. Non c’è dubbio che questa strutturazione sia assai originale, ma presenta anche lo svantaggio che può, e sovente ci riesce, disorientare. Ne esce un quadro del tutto particolare, il risultato dell’esatto incastro dei numerosi e variegati pezzi di un grande puzzle, in cui c’è di tutto: retorica e cattivo gusto, esaltazione e scoramento, fatica e dolore, tanto dolore. Oserei dire che Isnenghi più che impegnato a parlarci delle tante, troppe guerre che hanno visto coinvolto un popolo come il nostro che si atteggia pacifico, ha inteso fare una ricerca sociologica per comprendere e descrivere l’atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra. In questo senso l’impostazione è quella giusta – e non avrebbe potuto fare altrimenti – e l’opera assume un valore del tutto particolare per conoscere come eravamo, come siamo e forse come saremo. In tal caso il risultato cambia e diventa più che apprezzabile, tanto da consigliarne vivalente la lettura, pur con i li,iti dianzi precisati del tono accademico utilizzato.
Indicazioni utili
Il grande amatore che non sapeva amare
Giacomo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 – Dux, 4 giugno 1798) è stato un uomo dai mille volti e, a suo modo, un personaggio irripetibile; in un’epoca, quella dei lumi, in cui la ragione sembrava dare spiegazione di ogni cosa, ma che vide il fiorire di individui che ancora riuscivano a cogliere frutti dall’ignoranza e dalla superstizione, uomini come Cagliostro, o il conte di Saint Germain, Casanova fu un attento e abile osservatore, come testimoniato dalle sue memorie. E se fu senz’altro un avventuriero, ma anche un alchimista, un filosofo e un agente segreto, il suo nome é sempre stato associato alla figura del grande amatore, del massimo tombeur de femmes, attribuzione esagerata, anche se non infondata, ma che in epoca successiva ha diviso i suoi numerosi e spesso famosi biografi fra detrattori e incensatori.
Roberto Gervaso, con questo volume, frutto di un lavoro di certosina pazienza volto a verificare, con altre fonti, la coincidenza con quanto narrato nell’Histoire de ma vie, senza omettere gli aspetti negativi ha invece teso a porre in evidenza le sue grandi qualità di letterato. Uomo del XVIII secolo il veneziano ci ha fornito una pregevole descrizione della sua epoca, una sorta di belle epoque troncata dall’avvento della rivoluzione francese. Errabondo, sempre in movimento da una corte all’altra, Casanova ha saputo leggere e interpretare il sui tempo, fornendoci un contributo indispensabile per una migliore conoscenza del secolo dei lumi. Certo fu anche un avventuriero, ideatore di truffe finalizzate a supportare finanziariamente il suo esagerato modo di vivere, caratterizzato da un lusso sfrenato; tutto era messo in atto per soddisfare il suo accentuato narcisismo e per inserirsi nella ristretta cerchia dei nobili, di cui fu un parassita. Seppe abilmente approfittare delle naturali debolezze di una casta chiusa e immobile e in pratica riuscì a vivere, quasi sempre da gran signore, senza lavorare. Tuttavia il suo elevato grado di cultura, che lo portò ad incontrare e a misurarsi come filosofi come Voltaire, ci dice che non fu un semplice imbonitore da quattro soldi, ma un individuo dotato di una complessa personalità che aveva improntato la sua esistenza al carpe diem. In questo contesto si inserisce il suo aspetto più noto di grande amatore, meritato senz’altro anche se poi, a conti fatti, sembrerebbe abbia posseduto non più di duecento donne. E fra queste c’erano le predilette lolite, ma anche le tardone (a cui spillava soldi) e non mancavano nemmeno mercenarie che gli si concedevano contro pagamento. In questo turbinio di rapporti, a volte di gruppo, finì con l’incappare più di una volta in qualche malattia venerea, come lo scolo e la gonorrea, da cui uscì guarito curandosi con certi suoi impiastri. La donna del momento, qualunque essa fosse (e fra queste ci fu anche una gobba), era sempre la più bella e più desiderabile della precedente, e che lui si innamorasse veramente ogni volta non c’è dubbio, ma era estremamente volubile e quel ricercare nell’amore solo l’aspetto sessuale finì con il pregiudicare la possibilità di un’esistenza normale e lo portò a una vecchiaia casta (per i definitivamente sopiti ardori) e solitaria, in cui non poté che rivivere i bei tempi grazie al ricordo e scrivendo le sue memorie. Queste, un’autentica opera d’arte, sono appunto analizzate criticamente da Gervaso con la sua sottile ironia, soprattutto ove Casanova esagera, come nel caso dei rapporti avuti in una notte, il cui numero è fuori da ogni logica. Tuttavia, è per lo più sincero e finisce con il diventare simpatico, anche da vecchio, emarginato, rinchiuso nella sua solitudine, che solo il ricordo del passato riesce in parte a lenire.
L’uomo, il grande amatore, muore in silenzio, non circondato da affetti, che non aveva mai cercato: insomma, per quanto paia un ossimoro, a conti fatti non aveva saputo amare.
Questa biografia è veramente splendida e si legge con grande piacere, grazie anche allo stile snello e incisivo dell’autore.
Indicazioni utili
Smontata una bufala mediatica
Joseph Goebbels, ministro della propaganda del terzo Reich, le cui capacità di imbonitore sono fuor di dubbio,ebbe a dire:ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità. Perché ho pescato dalla mia memoria questa peraltro famosa citazione? Da alcuni anni un gruppo di storici, o meglio pseudo storici revisionisti, ma che si potrebbero anche definire neoborbonici, sta cercando di minare la già poca coesione nazionale con una pretesa verità, secondo la quale ai soldati del Regno delle Due Sicilie presi prigionieri dai garibaldini e dai piemontesi sarebbe stata riservata un sorte non dissimile da quella degli ebrei vittime dell’olocausto. Ci sono state pubblicazioni al riguardo, ma anche una diffusione capillare su Internet, che ho potuto verificare di persona e che mi ha lasciato piuttosto perplesso. Dico subito che non ho preso per oro colato le asserzioni di questi revisionisti, ma, considerato quanto di strano può accadere nel nostro paese, mi sono detto che una simile accusa, i cui elementi probatori in verità sono assai esili, meritava un approfondimento onde accertare la sua fondatezza. La perplessità è derivata sai dai toni accesi, sia confrontando i vari interventi, con numeri e notizie non concordanti. Tanto per citare un caso, l’Auschwitz del XIX secolo, l’antico forte di Fenestrelle, viene indicato sito a 2.000 metri di altezza, anziché a 1.200, e non credo si tratti di un errore, perché le temperature fra le due quote sono molto diverse e a quella più alta è molto più freddo, il che serve a giustificare lo sterminio, non solo per stenti, ma anche per la rigidità del clima, accampato dai revisionisti secondo i quali i soldati borbonici ivi rinchiusi - e sarebbero stati quelli che avevano rifiutato l’arruolamento nell’esercito piemontese –, coperti solo da camicioni di tela, sarebbero periti nel corso del lungo inverno. Alessandro Barbero, per quanto piemontese, è uno storico capace e coscienzioso e ha ritenuto necessario effettuare la verifica, da cui è scaturito questo saggio che, essendo fatto di tanti numeri e notizie probatorie capillari, può riuscire di non agevole e particolarmente piacevole lettura; tuttavia l’opera ha il pregio di smontare, senza ombra di dubbio, la teoria revisionista. A Fenerstrelle furono rinchiusi temporaneamente pochissimi soldati borbonici, ma non come prigionieri, bensì in attesa di destinazione, e in ogni caso non vi trascorsero l’inverno e se vi furono dei decessi questi furono solamente quattro e per malattia. Quindi, le persecuzioni, i maltrattamenti, il chiaro intento di dare la morte a questi sconfitti sono solo menzogne e la circostanza è di particolare gravità ove si consideri che l’intento mistificatorio è di dividere gli italiani, ancora poco uniti, e in un certo senso di contrapporre un meridione arretrato cronicamente a un settentrione visto come uno sfruttatore delle sane energie del sud. Simili pseudo storici, incapaci di supportare le loro teorie con un’analisi storica completa ed esauriente, hanno la possibilità di portare avanti il loro discorso secessionista solo perché siamo in democrazia, in cui vige quella stessa libertà di parola che se ritornassimo, come nelle loro intenzioni, ai bei tempi di Franceschiello, sarebbe totalmente proibita. Barbero, data l’importanza della questione, è stato ancora più scrupoloso del solito nel reperire le fonti e i documenti probatori, lavoro non certo facile, ma che costituisce il supporto indispensabile per dire con pressoché totale certezza che non vi fu alcun sterminio e che la teoria dei revisionisti si basa solo su chiacchiere e illazioni, senza che esista al riguardo il benché minimo elemento probatorio.
Quindi I prigionieri dei Savoia è assolutamente da leggere, e non solo per conoscere un aspetto della nostra storia spesso trascurato, ma per non dare il minimo credito alle tante e irresponsabili voci presenti su Internet.
Indicazioni utili
La fine di una dinastia
Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, vittime di un attentato dei nazionalisti serbi persero la vita l’erede al trono dell’impero austro-ungarico Francesco Ferdinando d’Asburgo e sua moglie Sophie Chotek; l’evento in sé, per quanto grave, sarebbe stato confinato nei fatti, non sempre lieti, che costellano la storia se non avesse invece costituito il pretesto per l’inizio di un conflitto enormemente sanguinoso, più conosciuto con il nome di prima Guerra Mondiale. Se forse è vero che nessuno voleva uno scontro aperto, è altrettanto vero che nulla fu fatto per impedirlo, con conseguenze nefaste per chi vi si impegnò militarmente soprattutto per tentare di risolvere il problema, invece ormai senza soluzione, di una inarrestabile decadenza. Furono sufficienti infatti pochi anni per cancellare dalla scena europea alcune grandi monarchie, che ormai da tempo apparivano in inesorabile declino; sparirono così i grandi regni e imperi di Russia, di Turchia, di Germania e di Austria-Ungheria. Perché ciò avvenne? Perché una grande dinastia quale quella asburgica giunse alla fine dei suoi giorni? E’ a queste domande che Edgarda Ferri intende rispondere con il suo romanzo storico Guanti bianchi, partendo proprio da quel funesto 28 giugno 1914. Ed è lì che con l’improvvisa scomparsa dell’Arciduca, nel vuoto di un potere rappresentato dall’imperatore Francesco Giuseppe, vecchio e stanco e soprattutto atrofizzato nel suo personaggio di regnante, padre di tante patrie di cui ormai non conosce più i figli, prende corpo una figura normalmente non di primo piano in una dinastia, ma che nella circostanza ha il potere di dettare regole e comportamenti a cui tutti devono soggiacere. Si tratta del principe Alfred di Montenuovo, il Gran Ciambellano, il cui compito è ora di organizzare le solenni esequie, secondo un protocollo rigido, pomposo, fuori di ogni logica e anche fuori dal tempo. Lui può tutto, ciò che decide è legge e deve essere obbedito; è un uomo insensibile, perfino gretto, che di certo non aveva in simpatia l’Arciduca, per non parlare si Sophie Chotek che, per quanto contessa, era troppo poco nobile per sposare un erede al trono. Infatti il futuro imperatore d’Austria avrebbe dovuto sposare solo una figlia di re e ce ne volle a Francesco Ferdinando per convincere Francesco Giuseppe a dare l’assenso al matrimonio, assenso frutto di un compromesso di una meschinità incredibile: la sposa avrebbe dovuto vivere nell’ombra, come se non ci fosse stata. E anche questo è un bel problema per il Gran Ciambellano, costretto a far convivere un funerale di prima classe con un altro di terza, un catafalco immenso su cui collocare il corpo dell’arciduca e qualche cosa di infinitamente più modesto per la moglie. Tuttavia, per gentile concessione, in un apparente impeto di umana pietà, il principe di Montenuovo consentirà che sulla bara di Sophie, esposta per due ore nella cappella palatina dell’Hoffburg, vengano messi un paio di guanti bianchi e un ventaglio nero. Perché? Per sancire un indiretto legame con la famiglia del marito in quanto lei da nubile era stata dama di corte della moglie di un arciduca Asburgo. Sophie era stata solo una dama di corte, quasi una cameriera di rango nobiliare, e tale era da considerarsi ancora. Non si tratta quindi di umana pietà, bensì di un ulteriore affronto a una donna che in vita sua aveva avuto solo il torto di amare l’erede al trono. E in un’atmosfera come questa, nella cappa opprimente del vecchio e stantio che l’attentato ha reso ancora più cupa, è evidente che ci troviamo di fronte alla degenerazione di un sistema che, divorando se stesso, finisce con l’implodere.
Il ritmo è dovutamente lento perché tale deve essere ed Edgarda Ferri ha saputo dare a un dopo (dopo l’attentato) il senso ben preciso di una cerimonia funebre con cui una dinastia finisce con il seppellire se stessa.
Da leggere senz’altro.
Indicazioni utili
La banalità è solo apparente
Questo narratore, di cui ho già letto gli splendidi romanzi Paese d’ombre e Il disertore non finisce di stupirmi, tanto che continuo a chiedermi perché sia caduto nell’oblio, domanda di cui non accetto la più che logica risposta che questa è la fine di chi sa parlare, senza mere astrazioni, dell’uomo e della sua esistenza. Quest’opera è apparentemente assai semplice, anche se presenta come al solito più piani di lettura. Infatti ci sono quelli della terra dell’autore, quella Sardegna arcaica a cui Dessì è senz’altro indubbiamente legato, ma c’è anche quello della terra intesa in senso puramente materiale, cioè di quel mondo rurale immobile per tanti secoli e che poi nel volgere di pochi anni, dopo la seconda guerra mondiale, è sparito, fagocitato da una mentalità di profitto che ha trasformato il contadino in agricoltore e poi in industriale.
In tal modo la specificità dell’ambiente isolano, chiuso in se stesso, arroccato su una difensiva da ogni novità, finisce con l’andare ben oltre il ristretto spazio a cui lo confina anche la mentalità della civiltà contadina per estendersi a tutti i rurali di questo mondo, almeno quali erano fino a non molto tempo fa. Ma se questa è la cornice di un quadro dipinto magistralmente, al centro dell’attenzione di Dessì c’è l’uomo, questa fragile creatura che, salvo rari casi, non riesce a emergere dall’anonimato della moltitudine, E in effetti la vita di Michele Boschino, questo contadino sardo il cui possesso di un paio di buoi e di un pezzo di terra costituisce la massima aspirazione, è di una banalità sorprendente, sembra una delle tante esistenze che non meritano memoria. E invece l’abilità sta nel fatto che tanti eventi che ci sono comuni assumano caratteristiche di particolarità, come nel caso della veglia del padre morente o del matrimonio, e ciò perchè il sapiente gioco di luci e ombre li fa assurgere a qualche cosa di straordinario e di irripetibile. Non solo questo però, perché dal punto di vista strutturale Dessì ha diviso il romanzo in due parti: nella prima si narra in terza persona degli anni forse migliori di Michele Boschino, a differenza della seconda, in cui lo troviamo solo, in miseria, esacerbato da quelle prepotenze dei parenti che avevamo inciso sulla vita di suo padre; tale condizione ci viene descritta in prima persona da Filippo, un giovane che nel percorrere il suo presente si trova sulla strada il nostro protagonista, in una ideale congiunzione fra il passato e tempi assai successivi, quasi a voler dimostrare che nella lotta per l’esistenza non vi è scorrere di lancette. Sono di rango sociale diverso, uno vecchio e l’altro giovane, ma nella vicenda sono indissolubilmente uniti da un destino, a loro indifferente, in un mondo campagnolo talmente immobile da sembrare senza tempo.
Non ci troviamo di fronte a due eroi, ma a due comuni mortali, anche se Michele riluce più di Filippo perché conosciamo molto della sua vita, fatta di lavoro e di umiltà; niente di particolare si potrebbe dire, se non che la banalità del vivere è come un grido lacerante, se pur muto, della condizione di passività a cui ogni uomo è assoggettato.
Non è facile trovare un autore che riesca a rendere così bene un’esistenza apparentemente anonima, a darle smalto, a ricordarci che se la vita di ognuno di noi può apparire del tutto simile, pur tuttavia é sempre irripetibile.
Indicazioni utili
Instabilità
Ho avuto modo di conoscere la scrittura di Milvia Comastri nel lontano 2006 allorché recensii il suo primo libro, Donne, ricette, ritorni e abbandoni, una raccolta di racconti il cui comune denominatore è la preparazione del cibo. Ne apprezzai lo stile fresco e semplice, che non poco contribuiva alla gradevolezza della lettura. Successivamente, nel 2012, è uscita un’altra raccolta di racconti, Colazione con i Modena City Ramblers che è caratterizzata da una varietà di tematiche che ancor di più offre la possibilità di attrarre esigenze diverse, accontentando una più variegata popolazione di lettori. Anche in questo caso ne ho scritto la recensione, evidenziando la sensibilità e delicatezza che accompagna queste prose e fermo restando quelle caratteristiche stilistiche che mi avevano in precedenza colpito.
Due opere, due raccolte di racconti, a riprova dell’inclinazione della scrittrice per la narrativa breve (occasionalmente, si diletta anche di poesia) sono pertanto caratteristiche della sua produzione e infatti il terzo libro, da poco pubblicato, è analogo nella realizzazione ai precedenti.
Squilibri è una raccolta di racconti (in tutto venticinque) il cui tema dominante é l’instabilità, intesa nella più ampia accezione del termine e quindi ricomprendendovi l’ingiustizia, la sopraffazione, la mancata accettazione di se stessi e la marcata diversità che fa sì che i personaggi si possano configurare come vittime di una società il cui equilibrio comporta anche lo squilibrio di non pochi suoi componenti. Per esempio, è questo il caso del primo racconto (Che cosa hai fatto) in cui una ragazza, vittima anni prima di una violenza del branco, quando un’altra fanciulla viene stuprata dagli stessi individui, si decide di denunciarli. Ma un errato senso del pudore del consesso sociale di cui lei fa parte finirà per usarle una violenza più sottile e più devastante, di fatto emarginandola, comportamento che assumerà anche sua madre. Guai quindi a violare le regole non scritte di una comunità, ad alterare un apparente equilibrio, perché in tal caso si finisce con l’essere messi fuori. Adesso non intendo parlare di altri racconti, altrimenti rischierei di togliere il piacere della scoperta ai lettori, ma preferisco soffermarmi sugli intenti civili dell’opera, presenti anche in passato, ma in modo meno evidente. L’autore ha la capacità di osservare da un punto di visualizzazione elevato e spogliandosi da quei preconcetti che inconsciamente ci portiamo dentro; in questo modo riesce a togliere il velo all’apparenza e a portare alla luce insanabili fratture fra la società e diversi suoi membri, un insieme di individui che hanno la caratteristica di essere involontariamente carnefici ( fa più male della violenza l’indifferenza, o peggio la supina accettazione) anche per non alterare quel fragile equilibrio su cui si basa ogni società. E così la vittima che si ribella diventa due volte vittima, marchiata indelebilmente per colpe che non sono sue e che sono invece i torti subiti.
Trattandosi di diversi racconti, per quanto ovvio ci sono quelli che mi sono meno piaciuti e quelli che invece ho particolarmente gradito; tra questi ultimi, oltre al citato Che cosa hai fatto, inserisco anche I miei amati figli sconosciuti, di rara delicatezza.
Lo stile è sempre accattivante e se voglio trovare un difetto, che in effetti non è tale, è la tristezza per lo più dominante, ma in fondo, se ci si guarda bene intorno, non ci sono abbastanza motivi per essere allegri.
In conclusione, Milvia Comastri riconferma le positive impressioni che già avevo ritratto dalla lettura delle due precedenti raccolte e quindi questo libro è senz’altro consigliato.
Indicazioni utili
Un Simenon sottotono
Credo che questa volta Simenon si sia lasciato prendere la mano privilegiando l’aspetto intimistico rispetto alla trama gialla che si presenta nel complesso esile. L’idea, di per sé, è interessante, con una vicenda di ricatti in cui anche uno degli estorsori finisce per essere una vittima, plagiato dal capo banda. Ma se le indagini per scoprire cosa si celi dietro l’omicidio di un deputato conosciuto per le sue continue interpellane e interrogazioni è il fil rouge attorno a cui ruota tutto, l’aver voluto, al di là di qualsiasi pratica investigativa, descriverci un Maigret quasi paterno finisce con lo squilibrare la struttura, smorza la tensione del poliziesco e in buona sostanza fornisce un prodotto che senz’altro non è in linea con l’eccellenza degli altri dell’autore belga. E’ un peccato, poiché l’indagine del noto commissario, alle prese con un giovane angosciato dal comportamento del padre, avrebbe aggiunto tensione alla tensione vera e propria del caso, ma purtroppo quella che latita è quest’ultima, perché già da quasi subito si sa chi è il colpevole di un omicidio, mentre quello che c’è ancora da scoprire è il movente. Intendiamoci, La rivoltella di Maigret non è romanzo da buttare, ma ha una certa caduta di tono che peraltro ci può anche stare in una produzione così vasta. E visto che allora Simenon ha inteso privilegiare il rapporto fra Maigret e questo giovane angosciato c’è anche da dire che il comportamento paternalistico del commissario è sì interessante, ma presenta la spiacevole sensazione di un qualcosa di precostituito, come se non fosse spontaneo, ma agisse così secondo un calcolo ben preciso per arrivare alla verità. Forse è solo una mia impressione, ma ci sono delle forzature negli atteggiamenti che, per quanto pietoso si possa considerare in certuni casi il commissario, qui sono un po’ eccessivi e certamente non in linea con quello che può essere il comportamento di un uomo che è coniugato da tempo, ma senza figli.
Detto questo, nulla toglie che l’opera sia meritevole di lettura, ma per chi è abituato ai gialli di Maigret potrà forse riuscire una delusione.
Indicazioni utili
Mussolini spogliato del mito
A distanza di più di mezzo secolo dalla sua morte e quindi sopite le passioni credo sia opportuno chiedersi chi sia stato veramente Benito Mussolini, al di là di quel che tutti sappiamo di lui (il capo del fascismo, il dittatore, l’uomo che portò l’Italia alla sventura della seconda guerra mondiale e che poi alimentò quella guerra civile che tanti lutti ha causato al paese). Era il capo di stato che con atteggiamento marziale passava in rivista le truppe? Era il padre di tutti, sorridente e affettuoso, quando si presentava agli italiano? O era forse il lavoratore che dava l’esempio nel corso della battaglia del grano? Era colui che prometteva gloria all’Italia e che invece la condusse alla rovina?
Chi lo conobbe, almeno per essere stato comandato da lui nel ventennio, sembra in preda a un mito indistruttibile che anzi nel trascorrere del tempo si autoalimenta (ormai sono rimasti in pochi, ma fra i vecchi fascisti aleggia sempre la figura del Duce come fu a suo tempo costruita), e questo nonostante la realtà dei fatti, ma i vecchi si possono scusare, perché in fondo vivono del passato. Mentre quelli che non hanno alcuna giustificazione sono i giovani, quelli che parlano di un Mussolini come non è mai stato, tanto da pensare che lo vagheggino. A questi e a chi vuole sapere di più consiglio di leggere questo piccolo libro di Denis Mack Smith, in cui sono ben delineate le ossessioni, la retorica, i tradimenti e il narcisismo esasperato del duce.
Ne esce una figura tragicomica, un individuo dalla dubbia sanità di mente, pur con quella capacità che gli deve essere riconosciuta di aver incantato, almeno fino alla seconda guerra mondiale, il popolo italiano. Vi sono raccontati episodi che se non avessero poi condotto allo sfacelo del paese sarebbero anche divertenti, con quest’uomo convinto di sapere tutto e che invece sa poco e niente, che non ascolta - ma nemmeno vuole – i consiglieri, che gioca d’azzardo con la pelle degli altri, che è abituato a raccontare menzogne a cui finisce con il credere anche lui. È un uomo che di anno in anno accentra sempre più potere e la cui mente va di pari passo oscurandosi.
Il partito, che ha forgiato, finisce con l’identificarsi con lui che agli inizi forse aveva qualche capacità politica, che poi però, in assenza di concorrenti, è svanita, tanto che non trova di meglio per liberarsi di due personaggi pericolosi per il sui potere di mandarli in pratica in esilio (Grandi ambasciatore a Londra e Balbo governatore in Libia). Fra tante incapacità, in una vanità smisurata ci sarebbe almeno da attendersi un buon carattere e invece era crudele (non certo come Hitler e Stalin), ma comunque feroce con chi, a suo giudizio, poteva mettergli il bastone fra le ruote, come nel caso di Ida Dalser, sposata solo in chiesa, e del figlio avuto da lei Benito Albino, non solo osteggiati, ma perseguitati e rinchiusi in manicomio affinchè non parlassero.
Il mito dunque é stato un bluff, perché nessuna di quelle caratteristiche positive che gli erano state costruite rispondeva a verità; anzi, Benito Mussolini era quasi una nullità e forse in questa nullità si ritrovava una parte di un popolo che amava sognare. Il giudizio è troppo severo? Beh, vediamo cosa dicono tre personaggi suoi contemporanei che non possiamo certo definire di parte avversa.
La moglie, donna Rachele, l’ha ricordato così:”mio marito pareva un leone, e invece, tutto sommato, era un pover’uomo.”.
Il genero, Galeazzo Ciano, dando un consiglio a Bastianini, destinato alla carica di sottosegretario agli Esteri, lo avverte che in passato “fu possibile parlare a Mussolini ma adesso non vuole più sentire nessuno e vuol aver ragione lui, ma per fortuna le sue opinioni mutano come il vento.”.
Ma il giudizio più preciso ed esauriente è quello di un fascista notoriamente colto, Bottai: “Mussolini è l’unico uomo che Mussolini non abbia mai tradito; é stato indotto in una serie di errori dagli anni, dalle donne, dalla lue, dall’ulcera, dall’invidia e dall’odio.”.
Vi consiglio, anzi raccomando vivamente la lettura di questo piccolo grande libro.
Indicazioni utili
I primi racconti
Questa raccolta di racconti, di diverse tematiche, è costituita dai primi lavori in prosa di Italo Calvino, ben lontani quindi dai successivi con cui l’autore si rivelerà uno dei più grandi narratori italiani del XX secolo. Nel leggerli si riscontra subito un certo approccio primitivo alla scrittura, una ricerca stilistica ben lungi dall’essere perfezionata e una varietà di temi che fa pensare al fatto che le epoche di stesura devono essere state necessariamente ben diverse. Grosso modo queste prose, per lo più brevi, si possono far rientrare in tre filoni: il primo è attinente l’ambiente e la natura della sua regione, la Liguria, pervaso da venature poetiche, alcune più riuscite, altre meno, con una certa impronta bonaria che tende a mettere in risalto delle figure emblematiche, quasi sempre picaresche; il secondo è una serie di ricordi d’infanzia e il terzo, che è il migliore, attinge a piene mani all’esperienza vissuta nel corso della Resistenza, esperienza che darà i suoi frutti più riusciti con il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. La lettura rimane sempre agevole, perché Calvino non è uomo che si arrovella in percorsi tortuosi del ragionamento e nel caso specifico poi l’approfondimento è quasi sempre limitato, preferendo l’autore che sia la vicenda in sé narrata a proporre al lettore quesiti e dovute riflessioni, finendo così per coinvolgerlo direttamente. Per quanto ovvio, in trenta racconti ce ne sono di buoni e di altri meno riuscito, tanto è vero che nelle edizioni successive (questa è la prima) Calvino provvederà a stralciarne, Personalmente credo che quelli sulla Resistenza siano i migliori e che il più bello in assoluto sia quello che dà il nome all’intera raccolta, cioè Ultimo viene il corvo, una sorta di duello fra un soldato tedesco isolato e un ragazzo partigiano dalla mira infallibile. C’è da dire anche che non è possibile riscontrare in queste prose quella visione metaforica surreale dell’umanità che sarà il tratto dominante del “grande” Calvino e che questi lavori, se pur gradevoli, appaiono assai minori rispetto alla sua produzione, ma ciò non deve costituire motivo per non leggerli, perché rappresentano la testimonianza del percorso letterario di un autore che troverà alla fine uno stile, una struttura e una tematica che ancor oggi stupisce e appassiona.
Indicazioni utili
Ecco il Medioevo visto da chi lo ha vissuto
Donne, madonne, mercanti e cavalieri è uno strano saggio storico, così diverso da quelli a cui ha abituato Alessandro Barbero, il cui talento e la cui competenza sono fuori discussione. Per comprendere meglio ciò che intendo dire mi avvalgo di un passo della sua introduzione all’opera in cui viene specificata la finalità della stessa; infatti Barbero scrive “Chi erano, come pensavano, come vedevano il mondo uomini e donne del Medioevo?”. Il compito che si è assunto lo storico torinese, cioè mostrarci come era la società dell’epoca, appare assai arduo, perché le fonti sono purtroppo limitate e i mezzi per la conoscenza sono quasi inesistenti; al riguardo, ricordo che la stampa all’epoca non c’era ancora e che quindi non esistevano i giornali, ma anche i libri erano pochi e con diffusione limitata, visto che dovevano essere scritti a mano, così come le loro copie, e che la carta come la conosciamo noi era ben diversa e costosa, insomma si ricorreva alla pergamena. Eppure, qualcuno ha lasciato ai posteri un’opera illuminante di cui si è avvalso Barbero per il suo lavoro e laddove questa non c’era , perché è appunto questo il caso di Giovanna d’Arco, analfabeta, ha attinto le indispensabili notizie dagli atti del processo a cui fu sottoposta. Aggiungo, inoltre, onde dimostrare ulteriormente le difficoltà incontrate, che gli scritti basilari non sono finalizzati a descrivere quanto si era proposto lo storico torinese, ma nei loro contenuti è necessario trovare ciò che interessa e proporlo all’attuale lettore, secondo un preciso filo logico che non venga mai meno allo scopo prefissato, magari arricchendolo di annotazioni, sovente velate di ironia, anche per rendere più agile e gradevole la lettura.
I personaggi, che inconsciamente ci descrivono il mondo medievale, sono tre uomini e tre donne, una giusta par condicio, soprattutto in un periodo storico che vedeva il massimo assoggettamento della femmina al maschio. Alcuni di questi soggetti sono famosi, altri meno, ma in ogni caso le notizie che ci forniscono sono tali da poter farci comprendere come era il mondo in cui vissero, un mondo in cui la religione aveva un aspetto predominante, con un Dio con la barba, cioè cattivo e vendicativo, tale da incutere terrore ai fedeli più sprovveduti, che erano la maggior parte. Inoltre, del resto come oggi, anche se in misura totalmente anelastica all’epoca, la società era rigorosamente classista, con i servi della gleba e i signori, cioè i cavalieri; in mezzo, sempre più importante, c’era una borghesia di medici, professori, artigiani, commercianti e banchieri che aveva l’aspirazione, consapevole dell’importanza delle sue funzioni, di decidere il destino di città, di sostituire nell’amministrazione dei comuni i nobili che, ovviamente, facevano di tutto per conservarla.
Ne esce il quadro di un medioevo non statico, ma che va progressivamente ad accentuare quel dinamismo che poi porterà all’età d’oro del rinascimento. È lecito chiedersi perché questi protagonisti hanno scritto le loro opere, in un periodo storico in cui ben pochi leggevano, ma credo che la spiegazione sia innata in ogni uomo: lasciare traccia di sé, cercare in tal modo di assicurare un surrogato di vita dopo la morte. A questi personaggi (frà Salimbene da Parma,
Dino Compagni, Jean de Joinville, Caterina da Siena, Christine de Pizan e Giovanna d’Arco) va riconosciuto il merito di essere riusciti a parlarci di un mondo ormai passato; ad Alessandro Barbero va il nostro plauso per essere riuscito a realizzare lo scopo di questo saggio, realizzando un’opera di grande interesse e di piacevole lettura.
Indicazioni utili
Un uomo, tre donne
In questo giallo c’è un morto ammazzato, il signor Couchet, colpito dal proiettile di una pistola sparato da non più di tre metri di distanza, le sue tre donne, cioè la prima moglie, da cui è divorziato da tempo, la sua attuale consorte, ora vedova, e la sua amante, nonchè un piccolo uomo, un travet, marito, secondo marito per l’esattezza, della prima. Il delitto è stato commesso nell’ufficio della vittima, un facoltoso industriale in campo farmaceutico, che ha brigato tutta la vita per arricchirsi, quasi sempre andando incontro a degli insuccessi, ma che con il preparato del dottor Riviere ha finalmente raggiunto il suo scopo e ora ha soldi, tanti soldi, di cui i 360.000 franchi sottratti dalla sua cassaforte, benché per nulla disprezzabili, paiono ben poca cosa.
Parrebbe un’indagine non particolarmente complessa, ma il commissario Maigret, per quanto capace, non riesce a farsi un’idea precisa dell’accaduto, dei suoi retroscena e del movente del delitto, tanto più che alcuni elementi lascerebbero supporre che chi ha rubato il denaro non sia l’assassino, una complicazione in più che rende assai difficile l’esito dell’inchiesta, tanto più che i personaggi hanno caratteristiche tali da poter essere tutti sospettati, fatta eccezione per la seconda moglie. Un Maigret di poche parole brancola a tratti nel buio, ma poi, come sempre succede in questi casi, basta un’intuizione per sbrogliare la matassa e allora il nostro commissario pende a giocare come il gatto con il topo, anche se arrivando a scoprire il colpevole gli resterà l’amaro in bocca e dimostrerà una volta di più quel senso di pietà che gli è proprio nel caso di particolari rei.
L’ombra cinese si svolge a Parigi, in un quartiere centrale, in un grosso palazzone, che è un campionario di varia umanità (indimenticabili le due anziane sorelle, di cui una pazza e l’altra che sta sempre a origliare dietro la porta dei vicini), in un’atmosfera grigia, tetra, opprimente, in cui la tensione cresce pagina dopo pagina fino ad arrivare ad un punto tale da sembrare un elastico lì lì per spezzarsi, e infatti su romperà grazie a Maigret, ancora una volta vincitore, ma senza soddisfazione.
Bello, forse uno dei migliori con protagonista il celebre commissario e quindi non posso che consigliarne la lettura-
Indicazioni utili
La lingua delle vichinghe è più comprensibile
Andrea Camilleri, prossimo ormai ai 91 anni, dimostra una continua e costante vitalità, con una produzione letteraria che a definire corposa sarebbe un eufemismo. Frutto di una creatività che oserei dire inesauribile i suoi libri escono a raffica, e poco importa che siano romanzi, oppure racconti, perché lui sembra avere sempre qualcosa di nuovo da dire. È ovvio che con così tante opere, nonostante la loro qualità sia mediamente buona, possa capitare che ogni tanto qualcuna sia in tono minore e secondo me è il caso di questa raccolta di racconti, a tema, in cui il tema è appunto l’amore, visto attraverso gli occhi dell’ironia che sono propri dell’autore. Il classico gallismo degli italiani, e in particolare dei siciliani, è del resto materia su cui un narratore attento e disincantato può lavorare a piacimento, con un intento ovviamente satirico-comico. Tuttavia, mi è sembrato che si siano riaffermati certi luoghi comuni che, più parecchio tempo fa che oggi, traevano un fondo di verità dalla realtà di una certa società. Direi che oggi sono anacronistici e il riproporli quindi può avere più un valore storico che una rappresentazione di una realtà immutabile che è invece ben cambiata. Certo a tratti si sorride e forse ci si lascerebbe coinvolgere maggiormente se non perdurasse, sempre più accentuata, quella caratteristica di Camilleri di scrivere in un italiano che italiano non è, ma è una italianizzazione, secondo un criterio tutto personale, del dialetto siciliano. Mi chiedo se ormai l’autore sarebbe in grado di scrivere con la nostra lingua, preso come è a coniare nuovi termini, sempre più spesso di difficile comprensione. Quando leggo mi piace entrare nel pensiero del narratore, cerco di partecipare, ovviamente in modo figurato, alla trama, ma se ogni due o tre righe sono costretto a fermarmi e a chiedermi che cosa possa significare una parola per la cui comprensione non potrà essermi di soccorso un dizionario, ecco che l’incanto che si andava formando scema vistosamente e mi trovo non più davanti alla scena, ma davanti a una pagina e, quel che è peggio, veramente incavolato. Mi chiedo allora che senso possa avere continuare la lettura di un qualcosa fatto di parole incomprensibili e rispondo nell’unico modo che è proprio di chi, oltre che deluso, é anche arrabbiato: getto il libro in un angolo. Se poi considero che per me – ma anche per ogni buon lettore - il ricorso almeno corretto alla propria lingua è essenziale, tendo allora a chiedermi come abbia potuto fino ad adesso perdonare a Camilleri questo importante aspetto. Anzi, mi sento in colpa, per avere fino a oggi sorvolato, ma tendo ad autoassolvermi con un dato di fatto certo: prima, in un ancora non lontano passato, pur scrivendo così Camilleri cercava di facilitare la comprensione, quella comprensione che ora per ben più di una parola mi è stato impossibile avere in questa raccolta di racconti. È ovvio che se il narratore siciliano si radicalizza sempre di più, non mi avrà ancora fra i suoi lettori ed è anche per questo motivo che, pur tenendo conto dei precedenti, non mi sento di consigliare questo libro.
Indicazioni utili
Gli anni più tragici della dittatura
Scritti negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale (tranne uno, il primo della serie, abbozzato nel 1937 ed edito nel 1940) questi cinque racconti ("Lidia Mantovani", "La passeggiata prima di cena", "Una lapide in via Mazzini", "Gli ultimi anni di Clelia Trotti" e "Una notte del '43") furono pubblicati, riuniti in un unico volume, dalla Einaudi nel 1956, ottenendo un immediato successo di critica e di pubblico, coronato nello stesso anno dal conferimento del prestigioso Premio Strega.
Tutte le prose sono accomunate dall’ambientazione (la città di Ferrara) e dalla malinconica consapevolezza che gli italiani amano troppo presto dimenticare, aderendo, spesso inconsciamente, al noto motto chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Tuttavia, il filo conduttore è costituito dalla opprimente cappa della dittatura fascista in dissoluzione, che vive, negli ultimi anni del conflitto, un rigurgito di violenza, tragica e inutile, come se le teste calde volessero portare con sì nella tomba anche gli altri, cioè quelli non come loro. Da questo punto di vista l’opera presenta l’indiscutibile pregio di farci capire, attraverso delle storie semplici e realmente accadute, come poté capitare che un regime, apparentemente dissolto dopo il 25 luglio del 1943, finisse con il rialzare la testa, dando vita a quello stato fantoccio che fu la Repubblica di Salò. Bassani lo fa parlando della sua Ferrara, terra di grandi squadristi, tra i quali Italo Balbo, e in cui la guerra civile prese avvio con l’eccidio di undici innocenti avvenuta nel novembre del 1943, che l’autore sposta a dicembre.
Ferrara è una città di provincia, a economia agricola, una sorta di grosso paese che l’autore ben conosce e descrive perfettamente, nelle sue strade e nei suoi personaggi, ma che riflette, per estensione, l’intera Italia, così che leggendo quelle pagine si comprendono tante cose, si capisce perché a guerra finita i processi ai criminali fascisti si siano quasi sempre conclusi in una farsa, così che dopo aver sollevato un gran polverone questo sia ritornato ad adagiarsi dove era prima, insomma un po’ il concetto del Gattopardo, alla cui pubblicazione l’intervento di Bassani fu determinante.
L’impressione che ho ricavato è che forse ò’autore, con questi suoi racconti, ha inteso dire che la natura del fascismo è innata in noi italiani, menefreghisti, prepotenti, pronti a scendere a qualsiasi compromesso, a cambiar casacca, ma restando sempre noi stessi. L’esperienza degli ultimi settanta anni parrebbe purtroppo dar ragione al narratore ferrarese, confermando ancora una volta che la storia è fatta di cotsi e ricorsi e che, contrariamente a quel che si dice, non insegna nulla, o meglio che da essa non impariamo, o non vogliamo imparare nulla.
Da leggere, perché lo merita.
Indicazioni utili
Silenzio, solo silenzio
Dopo aver letto lo splendido Paese d’ombre ho deciso che era necessario conoscere meglio questo autore sardo che tanto mi ha stupito per le indubbie eccelse qualità letterarie, onde anche verificare che quella non fosse da considerarsi un’opera unica e fortunata. È così che ho reperito, non senza difficoltà, Il disertore (e mi sto ancora chiedendo come sia possibile che noi italiani ci dimentichiamo i lavori di artisti così grandi, spesso andando a preferire altri, magari accattivanti, ma senz’altro qualitativamente inferiori).
È questo un romanzo più breve, ma più complesso, scritto nel solito italiano perfetto, senza tanti fronzoli, per nulla dispersivo, anzi intenso in ogni frase. Non sto a raccontare la vicenda, di indubbia originalità, con questa povera madre che ha perso gli unici due figli nel corso della prima guerra mondiale che, nella trama, è finita da poco tempo. In verità caduto in combattimento è solo il più vecchio, mentre il più giovane, dato per disperso, ha invece disertato e arrivato, fra mille traverse, nella sua isola va a morire nella capanna in montagna dove lavorava il latte degli ovini.
Il conflitto, quell’enorme mattanza, ha lasciato i suoi segni e il sangue dei morti si è riversato inesorabile sui vivi; in tanti hanno perso un familiare, in troppi c’è una sofferenza che con il tempo s’indebolirà, ma in una madre che è stata privata delle sue due uniche creature, una povera donna in tutti i sensi, si è aperto un tempo senza futuro, una lenta silenziosa agonia in cui il dolore regna sovrano; ci sono poi quelli che hanno sperato in un mondo più giusto, che si sono illusi con le false promesse e che, sulla scorta del successo della rivoluzione bolscevica, reclamano quei diritti sempre a loro negati e inoltre c’è una classe reazionaria che intende mantenere a ogni costo i suoi privilegi, ricorrendo anche alla forza e appoggiando apertamente il nascente fascismo; e infine, in contrapposizione a coloro che soffrono in silenzio i loro caduti, ci sono quelli che vogliono ricordarli pubblicamente, dando vita a cerimonie e monumenti pasciuti di quella retorica che è sempre foriera di nuovi conflitti. In questo scenario, fra scontri di piazza, non solo verbali, tanto che ci scappa anche il morto, ci sono tre personaggi di grande umiltà che danno vita al racconto: la madre dei due figli caduti, Mariangela Eca, una donna che sembra un’ombra, Don Pietro Coi, viceparroco del paese, un sacerdote scomodo, perché non allineato con i potenti, e il dottor Urbano Castai, medico di un altro villaggio, amico dall’infanzia con il prete, persona capace nella sua professione, uomo libero e indipendente, e perciò visto come strano o addirittura come anarchico. Ognuno dei tre ha un ben preciso ruolo: la prima, la donna, è il ritratto dell’intenso dolore rappresentato dal suo silenzio, il secondo è l’uomo di fede tormentato da un dubbio irrisolvibile (infatti ha assistito il disertore morente, ne ha raccolto anche la confessione, con grande senso di pietà non solo come religioso, ma anche come essere umano e continua a chiedersi se ha fatto bene a non denunciarlo, un obbligo derivante dall’appartenenza allo stato); il terzo, il medico, nulla sa dell’uomo che ha disertato, ma lo intuisce e lo aiuta. Sono tre personaggi emblematici di tre esseri umani che sanno di avere una coscienza, che sono disposti a correre dei rischi per non andare contro questa coscienza, che non conosco alternative, mosse politiche o altro, perché hanno nell’animo quella fiammella che li distingue dalle bestie e inoltre, per loro natura, sono pacifici e di conseguenza, anche se non esplicitamente, aborrono la guerra,
Quindi, come nel caso di Paese d’ombre, i piani di lettura sono più d’uno, anche se nel caso specifico la ricerca intimistica è prevalente.
Sono cessati i fragori dei cannoni, gli strepitii delle armi, per chi se n’è andato, per chi è caduto sul campo di battaglia deve restare solo il silenzio a fronte di roboanti commemorazioni che pretendono di rendere collettivo un dolore che può essere solo individuale.
Nell’assenza di suoni e rumori che chiude il libro si viene vinti dalla commozione, si resta un poco assorti nel pensare alle vittime di quella carneficina e anche noi apprezziamo cosa è il valore e il significato di quel silenzio.
Imperdibile.
Indicazioni utili
Fecero e disfecero l’Italia
Come sua abitudine Denis Mack Smoth ha scritto un saggio storico sui Savoia re d’Italia con la ben nota imparzialità e logica stringente che gli sono proprie. Certo, questi personaggi coronati non sono sconosciuti, ma il conoscerli meglio, per quel che effettivamente furono, è il grande pregio di questo libro. La dinastia dei Savoia, forse quella più duratura in Europa, ne emerge in modo chiaro, limpido, senza reticenze, per quel che rappresentò per il nostro paese, nel bene, ma soprattutto nel male. Regnò sull’Italia dal 1861 al 1946, allorchè Umberto II abdicò sulla base del referendum a lui avverso fra monarchia e repubblica, tenutosi il il 2 giugno dello stesso anno. In tutto si è trattato di quattro re nell’arco di nemmeno un secolo, monarchi che mai diedero prova di voler regnare per il bene comune degli italiani, condizionati da una mentalità feudale che li faceva ritenere superiori a tutti e non censurabili. Di ognuno Smith ci fornisce un quadro esauriente, parlando di quanto hanno fatto, quasi sempre sbagliando, e di quanto non hanno fatto e che invece avrebbe dovuto essere realizzato. Il giudizio è impietoso e può anche stupire alla luce del fatto che l’autore è nato e vive in uno stato monarchico, ma dove il re ha più una funzione rappresentativa che politica, ed è il primo a riconoscere l’inviolabilità della democrazia, con tutti i suoi diritti e doveri, validi anche per lui e non limitati ai suoi concittadini. Già la dinastia dei Savoia avrebbe potuto perdere il trono nel corso della prima guerra mondiale, dopo il disastro di Caporetto, ma si preferì, soprattutto da parte degli alleati, mantenerla in vita onde evitare di aggiungere a uno sconquasso militare una profonda crisi istituzionale.
E pensare che tutto era cominciato nel migliore dei modi, con Vittorio Emanuele II re d’Italia, ma già allora si poteva notare come il comportamento del monarca fosse inferiore alle aspettative e inadeguato ai problemi di uno stato appena nato. Rozzo, per certi aspetti volgare, ostile nei confronti dei politici prese l’abitudine, come i suoi successori, di tenere i piedi in due scarpe, con un indirizzo ufficiale di politica estera diramato agli ambasciatori in aperto contrasto con certe sue manovre sotterranee, di cui i nostri rappresentanti all’estero non erano a conoscenza, con frequenti casi di gaffes diplomatiche che solo per la scarsa considerazione che avevano di lui i reggenti degli altri stati non ebbero fatali conseguenze. Non era una nullità, ma in ogni caso era inadatto al ruolo che ricopriva. Ancora peggio fu il figlio Umberto I, succeduto al padre nel 1878; di indole conservatrice, diede avvio all’avventura coloniale italiana, segnata da tragici insuccessi e dai costi esorbitanti fatti pagare alla popolazione. Il suo è stato un regno di grande corruzione (basti pensare allo scandalo della Banca Romana); inoltre Umberto I appoggiò sempre apertamente un primo ministro come Crispi, che era un autentico farabutto. Fu fautore della Triplice Alleanza con Austria e Germania e sul piano interno una sanguisuga di prima categoria, e guai a chi osava protestare, anche civilmente, perché l’uomo era spietato (ricordate il massacro a Milano del 1898 operato dai cannoni del generale Bava Beccaris con oltre duecento morti fra i dimostranti che pacificamente chiedevano il calmiere del prezzo del grano con una riduzione dell’esosa e odiosa tassa sul macinato?). Fu proprio questa strage ad armare la mano dell’anarchico Gaetano Bresci che a Monza il 29 luglio del 1900 esplose contro il sovrano tre colpi di rivoltella che lo uccisero. La vedova Margherita, che era sua cugina e quindi anche lei una Savoia, ancor più conservatrice del marito, lo pianse coniando anche il famoso appellativo di “Re buono”, del tutto fuori luogo dati i precedenti. Gli successe Vittorio Emanuele III, senz’altro il peggiore, per quanto un po’ più intelligente degli altri. Di meriti che gli si possono attribuire non ne vedo e mi sembra giusto porre in evidenza invece i demeriti che riassumo brevemente. All’approssimarsi della prima guerra mondiale cominciò con il perfezionarsi nel tenere un piede in due scarpe, sostenendo la triplice alleanza mentre invece stava brigando per tradirla e passare alla triplice intesa; nel corso del conflitto poi protesse sempre il comandante in capo generale Cadorna, sebbene la sua incapacità divenisse ogni giorno più manifesta e fu a malincuore, perché costretto dagli alleati, a sostituirlo dopo Caporetto con il generale Diaz; Mussolini non sarebbe andato al potere se lui non l’avesse designato quale nuovo presidente del consiglio e la sua lunga amicizia con il dittatore gli fece chiudere più di un occhio, come sul delitto Matteotti e sulle leggi razziali; non batté ciglio nel caso della guerra d’Etiopia, ben sapendo che sarebbe stato un disastro per le casse dello stato e per quanto tentennante (un giorno sì, un giorno no) sottoscrisse l’atto di entrata del paese nel secondo tragico conflitto mondiale; restò fedele al duce nonostante le sconfitte, sebbene l’opposizione al fascismo crescesse nel paese in modo massiccio e a livello di qualsiasi classe, salvo poi farlo arrestare dopo la famosa seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943. Il suo capolavoro, però, doveva ancora arrivare e fu il modo in cui furono condotte le trattative con gli alleati per pervenire a un armistizio; infatti, mentre trattava con gli emissari americani e inglesi, lasciava aperta una porta ai tedeschi, ma quel che è peggio fu l’8 settembre del 1943, giorno in cui alla radio il Maresciallo Badoglio, dietro sue precise disposizioni, comunicava l’avvenuta cessazione delle ostilità con gli ex nemici, senza essere chiaro, e senza peraltro aver predisposto il necessario su che comportamento avrebbero dovuto tenere i militari italiani di fronte alla comprensibile reazione dei tedeschi (aggiungo che il re aveva rifiutato un consistente aiuto militare, costituito dal soccorso di una divisione di paracadutisti americana, nel timore di veder sminuito il suo prestigio); poi, i personaggi di questo zoo di incapaci, di inetti e di vigliacchi si diedero alla fuga, tipico di chi tradisce e qui i traditi furono ben tre: i tedeschi, gli alleati e il popolo italiano. Di Umberto II, succeduto al padre, che abdicò poco prima del referendum c’è ben poco da dire, anche lui poco capace, ma almeno, viste le tradizioni di famiglia, sincero.
Questi sono stati i Savoia re d’Italia e proprio non se ne sente la mancanza; comunque è sempre meglio conoscerli di più e questo libro di Smith è un’indispensabile fonte a cui attingere a piene mani e con vero interesse.
Indicazioni utili
In lotta con i Pitard e il mare
Se Louis Ferdinand Celine non avesse detto a proposito di Georges Simenon: «Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard, per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni», probabilmente non avrei letto questo romanzo, perché, solo per una sensazione, pensavo che mi sarei trovato di fronte a un’opera assai difforme dalla produzione del narratore belga. In effetti i Pitard è un giallo del tutto atipico, perché l’unico elemento che possa far pensare a una trama di questo genere è un biglietto anonimo che, quasi all’inizio del libro, il comandante Lannec si trova per le mani e che paventa il mancato ritorno al porto di partenza della nave da lui comandata, il Fulmine del Cielo. Questa è un mercantile, con svariati anni dal varo, ma in buono stato che Lannec ha acquistato con il suo secondo e, a fronte di una quota dilazionata del prezzo pattuito, con la garanzia del patrimonio della suocera, la signora Pitard, di cui lui ha sposato la figlia, che a tutti costi è voluta venire a bordo per accompagnarlo in quello che si può definire il primo viaggio della nuova proprietà. La minaccia non è dirompente, ma insinua dubbi, soprattutto in chi, andando per mare, sa di poter andare incontro a tanti rischi. Per quanto i Pitard appaiano sullo sfondo della vicenda sarà il loro comportamento ad accompagnare come un’oscura minaccia la rotta della nave. La presenza a bordo della moglie di Lannec, dal carattere spigoloso, appare già fin dall’inizio una fonte di potenziale conflitto in un ambiente di lupi di mare, che hanno nel sangue un profondo cameratismo. Sarà così un viaggio indimenticabile, un incubo che si palesa con gradualità, alimentato dalle tensioni emotive dei protagonisti e dalla forza bruta della natura. Fra mille difficoltà, incidenti, anche mortali, il Fulmine del Cielo riuscirà a ritornare al porto di partenza, ma per Lannec e il suo equipaggio la vita non potrà essere più quella di prima e resteranno segnati per sempre da un’esperienza che non è da augurare neppure al peggior nemico. La maestria di Simenon è fuori discussione, con quella sua comprovata capacità di sondare l’animo umano, in una fine analisi psicologica che riguarda, oltre il rapporto del comandante con la moglie, anche quello con i suoi uomini. Le atmosfere brumose, le tensioni che si vengono a instaurare sono rese in modo splendido, così come pressoché perfette mi sono sembrate l’ambientazione, con una vita di bordo a cui pare di partecipare, e la descrizione della forza immane della natura, con le onde che spazzano la nave e sembrano volerla ghermire, con gli uomini che, trepidanti, cercano di opporvisi. In certi momenti, nel ricreare il dramma della tempesta che si abbatte sul bastimento, mi sono figurato la scena e ho ritrovato certi spunti epici come nel romanzo di Melville Moby Dick o nel film Master and Commander, diretto da Peter Weir e interpretato magistralmente da Russel Crowe. Non si tratta solo di autosuggestione, ma l’abilità di Simenon è tale da avere l’impressione di rollare con la nave e di andare su e giù, si avverte la stretta allo stomaco degli uomini dell’equipaggio che, stremati, continuano a impegnarsi per salvare le loro vite.
I Pitard, in cui si inserisce anche un elemento di sciocca superstizione, non sarà un thriller in senso stretto, ma è comunque uno di quei libri che non solo si leggono con grande piacere, ma che riescono ad avvincere dalla prima all’ultima pagina. Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesimo capolavoro di Simenon.
Indicazioni utili
Spes ultima Dea
Il 22 agosto 1978 Ignazio Silone, malato da lungo tempo, morì in una clinica di Ginevra. Si chiuse così all’estero l’esistenza di uno che può essere considerato uno dei maggiori narratori italiani, autore di numerose opere di eccellente, se non addirittura notevole qualità. La sua passione per la scrittura non venne meno anche durante la sua malattia, tanto che quando si spense lasciò un romanzo incompiuto, La speranza di suor Severina, più conosciuto con l’abbreviazione di Severina. Il lavoro non era completo, nel senso che c’erano solo gli abbozzi degli ultimi due capitoli, mentre altri erano da rivedere e solo pochi potevano essere considerati definitivi o quasi. Stupì, quindi, quando nel 1981 il romanzo uscì per i tipi della Mondadori; a provvedere al completamento e a quanto necessario per rendere definitiva l’opera fu la moglie Darina, nella convinzione che del marito dovesse rimanere anche questo ricordo; tuttavia, troppo era ciò che non poteva definirsi completato e al di là del fatto che forse l’autore avrebbe magari provveduto a una profonda revisione, ne uscì un’opera che di Ignazio Silone conserva più lo spirito e l’ispirazione che la sua struttura, il che detto più in breve significa che è avvertibile l’intervento di un terzo nella stesura. Ho detto più sopra che pur tuttavia permane l’impronta dell’autore, soprattutto quel motivo ricorrente che si è andato accentuando negli anni e che potrei definire il messaggio di un riscatto dell’uomo che può avvenire solo grazie alla carità e alla speranza, e questo nonostante il pessimismo che contraddistingueva Silone, uomo non esattamente inquadrabile né dal punto di vista politico, nè da quello religioso; infatti un ideale di natura politica era presente in lui, una visione socialista del tutto personale, così come non gli mancava la fede, sebbene non si identificasse in una Chiesa cattolica dogmatica, ferma, incapace di mettere in pratica la dottrina del Cristo fra i suoi fedeli, soprattutto quelli più emarginati. Non sto lì a parlare della trama di questo romanzo, peraltro gradevole, mi limito solo a sottolineare che ancora una volta viene proposto l’invito alla Chiesa di non essere lontana dal mondo, ma di scendere in esso, perchè è inutile parlare di quanto ci ha lasciato Gesù Cristo, se poi non viene messo in pratica; l’eguaglianza non deve essere una vuota parola, la carità non deve essere una gentile concessione, la speranza, negli uomini e in Dio, deve essere la linea guida di un intero operato e così la redenzione e la salvezza non hanno senso se non in una visione collettiva, anziché individuale, come appunto farà suor Severina.
Non aggiungo altro, ma vi invito a leggere questo libro.
Indicazioni utili
Padrone (non padre) dell’Europa
Carlo, detto Magno, nacque il 2 aprile 742 in una località imprecisata e morì ad Aquisgrana il 28 gennaio 814, vivendo quindi per circa 72 anni, un lasso di tempo che oggi ci pare alla portata di tutti, ma che all’epoca era privilegio di pochi. Figlio di Pipino il Breve divenne re dei Franchi nel 758, allorchè scomparve suo padre; ne continuò la politica, volta da un lato a continue conquiste e dall’altro a mantenere un rapporti privilegiato con i Papi. Sul piano militare estese sempre di più i confini del regno, conquistando addirittura quello longobardo e venendo così in soccorso al pontefice Leone III che ne temeva l’espansione, aiuto che fu talmente apprezzato tanto da incoronarlo imperatore a Roma in un soleggiato mattino del Natale dell’800. Certo, questa nuova corona non faceva che sancire gli straordinari risultati ottenuti in tanti anni dai Franchi, popolazione di origine germanica, ma assumeva un significato del tutto particolare, in quanto il territorio dominato era di tale ampiezza da far risorgere l’impero romano d’occidente, senza dimenticare il privilegio di tenere con lo scettro anche la qualifica di difensore della cristianità. Insomma, Carlo di strada ne aveva fatta e poteva ben dirsi soddisfatto, con un riconoscimento della sua potenza anche dal punto di vista della legittimità. Infatti, la corona postagli sul capo dal papa, rappresentante di Dio in terra, era il segno di una volontà non umana, ma divina, a che lui fosse considerato a tutti gli effetti il signore dell’Europa. E’ di questo personaggio che parla il bel saggio storico di Alessandro Barbero, di quest’uomo che aveva in verità una visione non solo di conquista, ma di riunificazione di tanti territori europei fino a ricostituire nuovamente il Sacro Romano Impero d’Occidente. Da lì a definirlo uno dei padri dell’Europa può anche sembrare un azzardo, ma in ciò lo storico piemontese è confortato dal fatto che nel 1957 Schuman, Adenauer e De Gasperi, nel gettare le basi della futura Unione Europea, scelsero come patrono di quella che sarebbe stata la nuova realtà proprio Carlo Magno. Senza voler contestare le teorie di Barbero, storico oculato e che di certo ne sa molto più di me, non sono del tutto d’accordo nel considerarlo uno dei padri dell’Europa; infatti la visione dell’imperatore dei Franchi non era tanto rivolta al futuro, bensì al passato, appunto a quel Sacro Romano Impero d’Occidente che di per sé sembra la negazione di una confederazione quale dovrebbe diventare il nostro continente; gli si possuo però attribuire i meriti di essere riuscito a pervenire a una fusione fra latini e germani, di aver avviato riforme, fra cui, importantissima, quella di un unico sistema monetario, una moneta argentea che può essere considerata un euro primitivo. Come al solito Barbero è capace di presentarci il personaggio in tutte le sue sfaccettature, durante la vita di ogni giorno, una giornata fitta di impegni e lunghissima, perché Carlo era sostanzialmente un accentratore, e delegava poco. I capitoli più belli sono quelli relativi alla guerra, al governo dell’impero, all’impulso dato all’economia, alla macchina militare franca. Fu certamente un grande sovrano, ma la sua figura è oggetto di tante leggende che lo hanno fatto diventare un mito, attribuendogli capacità e meriti di gran lunga superiori a quelli che effettivamente aveva. Il suo regno, comunque, costituì una sorta di piccolo rinascimento in un medioevo prima confuso e chiuso in se stesso. Fu però solo una parentesi e proprio per questo il merito è tutto suo.
Da leggere, ovviamente.
Indicazioni utili
Il congedo di Sebastiano Vassalli
“Ho raccontato l’Italia” così termina l’ultimo romanzo di Sebastiano Vassalli, scritto quando era già consapevole dell’inesorabile progredire del male che l’aveva colpito e che poi l’ha condotto al trapasso il 26 luglio 2015. Questa breve frase, che sintetizza l’intento di tutte le sue opere, ha il sapore di un commiato, un saluto definitivo ai lettori che tanto hanno avuto modo di apprezzarlo. A volte, al termine di un libro l’autore riporta delle note conclusive a maggior chiarimento del testo, ma in questo caso Vassalli ha posto come oggetto di quelle poche paginette un vocabolo che non lascia dubbi: congedo. Per quanto non spinga sulla vena della commozione, quel suo voler giustificare il perché di tutta la sua attività letteraria, con un sottofondo di tenue malinconia, non può non toccare chi legge, non può fargli dimenticare le tante piacevoli e costruttive ore trascorse con la lettura dei suoi libri e sapere che quello sarà l’ultimo, perché il fato ha voluto così, porta a un senso di mestizia e stempera in fondo la tensione emotiva che è cresciuta dentro nel leggere Io, Partenope, che non è forse la sua migliore opera, ma che chiude egregiamente un ciclo destinato appunto a spiegare a noi stessi, gli italiani, chi siamo.
La vicenda di Io, Partenope, in cui la protagonista suor Giulia Di Marco, meglio conosciuta come suor Partenope, è esistita veramente, non è di quelle che possono attrarre come la trama della Chimera, ma Vassalli con opportuni accorgimenti narrativi ripropone un antico conflitto fra potere spirituale e potere temporale, con una Chiesa incline al totale dominio dei suoi fedeli, a cui non è lasciata la benché minima possibilità di un credo autonomo; tutto quello che è al di fuori del comandato diventa eretico, nel concetto dell’infallibilità del papa. Che suor Partenope sia una religiosa che crede in Dio con tutta la sua anima e il suo corpo è fuor di dubbio, che lei attraverso la preghiera raggiunga un punto di contatto con il Creatore è palese e che ritragga, raggiungendo l’estasi, un beneficio spirituale e fisico è inoppugnabile, ma è pratica che si discosta dalle rigide regole della Chiesa e soprattutto è esercitata da una donna, da sempre vista dagli ecclesiastici come un essere inferiore e impuro. Poco conta che raccolga intorno a sé un crescente numero di fedeli, anzi ciò viene visto come un pericolo per il potere di una istituzione religiosa che non solo da sempre predica bene e razzola male, ma che ha come politica principale l’assoggettamento dei suoi fedeli. In poche parole, la Chiesa dell’epoca - ma anche delle precedenti e delle successive - è composta da religiosi che, invece di cercare l’unione con Dio, vuole esclusivamente dominare. E le conseguenze per un’eretica come suor Partenope ( e sono tutti eretici quelli che cercano veramente di vivere da cristiani ) sarà tragica, anche se a lei sarà risparmiata la vita, a differenza della protagonista della Chimera. Le pagine che parlano di questa donna, dei suoi trascorsi miseri, della sua fede genuina e delle angherie a cui viene sottoposta sono per me le migliori del libro, mentre l’ultima parte, in cui si narra della sua amicizia con il noto architetto e scultore Gian Lorenzo Bernini mi è sembrata meno interessante, per quanto la descrizione di una Roma travolta dal “puttanesimo” sia quanto mai efficace e paragonabile, proprio per il vuoto morale che permea la città pontificia, al mondo attuale. Peraltro, come l’opera termina come detto con il Congedo, inizia con un Prologo, on cui rifulge il genio creativo di Vassalli, perché l’autore torna indietro nel tempo, nel ‘600 e segue un’anziana signora fin dentro una chiesa e lì la convince a raccontare la sua vita. La donna è suor Giulia Di Marco, terziaria francescana, che poi in una sorta di narrazione in prima persona, come in un’autobiografia, spiegherà il perché verrà meglio conosciuta come suor Partenope. Vassalli deve avere molto amato questo personaggio, come di certo amava la vita che avvertiva ogni giorno spegnersi e forse quell’invenzione di tornare indietro nel tempo, come se questo non esistesse, non è solo letteraria, ma nasconde l’inconscio desiderio di trovarsi poi in un altro mondo dal tempo immobile, una vaga speranza a cui aggrapparsi prima ancora di chiudere per sempre gli occhi.
Leggetelo, perché lo merita.
Indicazioni utili
Damnatio memoriae
Lucio Domizio Enobarbo (Anzio, 15 dicembre 37 – Roma, 9 giugno 58), più noto come Nerone, è stato il quinto e ultimo imperatore romano della dinastia giulio-claudia, figlio adottivo dell’inetto imperatore Claudio. Conosciuto per l’incendio di Roma, di cui diede la colpa ai cristiani, che per questo furono ferocemente perseguitati, depravato oltre ogni limite, è sempre stato considerato come il simbolo del male assoluto. Ma fu veramente così? Non poco, anzi tanto, contribuirono a questo quadro altamente negativo sia la Chiesa cristiana, che poté così portare al suo mulino i non pochi – ma non furono comunque tanti – martirizzati e due storici romani, di epoca successiva, Svetonio e Tacito, entrambi membri dell’aristocrazia, che trovava la sua naturale collocazione in quel senato così tanto disprezzato da Nerone. Appare evidente, quindi, che le notizie su questo imperatore romano finiscono con il mancare di quel requisito di obiettività che dovrebbe essere proprio dello storico, tanto che in epoca moderna gli studiosi, esaminando i testi che ci sono pervenuti, pur senza poter arrivare a una certezza, hanno rivalutato il personaggio. Non è stato da meno Roberto Gervaso, con questo suo Nerone, opera che, a differenza delle sue altre che ho letto, non mi ha convinto del tutto. Certamente le poche fonti a disposizione, peraltro come si è visto prevenute, non contribuiscono a un chiarimento e di ciò deve essere dato atto all’autore che in buona sostanza, sulla base di congetture, magari anche non improbabili, perviene a un giudizio salomonico, nel senso che Nerone non fu né peggiore, né migliore degli altri imperatori, fatta forse eccezione per Augusto e per Adriano. Si trattava, come nel caso degli altri, di un tiranno, di un padrone assoluto, spesso oggetto di congiure che, scoperte, si risolvevano in bagni di sangue. Né gli si può imputare di aver provocato l’incendio di Roma, anche se la plebe, opportunamente manovrata dagli onnipresenti cospiratori, cercò di incolparlo e lui trovò un miglior capro espiatorio rappresentato da quei cristiani che, benché Roma fosse ampiamente tollerante in materia religiosa, preferivano, come una setta, professare il loro credo di nascosto. Se è indubbio che i primi anni del suo impero furono i migliori e i più proficui per Roma, grazie alla costante presenza di due abili consiglieri come il filosofo Seneca, che era stato il suo precettore, e Afranio Burro, prefetto del pretorio, successivamente, con il ricorrere delle congiure, una delle quali ordita dalla stessa madre, che lui poi fece uccidere, lo portarono a disinteressarsi del lavoro di statista e a occuparsi esclusivamente di due passioni che aveva fin da giovane, e cioè l’ars poetica e le gare con i cavalli. Quando poi conobbe un commerciante di equini, tale Tigellino, fu come un colpo di fulmine, poiché trovò in questo individuo la perfidia e la cattiveria che ancora non si erano manifestate nel suo primo periodo di regno; lo nominò capo dei pretoriani e da allora esplose a Roma la violenza, fiorì il terrore, di cui tuttavia non fu vittima il popolino, a cui Nerone continuò a dimostrare il proprio interesse con donazioni di cibo e con l’allestimento di spettacoli gladiatori. In effetti lo scontro avveniva fra il potere assoluto del tiranno e quello nominale del senato, e in verità prevalse sempre Nerone, fino a quando Tigellino, nella sua sete di odio, non cercò di considerare fra i partecipanti a una congiura gente che non c’entrava, ma che aveva un potere notevole, quello militare; inoltre, i Pretoriani, con la promessa di un ingente guadagno, si ribellarono e il senato lo depose. Nerone fuggì dal suo palazzo e si diede la morte in una dimora suburbana di proprietà di un liberto. Il Senato, sperando così forse di riacquistare i pieni poteri – ma non fu così - decretò per lui la damnatio memoriae e iniziò così quella cattiva fama che è pervenuta ai giorni nostri. Gervaso, comunque, con grande e anche forse troppa prudenza, preferisce darci un ritratto tutto sommato positivo nei primi anni di governo e assai negativo nei successivi, lasciando comunque intendere che non è da considerare il mostro che ci è stato dipinto, bensì un uomo dei suoi tempi, con innumerevoli vizi, ossessionato dalle congiure e violento quel tanto che serviva in uno stato che per stare in piedi aveva bisogno di reiterare la forza.
In tutta franchezza quest’opera non ha particolarmente arricchito la mia conoscenza, ma comprendo i limiti di una pressoché impossibile ricerca, attesa la scarsa attendibilità delle poche fonti storiche. Tuttavia, la capacitò dell’autore di inquadrare il personaggio in un ben preciso periodo storico, in un contesto che giustifica per certi aspetti il comportamento del tiranno, sono elementi che se non portano a una certezza in ordine all’operato di Nerone, consentono però una lettura assai piacevole e ricca di spunti di sicuro interesse.
Indicazioni utili
L’irripetibile vita di Angelo Uras
Se si vuole conoscere il perché degli insanabili squilibri dell’Italia odierna e si vuole comprendere l’incompiutezza di quel grande periodo storico rappresentato dal nostro Risorgimento si deve leggere questo romanzo, un’opera che per valenza letteraria e per i contenuti può essere definita un capolavoro della nostra letteratura. Dietro la vicenda di Angelo Uras, orfano di padre e di condizioni disagiate che eredita bambino un vasto patrimonio dall’eccentrico e anticonformista conte e avvocato Francesco Fulgheri, diventando da adulto un uomo di grande impegno civile, si cela ben altro, si sviluppa un discorso sul mancato obiettivo del nostro Risorgimento, vale a dire quell’unione di spirito e di sostanza di tutti gli italiani, sostituita dall’unificazione delle burocrazie dei precedenti singoli stati, colpa soprattutto del reale intento dei Savoia di ampliare, in danno di tutti, il loro regno.
La Sardegna diventa l’esempio di un’emarginazione di esseri umani abulici e richiusi in se stessi, intolleranti a un’autorità che li spolpa e li persegue, uno sfruttamento che a suo tempo caratterizzò anche il meridione, ribellatosi attraverso un fenomeno troppo sbrigativamente definito con il termine di brigantaggio.
Il romanzo ha più piani di lettura e accanto a quello storico e sociologico figura, maestoso, quello naturalistico, con un’evidenziazione marcata del paesaggio della Sardegna che si compone come una pellicola di fronte a chi legge, natura che si vuole mantenere incontaminata il più possibile, poiché il rapporto fra la stessa e gli abitanti è indissolubile. Ci sono descrizioni di panorami e di atmosfere incredibilmente belle, c’è la forza delle tradizioni che accomuna un popolo che trova nelle sue origini lo stimolo per sopravvivere all’asservimento. Qualcuno potrebbe pensare a certe opere di Grazia Deledda, ma è tutto molto diverso, perché in Dessì c’è un realismo che evita di cadere in qualsiasi stereotipo, senza ricorrere alla ricerca di dubbi usi tipici di una regione; in Paese d’ombre c’è tutta la Sardegna, quella di ieri e quella di oggi, perché l’autore sa cogliere il carattere della sua gente, sa interpretarne i sentimenti, sa portare avanti il discorso di un riscatto che appare sempre di più in’illusione di fronte a uno Stato lontano e insensibile.
Tutto ciò viene raccontato in modo avvincente e semplice, in un italiano che oserei definire perfetto e che di certo Manzoni invidierebbe, insomma è proprio il caso di dire che questo romanzo s’ha da leggere soprattutto a scuola, e il fatto strano è che, benché nel 1972 si sia aggiudicato il Premo Strega, è poco conosciuto, ma senza voler essere maliziosi il motivo di questo oblio appare evidente poiché il potere centrale di uno Stato immobile e che sempre più va allontanandosi dai suoi cittadini non ha alcun interesse che quest’opera, che lo denuncia, sia portato a una conoscenza sempre più ampia.
Il mio commento sarebbe però incompleto se non accennassi almeno a un altro piano di lettura che è quello dei sentimenti, ben evidenziati nel corso della vita di Angelo Uras, un uomo dalla grandiosa umiltà, un eroe tuttavia borghese, orientato sempre a venire incontro alle esigenze dei più miseri, combattuto fra la mentalità inconscia che gli deriva dalla sua condizione agiata e il desiderio di sanare ingiustizie sociali fin troppo evidenti e stridenti. In questo contesto, come per tutti gli esseri umani, non mancano, anzi sono ben presenti l’amore e l’affetto, la passione e la temperanza, in una vita che se gli ha dato tanto, altrettanto gli ha tolto. Ci sono parti indimenticabili, come quelle della morte della sua adorata madre, in un dolore consapevole della fine di una donna la cui esistenza viene naturalmente meno, anche se nelle sofferenze di un male incurabile; c’è tutto lo strazio per la morte di parto della prima moglie, il suo primo e unico amore, e infine c’è la rassegnazione che porta sempre la vecchiaia.
La sua è stata una vita irripetibile, una continua cavalcata fra gioie e dolori, quasi un sogno il cui ricordo, per quanto attenuato, negli ultimi anni riaffiora per dargli uno scopo per tirare avanti, e il tutto è scritto con mano leggera, ma precisa, in una completezza di approfondimenti che raramente mi è capitato di trovare.
Sì, questo romanzo s’ha da leggere perché alla fine sorgerà una misurata commozione che quasi subito si tramuterà in un accentuato senso di serenità.
Indicazioni utili
Un polpettone indigesto
Ritengo opportuna una premessa affinché sia possibile meglio comprendere le mie motivazioni in ordine al giudizio dell’opera: ho avuto modo di leggere i romanzi con protagonista il commissario Ricciardi allorché questi erano editi da Fandango; mi sono piaciuti molto, anche se più di una volta ho espresso all’autore i miei dubbi sulla prosecuzione di una serie caratterizzata sì da personaggi accattivanti, ma con una trama gialla esile e poco interessante. Ho pure consigliato a De Giovanni una diversificazione della sua produzione, scrivendo per esempio dei noir o dei thriller, un po’ come a suo tempo ha fatto Georges Simenon. Si vede però che l’autore napoletano non ha né il talento, né la creatività del romanziere belga, poiché ha preferito inaugurare un’altra serie ambientata ai tempi nostri in un commissariato di polizia napoletano, di cui ho letto il primo (I bastardi di Pizzofalcone) che ho gradito talmente da non essere interessato ai successivi. Tuttavia, la mia simpatia per il commissario Ricciardi, per il brigadiere Maione, per il dottor Modo ha fatto sì che decidessi di sborsare 19 euro per questo Anime di vetro, nella speranza di una lettura gratificante. Dico subito che mi sono sbagliato e che mi sono trovato per le mani un polpettone, indigesto per tanto motivi. La considerevole lunghezza nuoce all’opera, tanto più che una parte non trascurabile è dovuta a una reiterata descrizione dei protagonisti, che in una serie, oltre che superflua, è del tutto inutile. Se poi prendiamo l’abitudine dell’autore di inserire un prologo, degli intermezzi e un epilogo, magari con l’intento di meglio spiegare, in un desiderio di parlare delle passioni umane anche con un approccio filosofico, peraltro di modesta levatura, si può benissimo comprendere come il lettore, più che interessato, finisca con l’essere frastornato, tanto più che, come sempre, la trama gialla è esilissima, con una soluzione finale questa volta altamente improbabile, a cui si accompagna anche una novità costituita dall’interessamento dell’OVRA (la polizia segreta fascista) per Ricciardi. Se questo doveva essere nelle intenzioni dell’autore la ciliegina sulla torta, messo lì, senza nemmeno qualche accenno precedente, sembra del tutto fuori posto e inoltre De Giovanni commette l’errore di far apparire gli agenti segreti come degli incapaci, e invece purtroppo non era così, perché invece erano notoriamente molto validi. A onor del vero il romanziere napoletano si deve essere accorto che era opportuno inserire dei nuovi personaggi dopo la morte della tata Rosa, e così sì è inventato uno spasimante di Enrica, un maggiore tedesco di fede nazista che tuttavia appare uno stereotipo, che probabilmente si finirà con il ritrovare in un seguito. La melodrammaticità dell’autore, inoltre, qui si accentua in un effluvio di pianti, di gelosie e di tormenti, degni di un romanzo d’appendice ottocentesco, ma che finiscono con il togliere spessore ai protagonisti, rendendoli delle macchiette. Questa inclinazione di De Giovanni all’eccesso, se da un lato può servire a conquistare nuovi lettori che amano le opere strappalacrime, presenta però l’inconveniente di non accompagnarsi a un velo di sottile ironia che sdrammatizzerebbe le situazioni, alleggerendo così la prosa e accontentando forse anche quegli appassionati di lettura che non amano situazioni al limite e anche oltre. Insomma, da qualsiasi lato lo si voglia guardare, questo romanzo presenta marcati aspetti negativi che non sono compensati da quelli positivi, costituiti quasi esclusivamente dall’empatia fra il lettore e i personaggi costruita faticosamente nei libri precedenti; anzi, devo dire che Ricciardi, Maione e tutti gli altri hanno finito con il perdere quell’alone di simpatia che così tanto mi era gradito.
Di conseguenza, il mio giudizio non può che essere totalmente negativo, non consigliandone la lettura, poiché per chi già conosce i personaggi sarebbe una cocente delusione e per chi invece per la prima volta si accosta a Ricciardi finirebbe con il non desiderare leggere i precedenti che invece sono ben altra cosa.
Indicazioni utili
Aveva un cuore immenso
Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera, 2 giugno 1882) è un personaggio storico talmente famoso che sembrerebbe superfluo leggere una sua biografia. A scuola se ne parla diffusamente e viene sempre presentato come il più grande patriota italiano, come colui che risultò determinante, nell’ambito del nostro Risorgimento, per giungere all’unità nazionale. Ci viene sempre descritto come l’eroe dei due mondi, per le imprese compiute nell’America meridionale, si esaltano le sue qualità di condottiero, lo si presenta come un uomo in camicia rossa che monta un cavallo bianco e che incita gli italiani alla riscossa. Si accenna appena alla sua onestà e frugalità, quando si dice che dopo l’impresa dei mille, con la consegna al re Vittorio Emanuele II del Regno delle Due Sicilie non volle onori e prebende, ma che si ritirò nel suo eremo di Caprera accontentandosi solo di un po’ di sementi da piantare in quella terra arida e sassosa. È inutile che aggiunga altro, poiché sto parlando di un mito, di un individuo le cui gesta ancor oggi destano meraviglia e fanno pensare a un che di unico e di irripetibile. Ci si chiede, pertanto e comunque, se non si tratti di una leggenda, di un’esaltazione collettiva e chi era veramente Giuseppe Garibaldi. Denis Mack Smith ci fornisce la risposta con questo libro, scritto con l’esperienza e la capacità che gli sono note, ma anche con il cuore, perché l’autore inglese, al pari dei suoi connazionali, ha per il nostro Giuseppe un’autentica venerazione, il che non gli impedisce di scremare il mito per arrivare a un ritratto veritiero, da cui risulta un uomo semplice e umile, dotato di una grande forza di volontà e di un cuore immenso. In questo modo Garibaldi risulta addirittura superiore al suo mito e pagina dopo pagina viene suscitata nel lettore un’autentica commozione. Ed è proprio nello sfatare certe esagerazioni che nel tempo sono maturate sul personaggio, nello scoprire la sua vera e autentica natura che questo rifulge come il sole in un limpido cielo primaverile. Come condottiero fu un eccellente tattico, con diverse vittorie, ma anche alcune sconfitte, e un pessimo stratega, ma ciò non toglie che le uniche vittorie italiane nella seconda e nella terza guerra di indipendenza sono esclusivamente merito suo. Il riunire gli italiani in un unico stato fu da lui considerata una missione, nell’ambito di una visione generale che tendeva ad aiutare gli oppressi nel ribellarsi al giogo straniero, sia che questo fosse quello austriaco, sia che fosse quello argentino. E per quanto sia possibile credere che fosse un guerrafondaio, più di altri sognava un mondo di pace, in cui non esistessero più servi e padroni, senza con ciò desiderare l’eliminazione di chi godeva di tante ricchezze, ma elevando il livello economico delle masse, che alla sua epoca spesso e volentieri facevano la fame. Arrivò, per primo, a ipotizzare un consesso di stati il cui scopo fosse quello di dirimere le controversi che insorgessero fra gli aderenti, anticipando coso l’istituto dell’ONU, e intuì che all’Europa, per ritrovare un suo ruolo ben specifico e ovviare al calo della sua influenza a beneficio degli Stati Uniti d’America, era necessaria un’ unione dei suoi stati. La sua spontaneità si accompagnava a un’innata ingenuità, di cui più volte fece le spese, soprattutto nelle macchinazioni che gli ordirono i politici (in primis Cavour) e lo stesso Vittorio Emanuele II, che avrebbe dovuto trattare molto meglio chi gli aveva così tanto ampliato il regno, ma c’era poco da aspettarsi da un re meschino, falso e vile. In un’Italia sabauda, dove esplose la disgrazia della corruzione, ne fu totalmente immune, anzi cercò ripetutamente di sensibilizzare il parlamento perché desse l’aiuto indispensabile alla quasi totalità degli italiani, che vivevano in condizioni miserabili ed erano costretti ad emigrare per sopravvivere. L’Italia che aveva così tanto contribuito a creare non rispondeva certo alla sua visione di un popolo felice e sempre ebbe nel cuore le sorti di chi, ed erano tanti, la stragrande maggioranza, viveva nella più completa indigenza, sfruttata per un pezzo di pane che non era mai sufficiente a saziare; sempre a loro andò il suo pensiero nella vecchiaia, afflitto da una dolorosa artrosi che ben presto gli impedì di camminare- Fu certamente lo sceneggiatore, attore e regista del nostro Risorgimento, un insieme di ruoli che seppe interpretare con assoluta dedizione.
Si spense come aveva vissuto, povero ma da uomo dignitoso e consapevole che aveva dato tutto se stesso, senza pretendere e senza avere avuto nulla in cambio. Chiese di essere cremato su una pira, ma il re e i politici gli fecero un ultimo tiro, con solenni funerali di stato, un affronto anche da morto a colui che era sempre vissuto in grandiosa umiltà.
Da leggere e rileggere, perché scoprire l’autentica grandezza di un mito non vuol dire demolirlo, ma rendersi conto come la realtà possa essere ben superiore al mito stesso.
Indicazioni utili
Il regalo di Babbo Natale
Georges Simenon è talmente bravo che mi riesce sempre più difficile scrivere un commento critico delle sue opere; non è facile infatti trovare nuove parole per descrivere la sua straordinaria abilità nel sondare l’animo dei suoi personaggi, nel proporci, con apparente semplicità, situazioni in cui con brevi frasi si riesce a comprendere perfettamente l’atmosfera, senza dimenticare ls capacità di fornirci una precisa descrizione dell’ambiente che si materializza davanti agli occhi del lettore; inoltre é dotato di una creatività così ampia da riuscire a proporre nuovi testi la cui originalità li impreziosisce ulteriormente. Sono tutte caratteristiche che si ritrovano in ogni sua opera, anche in questa raccolta di tre racconti abbastanza lunghi;.i primi due sono accattivanti e gradevoli e ritengo di non dover spendere una parola di più, preferendo soffermarmi sull’ultimo che dà il titolo all’intero libro. Sarà perché siamo prossimi al Natale con le sue magiche atmosfere che però vanno disperdendosi, ma Un Natale di Maigret mi è piaciuto in modo particolare. Inizia con la mattina della festività, Maigret che, già sveglio, si gode il tepore del letto, ma che poi decide di alzarsi ed è ancora in vestaglia quando riceve la visita di due dirimpettaie, un’anziana zitella e la zia, madre di fatto adottiva, di una bambina che si trova forzatamente a letto da un po’ di tempo a seguito di una frattura. Una delle due è poco ciarliera, ma la “signorina”, che è una estimatrice di Maigret, insiste e così salta fuori che la bambina asserisce di aver visto nella sua camera da letto - e di notte - Babbo Natale, che le ha lasciato una bambola. La fantasia di bimbi? No, perché la bambola, nuova, c’è davvero e nessuno di casa l’ha donata. Da lì nasce un giallo la cui bellezza risiede nello sviluppo di un’indagine del tutto atipica (il commissario non va al Quai del Orfevres, ma resta in casa, anzi la sia abitazione diventa una succursale della polizia), infarcita di tanti particolari che, senza far perdere di vista il percorso per la soluzione dell’enigma, propone un Maigret casalingo e dà spazio anche a sua moglie, quasi sempre silenziosa e intenta a cucinare, ma che ogni tanto pone domande al marito che saranno punti ben precisi per risolvere il caso. L’atmosfera natalizia, il nevischio, Maigret tenero con la bambina, a cui farà visita, il ritmo non convulso, ma volutamente lento accompagnano una trama di straordinaria originalità rappresentano un piacere particolare per il lettore, tanto che gli sembrerà di essere presente, di respirare l’aria fredda dell’inverno, di avvertire il profumo dei cibi che la signora Maigret sta preparando e infine di rammentare che quello era ancora un Natale come si deve, e non una festa come quella di oggi, votata non alla fede, ma al consumismo.
Indicazioni utili
Fango su fango
Trecentoquarantotto pagine non sono di certo poche e alla fine del libro, quasi costretto a leggere con ben poche interruzioni a causa dell’intricata e appassionante trama, sono arrivato esausto, ma anche soddisfatto. Se La città d’oro mi è sembrato un romanzo per nulla riuscito, con L’angelo del fango ho ritrovato il Gori dei tempi migliori, tanto per intenderci quello di Nero di maggio e di Il passaggio, romanzi in cui il protagonista principale è il capitano dei carabinieri Bruno Arcieri. E non è quindi un caso se anche in quest’opera giganteggia Bruno Arcieri, invecchiato, da pensione, ma diventato nel frattempo colonnello del SID, il servizio segreto italiano. Il palcoscenico è sempre Firenze, ma non quella della visita di Hitler nel 1936 e della liberazione della città avvenuta nell’estate del 1944, bensì quella devastata dall’alluvione dell’Arno del 4 novembre 1966. A ben guardare il romanzo presenta, se pur indirettamente, un collegamento con la lotta per la liberazione di Firenze del 1944 e quindi con Il passaggio, ed è un filo riannodato debolmente, ma che nella circostanza lascia ampi margini di azione a un autore che sembra ritrovare nel fascismo repubblichino o in quello post bellico il terreno ideale per inventare le sue storie. Se le altre narrate hanno trame tutto sommato semplici, questa invece è oltremodo intricata e pur tuttavia scorre su binari ben precisi su cui l’autore è riuscito a farla procedere in un crescendo di colpi di scena e di tensione che vanno a tutto vantaggio del piacere della lettura. Inoltre, come per il passato e nel caso specifico ancora di più, le descrizioni della devastazione della città e dell’atmosfera che vi regna sono elementi particolarmente qualificanti che non poco contribuiscono ad avvincere, in alcuni casi anche impressionando, con il colore funereo del fango e il tanfo della nafta uscita dai serbatoi, che danno una vera e propria sensazione del marciume di una palude. La decomposizione del paesaggio non fa altro che anticipare una decomposizione delle coscienze che possiamo riscontrare nei notabili che quasi fanno a botte per stare accanto al Presidente della Repubblica in visita e ai tragici giochi di potere di cui solo per un soffio Arcieri non resterà vittima. Ma se nel romanzo sulla liberazione di Firenze, nonostante i lutti, i morti colpiti dai cecchini fascisti, le vendette lasciano spazio a un domani di speranza, in L’angelo del fango tutto comincia e finisce con una massa d’acqua fangosa a lordare, o comunque a cercare di lordare anche chi della dignità e della coerenza ha fatto un principio di vita. Nei giochi sporchi dei servizi segreti il colonnello Arcieri rappresenta un mondo passato, di una generazione che ancora credeva che fare il proprio dovere con coscienza e nel rispetto delle norme fosse il codice etico a cui uniformarsi. Immersi nella fanghiglia, ma non ancora lordati dentro sono i tanti giovani, venuti da ogni dove, che sguazzando nel putridume cercano di recuperare i libri della Biblioteca Nazionale; chissà che loro riescano a mantenere la purezza di cuore necessaria, ma il timore è che si perdano poi negli infiniti rivoli del fango morale. L’epoca degli anni di piombo è a due passi, con gli scellerati attentati e gli estremisti rossi e neri che faranno a gara per alimentare la strategia della tensione, probabilmente marionette manovrate da un abile burattinaio di cui non verremo mai a sapere il nome. Ecco nella trama di L’angelo del fango ci sono anche i prodromi di un periodo che mi è toccato vivere, iniziato con l’attentato di Piazza Fontana a Milano e culminato con quello alla stazione di Bologna.
Mi pare superfluo aggiungere che la lettura di questo libro, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco nel 2005, è senz’altro raccomandata.
Indicazioni utili
Il rispetto per gli altri
Almeno io ne sapevo ben poco della storia dei Balcani e in particolare della Bosnia, teatro di un recente conflitto derivante dalle varie secessioni della Repubblica di Jugoslavia, ora non più esistente. Eppure si tratta di fatti di nazioni che ci sono abbastanza vicine, ma che ci sono soprattutto note per massacri di cui spesso ci sfuggono i motivi. Il problema è che quelle zone ci sono sempre sembrate delle semplici entità geografiche, dapprima assoggettate all’impero ottomano e poi a quello austro.ungarico, territori che nel nostro immaginario sembravano costituire un’unica entità e che invece erano e sono popolati da nazionalità ben diverse e ben distinte. Nel leggere questo romanzo storico, scritto da Andric fra il 1942 e il 1943, pubblicato nel 1945 appena finita la seconda guerra mondiale, ne possiamo sapere motto di più e peraltro in modo piacevole, benché il ritmo sia lento, come i secoli in cui si svolge la trama, ma è lo scotto da pagare per poter finalmente capire. Tutto si svolge nella cittadina di Visegrad, sita nella parte orientale della Bosnia, in un arco di tempo che va dal XVI secolo fino alla Prima guerra mondiale. Il protagonista non è una persona, ma un ponte eretto sul fiume Drina per volontà di Mehmed Sojolovic Pascià, un Visir dell’impero ottomano originario del luogo. Questa costruzione, imponente e anche ardita, vede impassibile, come la pietra di cui è fatta, avvenimenti, fatti e conflitti che accaddero in questo lungo periodo in quella terra. Si sviluppano così una serie di racconti, anche di aneddoti, ambientati intorno al ponte o anche sullo stesso dando vita a un romanzo storico epico e di grande respiro, corale, ma anche individuale, con cui Andric ci rende edotti della storia di Visegrad e dell’intera Bosnia, un cuscinetto interposto fra le culture orientali e quelle occidentali, fra la religione mussulmana e quella cristiana, luogo di passaggio di mercanti che si spostano da un mondo all’altro, così che le genti balcaniche si mescolano, inevitabilmente contaminate da altre civiltà, in uno scambio continuo, che se da un lato rappresenta una fonte insperata di crescita, dall’altro è motivo di conflitti, spesso sanguinosi. Ivo Andric descrive e racconta con un senso di umana pietà, approfondendo le tematiche e senza mai giudicare, ma non solo, perché ha la capacità di farci rivivere situazioni e ambienti, finendo con il porgerci la mano per poter entrare anche noi nel cuore di quella che é l’ex Jugoslavia.
Pagina dopo pagina si finisce con l’essere avvinti e giunti all’ultima mi sono accorto che Andric è riuscito a sfatare i miei preconcetti, in un messaggio, di grande efficacia, di pace e di rispetto, non solo fra quelle etnie, ma per tutte le etnie, poiché la storia che ognuno di noi si porta dietro, quella che chiamiamo le nostre radici merita lo stesso rispetto di quella degli altri. E quindi Il ponte sulla Drina va oltre il semplice romanzo storico, ma è una di quelle opere che restano patrimonio dell’umanità.
Indicazioni utili
Maigret in pensione
Continuo nella lettura dei racconti gialli di Simenon, soprattutto in questo periodo che viaggio spesso in treno, il che mi consente, durante il tragitto, di iniziarne e di ultimarne anche più d’uno. Nel caso di Minacce di morte e altri racconti si tratta di cinque prose di diversa lunghezza (in totale l’opera consta di 166 pagine), con alcune più riuscite e altre meno, come nel caso di quella che dà il titolo all’opera, con un tentato omicidio in un ambito familiare caratterizzato da una grettezza quasi inverosimile. Nella circostanza Simenon ha calcato un po’ troppo la mano, con dei personaggi un po’ all’eccesso e quindi sicuramente meno credibili. Di miglior qualità mi sono parsi Vendita all’asta, ambientato in un’osteria di campagna in cui viene assassinato uno dei partecipanti all’asta di una limitrofa tenuta agricola e Il prigioniero della strada, un pedinamento parigino, in cui nasce fra il sospettato e il commissario una sorta di scommessa a chi cederà per primo. I migliori, a mio avviso, sono L’enigmatico signor Owen e Quelli del Grand Café, che presentano la novità di un Maigret in pensione. Nel primo l’ex commissario si trova a soggiornare in un Grand Hotel della Costa Azzurra in cui viene commesso un delitto, nel secondo, che è un autentico gioiello, lo troviamo, con la consorte, in un paesino di campagna dove si è ritirato a vivere, una volta cessato il servizio. In questo Simenon ricrea in modo perfetto quella che è la vita di un pensionato il cui problema è di trovare come passare il tempo e allora c’è la pratica della pesca, il lavoro nell’orto e la puntuale partita a carte di ogni giorno in un bar, sempre con gli stessi giocatori, di cui uno viene ammazzato. Il piacere della lettura non risiede tanto nella ricerca dell’assassino, quanto nell’atteggiamento dell’ex commissario nel dilemma fra disinteressarsi del delitto o dare il suo prezioso contributo alle indagini. È un Maigret combattuto fra il risolversi a iniziare una nuova vita, o a continuare a essere pesantemente influenzato dalla precedente, e in questo dubbio amletico emerge ancora una volta la straordinaria abilità di Simenon, che ci fornisce l’immagine di un uomo che non si rassegna ad abdicare, ma che comprende anche che un certo tempo è finito e che di questo dovrà serbare solo il ricordo. Ed è proprio questo racconto che secondo me si contrappone in modo chiaro a quello più modesto che dà il titolo all’opera e che ci permette di scoprire un altro Simenon, capace di ricreare con acume e abilità un comportamento del tutto umano in una persona che, dopo aver lavorato con passione e dedizione per tanti anni, si vede ora costretta a reinventarsi la vita: è un lampo di genio di un autore che, essendo un’artista, non andò mai in pensione, né poté trovarsi in una simile situazione.
Indicazioni utili
La Sublime porta
L’impero ottomano, chiamato anche Sublime porta, è durato più di sei secoli, all’incirca dal 1300 fino al 1922 e prima che iniziasse la sua decadenza, avviata nel 1699, quando i turchi, pressati dagli austriaci, dovettero abbandonare l’Ungheria e la Transilvania, fu una potenza antagonista del mondo occidentale, costituendo una reale minaccia per i vari stati europei. Per quanto mi sovviene la memoria, però, a scuola si insegna poco e in modo lacunoso anche una sua breve storia, confinandola più alla minaccia costante dei pirati saraceni e alla famosa battaglia navale di Lepanto, uno dei rari episodi da cui gli ottomani uscirono sconfitti. Nello studente si crea così l’immagine di una potenza feroce, di uno stato impostato e retto ben diversamente da quelli che erano i suoi antagonisti e in pratica si ritrae l’impressione di qualche cosa di lontano dai nostri interessi al punto da non richiedere una maggior conoscenza. È quasi inutile che dica che questo è un errore, perché molto della storia medievale e soprattutto rinascimentale europea potrebbe essere capito meglio solo che si dedicasse un po’ più di attenzione alla Sublime porta. Ho ritratto questa opinione dalla lettura di questo interessante libro (Il divano di Istanbul), scritto da Alessandro Barbero, uno storico di cui vado sempre più apprezzando il rigore logico e l’indubbia obiettività. Il titolo in verità può apparire fuorviante, richiamando quel pezzo d’arredamento quasi sempre presente nelle nostre case e grazie al quale possiamo riposare senza dover necessariamente dormire, a meno che non ci troviamo di fronte a un televisore acceso. No, quel divano non c’entra, perché in turco è con il termine divan che si indica il governo. Fatta questa premessa, preciso che il lavoro di Barbero, a cui non manca di certo la capacità di rendere attraente e comprensibile un’opera anche a un profano, nella circostanza, come impostazione, appare più cattedratico, pur non assumendo caratteristiche di grevità, e d’altra parte non potrebbe essere altrimenti perché per parlare di un impero così diverso è stato quanto mai necessario dedicare ogni capitolo a una sua caratteristica. Si apprende così che, benché il Gran Sultano, cioè l’imperatore fosse mussulmano, vigeva la più ampia liberta religiosa, che i famosi giannizzeri, la miglior fanteria, era reclutata, come del resto gli addetti di corte e il Gran Visir e l Visir, cioè il primo ministro e gli altri ministri, fra i giovani cristiani dell’impero, che i sudditi, a differenza che in occidente, non erano servi della gleba, legati mani e piedi ai feudi, ma completamente liberi. Sembrerebbe, quindi, uno stato con tanti pregi, ma non mancavano i difetti, fra cui un’endemica corruzione, una continua sete di conquista e anche una chiusura alle novità (influsso questo della religione mussulmana) che faceva scontare un’arretratezza non solo artistica, ma anche economica. Di conseguenza, come tutti gli stati, era caratterizzato da luci e da ombre, ma ciò non toglieva il desiderio dei nostri servi della gleba di esservi sottomessi, pur paventando le incursione dei pirati saraceni, spesso protetti dagli ottomani, e che quanto a ferocia sembra non avessero uguali: arrivavano sulle coste, sbarcavano, assalivano i villaggi, uccidevano gli uomini, oppure li rendevano schiavi, violavano le donne, per poi portarle via per venderle pure loro come schiave. L’esercito ottomano, normalmente, si comportava meglio, ma ciò non toglieva, come anche nel caso degli armati europei, che la conquista di una città sovente finisse in saccheggi e violenze.
Il merito di Barbero è di aver sollevato il velo su questo grande stato, facendoci conoscere cos’era e com’era, temuto, ma anche rispettato, un coacervo plurireligioso e multilinguistico, che molto contava sull’agricoltura, all’epoca una delle più floride, a volte dominato da Sultani debosciati, altre da uomini di grande talento, come nel caso di Solimano il magnifici, detto anche Il legislatore. Ne esce così un quadro che pur in un numero di pagine non ampio, ci offre una serie di notizie che ci portano a conoscere un mondo di cui sapevamo l’esistenza, ma che ci sembrava confinato al di là di una linea che marcava il passaggio dalla realtà alla fantasia.
Da leggere, ci mancherebbe altro.
Indicazioni utili
Eros e Thanatos
Che la vicenda di suor Virginia Maria, al secolo Marianna de Leyva y Marino (Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650) avesse, e ha tuttora, tutti i crismi per attrarre la curiosità, spesso morbosa, della gente è fuor di dubbio. La relazione amorosa con il conte Gian Paolo Osio presenta caratteristiche di sicuro interesse: passione sfrenata, la profanazione del convento, ripetute uccisioni e perfino due nascite. Tuttavia che all’epoca nei monasteri potessero coesistere preghiera e carnalità sfrenata non era una stranezza, anche perché molte delle ospiti non si trovavano lì per autentica vocazione, ma vi venivano richiuse da padri che intendevano tramandare il patrimonio solo al primogenito, senza dimenticare anche i casi, non rari, di giovani che prendevano il velo unicamente per sfuggire alla miseria e con essa allla scarsa e irregolare alimentazione. I fatti di sangue, peraltro, non mancavano, dettati da gelosie o da opportunità. Ma allora perché tanto interesse per quella che è più conosciuta come la monaca di Monza? Se Alessandro Manzoni non ne avesse parlato nei Promessi sposi probabilmente non ci sarebbe stata tanta notorietà; il narratore lombardo la inserì, cambiandone il nome dei protagonisti, rispettivamente in Gertrude e in Egidio, probabilmente per dimostrare quanto in quell’epoca, nonostante la Controriforma, la rilassatezza dei costumi fosse imperante e anche per esaltare maggiormente, per contrasto, la fede, profonda e integerrima, di personaggi come il cardinale Federico Borromeo, che infatti avrà una parte in questa vicenda. Con ogni probabilità Manzoni apprese di questa tresca nel corso delle ricerche da lui effettuate e propedeutiche alla stesura dei Promessi sposi; infatti, trovò le carte del processo e altro, così che ebbe gli elementi per interessarlo, un po’ come fece nel caso degli “untori”, di cui scrisse anche un saggio storico (Storia della colonna infame) ed egualmente fece per suor Virginia Maria e Gian Paolo Osio (La monaca di Monza).
Questa vicenda interessò non solo il popolino, ma anche storici e registi cinematografici, che diedero vita a pellicole per lo più boccaccesche.
Anche Roberto Gervaso ha voluto dire la sua e lo ha fatto da storico appassionato, razionale e imparziale. Nel presentarci l’epoca, l’ambiente e le origini dei protagonisti l’autore ci fa entrare piano piano in una vicenda che oserei definire più squallida che boccaccesca, con questo lazzarone del conte Osio che soddisfa sessualmente non solo suor Virginia, ma anche altre due monache, e spesso gli incontri avvengono simultaneamente con queste tre donne. Senza peraltro scriverlo, sollecita così un’immaginazione che porta a fantasticare su amplessi multipli, su laide carezze e su qualsiasi immaginabile, e anche inimmaginabile, gioco erotico. Ma se Gervaso non è un bacchettone, non è nemmeno un cultore del boccaccesco: si limita a raccontare solo quel che sa dalle carte in suo possesso ricorrendo spesso alla sua sottile ironia, che può essere scambiata solo da un lettore disattento per compiacimento sessuale. No, non si deve temere questo; se il Manzoni nei Promessi sposi per descrivere l’incontro di Suor Virginia con Osio, scrive che, al richiamo di quest’ultimo, La sventurata rispose (in questa brevissima frase ci sta tutto il possibile della tresca che sarebbe stata avviata e la gravità del gesto), lo storico invece descrive con minuzia il fatto, sulla scorta degli elementi in suo possesso, opera anche di altri storici di quel periodo e dei secoli successivi. Però, mette in guardia, nel senso che, secondo la sua esperienza, dà maggiore o minore credibilità a questo o a quell’altro scritto, ritraendone una comprensione personale che partecipa al lettore. Questa è una tecnica che gli è comune e che impreziosisce il saggio, in una ricerca di una verità che si avvicini il più possibile alla realtà. Peraltro, non si esime da un giudizio sui protagonisti, con Suor Virginia che amava solo carnalmente il conte Osio e che non conosceva, né ebbe modo di conoscere un amore diverso, fatta eccezione per quello verso Dio che permeerà la sua lunga esistenza dopo la condanna a essere murata viva (nel senso che dovette vivere in un esiguo spazio chiuso, senza possibilità di vedere il sole, ma con un’apertura che permetteva il passaggio del cibo); la sua diventerà una dedizione assoluta, tanto da convincere il cardinale Borromeo che non solo si era redenta, ma che stava diventano una santa. Se Gian Paolo Osio era un farabutto già prima di conoscere Suor Virginia, se si macchiò di orrendi delitti, per cui fu condannato a morte in contumacia (morì colpito da bastonate mentre era ospite in casa di quello che credeva un amico), tuttavia era effettivamente innamorato di suor Virginia, e non solo sotto l’aspetto sessuale, finendo con il rivelare un carattere diverso da quello che si sarebbe atteso, tanto da prendersi cura, finchè gli fu possibile, della figlia che l’amante aveva partorito. Senza togliere nulla ai suoi tanti demeriti, finisce con il dimostrarsi un essere che sapeva veramente amare, nel modo più assoluto e completo; in questo non era di certo ricambiato, anzi era considerato nulla di più di un semplice giocattolo sessuale.
Si tratta quindi di una storia, vera, a tinte forti, in cui l’abilità e il senso di misura di Gervaso sono messe a dura prova, ma quel che ne esce è un racconto che non può lasciare indifferenti, è una vicenda in cui gradualmente le sfumature di morbosità si scolorano, per lasciare il posto a una pietà non di maniera, in cui ognuno dei protagonisti, da carnefice diventa volontariamente vittima.
Da leggere, senza il minimo dubbio.
Indicazioni utili
Era meglio non scriverlo
La città d’oro, più che un giallo storico, è una spy story, ambientata nei primi anni del XVI secolo a Firenze, in diversi paesi europei e addirittura nel da poco scoperto Nuovo mondo. L’autore è Leonardo Gori, di cui ho giù letto e apprezzato Nero di maggio e Il passaggio; nello scrivere questo romanzo non doveva essere tuttavia al meglio delle sue capacità, perché ha creato una sorta di polpettone, con una vicenda intricata, spesso inutilmente, senza capo, né coda, e che alla lunga stanca il lettore che cerca di affrettarsi inutilmente per venire a capo di un mistero, la ricerca di un libro a cui tanti sono interessanti e in primis nientemeno che Nicolò Macchiavelli, che indubbiamente fu lo statista e saggista che ben sappiamo, ma che come dominus dei servizi segreto fiorentini appare poco credibile. E gli altri personaggi? Nemmeno questi sembrano veritieri, anzi sono degli stereotipi, peraltro senza che sia presente un seppure minimo approfondimento psicologico. Certo, con una produzione mondiale di questo genere assai vasta, è difficile inventare qualcosa di nuovo e che sia anche logico, ma nel caso di questo libro non ho trovato niente di originale e nemmeno un filo razionale che possa, pur nella complessità dell’intreccio, essere motivo per appassionare il lettore; detto francamente, dopo un inizio promettente in una Firenze notturna piegata da un morbo misterioso, il romanzo svapora pagina dopo pagina, tanto che a un certo punto sono stato costretto a interrompere la lettura e a non riprenderla più.
Senza voler infierire sull’autore mi auguro - e gli auguro - che si tratti solo di un infortunio nel suo percorso letterario e questo mio giudizio così stroncante mi risulta sia condiviso da molti altri, abituati a un Leonardo Gori che con i romanzi che vedono protagonista il capitano dei Reali Carabinieri Bruno Arcieri ha saputo farsi notare e stimare per l’indubbia capacità di ideare una trama avvincente in un contesto storico e ambientale esposto splendidamente.
Indicazioni utili
Dal paradiso all’inferno
La domanda è d’obbligo: che ci faceva lì l’architetto Manrico Barbarani, stimato professionista della “Milano bene” , in una periferia degradata, dove la notte è un brulicare di prostitute, e il cui corpo esanime è stato trovato da una guardia giurata nei pressi dell’auto-officina Privitera? La mancanza del portafoglio e di un orologio di valore lascerebbe pensare a una rapina, in cui ci è scappato il morto, ma non è stato così, come emergerà nel corso delle indagini svolte dalla squadra speciale del commissario Melis, da poco promosso a vicequestore.
Questo è il primo giallo di Hans Tuzzi che ho l’occasione di leggere, autore di cui avevo apprezzato Il Trio dell’Arciduca, spy story collocata cronologicamente nei giorni che precedettero l’attentato di Sarajevo, con conseguente scoppio della prima guerra mondiale.
Penso che ormai si sia consapevoli che, a fronte di tanti polizieschi scritti in tutto il mondo, riuscire a inventare una trama del tutto originale è come cercare un ago in un pagliaio e del resto la fantasia degli autori ha naturali limiti logici, oltre i quali non si riesce ad andare, e anche questo giallo non sfugge a questa regola. Del resto i narratori che sono capaci di avvincere il lettore con i loro romanzi ci sono riusciti grazie a tre elementi qualificanti: l’invenzione di un protagonista ricorrente, che abbia caratteristiche sue proprie da farlo emergere dall’anonimato, la capacità di ricreare un’atmosfera credibile e pertinente la trama, l’analisi psicologica dei personaggi. In questo compito non certo facile brillano, fra gli altri, Georges Simenon, con il suo commissario Maigret, Andrea Camilleri con Montalbano e Maurizio De Giovanni con il commissario Ricciardi. Questi autori sono per me un preciso punto di riferimento, a cui mi sono uniformato nel corso della lettura di Un posto sbagliato per morire. Dico subito che Hans Tuzzi è stato capace di concretizzare questi elementi qualificanti, anche se l’analisi psicologica mi è parsa preponderante rispetto all’atmosfera che, per certe caratteristiche, a volte rispecchia alcuni stereotipi e quindi manca di originalità. Potrebbe anche trattarsi di una mia impressione limitata al caso specifico, tanto che mi sono ripromesso una verifica leggendo altri gialli di Tuzzi, ma comunque è quello che ho subito pensato quando sono arrivato all’ultima pagina e ho chiuso il libro. A scanso d’equivoci, comunque, non é che questo giallo non sia ben scritto e avvincente, ma secondo me se l’autore avesse posto più attenzione nel porre l’accento, con originalità, sul divario fra una Milano del centro, opulenta, e una periferia squallida il risultato sarebbe stato indubbiamente migliore.
La lettura è in ogni caso consigliata, perché gradevole e comunque appagante.
Indicazioni utili
Quattro autentici gioielli
Abituato ai romanzi di Simenon, che è uno dei miei autori preferiti, ho avuto la naturale curiosità di verificare se anche in una prosa assai più breve quale il racconto il narratore belga riuscisse a dimostrare le sue straordinarie capacità. Infatti, benché si tratti sempre di narrativa, la lunghezza assai più contenuta impone un notevole sforzo al fine di esporre in poche pagine una vicenda completa, che nel caso del giallo si può riassumere in uno o più delitti, nelle indagini e nell’assicurare alla giustizia il colpevole o i colpevoli. Quindi ci sono necessariamente anche meno parole per l’analisi psicologica dei personaggi e per ricreare ambiente e atmosfera, aspetti che Simenon cura in modo particolare, ottenendo risultati di assoluta eccellenza, magari lasciando in secondo piano l’intreccio vero e proprio. Dico subito che la lettura di La pipa di Maigret e altri racconti mi ha lasciato stupefatto perché non solo l’autore è riuscito a far emergere le sue capacità, ma anche a imbastire delle trame che sono particolarmente avvincenti e che si fanno apprezzare per la rigorosa logica a cui sono improntate. Senza ovviamente svelare il contenuto di ognuno di questi quattro racconti, di lunghezza variabile, dico che il primo, quello che dà il titolo al libro, vede un testimone che ruba la pipa del commissario, il secondo (Non si uccidono i poveri diavoli) ha il suo immancabile omicidio di un uomo tanto umile e modesto da passare quasi inosservato, ma che forse nasconde un’altra esistenza, il terzo (La testimonianza del chierichetto), che è poi quello che mi è piaciuto di più, presenta un interessante accostamento nei comportamenti di un bambino e di un vecchio, il quarto (La vecchia signora di Bayeux), caratterizzato dall’omicidio di una vecchietta, ripropone la nota avversione di Simenon per il mondo fatuo di una certa borghesia di provincia.
Tutti e quattro i racconti hanno come protagonista il commissario Maigret, talora in trasferta per motivi di lavoro in piccole cittadine francesi, mondi spesso silenziosi e chiusi, dove facilmente un viso nuovo può apparire come un intruso. In verità, questo è l’ambiente preferito dall’autore, perché in una comunità ristretta, benchè le indagini possano sembrare più facili, scontano tuttavia un miscuglio di maldicenza e di omertà.
Questo libro, che si legge velocemente, non dovrebbe mancare nella biblioteca degli amanti del giallo e in particolare di quelli che reputano Simenon un narratore che, al di là del genere, ha lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura.
Indicazioni utili
Il delirio del potere
Vi ricordate l’omonimo film, uscito nel 1957, diretto da Stanley Kubrick e magistralmente interpretato da Kirk Douglas? La pellicola è una libera trasposizione di questo libro scritto da Humphrey Cobb, narratore anglosassone che ha svolto per lo più l’attività di sceneggiatore, ma che con questo romanzo ha realizzato non solo la sua opera migliore, ma anche uno dei grandi capolavori della letteratura mondiale, non dissimile, per livello di eccellenza, a opere come Niente di nuovo sul fronte occidentale, di Erich Maria Remarque, e Un anno sull’altipiano, di Emilio Lussu. Sarebbe facile, di primo acchito, paragonare Orizzonti di gloria a questi due grandi romanzi ed etichettarlo come una prosa pacifista, come un’accusa spietata all’insensatezza e alla bestialità della guerra: sì, Cobb denuncia quanto di inumano ci sia in un conflitto, ma va anche ben oltre, come cercherò di seguito di spiegare meglio. La vicenda narrata è tutto sommato semplice r anche piuttosto lineare. È in corso la prima guerra mondiale, il fronte è quello occidentale e a un reggimento francese, duramente provato da furiosi combattimenti e che si avvia alle retrovie per un più che meritato periodo di riposo, viene imposto dal generale Absolant, comandante la divisione, un uomo ambizioso, gretto, senza cuore e che sogna la Legion d’onore, di tornare indietro e di assaltare una posizione tedesca, il formicaio, pressoché imprendibile. Si prospettano perdite immani, l’esito infausto è quasi scontato, ma se il colpo riesce la carriera è assicurata e l’onorificenza tanto agognata verrebbe senz’altro conferita. Nonostante le rimostranze del colonnello Dax, comandante del reggimento, che cerca di dimostrare l’insensatezza di una simile decisione, l’attacco s’ha da fare. Dax è un militare, un uomo che ha però un po’ di umanità, si batte contro questa decisione assurda, ma tutto è inutile e così, come prevedibile, l’assalto al formicaio fallisce, anzi gli uomini non riescono nemmeno a uscire dalle trincee, dilaniati dalle bombe dell’artiglieria tedesca e falciati dalle raffiche di mitragliatrice. Da notare che, come anche nel film, il nemico non si vede mai e si manifesta solo con l’impersonalità delle bombe e dei proiettili, insomma quasi una metafora di un nemico che è soprattutto in noi. Il generale Absolant vede così svanire i suoi sogni di gloria e già che buono non è si incattivisce ulteriormente e anche per giustificare l’assurdità del suo ordine di conquistare una posizione imprendibile fa ricadere la colpa sui poveri soldati, accusandoli di codardia di fronte al nemico. Vorrebbe procedere alla decimazione, ma il comandante d’armata è dell’idea che sia eccessivo, e quindi decide che siano quattro militari (poi diventati tre per la ferma decisione di un comandante di compagnia di non consegnare un uomo da sacrificare) ad essere presi a caso per sottoporli a un giudizio, già precostituito, di una corte marziale sommaria, cioè senza possibilità di appello e di grazia. Le pagine di questo processo farsa e i preparativi, nonché le fasi della fucilazione, sono senz’altro il meglio del romanzo e provocano nel lettore diverse emozioni, che vanno dalla indignazione a una intensa commozione.
Ci si chiede però il perché un comportamento simile, perché il generale dell’armata accolga, se pur in parte, il desiderio di vendetta del comandante Absolant. Che senso può avere fucilare degli individui per un reato che non hanno commesso? La conclusione è che nel mondo la giustizia non esiste mai, mentre l’ingiustizia é la norma, ma che soprattutto quegli uomini non vengono fucilati per un delitto che non hanno commesso, ma come esempio agli altri, che d’ora in poi sapranno che non esistono alternative: o morire per la vittoria, oppure morire davanti a un plotone di esecuzione. Chi potrebbe salvarli, cioè il comandante d’armata, non lo fa, perché non solo è convinto che l’esecuzione costituisca il miglior monito, ma anche per quella perversa prevaricazione che consente a uomini indegni anche del loro grado di dimostrare il loro potere assoluto, per l’inconsapevole appagamento che costoro possono ritrarre nel decidere il destino di esseri umani e che con ogni probabilità ripaga ampiamente gli insuccessi derivanti unicamente da una perniciosa miopia.
È inutile che aggiunga che Orizzonti di gloria merita ampiamente di essere letto.
Indicazioni utili
Un tentativo di riscatto
Andrea Camilleri, di tanto in tanto, rispolvera fatti e personaggi del passato, quasi del tutto caduti nell’oblio, per trarre lo spunto per interessanti e piacevoli romanzi storici. È il caso di quell’autentico capolavoro che è Il birraio di Preston, oppure di La setta degli angeli, una sorta di bunga bunga di inizi ‘900. Il re di Girgenti é basato su un fatto accaduto realmente nella prima metà del XVIII secolo ad Agrigento, allorché un semplice contadino, uno di quelli che lavoravano a giornata, tale Michele Zosimo, più conosciuto come Zosimo, per alcuni giorni divenne re della città. Che un umile lavoratore della terra, un plebeo potesse diventare un capo popolo e assurgere, sia pure quasi nel tempo di un battito d’ali di farfalla, al trono di un improvvisato regno è materia di per sé particolarmente interessante e in cui Camilleri si getta a capofitto. In sé la vicenda, a parte lo scalpore, non sarebbe gran cosa se l’autore siciliano non ci mettesse tanto del suo, con la rappresentazione di un mondo atavico, in cui sopravvivono – quando ci riescono – migliaia di poveri diavoli, accanto alla stridente realtà dell’opulenza di nobili, la cui indolenza e protervia non viene minimamente scalfita dall’abbondanza di superfluo. Questo terreno, così spaccato, è la coltura ideale perché possa dare i natali a qualcuno che osi sollevare la testa, diventando il simbolo dei sudditi considerati dai padroni più bestie che uomini. Accanto alla figura di Zosimo, esistito veramente, la cui vita è ovviamente romanzata da Camilleri, si ritagliano un angolo di notorietà tanti altri personaggi, del tutto di fantasia, che danno una coralità all’opera tale da costituire uno dei motivi del suo successo. Ma se nell’analisi sociologica dei villani dell’epoca l’autore siciliano fa rientrare un certo alone di magia e di un empirico e rozzo esoterismo, ha la capacità tuttavia di innestare una trascendenza non di maniera, in un’opera che unisce riso e anche pianto, perché il Re di Girgenti non abdicherà, né sarà costretto a farlo; non è tanto l’attribuzione del titolo il suo reato, quanto invece quello di aver richiesto un po’ di giustizia e di umanità. Per la sua ribellione, per la ribellione di un popolo di derelitti che lo ha seguito, finirà sulla forca ed è proprio l’esecuzione forse la parte più riuscita del romanzo; in quelle pagine la parola vola alta e si tocca il sublime. Quindi tanto di cappello a Camilleri e a questo suo lavoro, a cui nuoce solo quel suo linguaggio di dialetto siciliano italianizzato che a volte è comprensibile solo a senso, impedendo così di apprezzare la bellezza della parola giusta al momento giusto.
Indicazioni utili
Quel gran diavolo del dio della guerra
Giovanni dalle Bande Nere, al secolo Giovanni di Giovanni de’ Medici (Forlì, 6 aprile 1498 – Mantova, 30 novembre 1526) è stato forse il più noto condottiero italiano, uno di quegli uomini d’arme che, unitamente alle truppe di cui disponevano, si mettevano al soldo di vari Signori per combattere nelle guerricciole – ma anche in grandi conflitti – che nel Rinascimento erano piuttosto frequenti. Sul suo ardimento e sulla sua capacità tattica non ci sono dubbi, mentre difettava di doti di stratega, tanto che non fu mai messo a capo degli eserciti dei vari committenti, a differenza per esempio del marchese Francesco II Gonzaga. Discendeva, per parte di madre (Caterina Sforza, la Signora guerriera di Imola e Forlì) dal ben più capace condottiero Muzio Attendolo Sforza, dal qualeti ereditò lo spirito indomabile e il coraggio; il padre Giovanni faceva parte di un ramo cadetto della famiglia Medici, come si sa ricca e assai potente. Benché quindi ci fossero tutti i presupposti affinchè il giovane Giiovanni potesse diventare di fatto il padrone di Firenze (lo diverrà suo figlio Cosimo) spinto da uno spirito di avventura indomito preferì abbracciare il mestiere della guerra, che gli diede un’ampia popolarità in un alone quasi di mistica leggenda, a cui contribuì anche la sua morte in ancor giovane età.
Scrivere di quest’uomo significa quindi rievocarne la memoria, magari presentandolo come un cavaliere senza macchia e senza paura, andando incontro facilmente ad abusati stereotipi.
Sacha Naspini, che si può dire abbia visto crescere come narratore e di cui ho individuato subito l’innato indubbio talento, alla prima prova con il romanzo storico non è caduto in questi tranelli, ma ha congegnato un’opera, che pur fedele alla realtà, si esprime attraverso una visione originale, resa anche possibile dal fatto che la vicenda del condottiero viene esposta attraverso gli occhi di un personaggio che ritengo di fantasia, anzi agli inizi è tutto un alternarsi di capitoli dedicati alle vite di Giovanni e di Nicolò Durante (così si chiama quello che è forse il vero principale protagonista). Le due esistenze procedono parallele per un poco, poi convergono giusto quando il lettore potrebbe affaticarsi nel passare da pagine dedicate all’uno o all’altro, mossa abile che consente anche di avere un’idea ben precisa dei caratteri di entrambi. In particolare Nicolò Durante é appassionato di erbe officinali che ne fanno un alchimista, nonché è fedele alla tradizione del suo paese della Conca del Fucino, con la processione di Pentecoste, con la statua di San Domenico portata in giro per le vie ricoperta da serpenti vivi, alcuni dei quali lui si porta sempre appresso in una sacca legata in vita, da cui li toglie per tenerli arrotolati al braccio, onde trarre dal loro comportamento gli esiti dei prossimi scontri, come un vero e proprio negromante. Se Giovanni è un personaggio relativamente semplice, ben più complesso è Nicolò, che osserva, partecipa con valore ai combattimenti, ma sembra sempre assorto nei suoi pensieri, quasi che per lui quella guerra che porta la morte servisse solo per avere di che vivere, non inseguendo certo sogni di gloria, tutto teso a dare risposte alla sua sete di conoscenza. Nel primo c’è il Rinascimento nella sua futura decadenza, nel secondo appare uno spiraglio di quell’illuminismo che si realizzerà ben più tardi. Si potrebbe dire che uno è la forza pura e l’altro è invece l’emblema della ragione. È intorno a loro due che si svolge la vicenda, in un mondo in cui si massacra con indifferenza e con altrettanta indifferenza si è massacrati. Spade contro picche, ma già prendono piede gli archibugi che uccidono senza che si veda il nemico negli occhi. Il mondo delle giostre e dei tornei è al suo crepuscolo e Giovanni dalle Bande Nere rappresenta l’ultimo sole, ancorché morente in una nebbiosa giornata di novembre.
Senza enfasi, rifuggendo ogni retorica, razionale e imparziale Sacha Naspini ci accompagna in questa lunga cavalcata di fine epoca, e senza mai ergersi a giudice, grazie anche a una vena di pietà, ci fornisce l’immagine di un Giovanni de’ Medici vivo e vitale come doveva essere, ma egoista e vanitoso, cattivo marito e pessimo padre, insomma questo gran diavolo, come era anche soprannominato, era solo un dio della guerra, incapace di reggere il peso della pace.
Leggetelo, perché questo romanzo è bellissimo.
Indicazioni utili
Guerra di spie
È il mese di giugno del 1914 e tutta l’Europa è in ebollizione; anche se la vita sembra scorrere tranquilla nei fasti della Belle Epoque soffiano venti di guerra sempre più forti. Dal mare di Trieste viene ripescato il corpo esanime di Celik Yilmaz, un mercante levantino che è anche l’informatore di un giovante agente segreto imperialregio. Si potrebbe pensare a una disgrazia, ma un segno inequivocabile sul capo della vittima è la prova che si tratta di un omicidio.
Perché uccidere un pesce così piccolo? Che cosa aveva di così importante da riferire e che si è voluto che non arrivasse alle orecchie dei servizi segreti austriaci? Sono queste le domande che si pone Neron Vukcic, montenegrino, giovane, ma molto intraprendente, dotato di un finissimo intuito, insomma in breve uno dei migliori agenti di cui disponga l’Austria. Inizia così una spy story che pagina dopo pagina si tinge sempre più di giallo, in un gioco di spie che vede coinvolti anche altri stati, in una corsa tesa a evitare, o a realizzare a seconda di una delle parti contrapposte, l’evento scatenante di quella che sarà chiamata la Grande Guerra. È forse superfluo che dica che Neron riuscirà a giungere alla soluzione, ma senza che il suo paese ne tragga vantaggio, perché la ragion di stato dei politici a volte è di una sottigliezza che cela perfidi interessi. Questo è il primo libro di Hans Tuzzi, che leggo e posso dire che è stata una gradevole sorpresa. Quest’autore, che nonostante il nome è italianissimo (si tratta in effetti di Adriano Bon, nato a Milano nel 1952 e docente universitario) è quel che si suol dire una buona penna. La sua è una scrittura fluida, scorrevole, uno stile fresco che, comunque, riesce a mettere in risalto capacità di ricreare atmosfere veramente encomiabile e poi si ha sempre l’impressione che per questo narratore lo scrivere un libro sia un gioco appassionante, volto sì a coinvolgere il lettore, ma a rendere anche gioioso partecipe lui stesso. E se qualche sospetto ho avuto in ordine al personaggio dell’agente imperialregio (giovane, ma di buona stazza, misogino, appassionato di orchidee) puntualmente alla fine ha trovato conferma, perché l’abile spia, messa in disparte con il pretesto di seguire un’indagine di nessuna rilevanza, matura l’idea di emigrare, di andare in America, dove già in prospettiva si vede sempre chiuso in casa, a coltivare orchidee, a santificare i pasti, a inglesizzare il suo nome, che tradotto sarebbe Nero Woolf.
Posso quindi confermare che Il Trio dell’arcidica è un prodotto di ottima fattura che si legge con vero piacere, tanto che mi sono ripromesso di mettere in agenda altri libri di questo autore.
Indicazioni utili
| 1070 risultati - visualizzati 301 - 350 | « 1 ... 4 5 6 7 8 9 ... 10 22 » |