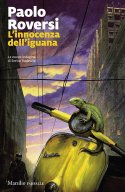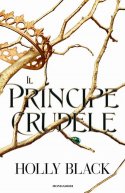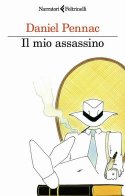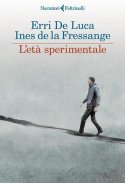Opinione scritta da Renzo Montagnoli
| 1070 risultati - visualizzati 201 - 250 | « 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 22 » |
La grande umanità di Maigret
Un grande allevatore di pecore australiano, straricco, tutto dedito al lavoro, viene in Europa dove scopre che la vita riserva ben altri piaceri, meno monotoni di quello dell’accumulo del denaro, così che finisce per darsi alla bella vita (donne, champagne, panfili), dimenticando quello che ha lasciato nell’emisfero meridionale, famiglia compresa; ma presto questa vita lussuosa e vorticosa viene a noia ed è pertanto necessario scendere i gradini della scala sociale fino quasi a scomparire, trascorrendo alcuni giorni del mese in un bar, bevendo smodatamente in compagnia della padrona, di una prostituta e del suo magnaccia. Proprio fra le mura di quel locale, il Liberty bar, l’uomo ottiene ciò che ha sempre desiderato e cioè un’esistenza anonima e indolente, e tutto filerebbe liscio se non gli accadesse un giorno di tornare nel villino, dove normalmente risiede con una donna e sua madre, gravemente ferito per una pugnalata che lo condurrà alla morte senza nemmeno la possibilità di entrare in casa. É un delitto sulla Costa Azzurra, fuori dai perimetri operativi di Maigret, che tuttavia viene inviato a risolvere il caso con la raccomandazione di andare con i piedi di piombo, alquanto vaga, ma che lascerebbe supporre che la vittima rivesta una particolare attenzione per il governo francese.
Sarà la stagione balneare, sarà una generale atmosfera di rilassamento che accolgono il commissario al suo arrivo, ma sta di fatto che anche lui sembra intorpidirsi, come un gigantesco basilisco al sole. Ciò nonostante arriva anche abbastanza rapidamente alla soluzione, senza tuttavia assicurare alla giustizia un assassino che ha ucciso per gelosia e a cui resta ben poco da vivere, dimostrando un’umanità che già abbiamo avuto di vedere in altre circostanze, ma che qui non è disgiunta da una certa simpatia per il reo, tanto da costituire un’eccezione. Per il resto, in una vicenda tutto sommato semplice, si ritrovano tutte le caratteristiche di Simenon, quali le descrizioni puntuali, l’atmosfera sapientemente ricreata, l’analisi psicologica dei personaggi, una marcata antipatia nei confronti di un’alta borghesia che crede con i soldi di poter comprare tutto.
Da leggere, lo merita.
Indicazioni utili
Il forse è d’obbligo
se mi chiedi un per sempre
ti rispondo forse
se (anche) il tuo infinito
è di tanti piccoli forse
potrei scegliere di camminarti
accanto. Forse
All’inizio del libro, prima ancora della eccellente prefazione di Davide Rondoni, ci sono questi sei versi, un’introduzione dell’autore alla sua opera, che già sono esplicativi della finalità dell’opera stessa, di questa indeterminazione che da sempre accompagna ogni essere umano nel corso di una vita la cui unica certezza è che non sarà eterna. Anche le precedenti sillogi di Angela Caccia non sono meri esercizi poetici, ma riflettono una continua analisi filosofica che coinvolge soprattutto il proprio “io”, ma che inevitabilmente si estende agli altri (e gli altri, non sono forse un complesso di tanti “io”, pur nella loro diversità?). In questa raccolta, forse più che in altre, la trasposizione delle riflessioni in versi è quanto mai varia e scandita con un ritmo pacatamente costante. Nulla viene gridato, ma nemmeno sussurrato, è un canto lento e assorto che qualsiasi orecchio può udire, che qualsiasi mente può comprendere. E’ solo così, infatti, che le mille incertezze, i perduranti e affioranti dubbi possono trovare una letterale forma e costituire la base di quell’ideale dialogo che si svolge fra poeta e lettore. La parola è l’unica certezza dell’autore e questa appare ricercata, non frutto di un istinto, bensì il risultato di un laborioso percorso con cui ciò che è nell’animo viene esplicitato per una maggiore e più coerente conoscenza.
La vita, nei suoi eventi, impone, in chi non si ferma a una loro supina accettazione, una ricerca approfondita per arrivare a chiarimenti, forse, però...
Il senso del giorno, l’esistenza della notte, la vita, la morte, sono fatti ricorrenti, ma anche grandi temi su cui tanti hanno ragionato per cercare i motivi, gli scopi, giungendo anche a delle risposte, ovviamente non certe, cioè può essere così, oppure, forse, tutt’altro. Queste riflessioni già non sono facili da esporre in prosa, immaginiamoci allora in poesia, ma ancora una volta ricorre quel “forse”, perché per Angela Caccia sembra molto più facile la seconda forma.
No, non sono in verità piccoli, questi forse, perché tutto ciò che è parte dell’esistenza appare infinitamente grande, proprio perché non sappiamo perché sia così; piccolo, forse, lo è nella misura in cui, essendo comune a tutti, non ha quell’evidenza di eccezionalità propria di altri. In fin dei conti nulla vi è di grande, né di piccolo nei temi oggetto di queste approfondite riflessioni, c’è solo la vita, nei suoi variegati aspetti, c’è solo il bisogno di una conoscenza a cui ci sforziamo di arrivare inutilmente, o a cui crediamo di arrivare, ma sempre con quel ricorrente e indifferente “forse”.
Piccoli forse è un’altra tappa della ricerca poetica di Angela Caccia, è un’altra raccolta che merita di essere letta.
Indicazioni utili
La speranza
A leggere il breve stralcio riportato nella quarta di copertina si sarebbe indotti a credere che I giorni dello sgomento sia uno dei non pochi romanzi aventi per tema la resistenza e di ciò non ci sarebbe da meravigliarsi, attesa l’attitudine di Fiorella Borin che del romanzo storico ha fatto il suo pane. E invece, mano a mano che scorrono le pagine, ci si accorge che, pur nell’ambientazione storica di quel tragico periodo italiano, l’opera presenta caratteristiche diverse. Senza rinnegare i valori della resistenza, di questa guerra civile che insanguinò per quasi due anni il nostro paese, il romanzo affronta una tematica molto più ampia e, purtroppo, sempre di attualità: l’insensatezza della guerra.
Non ci sono eroi, ci sono solo esseri umani con le loro paure, ma anche con la loro dignità, ci sono quei sentimenti sempre presenti, che magari si rafforzano in tempo di guerra, quali l’amore e l’amicizia. Sono umili della cui umiltà fanno la loro bandiera, persone come tante che incontriamo durante la vita e di cui nemmeno ci accorgiamo. Le figure di questi tre reduci dalla disastrosa campagna di Russia, accolti freddamente dalla gente del loro paese in quanto sconfitti, danno la giusta misura dell’impotenza di ogni uomo di fronte a qualcosa di troppo grande per lui e che non potrà mai capire; i tre sono sgomenti, ma quel che sanno è che l’amicizia è più forte di ogni astio e di ogni odio e che la guerra, che li ha offesi fisicamente e moralmente, è un’orrenda realtà con cui misurarsi ogni giorno. Sì, ogni giorno, perché il loro paese sarà devastato da un grande bombardamento, con numerose vittime, e poi perché, dopo l’8 settembre del 1943, con l’occupazione tedesca, la nascita della Repubblica Sociale Italiana e la ribellione che prende sempre più piede, la tanto auspicata pace sarà solo un ricordo. In poche, pagine le ultime, c’è tutta la sofferenza di quel periodo nelle scorrette prose del diario di Luigino, che frequenta con scarso profitto le elementari, c’è un abbozzo infantile di resistenza che non è un NO deciso verso il nazifascismo in quanto ideologia contraria, ma è un’avversione per quanto di male ha comportato il suo avvento, soprattutto per la guerra che ha scatenato. E, nelle riflessioni che chiudono l’opera, in Cesare, padre di Luigino e unitosi ai partigiani, c’è l’amarezza per la tragica fine dei suoi due compagni in un silenzioso e immaginario colloquio con loro, ci sono i patimenti morali per aver dovuto lasciare la famiglia e per aver dovuto battersi contro degli altri italiani; eppure, proprio perché domani può essere un altro giorno, alla voce dolente di Cesare segue quella meno malinconica di Mariella, sua moglie, che chiude il libro con una speranza, vale a dire che tutte quelle sofferenze non siano state vane e che un giorno i loro discendenti possano vivere in un mondo migliore, un mondo senza più guerre.
I giorni dello sgomento, proprio per la sua atipicità, per la pacatezza che si alza dalle righe, per il messaggio universale che porta è un romanzo che merita di essere letto.
Indicazioni utili
Voglia d’Impero
L’Italia fascista aveva mire di espansione in Africa e poiché questo continente, in cui pure erano ricomprese colonie italiane, era già stato da tempo occupato, o direttamente o attraverso protettorati, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dal Belgio, rimaneva ben poco, in pratica solo l’Etiopia. Ed è a questo stato che già dal 1930 Mussolini iniziò a rivolgere l’attenzione, tanto più che occuparlo avrebbe anche significato una rivincita della cocente sconfitta subita ad Adua il 1° marzo del 1896. Fu così che vennero predisposti con largo anticipo i piani di guerra, anche perché prima si sarebbe dovuto ottenere, se non il consenso, la tacita indifferenza delle altre potenze coloniali. Inoltre, fra i motivi per l’intervento, c’era una situazione economica interna per niente soddisfacente, con una gran massa di disoccupati che avrebbero potuto essere utilizzati per coltivare le terre fertili dell’altopiano etiopico. L’avversario, peraltro, era piuttosto facile da sconfiggere, visto che la struttura statale era ancora embrionale, così come quella dell’esercito, non armato modernamente e privo di aeronautica, tutti elementi positivi per il Duce in quanto la pressoché assoluta certezza di vittoria, con conseguente istituzione dell’impero, avrebbe galvanizzato gli italiani, la cui simpatia per il fascismo si era alquanto intiepidita. D’altra parte, l’eventualità, se pur remota, di una sconfitta avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per il regime e per scongiurare questa infausta ipotesi si preparò la guerra con una larghezza di mezzi mai vista prima e con un onere economico, di cui non si è avuto mai un conto esatto, ma del tutto astronomico e che l’aggiunta delle sanzioni degli altri stati contribuì a far lievitare tanto da indurre il regime a effettuare una sottoscrizione straordinaria mediante il conferimento volontario dell’oro (fedi d’oro contro fedi metalliche, per esempio). Nonostante la nostra netta superiorità di mezzi corremmo il rischio di essere battuti, almeno fino a quando il Negus Hailé Selassié condusse una campagna di guerriglia, senza mai arrivare al confronto aperto in una battaglia campale, che invece sostennero a Mai Ceu il 31 marzo 1936, subendo una batosta da cui non si sarebbe più ripreso. Vi è da dire che, oltre all’armamento moderno degli italiani e il ricorso massiccio alla nostra aeronautica, i due comandanti in capo (erano due le nostre direttrici d’attacco), cioè il maresciallo Pietro Badoglio e il generale Rodolfo Graziani, stimolati da Mussolini, non esitarono a ricorrere a un’arma proibita dalle convenzioni internazionali, sottoscritte anche dall’Italia, e cioè i gas, soprattutto il fosgene, che provocò un’ecatombe fra le truppe e la popolazione etiopica. Formalmente, almeno per noi, con il Negus in fuga e poi in esilio, la campagna terminò il 5 maggio 1936, con l’ingresso nella capitale Addis Abeba delle nostre truppe al comando di Badoglio. Ma la guerra non era terminata, perché avevamo occupato solo un quarto del territorio, al punto che intorno alla capitale pullulavano i guerriglieri etiopi e rendevano difficoltosi i rifornimenti. É pur vero che Graziani, diventato governatore della nuova colonia, usò il pugno di ferro per reprimere i partigiani, con massacri inauditi di cui furono vittime ribelli e popolazione, ma il territorio restò sempre insicuro, al punto che di nostri coloni ne arrivarono ben pochi. Intanto il costo della spedizione aumentava ancora, per fare strade, acquedotti, insomma per dare una struttura al paese; si arrivò così alla seconda guerra mondiale e alla rapida occupazione dell’Etiopia da parte di truppe inglesi ed etiopiche, queste ultime sotto il comando del Negus che non infierì sugli italiani, dando prova di una misericordia che ebbero ben pochi capi di stato e dimostrando così al mondo che lui non era la belva, il senza Dio dipinto da Mussolini, che volutamente non teneva conto del fatto che gli etiopici erano cristiani prima di noi. Aveva inizio così la fine della nostra avventura coloniale (a breve sarebbe seguita la perdita dell’Eritrea e della Libia), con miliardi buttati al vento e un costo nostro in vite umane veramente ragguardevole (fra guerra e guerriglia circa 50.000 morti).
La grande riconciliazione con Hailé Selassiè si ebbe solo il 6 novembre 1970, quando su invito del nostro Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat il Negus venne in visita ufficiale in Italia. Si chiuse così un capitolo, che era proseguito in piena democrazia negando l’estradizione dei non pochi soggetti che si erano macchiati di orrendi crimini in Etiopia, in primis Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani.
Il saggio di Del Boca parla di tutto questo e di altro ancora, e lo fa con il rigore proprio dello storico di razza, cioè verificando sempre prima l’attendibilità delle notizie con riscontri documentali, riportati nell’ampio elenco delle fonti e bibliografia di supporto; lo stile è snello, la narrazione appassionante e, per quanto l’autore cerchi di mantenersi equidistante, più di una volta trapela una simpatia per gli etiopi, per questi coraggiosi e ben pochi armati soldati che si immolarono per difendere la loro patria.
La guerra d’Etiopia è un libro che non delude le aspettative, è una di quelle opere la cui lettura è quasi d’obbligo.
Indicazioni utili
Il sogno di un nuovo mondo
Crescente disoccupazione, lavoratori che vanno perdendo le tutele frutto di decenni di lotte, l’insicurezza che aumenta ogni giorno di più, il mito della crescita che sembra sempre più una chimera, la mancanza di una speranza che qualcosa possa cambiare in meglio fanno sorgere spontanea una domanda: che cosa sta succedendo alla nostra società?
A queste e altre domande hanno cercato di rispondere Francesco Gesualdi e Gianluca Ferrara con un interessante libro edito da Arianna. Lo scopo dell’opera è evidente: trovare i motivi che ci hanno portato allo stato attuale e suggerire i necessari rimedi. Così la prima parte, piuttosto corposa, tende a mettere in evidenza la crisi generale, economica e sociale, indotta dal pensiero neoliberista, che politicamente ha trovato fra i suoi paladini George Bush e fra i suoi teorizzatori il premio Nobel per l’economia Milton Friedman. Non è che abbiano scoperto un’idea nuova, in quanto è propria del capitalismo, e già a metà del XVIII secolo trionfava il laissez faire, laissez passer, cioè una netta repulsione a qualsiasi intervento dello stato in campo economico, nella convinzione che eventuali storture del liberissimo mercato si sarebbero aggiustate da sé. Sappiamo che non è così, tanto è vero che proprio in seguito alla grande crisi economica del 1929, una bolla finanziaria, si decise, dapprima negli Stati Uniti, di ricorrere anche all’indebitamento per avviare grandi opere pubbliche che potessero fornire occupazione e sostentamento a milioni di disoccupati. Fu tuttavia un fuoco di paglia, per quanto nel dopo guerra, anche per contrastare il timore dell’avanzata del comunismo sovietico, venissero adottate misure volte a integrare l’iniziativa privata con quella pubblica. Venuto meno, come è ben noto, il pericolo rosso, il capitalismo, che pur in precedenza non disdegnava l’intervento dello stato quando fosse a sostegno delle sue necessità, rialzò la testa e, influente grazie alle disponibilità finanziarie, ha avviato pressioni sui politici affinché quello stato sociale, frutto di battaglie e faticosamente raggiunto, venisse smantellato. É stata una guerra a tutto campo, che ha coinvolto i mezzi di comunicazione, il mondo della scuola, insomma tutto quanto potesse servire per ridurre il già limitato potere dei lavoratori; inoltre, sono stati indotti i governi a non effettuare investimenti pubblici per sanare la piaga della disoccupazione, al fine di creare una netta sperequazione fra offerta e domanda di lavoro, presupposto indispensabile per avere bassi salari.
Ho esposto solo in parte e in modo molto succinto le problematiche, a cui va aggiunta da qualche anno una riduzione tendenziale della crescita, circostanza che però, a patto di introdurre diversi correttivi, può non essere considerata negativa, anzi una sana e corretta decrescita salverebbe anche noi e il pianeta dal disastro ambientale e dal rischio sempre più concreto di esaurimento delle sue risorse. E con questo scopo si arriva alla parte seconda, alle formulazioni di fini e metodi per ottenere la Società del benessere comune, in cui si lavora meno, in cui il monetarismo tende a diventare un ricordo, dove la solidarietà impera a vantaggio di tutti. La finalità è senz’altro condivisibile, ma i metodi per raggiungerla presupporrebbero un essere umano diverso, un individuo che finalmente ha recepito e fatto proprio il pensiero sociale di Gesù Cristo. Ci si entusiasma anche a leggere le soluzioni, ma poi sorge inevitabile una domanda: si potrà fare? Forse sì, ma ripeto che è il materiale umano che deve essere diverso, altrimenti il tutto resta nel campo delle buone intenzioni. Comunque resta valida la traccia fornita dagli autori e chissà che un giorno dimostri di non essere una semplice chimera, ma dilaghi sul pianeta creando una nuova società, meno ricca, ma più umana.
Indicazioni utili
Noi e l’infinito
Nella breve nota introduttiva dell’autore c’è un cenno a Giacomo Leopardi, con la citazione dell’ultimo verso dell’Infinito (e il naufragar m’è dolce in questo mare), quel perdersi negli spazi incommensurabili dell’infinito, una riflessione che può portare allo sgomento, ma anche a una dolce struggente malinconia. E questo infinito è un motivo ricorrente nella poesia di Gavino Puggioni che, pur tuttavia, resta ancorata alla realtà di ogni giorno, ma tiene conto dell’umano dolore, delle tragedie che accompagnano l’esistenza, quali le ingiustizie e le guerre. Il poeta si chiede giustamente, visto che noi siamo un nulla di fronte a uno spazio temporale che trascende ogni umano concetto, perché mai non dobbiamo condurre un’esistenza di affetti e di pace, senza prevaricazioni, ma solo aprendo il proprio animo agli altri. E ciò appare tanto più indispensabile quando si consideri che la solitudine permea quell’attimo fuggente che è la vita di ognuno di noi. Nascono così dei versi di pacata riflessione, si instaura un dialogo con il proprio “io” volto al coinvolgimento di terzi, si apre un cancello nel muro che altrimenti rinchiude e isola, un desiderio di comunicazione in cui il poeta si libera da vincoli innati e acquisiti nella convivenza, esprime una sincerità offerta in pegno di un reciproco comprendere.
Sono molte le poesie di questa silloge e anche varie, pur nel rispetto di quel fil rouge di cui ho accennato, scritte in una metrica libera che comunque non prescinde dal raggiungimento di un equilibrio strutturale convergente in un’apprezzabile armonia. Non mancano quelle del ricordo, legato alla propria terra e in cui è ben espresso il percorso seguito per cercare di dare un senso alla propria vita (Era la vita / in quelle verdi vallate / bruciate dopo dal solleone / ridente / nell’arcobaleno delle stagioni/…) (Pietra di mare / arsa dal sale / amore nel sole / neve fissata/ nella croce / del tempo). Quella che però esprime meglio il pensiero dell’autore, permeata da un pessimismo esistenziale, è secondo me Questa vita, che merita di essere riportata integralmente perché compendia abilmente quell’infinito senso di solitudine per cui è giustificabile l’accostamento a Leopardi (Questa vita / come l’amore / Questa vita / fatta di terra / e di nuvole / di fumo e di fuochi / Questa vita / che sembra correre / e invece è ferma / fatta di parole inutili / Questa vita / che corre senza argini / nella culla di pensieri / arrugginiti dal tempo / Questa vita / come l’amore / vive di trasparenza / nell’attesa di una porta / che rimarrà chiusa / per sempre).
Ecco, credo che Gavino Puggioni sia riuscito a scrivere una silloge che rappresenta, non solo per lui, il frutto di una lunga serie di riflessioni sull’esistenza, in modo chiaro e senz’altro di gradevole lettura; a mio avviso Afonie indispensabili è il suo capolavoro, magari irripetibile, anche se auguro all’autore di ripetersi, di allietarci con altre e nuove pregevoli raccolte.
Indicazioni utili
Un Petacco ondivago
Mi corre l’obbligo di un’opportuna premessa e cioè che il miglior storico in tema di impero coloniale italiano è, non solo a mio parere, Angelo Del Boca. Ciò non toglie che altri studiosi abbiano cercato di approfondire l’argomento, scrivendo dei saggi nel complesso accettabili. Mi spiace, pertanto, dover parlare non positivamente di questo Faccetta nera di Arrigo Petacco, autore che peraltro stimo per non poche riuscite biografie. E quel che forse meno mi è garbato in questo libro non è tanto l’approssimazione, il liquidare fatti importanti in due parole, ma un atteggiamento ondivago, tanto che a tratti, soprattutto a proposito della conquista dell’Etiopia, Petacco potrebbe essere considerato un fascista, mentre in altre pagine c’è uno smarcamento e ritroviamo il saggista antifascista. Comprendo che, sebbene uno storico dovrebbe essere apolitico, tuttavia non gli si può impedire di avere un atteggiamento politico, ma almeno che questo sia continuo e non come ho precisato prima, tanto che ho ricavato l’impressione che Petacco, nel timore di scontentare qualcuno, ha finito con lo scontentare tutti. Avevo già notato questo strano comportamento leggendo L’uomo della provvidenza e mi ero stupito, perché là a voler considerare Mussolini un grande statista almeno fino alla guerra d’Etiopia vuol dire mettersi i paraocchi, visto che uno dei motivi, non secondario, che spinsero il duce a conquistare quel paese era un diffuso malcontento popolare di un regime che ogni giorno che trascorreva si rivelava sempre più mendace e incapace di condurre un paese sia sotto l’aspetto politico che quello economico. Cosa c’è di meglio di una guerra per ricompattare un popolo accanto al suo capo? E se poi l’avversario, almeno sulla carta, è facile da sconfiggere, si ottiene la quadratura del cerchio, coronata dal pomposo nome dell’Impero, che inorgoglisce, ma non riempie la pancia.
Ecco, dopo aver letto questo libro, di primo acchito l’impressione è che la nostra esperienza coloniale sia stata motivo di vanto, soprattutto con la guerra d’Etiopia, ben condotta, magari con qualche eccesso (basti pensare ai gas utilizzati conto la popolazione inerme), insomma ancora una volta rifulge l’immagine degli italiani eroici, bravi e buoni, ma è falsa, e se questo lo scrive il regime è logico, meno logico è invece se lo si evince da mezze frasi buttate qua e là da uno storico che continuo a stimare, anche se non mi sarei aspettato che nel corso del tempo il suo modo di pensare dovesse cambiare, e non di certo in meglio.
Indicazioni utili
- sì
- no
No, se ci si attende un'analisi approfondita con un atteggiamento neutro.
L’aedo del Sud
Non me ne voglia l’autore, che infatti stimo molto, ma nel leggere le poesie che compongono questa raccolta mi è venuto in mente un altro uomo del Sud, un grande poeta che troppo presto ci ha lasciato: Rocco Scotellaro. Infatti, nei versi ritrovo quel misto di nostalgia e rimpianto, non dissociato peraltro anche da un sentimento di ribellione all’ingiustizia che erano propri del poeta di Matera. Più che somiglianze, direi che c’è lo stesso spirito che, accomunando un lucano con un campano, riesce a dare voce a un meridione avaro di ricchezze materiali, ma ricco di di sentimenti e di aspirazioni, le stesse che nella sua veste di emigrante si porta dietro nella valigia colui che, pur amando la sua terra, è costretto ad andare altrove, per sfuggire alla miseria (noi giovani emigrati del Sud / pietre staccate da montagne / restiamo a Nord vestiti /di lutto per la terra nemica /…). Costretti quasi all’esilio i meridionali vivono nel ricordo di ciò che hanno lasciato, a quelle cose buone di una volta di cui noi, al Nord, non abbiamo più memoria (Ti elogio pane di Montefusco / impasto di grano solare / e acqua leggera di fonte / lievitato di notte pronto / all’alba per salire nel forno /…) (La mia terra ha capelli / spettinati di donna acerba / faggete colme di aquiloni / siepi al sole /….). Ma se la nostalgia può placare il rimpianto, l’assenza di una speranza di ritorno in un sud diverso, volto a riabbracciare i figli dispersi, si traduce in una sorda rabbia per quello che potrebbe essere e forse non sarà mai (Il Sud ha sapori / di ruggine e tradimenti / del poco lavoro della sofferenza /…) e rende ancora più stridente il confronto con un ricco artificioso Nord, dipinto con quei giochi di luce che solo un poeta può vedere (Ci sono notti di pietra. / Milano non dorme / strade arse di petrolio /rombo sopra l’urlo / delle chiese /…). E’ tuttavia una rabbia senza rancore, è il dolore della rassegnazione che mitiga l’affanno nel ricordo, latente, ma sempre pronto a emergere quando necessario (Canto meridionale dove sei? / bussi alle porte antiche / delle case, scendi le scale ripide / che vanno verso il mare / svegli i miti / nel verde dei lecci / sopra sassi puri / reggi le armonie dei cieli. /…).
E’ un meridione che riappare nella nebbia del tempo e la cui debolezza, fonte di un’eterna diaspora, intenerisce il cuore, riluce come una vampa nel focolare e fa sognare anche chi mai l’ha conosciuto.
Una raccolta semplicemente stupenda.
Indicazioni utili
Passioni segrete
Fino ad adesso ero convinto che nessuno, meglio di Georges Simenon, fosse capace di descrivere il ristretto mondo della provincia francese, un’entità socio-economica legata strettamente alla terra, in cui tutto sembra, ed è, immobile, pur seguendo il ritmo delle stagioni. Gente ottusa, questi agricoltori, rinchiusi in comunità dove ognuno sa tutto degli altri, anche dei segreti che spesso sono tipici di questi esseri, ma che li difende strenuamente onde non superino l’ideale limite invalicabile che si sono costruiti. É stata una sorpresa, pertanto, apprendere che anche Irène Némirovsky abbia analizzato queste piccole realtà, riuscendo a descriverle in modo completo e più che comprensibile. Il romanzo da lei utilizzato per questo scopo è Il calore del sangue, un’opera relativamente breve (in tutto 142 pagine), ma estremamente avvincente. Ogni personaggio cela passioni, emozioni, desideri inconfessabili e perciò repressi, così che se in apparenza tutto scorre tranquillo, sotto sotto ci sono fremiti d’amore, odi implacabili, amori adulterini. Nello scorrere delle pagine poco a poco emergono questi vizi privati, in netto contrasto con l’apparenza delle pubbliche virtù; e nessuno ne è immune, anche quelli a cui va la nostra simpatia, soggiogati da comportamenti che sembrano frutto di animi puri e perfino casti. La penna della Némirovsky è impietosa, con donne e uomini che non sanno resistere al calore del sangue e si lasciano travolgere dalle passioni, al punto di arrivare anche al delitto, di cui tutti sanno, ma nessuno parlerà mai alla polizia, perché il mondo là è così e anche un reato deve rimanere la faccenda privata di una comunità. Ma come è riuscita irène, che non era francese, a penetrare così profondamente in un tessuto sociale? Va detto che il romanzo è stato da lei scritto con ogni probabilità nell’estate del 1941 e, guarda caso, è ambientato nello stesso paese (Issy-l'Évêque) dove con la famiglia aveva cercato riparo dalle persecuzioni negli ultimi giorni di maggio del 1940 e in cui sarà arrestata per essere poi avviata ai campi di sterminio. Un’altra particolarità dell’opera è che la voce narrante è quella di Silvio, un proprietario terriero che ha alienato gran parte del suo patrimonio e che vive un’esistenza quasi solitaria, ma che gli consente di osservare meglio gli altri. Anche lui ha provato in gioventù il calore del sangue, ma ormai si è incamminato lungo il viale del tramonto; pur tuttavia, nel ricordo del passato, che si intreccia con il presente, avvertirà anche lui un ultimo calore del sangue, rafforzandosi un desiderio che pareva ormai sepolto sotto la cenere. Ma non è una fiamma, è una brace che lenta, come lui, si spegne.
Dire che il romanzo è bello è riduttivo, perché a mio parere è veramente stupendo.
Indicazioni utili
Diavolo di una ragazza!
Maigret potrà sembrare di primo acchito un burbero, ma se poi lo si osserva con attenzione rivela, in alcune circostanze, una tenerezza che lui cerca di dissimulare accentuando i tratti, a volte spigolosi, del suo carattere. É questo il caso dell’indagine che conduce in ordine all’omicidio di un ex contabile, un uomo solitario che viveva in una casa facente parte di un progetto di vasta lottizzazione; sì, era solitario, nel senso che non aveva amici, ma ospitava una domestica, una giovane ragazza che lo accudiva e che beneficerà della sua eredità. Ma chi può avere assassinato, e per quale motivo, un individuo di cui quasi si ignorava l’esistenza? Che cosa ha da nascondere Felicie, la domestica, che tiene testa alle domande del commissario con una sfrontatezza e un’abilità
perfino superiore a tutti i duri che lui aveva sbattuto in galera? Più che nei risvolti dell’indagine e nella ricerca del colpevole il romanzo sta tutto in questo dualismo, in questa tenzone che agli occhi di Maigret pare un gioco. Lui è consapevole dell’innocenza della ragazza e avverte chiaramente che il suo comportamento è votato alla difesa di qualcuno che lei crede innocente. Tutto qui? Assolutamente no, perché questo romanzo fa perno più sugli innocenti che sui colpevoli, sul carattere di questa giovane che, non contenta del mondo che la circonda, si è chiusa in un bozzolo in cui ama fantasticare, al punto che è cruciale il suo innamoramento per il figlio del padrone, convinta che lui contraccambi e invece non sa quasi nemmeno che lei esista. Questo carattere é senz’altro spinto all’eccesso, ma non era poi raro per l’epoca (il romanzo fu scritto nel 1942), con tante giovani sognatrici che, magari sulla modesta trama di un fotoromanzo, costruivano un’illusoria realtà per sfuggire a situazioni non soddisfacenti e guarda caso si era nel pieno della seconda guerra mondiale. É un Maigret che forse può sembrare irretito da questo personaggio femminile, ma non è in cerca di avventure, perché anche lui ha in fondo bisogno di sognare, di far uscire dal suo intimo quell’affetto paterno per un figlio o una figlia che non ha mai avuto.
Se lo sviluppo dell’indagine e l’arresto del colpevole sono di ordinaria amministrazione, questo duetto fra due sognatori è veramente formidabile, tanto che Félicie è forse uno dei migliori gialli scritti da Simenon con protagonista Maigret.
Indicazioni utili
Una grande dinastia
La città di Mantova, città d’arte, deve le sue fortune ai Gonzaga, una famiglia che vi regnò per circa 4 secoli e che l’abbellì e le diede lustro. Poiché si tratta di una dinastia, fra le più importanti e famose in Europa, non pochi storici ne hanno scritto, con opere anche ponderose e approfondite, ma per il curioso, per il turista che intende visitare la mia città è assai più utile questo libretto di Roberto Brunelli, che è riuscito a compendiare la vita dei maggiori esponenti di questa famiglia in poche pagine, con precisi riferimenti anche ad architetture, o comunque a opere d’arte, che hanno lasciato ai posteri e che sono visibili e accessibili. Pochi forse sanno che il nome di questo casato non era Gonzaga, perché invece si chiamavano in origine, allorché erano solo ricchi agricoltori, Corradi e vivevano appunto a Gonzaga, un borgo rurale a sud del Po. Trasferiti a Mantova, allora libero comune, diventarono presto una delle famiglie più in vista fino a quando, liberatisi dai Bonacolsi, loro concorrenti nel dominio della città, avviarono quel ciclo che li renderà famosi in tutta Europa e li farà assurgere alla nobiltà; fu solo allora, con il conferimento del titolo di marchese, che decisero di privilegiare, per il nome della loro dinastia, il luogo d’origine. Nell’opera di Brunelli troviamo la biografia di tutti quelli che contarono, da Luigi, Primo Capitano (1328 - 1360), a Gianfrancesco, quinto capitano (1407-1433) a primo Marchese (1433 – 1444), e poi Federico Ii, quinto Marchese (1519 – 1530) e primo Duca (1530 – 1540); a seguire tutti gli altri, per arrivare ai Gonzaga Nevers, duchi di Mantova e del Monferrato fino all’ultimo, Ferdinando Carlo, decimo Duca di Mantova e ottavo Duca del Monferrato (1665 – 1707), accusato di fellonia dall’imperatore e deposto e con il quale finì la dinastia. Il lavoro di Brunelli non comprende però solo queste biografie, ma si estende ai cadetti, fornisce ampi spazi in ordine alla storia dei principali edifici realizzati e molte altre notizie che consentono una visione d’insieme, utili per capire chi fossero veramente i Gonzaga e per visitare ciò che ci hanno lasciato. Al riguardo sono numerose le fotografie in bianco e nero e a colori e fra queste non potevano mancare i particolari della celebre camera picta, meglio conosciuta come Camera degli sposi, un affresco di incredibile bellezza realizzato da Andrea Mantegna, pittore di corte di Ludovico II.
Alla luce di quanto esposto, sono dell’opinione che sia più che consigliabile la lettura di questo libro, agevole, facile e piacevole, costituendo, fra l’altro, la base indispensabile per una visita alle bellezze della città di Mantova.
Indicazioni utili
J’accuse
Nelle ultime pagine del romanzo si comprende il motivo del titolo: Germinale è un mese del calendario che corrisponde all’inizio della primavera e con essa di nuove foglie, di fiori, insomma di una rinascita; infatti, mentre il protagonista Stefano lascia le miniere per recarsi a Parigi passando per i campi, d’istinto accosta i minatori ai vegetali che nascono dalla terra e germogliano, così che questa fioritura diventa la metafora dell’insurrezione operaia, di quel lunghissimo sciopero con cui, pur se usciti sconfitti, hanno acquisito la certezza di costituire una forza che prima o poi finirà per trionfare su una esosa e crudele borghesia.
Per scrivere il suo romanzo l’autore, come sua abitudine, si documentò con certosina pazienza, andando addirittura a visitare delle miniere, a vedere con i suoi occhi le inumane condizioni di lavoro a cui erano costretti gli operai, remunerati solo di quel tanto che consentiva loro di sopravvivere.
Zola, uno fra i capostipiti di quella corrente letteraria frutto del positivismo e che prenderà il nome di naturalismo, si prefigge lo scopo di rappresentare la realtà nel modo più oggettivo che sia possibile, osservando, descrivendo e, con lo scopo di mostrare le grande distorsioni di una società. All’epoca della stesura (correva il 1884), a fronte di una borghesia che aveva di fatto soppiantato l’antica nobiltà, esisteva un vasto proletariato, ampiamente sfruttato e spesso abbrutito dalle condizioni di miseria. In questa classe sociale indubbiamente ai minatori spettava la palma dei più disgraziati, costretti a far lavorare sotto terra anche i figli più giovani, senza ritrarre un guadagno dignitoso, ma anzi con una remunerazione appena sufficiente per non morire. E se la paga era inadeguata, l’ambiente di lavoro e i rischi erano infernali; inascoltati, vessati dai padroni questi disgraziati mancavano di tutto, ma specialmente della speranza di un miglioramento della loro condizione. La vicenda descritta del romanzo, cioè quella del giovane meccanico Stefano Lantier, giunto in quelle terre di miniere dopo essere stato licenziato per avere alzato le mani sul suo capo, sceso nelle viscere della terra per trarre il minimo indispensabile per vivere, e che, smanioso di avere un po’ di giustizia per sé e per gli altri, diventa capo popolo, organizzando un colossale sciopero a oltranza, è una di quelle che non può lasciare indifferente il lettore. Zola, poi, sa toccare i tasti giusti, descrive in modo mirabile l’ambiente, ricreando un’atmosfera lugubre, quasi gotica, in cui si muovono, si agitano, si spengono più che degli esseri umani, dei dannati. Se lo scopo iniziale di Stefano era di reclamare per sé e per gli altri un po’ di dignità, mano a mano che si accorge di essere seguito e osannato, di aver realizzato un po’ di potere personale, subentra, pur restando presente lo scopo civile, l’ambizione, il desiderio di primeggiare, di disporre degli altrui destini. Pur con le debite proporzioni, Stefano diventa simile a quei borghesi che combatte, a dimostrazione che è insanabile nell’uomo la sua natura di essere bestiale, portato, qualora circostanze e occasioni lo mettano in luce, al predominio sui suoi simili, in barba a qualsiasi concetto di uguaglianza. É un’amara constatazione quella che lascia trasparire Zola, ma non può sottacere quello spirito di corpo che ha compattato i minatori per uno sciopero da cui non trarranno vantaggi, ma che lascerà una lunga e disperata scia di lutti e di sangue. Senza mai indulgere alla facile commozione, l’autore ha la capacità di stemperare il furore della massa con la struggente visione della giovane Alzira, una dei figli di Maheu, nata rachitica, con la gobba, e che muore di inedia nei lunghi giorni dello sciopero. Come un regista che sa ben manovrare la macchina da presa ci offre immagini memorabili dello scontro con le truppe, in una tensione che arriva a coinvolgere ai massimi livelli il lettore, ma poi c’è tutta una dolcezza di rara bellezza nell’unico rapporto, nella mota, fra Stefano e Caterina, un’altra figlia di Maheu; sono due righe, scritte con un tenero pudore che tutto dice senza malizia e solo con grazia.
Dall’uomo del j’accuse della vicenda Dreyfus, quindi Germinale è un altro j’accuse a una borghesia gretta e insensibile, all’uomo in sé, ricco di egoismo e avaro di altruismo.
É un grande capolavoro, da leggere, rileggere e meditare.
Indicazioni utili
Istruzioni per la vita
Accade, talvolta, che nel leggere le presentazioni o le recensioni di alcuni libri si dica espressamente che si tratta di un romanzo di formazione. Ecco, se si vuol comprendere cosa intenda con questa dizione mi pare opportuno che si provveda alla lettura di La linea d’ombra, un capolavoro e un classico della letteratura mondiale. L’opera venne pubblicata da Conrad nel 1917, un anno che si rivelò uno dei più sanguinosi fra quelli della prima guerra mondiale ed è risaputo che il romanzo, breve, venne dedicato al figlio ferito sul fronte occidentale; più che una dedica, è però da considerarsi un compendio di istruzioni per la vita. Infatti, la linea d’ombra, da cui il titolo, è quel confine indefinibile che segna il momento del passaggio dalla spensierata giovinezza alla concreta maturità, dal desiderio che il domani sia oggi al sogno che il tempo invece possa rallentare; in ogni uomo c’è un periodo di gaia spensieratezza e un altro in cui si comprende di essere diventati indipendenti e responsabili. Non c’è dubbio che La linea d’ombra racconti di un’esperienza dell’autore, una sorta di confessione che, partecipandola ad altri, gli fornisce la conferma del vissuto. La vicenda del secondo ufficiale che sbarca per tornarsene a casa e poi si ritrova comandante di una nave che non naviga certo in acque tranquille, fra bonacce, tempeste della natura e dell’equipaggio, è un po’ la metafora dell’uragano che si scatena nell’intimo quando da giovani si diventa adulti, quando si abbandona il beato stato d’incoscienza per confrontarsi con gli altri e anche con se stessi con i mille problemi della vita. Proprio per comprendere pienamente quel senso di inadeguatezza che ci coglie nel passaggio dalla gioventù alla maturità è uno di quei romanzi che possono essere letti, e ben capiti, solo da un adulto, che avrà fra l’altro il piacere di verificare come anche lui ha navigato in acque infide, fra bonacce e tempeste, fra uomini disperati e trasognati, per poter prendere infine coscienza di se stesso; e così, essere riusciti ad avere la consapevolezza dei propri difetti e dei propri pregi permette di lasciare alle spalle un periodo di gioiosa incoscienza di cui non resterà che un ricordo e a cui più avanti negli anni si guarderà con malinconica nostalgia.
Mi pare superfluo aggiungere che la lettura è da me più che raccomandata.
Indicazioni utili
Il senso di colpa di Maigret
Povera Cécile, 28 anni, bruttina, con l’aspetto già di vecchia zitella, una vita scialba a far da domestica all’anziana zia che, benché ricca, non la pagava nemmeno. Aveva preso l’abitudine di andare ogni mattina al Quai des Orfèvres, dove attendeva di avere udienza da Maigret per certi rumori che avvertiva nella notte nell’appartamento dove viveva con la zia. A onor del vero il commissario aveva fatto fare degli appostamenti per alcuni giorni, ma questi non avevano avuto esito. Anche in quel giorno di foschia lattiginosa si era presentata in sala d’attesa; Maigret intendeva darle udienza, ma preso da una difficile indagine sulla banda dei polacchi si era liberato solo alle 11, quando lei già se n’era andata, lasciando però un bigliettino, con cui implorava di essere ricevuta perché nella notte era accaduta una terribile tragedia. Era inusuale per lei, anche andarsene senza aver avuto udienza, e a Maigret all’improvviso era venuto il terribile sospetto che quella donna, che i colleghi, motteggiando, dicevano essere la sua fidanzata, fosse in pericolo. E lo era, perché il suo cadavere verrà poi ritrovato in uno sgabuzzino dell’adiacente e comunicante palazzo di giustizia. Questi eventi sono il punto di partenza di un poliziesco intricato, dalla soluzione non del tutto convincente che il commissario riuscirà a dare al caso. Quindi, dal punto di vista della trama relativa alle indagini, questo romanzo di Simenon non è dei migliori; si fa apprezzare, invece, per quel senso di colpa che pervade Maigret, il cui desiderio di giustizia qui si fa personale, quasi che trovare il colpevole possa sanare una ferita nell’animo, quel rimorso per non essere intervenuto in tempo. Una volta tanto, più che l’analisi psicologica dei personaggi, è interessante quella di quest’uomo dall’apparenza burbera che si sente ferito anche nel suo orgoglio. Questa personalizzazione dell’indagine si riflette anche in una minore lucidità, tanto che la soluzione, a mio avviso, non è del tutto convincente. Un’ipotesi si sussegue all’altra, ma non si va da nessuna parte, poi, all’improvviso, un passo falso del colpevole, che fino a quel momento non era nemmeno sospettato, metterà il commissario sulla strada giusta, squarciando la confusione che ha in testa e facendo scoprire altri delitti.
Da leggere, comunque.
Indicazioni utili
Indagini su casi irrisolti
E’ risaputo che più il tempo passa, più diventa difficile trovare l’autore, o gli autori, di un delitto. Quando poi non si tratta di anni, ma di secoli la cosa diventa praticamente impossibile. E allora, con quale fine Roberto Brunelli racconta in questo libro di delitti accaduti in territorio mantovano addirittura a partire dal 6 maggio 1052? La risposta è semplice ed è rinchiusa nello scopo dello storico, cioè quel desiderio e quel tentativo di avvicinarsi il più possibile alla verità. Nei casi esaminati, oggetto di questo testo, Brunelli non cerca il colpevole (per un delitto del resto è già notorio), ma si propone di dare una risposta a due semplici domande: quali furono le cause e quali le finalità. Del resto, ancor oggi, il movente è uno degli elementi basilari di un’indagine, come anche il sapere chi può trarre beneficio dall’evento. Credo sia superfluo evidenziare che l’autore formula delle ipotesi, tutte egualmente valide, ma pressoché impossibili da verificare, dato il tempo trascorso. Ne esce così un quadro storico di non comune efficacia, che aiuta a comprendere come si vivesse in epoche in cui le lotte per il potere non erano mai incruente, con la ragion di stato che quasi sempre si identificava nel tornaconto personale.
Si passa così dall’omicidio del marchese Bonifacio di Canossa (6 maggio 1052), trafitto da una freccia durante una battuta di caccia sulle rive del fiume Oglio, a quello del vescovo Guidotto da Correggio, passato a fil di spada il 14 maggio 1235 mentre si recava all’abbazia per presiedere il Capitolo che avrebbe dovuto eleggere il nuovo abate. Stranamente di veri e propri gialli a corte ce ne sono pochissimi, se per corte intendiamo quella dei Gonzaga, che in effetti ricorsero al delitto in misura assai inferiore a quella di altri Signori coevi. Fra i pochissimi ci fu l’esecuzione di Agnese Visconti Gonzaga, sposa di Francesco Gonzaga IV Capitano di Mantova, e del suo presunto amante Antonio da Scandiano. Esecuzione presuppone un processo, che in effetti ci fu, ma è più che mai logico pensare che questo adulterio sia stato artatamente predisposto, con testimonianze non veritiere, e che quindi i rei non fossero colpevoli, tanto da poter parlare di assassinio di stato. Un omicidio vero sotto tutti i crismi fu invece quello del dotto James Crichton, il mirabile Critonio, infilzato dalla spada del bel Vincenzo I, figlio e successore di Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, vicenda peraltro molto ben descritta nel riuscito romanzo storico I leoni d’Europa, scritto da Tiziana Silvestrin. Anche in questo caso conosciamo l’assassino, ma il movente e gli scopi lasciano adito a non pochi dubbi. E infine, a dimostrazione che il giallo non riguarda solo un fatto di sangue, Brunelli nell’ultimo capitolo (Duchesse di Mantova rifiutate:tre) ci porta per mano a comprendere come una dinastia, quella dei Gonzaga, un tempo potente, sia pervenuta alla sua estinzione, un tracollo dovuto all’insipienza e alla disonestà degli ultimi duchi, che non riuscendo anche ad assicurarsi una discendenza, incolparono di ciò le incolpevoli consorti.
Lo stile è snello, i casi interessanti, insomma qui i motivi per leggere il libro sono ben chiari e non danno adito a dubbi..
Indicazioni utili
Quando il silenzio è più forte di un grido
La poesia sa essere immagine, o acuto grido di dolore, e anche tanto altro, perché nei versi si può ritrovare l’anima dell’autore. In genere ogni poeta ha una tematica preferenziale, più volte sviluppata, scavata e ricercata; meno facile che in uno stesso artista si ritrovino argomenti diversi e che questi riesca a fonderli in un equilibrio sostanziale che dona integrità alla lirica, capace di proporsi come autentico specchio delle innumerevoli sfaccettature dell’anima. É questo il caso di Immagine convessa, una raccolta di Vincenzo D’Alessio dedicata al figlio Antonio, scomparso troppo presto e innaturalmente prima dei genitori. Sì, innaturalmente è il termine più adatto, perché se la scomparsa di un proprio caro è sempre dolorosa, qualora questi sia molto più giovane di chi resta appare talmente contro ogni logica che al dolore si aggiunge l’angoscia. Non vorrei, però, che chi legge queste mie righe dovesse pensare che si troverà di fronte a una serie di lamenti continuati, perché non è così, perché il dolore è prima di tutto una lacerazione individuale e interna. Il dolore, per essere tale, non deve essere gridato, si deve convivere con lo stesso, giorno dopo giorno, in un silenzio che di per se stesso è un urlo. Eppure, il figlio ogni tanto ritorna, in versi sommessi (Dio del vento / riportami la voce / di mio figlio / ora tuo figlio / per un attimo di eterno.). E se lì il riapparire nel ricordo è esplicito, meno evidente, ma ancor più presente, è la presenza del figlio nei versi dedicati ai giovani del sud , giovani come quello perduto. Pur tuttavia,
nella presenza saltuaria di una tendenza naturalistica, non manca e anzi è preminente un grande senso civico, una ferma volontà di affermare un’idea di umanità lontana dal materialismo, ma fatta di giustizia e di sostanza. (Solofra terra d’inganni / rubi l’innocenza ai poveri / senza ascoltarne il pianto / distruggi la memoria / con il facile guadagno. /…). E in questo quadro, nel solco di un altro poeta che l’ha preceduto, quel Rocco Scotellaro, che ha saputo vedere la sua terra con il cuore e con la mente, prorompono vitali, quasi anatemi, ma senza violenza, i versi dedicati a un meridione sempre più senza speranza (Non dormiamo sottoterra / l’anima fugge le distanze / il vento accompagna il fischio / dell’uomo dentro le montagne,. / Sud di miseria e tradimenti / strada ferrata senza più ritorni / dove veglia il cuore? / è nuova l’alba, è nuova!).
Se ciò non bastasse, troviamo pure il solco del ricordo che si rincorre, si apre, si chiude, si riapre, ma la memoria non è mai fine a se stessa, è un pozzo a cui attingere per lasciarsi andare a un dolce rimpianto.
Quindi, si tratta di una silloge che presenta una grande ricchezza di varietà tematiche e che probabilmente è il compendio di un lungo lavoro, con poesie più lunghe e più brevi, e fra queste ultime ce n’è una di soli quattro versi che, forse a causa della mia non più verde età, mi si è fissata bene nella mente e nel cuore: Ride il vecchio nello specchio / ha divorato la giovinezza / avidi occhi puntati ai fogli / dell’ultimo quaderno.
Non aggiungo altro, se non la mia calda raccomandazione a leggere questa bellissima raccolta.
Indicazioni utili
I vitelloni in Turchia
Non so se Federico Fellini abbia letto I clienti di Avrenos prima di girare I vitelloni, suo eccellente film del 1953, ma fin dalle prime pagine ho ritrovato la stessa atmosfera in cui trascinavano stancamente la loro esistenza i protagonisti della pellicola, ambientata a Roma, anziché a Istanbul come nel libro. E questo, né giallo né noir, è uno di quei romanzi – rari in verità – in cui Simenon, pur distaccandosi dalle tensioni proprie dei thriller, riesce a ricreare un’atmosfera ovattata, lattiginosa in cui i personaggi si muovono come ombre. Del resto, definirli ombre non è esagerato: tutti rappresentanti di un ceto medio decadente, più che vivere, vegetano, senza impeti sentimentali, incapaci di scuotersi dal torpore in cui da troppo tempo sono immersi.
Si tratta di un gruppo di amici, turchi ed europei, non in grado di dare un senso alla loro vita e che fra una bevuta e una fumata di hashish sembrano avere come unico scopo quello di far trascorrere le ore. Spicca, in mezzo, una donna, una ballerina di night, l’ungherese Nouchi, non proprio bella, ma comunque desiderabile, che proviene dal proletariato e che fra gli amici è forse quella che ha uno scopo, e cioè illudersi di essere diventata ricca, mettendo in pratica continuamente il famoso motto “Carpe diem”. Civettuola, anche se a primo colpo può essere considerata una donna disposta ad andare con tutti, ha la capacità di attrarre e respingere, rendendosi così più desiderabile, una vera e propria esperta nell’arte della seduzione. La quasi totalità dei componenti della combriccola non lavora, vivendo di piccole o medie rendite, oppure si è trovata un’occupazione che lascia molto tempo libero, come nel caso del francese Bernard de Jonsac, interprete dell’ambasciata del suo paese. Da quanto ho esposto appare quindi logico farsi venire in mente il film di Fellini, perché anche qui nel libro siamo in presenza di vitelloni, di esseri che appaiono nati stanchi e incapaci di risvegliarsi, privi di sentimenti autentici e di passioni, a differenza di Lelia, una bella e ricca ragazza che entrerà nel gruppo e ne uscirà come una meteora .
E il titolo? Chi è Avrenos? É il nome di un locale, per la precisione di un ristorante, quello più frequentato dai vitelloni, il campo base per organizzare improvvisate spedizioni verso il nulla.
Da leggere.
Indicazioni utili
Alla conquista del trono di Francia
Arrigo Petacco è un bravo autore di eccellenti biografie nelle quali, pur restando fedele alle risultanze storiche, è capace di far sembrare come vivi i personaggi che in un modo o nell’altro, nel bene e nel male, meritano di essere meglio conosciuti. Sono soprattutto quelli femminili i più riusciti, donne nate troppo presto, cioè in un’epoca nella quale le loro idee risultavano di gran lunga avveniristiche, come nel caso di Cristina Trivulzio di Belgioioso, oppure troppo tardi, ancorate a concetti desueti o comunque prossimi a essere considerati tali, appunto come nel caso di Maria Carolina di Borbone. Costei era la figlia di Francesco I, re delle Due Sicilie, e dell’arciduchessa Maria Clementina d’Asburgo Lorena, figlia a sua volta dell’imperatore Leopoldo II. Minuta, non bella, ma graziosa, anzi charmant, andò in sposa a Carlo Ferdinando d’Artois, duca di Berry, figlio minore del conte d’Artois, il futuro re di Francia Carlo X. Lo sposo aveva vent’anni più di Carolina, ma ciò nonostante
e benché si trattasse di un matrimonio combinato, i due si vollero veramente bene e tutto sembrava procedere per il meglio, nell’attesa che dalla coppia uscisse un figlio maschio, tanto più atteso poiché sarebbe stato l’erede al trono, allorché il duca di Berry venne assassinato. Poco tempo dopo nasceva il tanto sospirato maschio, che prese il nome di Enrico e a cui furono attribuiti, quali titoli nobiliari, quello di Duca di Bordeaux e Conte di Chambord. Tuttavia, con la Rivoluzione di Luglio, nota anche come rivoluzione del 1830, Carlo X fu spodestato a beneficio di Luigi Filippo di Borbone e dovette riparare in esilio in Inghilterra, seguito dall’intera corte e anche da Maria Carolina e dal figlio Enrico. Poiché Carlo X aveva abdicato, restava come legittimo pretendente solo il conte di Chambord, ancora minorenne, e fu per questo che Maria Carolina
cercò di farsi proclamare come reggente. Ma reggente di una corona senza potere sarebbe stato inutile e fu per questo che lei brigò a lungo e tanto fece per addivenire a una sollevazione legittimista, che sarebbe dovuta partire dalla Vandea, con lo scopo di rimettere sul trono quello che era da considerare a tutti gli effetti il naturale successore di Carlo X e cioè il giovane Enrico. Non intendo andar oltre, perché la vicenda è ricca di colpi di scena, di tutti i tipi, al punto che viene da dire che qualche volta la realtà supera la fantasia.
Oltre alla trama particolarmente avvincente il libro è interessante anche per conoscere un po’ di più il periodo della restaurazione in Francia, periodo per certi aspetti caotico e nel quale chi comandava doveva dimostrare una particolare elasticità, tenendo conto, nel riproporre l’assolutismo a cui aveva posto fine la rivoluzione del 1789, delle idee proprie di quella rivoluzione che avevano attecchito in modo incancellabile in parte dei sudditi, soprattutto in quella borghesia che sarà poi il motore pulsante per riportare la Francia alla potenza economica del passato.
Petacco si destreggia bene e non nasconde una certa simpatia per questa donna, che si mette in gioco con l’energia di un uomo e l’entusiasmo di un bambino, senza rendersi conto che non ci sono speranze, che il mondo, il suo mondo, è cambiato in modo irreversibile; eppure si batte, rischia anche la vita, ma sarà tutto inutile, perché perderà.
Da leggere, senza dubbio.
Indicazioni utili
Un po’ troppo lungo
La battaglia di Legnano, combattuta nel 1176 fra i comuni padani, alleati a seguito del giuramento di Pontida che diede origine alla Lega Lombarda, e gli imperiali di Federico Barbarossa, sceso in Italia con un possente esercito per riaffermare il suo potere assoluto, è senz’altro uno degli episodi storici che si studiano a scuola e di cui si conserva più a lungo la memoria. Sarà stata per l’istituzione del carroccio, un emblema di questa alleanza comunale, per i continui rintocchi della campana Martinella, per gli indubbi atti di valore, fra i quali, preminenti, quelli di Alberto da Giussano e della sua Compagnia della Morte, sta di fatto che al di là di più recenti motivazioni politiche questo episodio è ben ricordato, magari con svariate eccezioni di fantasia, ma questa unanime volontà di rivendicare la propria autonomia, anche a costo della morte, è qualcosa che rimane bene impresso, perché nella storia italica, fino all’unità del paese, non esistono altri pronunciamenti simili. Desiderio di libertà, sforzo comune e le battaglie sanguinose sono argomenti che giustificano un romanzo storico sulla vicenda, cosa che ha fatto Franco Forte con La compagnia della morte, opera ponderosa, come testimoniano le 417 pagine, non tutte necessarie, anzi a volte si ha l’impressione che l’autore si dilunghi volontariamente per fare corpo.
E’ forse questa la pecca maggiore di questo libro che, per altri versi, si lascia leggere, pur senza particolari entusiasmi, poiché i personaggi veri e di fantasia non sono ben delineati, mancano di quegli approfondimenti necessari affinché il lettore ne avverta la presenza. Si dà più spazio alla vicenda, alla battaglia, insomma all’epico scontro, ed è un peccato perché con un po’ più d’attenzione e un più ampio risalto ai protagonisti sarebbe potuto sortire un romanzo di pregevole livello, fermo restando il difetto della verbosità, delle lungaggini, del numero eccessivo di pagine non completamente giustificato.
Si lascia leggere, a volte con qualche punta di noia, ma non è di quelle opere che restano dentro; va bene al massimo per trascorrere un po’ di tempo ed è inutile pretendere di più.
Indicazioni utili
Discesa nello squallore
Certo che ci sono vittime che sembrano aver meritato la loro fine, come nel caso del ragionier Cosimo Barletta, uno squallido personaggio, usuraio, profittatore e gran donnaiolo, ma con attenzioni rivolte solo verso giovani ragazze. E vien da pensare che in fondo, con i non pochi nemici che aveva, non è forse un caso se è stato ammazzato due volte, la prima con il veleno e la seconda con un colpo di pistola. Del resto la vittima era di una bassezza quasi unica, usa al ricatto nei confronti di diverse giovani, anzi il ricatto costituiva quasi una prassi, avvalendosi di numerose fotografie scattate in momenti compromettenti, la cui divulgazione avrebbe senz’altro disonorato la ragazza di turno. Più Montalbano, Augello e Fazio vanno avanti nelle indagini, più si rendono conto di scendere poco a poco in un covo di vipere, a cui non è estraneo neppure l’ambiente familiare, con un figlio che ha più di un motivo per odiare il padre Cosimo e desiderarne la morte, e con una figlia che, all’apparenza sembra la migliore, la più presentabile, ma che nasconde inconfessabili tendenze. In questa vicenda di sesso, di amore e di odio Camilleri pare trovarsi a suo agio, senza mai correre il rischio di scivolare nel pornografico o, forse peggio, nella farsa ridanciana. In fondo il ragionier Barletta è sì squallido, ma anche il mondo di cui si circonda non è da meno, e non è facile per un pur bravo investigatore come Montalbano giungere alla conclusione, ma ci riuscirà, trovando il reo che tuttavia non apparirà mai in un’aula di tribunale.
Un covo di vipere è un bel poliziesco, forse uno dei migliori della serie con Montalbano, anche grazie alla capacità di Camilleri di sondare l’animo umano, di mettere a nudo quanto di peggio vi si cela, e il tutto con la consueta prosa scorrevole che non potrà che risultare gradita al lettore.
Indicazioni utili
Si poteva fare molto meglio.
Holodomor, conosciuto anche come l’Olocausto ucraino, è il nome della carestia che gravò sull’Ucraina dal 1929 al 1933, provocando una vera e propria ecatombe, con milioni di morti. Tuttavia, chiamare carestia la mancanza di grano ha quasi il sapore di una beffa, poiché non si trattò di scarsità del raccolto, ma di sottrazione dello stesso per ordine e volere di Stalin, che in tal modo intendeva punire i contadini ucraini per il loro scarso entusiasmo alla pratica della collettivizzazione. La fine della proprietà privata della terra, la deportazione in Siberia dei tanti piccoli proprietari terrieri già di per sé comportò una riduzione della produzione agricola, ma la pressoché integrale requisizione della stessa segnò la fine di milioni di esseri umani. Parlare di genocidio o di olocausto non pare proprio eccessivo quando si consideri che le vittime sono state stimate (dati certi è impossibile averne) in circa 3,5 milioni. Non scrivere, quindi, di un simile fatto è sbagliato, perché è giusto che la gente conosca quanto fosse un “Paradiso” il regime staliniano e anche per rispetto e giustizia verso quelle persone (uomini, donne e bambini) decedute per denutrizione.
Lo fa un ucraino, Vasyl’ Barka, non con un saggio storico, ma con un romanzo, appunto Il principe giallo, e considerato che all’epoca dei fatti lui non solo era presente, ma era maggiorenne, e quindi in grado di capire, nell’opera è profusa questa caratteristica di testimone oculare che, se ben strutturata, avrebbe potuto dare lustro al romanzo, ma purtroppo non è stato così. Questo libro, potenzialmente interessante ed avvincente, presenta tante e tali lacune da renderne ben poco gradevole la lettura. La struttura poco equilibrata, le inutili lungaggini in certe descrizioni, il ritmo di una lentezza esasperante, anziché attrarmi, mi hanno respinto; in particolare ho trovato un’accentuazione della grevità tipica dei narratori dell’est europeo, senza che tuttavia lo spessore del discorso sia di particolare rilievo. Insomma, per farla breve, le mie aspettative sono state ampiamente deluse, tanto che non mi sento di consigliarne la lettura.
Indicazioni utili
La resurrezione dell’avvocato Loursat
Da quando sua moglie Geneviève se ne era andata la vigilia di Natale di diciotto anni prima con il suo amante Bernard, l’avvocato Hector Loursat de Saint-Marc si era rinchiuso in una sorta di bozzolo in cui esistevano giornate sempre uguali, trascorse bevendo e fumando, in una casa troppo grande ormai, benché abitata anche dalla figlia Nicole e dalla cuoca Joséphine, soprannominata Fine, oppure la Nana, una donnetta brutta e magra. Era scattato qualche cosa nella sua testa che gli impediva di vivere, lui che poteva essere considerato un principe del foro e che, di ricca famiglia, poteva permettersi di condurre l’esistenza anche senza lavorare. Nessun dialogo con la figlia, isolato dall’esterno, più che vivere Hector vegetava, fino a quando una sera uno sparo nell’abitazione darà corpo a una serie di eventi che lo indurranno ad affacciarsi al mondo, a rientrare nella società, a essere di nuovo il grande avvocato, temuto e rispettato da tutti. Gli intrusi, scritto nel 1938 e pubblicato l’anno successivo, è un romanzo che in altre mani non sarebbe riuscito bene, ma quando l’idea viene sviluppata da un genio come Simenon non ci sono limiti alla bellezza di un’opera, in cui tutto, dico tutto, risulta in perfetto equilibrio. Se la trama è piuttosto originale, ritroviamo quello stile attento che è proprio dell’autore, con un’ambientazione che oserei definire perfetta e con un’atmosfera che, di pari passo con la rinascita di Hector, passa dal cupo grigio di giorni di pioggia all’azzurro di cieli sereni, e con un’analisi psicologica dei protagonisti - punto di forza di Simenon – che desta ancora una volta meraviglia. Inoltre, e non è una novità, scopo del romanzo è di mettere bene in evidenza le piccinerie della borghesia, un ceto fatto di stolte apparenze e di modeste sostanze,. Non c’è tuttavia cattiveria in Simenon quando descrive il procuratore della repubblica Rogissart, suo cugino per parte di moglie, il suo impegno ad evitare che lo scandalo dell’omicidio travolga anche lui, per effetto della parentela, o quando parla di una certa gioventù, in cui si mescolano ricchi e poveri, questi ultimi invidiosi dei primi, una gioventù che vive di noia e di alcool.
Hector Loursat sembra essere l’unico personaggio positivo, risorto dalla tomba e tornato alla vita cittadina, ma sarà così? Forse, anzi probabilmente no, perché alla radice c’è il problema di base, cioè quell’appartenenza a una borghesia che in ogni caso conduce una vita vuota.
Da leggere, ci mancherebbe altro.
Indicazioni utili
Si sorride e, anche, si ride
Vien da dire che Vigata non ci sarebbe se non ci fosse Camilleri e infatti questa località siciliana è frutto di esclusiva fantasia, per quanto lo stesso narratore abbia voluto identificarla con Porto Empedocle. Certo, l’escamotage così architettato è stato un artificio che gli ha consentito di tessere una fitta trama di vicende, tutte di fantasia, partendo da un modesto, ma concreto piano di verità. A parte gli episodi del commissario Montalbano che si svolgono appunto a Vigata, è tutto un fiorire di racconti lì domiciliati. Al riguardo, mi viene in mente Gran Circo Taddei e altre storie di Vigata, ma anche Il birraio di Preston che è a mio avviso un autentico e irripetibile capolavoro. Ora, la creatività, ma anche la verve comica di Camilleri possono – e lo fanno – stupire per la genialità di alcune trovate, per una serie cospicua di trame mai uguali.
Anche in questi otto racconti ci si lascia volentieri trascinare in una Sicilia sì immaginata, ma che compendia perfettamente tutte le caratteristiche di una qualsiasi realtà abitativa dell’isola. Le avventure possono essere le più disparate e per divertire e interessare non devono essere necessariamente boccacesche, ma devono presentare un paradosso, un qualcosa spinto al limite in base al quale qualsiasi fatto di normale amministrazione deve diventare un evento unico e addirittura irripetibile. E’ questo il caso di Il morto viaggiatore, con un cadavere che non riesce a trovare pace, sbattuto di qua e di là e “ più vivo da morto che da vivo”. Ma anche Il palato assoluto pare l’esaltazione di ciò che non può essere, cioè la totale genuinità del cibo. Il racconto che però ha una valenza più generale, impietoso con un popolo che da sempre vive di piccole astuzie e soprattutto di sogni è L’oro a Vigata, un classico per certi aspetti di un modo di mettere in evidenza le nostre miserie, qui rese ancora più stridenti dall’epoca fascista. Come dicevo, sono otto racconti, qualcuno migliore degli altri, in cui a volte si sorride e altre, più raramente, in cui si ride, una risata amara , come quella che accompagna Lo stivale di Garibaldi, con il quale si comprende come la distanza dallo stato sia stata una costante dalla spedizione dei mille in poi. Lì infatti troviamo una
serie di incomprensioni, da parte di chi non vuole comprendere, che condanna la Sicilia a un isolamento senza appello e la protervia del potere centrale, rappresentata da un ottuso prefetto, non può che far sembrare simpatici quei carcerati che hanno deciso di prendere la via della libertà.
Insomma, si legge con piacere e, anche se non ci troviamo di fronte a un capolavoro, non possiamo che constatare l’apprezzabile svolgimento dei temi, pur confezionati in quel particolare siculo-italiano, che non è né l’una né l’altra lingua, ma solo il marchio di fabbrica di un sempreverde Camilleri.
Indicazioni utili
Chi fu veramente?
Data la fama del personaggio e la sua particolare personalità, scrivere di Benito Mussolini si può considerare una delle massime aspirazioni di uno storico. Arrigo Petacco non fa eccezione ed è stato tentato di stilare una biografia del duce, ma, consapevole delle difficoltà e del fatto che già tanto ha scritto in proposito Renzo De Felice, ha preferito strutturare la sua opera sulla base degli eventi più significativi della vita politica di Mussolini. Non è un caso, quindi, se interi capitoli sono dedicati, per esempio, al Concordato o agli attentati di cui fu vittima. In questo modo è infatti possibile farsi un’idea di quel che fu l’uomo che la Chiesa cattolica considerò mandato dalla Provvidenza, un’idea se vogliamo parziale, ma che porta a mettere in chiaro risalto i pregi (pochi) e i difetti (tanti) che furono propri di Mussolini. La tentazione, però, di trarre delle conclusioni deve essere stata particolarmente forte, tanto che Petacco provvede a dedicare un intero capitolo – e peraltro il primo – per cercare di determinare se ci si trovi di fronte a un grande, oppure a un mediocre protagonista della sua epoca.
Purtroppo, il tempo ancora poco trascorso (nemmeno un secolo), episodi oscuri su cui è indispensabile fare luce (il famoso presunto carteggio Mussolini – Churchill), le varie vulgate costruite ad arte a vantaggio ora dei suoi sostenitori, ora dei suoi detrattori, non ancora sopite, costituiscono difficoltà allo stato insormontabili per poter addivenire almeno a un giudizio parziale. Petacco mi sembra che lo intenda considerare un grande almeno per le decisioni prese fino alla guerra d’Etiopia, quando ancora non era succube di Hitler. Non ho nulla da eccepire sulle capacità politiche e soprattutto su quelle di irretire milioni di italiani, che gli tributarono ampia e non del tutto meritata fiducia, ma al di là della indubbia abilità di essere presente nei momenti più cruciali, per il resto non vedo che cosa ci sia di tanto positivo in quest’uomo e anche se le note fossero le migliori possibili, restano le macchie che cancellano qualsiasi pregio, quali le famose leggi razziali e l’entrata in guerra dell’Italia, pur nella consapevolezza della nostra totale impreparazione. La portata di questi fatti è tale da oscurare ampiamente quel poco di buono che Mussolini aveva fatto in precedenza. Se poi aggiungiamo la scellerata decisione di presiedere lo stato fantoccio voluto da Hitler, cioè la Repubblica Sociale Italiana, contribuendo così in modo determinante allo scoppio della guerra civile, si vede come il giudizio debba essere ridimensionato. Personalmente sono dell’idea che è troppo presto per giungere a delle conclusioni e che c’è anche il rischio da valutare della incompletezza delle informazioni.
Se non ci fossilizza quindi sulla domanda “Mussolini si può definire grande?” questo lavoro di Petacco si fa apprezzare in alcuni capitoli per la capacità di sintesi dell’autore, che non va tuttavia a discapito della chiarezza. Appare in tal modo evidente che le divisioni tematiche sono in grado di arricchire le nostre conoscenze del personaggio, ma finiscono con il costituire solo un esile tassello del mosaico che si va a comporre , troppo poco per poter formulare un giudizio compiuto e in sintonia con la verità.
Indicazioni utili
Come era l’Austria felix
Alla fine del XIX secolo (corre l’anno 1898) una giovane della piccola nobiltà di provincia viene assunta, come dama di compagnia, di un’Arciduchessa, e in tale veste vive alla corte di Vienna, permeata dalla presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe. Dato il suo rango è quanto di meglio le potesse capitare e ha tutti i motivi di essere soddisfatta; lontana dall’ambiente rurale di famiglia, potrà assaporare i fasti di una corte che, imperterrita, trascina la sua esistenza indifferente ai cambiamenti di un’epoca, verso quella guerra che segnerà la fine di una dinastia. Le scoperte che farà in quel mondo ovattato e frivolo e le sue giornate sono riportate in un diario attraverso il quale anche noi potremo esserne, figurativamente, parte, un mondo talmente lontano dal nostro modo di vivere che appare, a tratti, ammantato da un velo magico, in una situazione irreale, quasi da favola. Le feste, ma anche e soprattutto la quotidianità sono riportate in modo encomiabile e suggestivo, così che, oltre che per le riuscite illustrazioni, alla fine della lettura si potrà capire come era la vita di corte, sottoposta a rigidi rituali che ci portano involontariamente a sorridere, ma che rappresentavano il perpetuarsi di una tradizione, di usi e di costumi avulsi dal tempo. I bei vestiti, i gustosi manicaretti, i viaggi, i balli si susseguono come in un sogno di cui è contenta e soddisfatta la nostra dama di corte e per lei non poteva mancare anche l’amore, con un misterioso J., tuttavia destinato a un matrimonio di mero interesse. Il libro è scritto benissimo ed è brava Isabella Bossi Fedrigotti nel ricreare quell’atmosfera viennese di fine secolo, un’atmosfera di cui, ancor oggi, esistono molti nostalgici, pur non avendola sperimentata. Devo dire che pure io sono rimasto affascinato da quel mondo, ma, sarà forse perché con il senno di poi so della sua tormentata fine, ho alla fine pensato che sia stato tutta apparenza e niente sostanza, una vita che tutto sommato si reggeva su un precario equilibrio, chiusa in una dorata prigione, lontana dall’esterno, da quei sudditi che cominciavano sempre di più a reclamare quell’autonomia sempre negata e che otterranno solo dopo una sanguinosa guerra. Era forse una bella “epoque”, in cui tutto sembrava immutabile, come se il tempo non scorresse mai, con sullo sfondo la figura paterna, ma autoritaria di un imperatore vissuto troppo a lungo per capire che ogni cosa ha le sue stagioni; se dentro le mura del castello si viveva in un’eterna primavera, fuori dominava un autunno fatto di foglie ormai morte, pronte a cadere, come le parti di quell’impero.
Da leggere, indubbiamente.
Indicazioni utili
Da due soldi non è solo la balera
Gran brutta cosa è andare da un condannato a morte per dirgli che la sua domanda di grazia è stata respinta, ma ancor peggio è quello che lascia intendere costui e cioè che, collegato a una balera da due soldi, c’è il colpevole di un omicidio in assoluta libertà. Maigret abbocca all’amo e inizia un’indagine del tutto sconclusionata, in un ambiente che non gli è tipico, anzi dove, nonostante tutti gli sforzi, è come un pesce fuor d’acqua. Più che condurre il gioco ne è attirato, anzi quasi si lascia prendere per mano in quello che di tutti i gialli con protagonista il celebre commissario è probabilmente il meno riuscito. Le carenze sono tante, a cominciare dall’ambientazione, più artificiosa che reale, e anche le atmosfere sono forzate e rivelano a tratti qualche ingenuità. Del tutto superficiale, poi, appare l’analisi psicologica dei personaggi che si muovono a comando come dei veri e propri stereotipi. Fra bicchierini di pernod e di acquavite è già tanto se il lettore non si ubriaca, un lettore tutto teso a sbrogliare quella matassa che dovrebbe sciogliere Maigret e che invece rende sempre di più intricata. Per fortuna, stringendo i denti, si arriva all’ultima pagina, con finalmente il nome del colpevole, di cui tuttavia si è ben poco convinti; l’unica certezza è che anche a Simenon non tutte le ciambelle non riescono con il buco e che, oltre che la balera del titolo, anche questo romanzo è da due soldi.
Indicazioni utili
- sì
- no
Le grazie della contessa per l’Unità d’Italia
Nelle tormentate e complesse vicende che portarono all’Unità d’Italia è ben chiara la figura di Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, all’epoca considerata la più bella donna d’Europa. Infatti, nel complesso progetto di Cavour volto ad assicurare al Piemonte l’alleanza della Francia nella guerra contro l’Austria lei ebbe un ruolo importante, facendo perdere la testa a Napoleone III. É un po’ difficile pensare che la contessa di Castiglione si sia sacrificata per il bene supremo del paese, poiché il provocare l’interesse degli uomini, per poi portarseli a letto, era una sua caratteristica, così come amava anche carpire notizie, segreti, cercando di ritrarre un vantaggio economico personale. É evidente che non ci troviamo di fronte a una novella Giovanna d’Arco, ma a una avventuriera capace di sfruttare ogni occasione, rivelando in ciò un’intelligenza che in genere non è riscontrabile in una donna di facili costumi.
Abile civetta, consapevole che la sua bellezza era tanto più preziosa quando non facilmente accessibile, nei suoi incontri galanti non era mai disinteressata, ma spesso e volentieri riceveva dall’occasionale compagno regali di notevole valore. Questa ampia disponibilità di ricchezze la portava a scialare, senza che tuttavia non le rimanesse in cassa qualcosa per la vecchiaia che impietosa arrivò anche per lei. Vanitosa e narcisista come era deve essere stato un trauma notare la comparsa delle prime rughe, le carni che diventavano meno sode, ma soprattutto il diminuito interesse per lei degli uomini.
Né si può definirla una grande amatrice nel senso più nobile del termine, poiché non ebbe il minimo interesse per un marito che pure si svenò per assicurarle l’agiatezza che lei pretendeva; ancor più desolante era il rapporto con il figlio, da lei mai voluto, in quanto di impedimento alla sua libertà.
Alla fin fine, tirando le somme e pur non disconoscendo i suoi meriti per aver favorito l’alleanza con i francesi, era un personaggio che amava solo se stesso, talmente egoista da risultare spesso antipatico; il libro di Petacco descrive la sua vita con la nota abilità, ma l’autore, senza voler apparire come un moralista, ne parla con distacco, perché con la girandola di amanti che aveva (anche dodici contemporaneamente, ognuno all’insaputa dell’altro) non ci sono parole per descrivere l’immoralità di una donna che fu protagonista del nostro risorgimento.
Indicazioni utili
Una piacevole lettura
Questo giallo è del tutto atipico e in questa peculiarità rivela l’attenzione di Simenon a cercare sempre qualche cosa di nuovo affinché un personaggio così amato come Maigret non venga a noia. Prima di tutto il celebre commissario non è più di stanza a Parigi, ma è stato relegato in un oscuro paese della Vandea perché caduto in disgrazia e senza che se ne sappiano i motivi. Lì soffocherebbe nella noia se non ricevesse la visita di una vecchietta tanto minuta quanto intraprendente e che gli accenna a un cadavere che da qualche giorno è disteso sul pavimento di una stanza del villino di un suo vicino, un giudice di pace in pensione. Ecco l’occasione per risvegliare dal torpore il commissario e fargli avviare un’indagine che, dopo le prime fasi piuttosto lente, diventa un susseguirsi di colpi di scena con un ritmo incalzante e crescente, quasi si trattasse di un lavoro scritto sull’onda delle note del celebre Bolero di Ravel. Una piccola comunità, dove tutti si conoscono o credono di conoscersi, una stagione che alterna sole a pioggia, la vita regolata dal movimento delle maree che si riflette sul lavoro dei mitilicultori, insomma una provincia francese non rurale, ma marittima e che Simenon descrive con la consueta sorprendente abilità. Maigret giganteggia su tutti, non solo per la sua mole, a tratti sembra il gatto che gioca con il topo, ma non c’è nessuna ferocia in lui, c’è quel senso di pietà che spesso lo caratterizza e che lo porta ad avere compassione nei confronti di certi assassini. La vicenda può apparire forse piuttosto intricata,ma il gomitolo si sbroglia progressivamente in itinere e la conclusione è come al solito logica e plausibile.
Di sicuro la lettura di La casa del giudice consentirà di trascorrere in modo veramente piacevole alcune ore, il che non è poco; le indubbie qualità letterarie, inoltre, contribuiscono a rendere questo romanzo meritevole di attenzione.
Indicazioni utili
La grande forza dell’amore
Non c’è che dire: la Némirovsky sa toccare le corde giuste e ogni pagina riserva una particolare emozione, senza tuttavia mai esagerare, senza scivolare nel melodramma. I doni della vita è un’ appassionante saga di una famiglia dell’alta borghesia, gli Hardelot, lungo un arco di tempo che va dagli inizi del XX secolo, fino al 1940. I contrasti insanabili fra le classi sociali sono ben rappresentati, con il padrone del vapore che vuole comandare in tutto, anche negli affetti, ma per fortuna che c’è un nipote che si ribella per sposare la ragazza dei suoi sogni, un’esponente della piccola borghesia. La rigida presa di posizione del grande vecchio, l’acquisita consapevolezza che qualcosa deve cambiare del figlio imbelle, padre del giovane ribelle, la tenera storia d’amore di quest’ultimo con la delicata Agnes, il dramma della Grande Guerra che travolge ogni certezza, ma che non riesce a sradicare un’ottusa mentalità capitalistica, l’invasione tedesca della Francia nel 1940 scorrono sotto gli occhi del lettore come in una pellicola cinematografica, con descrizioni degli ambienti e approfondimenti psicologici che risultano di grande efficacia, seppure espressi con uno stile per nulla ridondante, anzi semplice, e perciò immediato. La Nèmirovsky riesce a parlare di tutto, a mostrarci la vita come essa è, senza banalità, ma con precisione e delicatezza, tanto che sono frequenti le pagine di vera e propria poesia. É evidente che parteggia per il giovane ribelle e che confina il grande vecchio nel suo cuore di granito, una costante direi della sua produzione che ha sempre avuto come bersaglio il potere e la ricchezza per il potere. La descrizione dell’incedere della guerra, la fuga disperata degli inermi cittadini di fronte al nemico creano uno stato d’animo incredibile e così si finisce con il trepidare con questa gente che non sa che fare, se non scappare. E poiché in questa saga si racconta vita, ci sono le morti, ma anche le gioie e, soprattutto la gioia più grande, l’amore. Fra il giovane rampollo Pierre e la dolce Agnes é un idillio capace di vincere le difficoltà, perché l’amore reciproco è un sentimento che dà forza, che consente di saper cogliere quelli che, se non sono molti, sono pur sempre i doni della vita.
Per alcuni aspetti, il romanzo può sembrare una prova per quello che sarà, benchè incompiuto, il grande capolavoro della narratrice: Suite francese. Tuttavia sarebbe ingiusto ridurlo a un semplice canovaccio, a un mero esperimento, perché mostra delle grandi qualità, tanto da raccomandare la sua lettura.
Non ve ne pentirete, perché I doni della vita finisce con l’essere, esso stesso, un dono della nostra vita.
Indicazioni utili
Delitto e castigo
La solitudine dell’assassino, ultimo lavoro di Andrea Molesini, narra dell’incontro fra il traduttore e scrittore Luca Rainer e l’ergastolano Carlo Malaguti, incontro voluto dall’editore affinché il suo autore scriva una biografia di quest’uomo, ormai vecchio, che dopo aver trascorso dietro le sbarre venti anni della sua vita viene messo in libertà per buona condotta. Non è però che la notizia della liberazione rallegri in modo particolare il carcerato che, anzi, sembra piombare, nonostante le apparenze, in un grave disagio, come se la colpa dell’omicidio che a suo tempo ha commesso non fosse stata totalmente espiata. C’è qualche cosa che avvolge come una cappa Malaguti, un segreto che si porta dentro e su cui Rainer, sempre più incuriosito, vorrebbe far luce. Non aggiungo altro perché la trama ha la giusta tensione di un giallo e un giallo in effetti è, anche se è un pretesto per mettere a confronto due anime: quella complessa di un Malaguti che ha maturato, nel lungo soggiorno in galera, una filosofia di vita per nulla disprezzabile e quella di Rainer che, nonostante non sia proprio un giovanotto, rivela una certa immaturità. I dialoghi fra i due protagonisti hanno il pregio di non essere banali, ma sono fatti da piccole perle rappresentate da osservazioni filosofiche, da dei piccoli cammei sull’esistenza che finiscono per interessare il lettore forse ancor più della vicenda. Alla fine l’alone di mistero sarà squarciato, ma si potrà anche constatare come ogni essere umano debba imparare a vivere con i propri errori, con i sensi di colpa, accettandoli, come parte integrante di un “io” che, accanto ad aspetti positivi, ne ha pure di negativi, insomma siamo quel che siamo e come tali dobbiamo accettarci.
É da un po’ di tempo che leggo i libri di Andrea Molesini e quindi ritengo opportuno evidenziare le caratteristiche dell’autore presenti appunto nelle quattro opere fino a ora edite. Il comune denominatore è il dramma della guerra, alternando la prima alla seconda, entrambe quelle mondiali (ed è di quest’ultima l’origine della vicenda di La solitudine dell’assassino); la scrittura, fresca e semplice, propria di Non tutti i bastardi sono di Vienna, si è fatta via via più complessa e non sempre è riuscita; la struttura è sovente esile, ma non per questo fragile e infine la capacità di descrivere situazioni, paesaggi e protagonisti permane di buon livello. Personalmente sono affezionato a Non tutti i bastardi sono di Vienna, ma non è che le opere successive siano poca cosa; il fatto è che ogni tanto ritraggo l’impressione che qualche cosa gli sia rimasto nella penna, che ci sia un che di incompiuto al di là delle apparenze.
Resta in ogni caso il fatto che, come gli altri, anche La solitudine dell’assassino è meritevole di lettura.
Indicazioni utili
Lo scontro di due civiltà
E’ il 9 d.C. e nella fitta selva di Teutoburgo i Romani subiscono una delle più tragiche disfatte della loro storia; sono ben tre le legioni che vengono sterminate da una coalizione di Germani capeggiata da Arminio, figlio del defunto re dei Cheruschi, portato con il fratello in ostaggio a Roma quando ancora erano ragazzini in pegno dell’alleanza con il loro padre. I due, cresciuti come romani e con tutto il rispetto, sono diventati in breve due guerrieri formidabili, tanto da ricoprire, soprattutto Arminio, incarichi di grande responsabilità nell’esercito. Ma mentre il fratello ha compreso il significato della potenza dell’impero e ne è stato soggiogato, Arminio, pur divenendo addirittura per alti meriti cittadino romano, è rimasto legato alle sue genti tanto che a un certo punto decide di cambiare casacca e di attirare in un tranello le legioni del suo amico Varo. Vincerà la battaglia, dei soldati romani verrà fatto scempio, ma non riuscirà a debellare Roma e, nonostante altri scontri, per lo più infausti, il suo sogno di diventare re di tutti i popoli germanici si infrangerà, anzi lui verrà assassinato dai suoi stessi soldati. Teutoburgo, l’ultimo romanzo di Valerio Massimo Manfredi, ci parla di tutto questo, con toni sovente epici e con
precisi riferimenti storici laddove è stato possibile. Credo che l’impegno dell’autore sia stato notevole, a cominciare dalla struttura, in altre sue opere carente, ma qui ben progettata; inoltre è riuscito a ricreare il fascino di una grande civiltà nei confronti di un’altra senz’altro rozza e primitiva, incapace di paragonarsi a quella romana sotto tutti gli aspetti, ivi compreso quello militare, perché se è vero che i romani non riusciranno mai a sottomettere i Germani, tanto da rinunciare ad estendere i confini dell’impero dal Reno all’Elba, é altrettanto vero che queste popolazioni, abituate a vivere in selve oscure, divise e spesso in guerra fra di loro, non potevano competere in nessun campo con uno stato monolitico, pur se multietnico, come quello romano. Il romanzo presenta diversi aspetti interessanti, come appunto il contrasto fra le due civiltà, la progressiva consapevolezza dell’importanza dello Stato in chi non ne fa parte, il significato del valore non tanto come pregio individuale, ma in funzione dello sforzo collettivo. La scrittura è semplice, ma non è un difetto, perché l’opera, abbastanza lunga, se ne avvantaggia, così che le pagine scorrono piacevolmente e consentono al lettore di unire allo svago anche un po’ di nozioni storiche, insomma il romanzo è meritevole di attenzione.
Indicazioni utili
La memoria
Questo libro ha un’introduzione che deve essere assolutamente letta prima di passare al testo vero e proprio, perché Nuto Revelli spiega il metodo seguito per parlare, con estrema concretezza e lucidità, del triste destino della campagna e della montagna del cuneese nel dopoguerra. Per estensione lo stesso fenomeno avvenne in tutta Italia nel mondo legato alla coltura dei campi, un fenomeno che in breve può essere definito la fine della civiltà contadina, di cui ha parlato anche con i suoi appassionati romanzi Ferdinando Camon. Certo le singole realtà possono essere diverse, ma quello che è stato un mondo immutato per secoli le accomuna tutte. Nel caso del cuneese, se la campagna non viene sfruttata all’eccesso o peggio ancora industrializzata, resta una realtà di miseria senza speranza; la seconda, se non è oggetto di insediamenti turistici, viene abbandonata e diventa quasi un deserto. Revelli, forte di quanto appreso durante la drammatica ritirata dal Don circa il dovere della memoria, ci racconta nel suo libro come era una civiltà che ora non c’è più e lo fa sulla falsariga di un’inchiesta, intervistando gente anziana della pianura, della collina e della montagna. Il suo è stato un lavoro certosino, perché munito di registratore ha interpellato ben 270 persone, poi ha provveduto alla trascrizione rispettando, per quanto possibile, la forma del parlato. A tratti sembra una delle interessantissime inchieste di Sergio Zavoli, solo che qui non ci sono immagini, ma egualmente si crea un’atmosfera che consente alla fantasia di farsi un’idea di come possa essere l’intervistato: anziano, rinsecchito da anni di duro lavoro, con la malinconica tristezza di chi si sente un vinto. E in effetti, da questi ricordi emerge un mondo di profonda miseria, fatto di duro lavoro, talmente malpagato che il guadagno sembra quasi un’elemosina; peraltro era gente che si accorgeva di non contare nulla, anzi di essere, oltre che emarginata, buona solo per essere sfruttata. E per quasi tutti c’è la memoria della Grande Guerra, il massimo dell’infelice vita personale, ognuno considerato solo uno dei tanti, in pratica un numero, niente di più che carne da cannone.
Eppure, questo mondo di sofferenza e di ignoranza presentava valori oggi ormai sconosciuti, univa persone dove oggi si dividono, trovava nel poco e niente il necessario per vivere.
Adesso non é più così e ha ragione uno degli intervistati quando dice che il povero di adesso è più ricco del ricco del suo tempo, perché esisteva in passato anche nelle classi meno disagiate quella continua incertezza del futuro che le portava a essere sparagnine, insomma che si conteneva nelle spese , limitando quei consumi che oggi invece sono lo scopo continuo di ognuno di noi.
Il mondo dei vinti é una testimonianza irripetibile di ciò che fu e di questo dobbiamo ringraziare Revelli, perché ci porta a conoscere le nostre lontane radici , ci aiuta a comprendere da che passato veniamo.
Indicazioni utili
L’emarginazione
E’ una bella giornata di sole che annuncia l’imminente primavera quella che vede Maigret raggiungere il suo ufficio al commissariato. In sala d’attesa c’è un ometto dall’aspetto insignificante che è lì da un bel po’ per parlare con lui. Lo riceve e il commissario apprende che si tratta di un maestro, nonché segretario comunale, di un paesino presso La Rochelle, e che inoltre è sospettato del delitto di una vecchia conosciuta come accidiosa, insomma una strega. Maigret vuol vederci chiaro e così, benché il caso sia fuori dalla sua giurisdizione, accompagna al paese il suo interlocutore, convincendolo a costituirsi.
Inizia così questo giallo scritto da Simenon nel 1953 nel periodo del suo soggiorno negli Stati Uniti, un romanzo che ripropone il mondo chiuso proprio delle piccole realtà locali, argomento che l’autore conosce particolarmente bene e che gli offre la possibilità di esaminare la psicologia rozza, e tutto sommato semplice, dei suoi abitanti. Tuttavia, forse l’atmosfera del Nuovo Mondo, per certi aspetti così lontana da quella della vecchia Europa, mette un po’ in ombra le indubbie capacità di Simenon che, con il problema dell’emarginazione dello straniero, tipica delle piccole comunità, se non si trova a proprio agio, comunque appare un po’ sotto tono. Anche la trama, che non presenta colpi di scena, nella sua linearità contribuisce a togliere un po’ di mordente alla vicenda, così che, se la lettura è comunque sempre gradevole, non avvince come invece in altri romanzi. Non si arriva mai, pertanto, a momenti di particolare emozione, perché tutto scorre liscio, tranquillo, e anche i personaggi non hanno una personalità tale da contribuire a tenere attaccato alle pagine il lettore, desideroso di di arrivare a scoprire la verità. Inoltre, il commissario sembra in vacanza in questo giallo; arriverà sì alla soluzione del caso, ma l’impressione è che non si sia applicato più di tanto, quasi si trattasse di normale routine.
Quindi, da leggere, ma senza aspettarsi chissà cosa, un romanzo insomma adatto a trascorrere tranquillamente qualche ora, e non di più.
Indicazioni utili
Un uomo che amava la giustizia
Era un uomo giusto che valeva la pena di conoscere, sono addolorato per la perdita del mio amico Joe (Theodore Roosevelt ai funerali)
La mafia si è macchiata nel tempo di orrendi delitti, giungendo a eliminare uomini delle Forze dell’Ordine (per esempio il capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano) e della magistratura, come i sostituti procuratori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma è indubbio che il nome di Joe Petrosino sia ormai entrato nella leggenda, conosciuto da noi e, soprattutto, negli Stati Uniti. Infatti, se non fu la prima vittima fra i poliziotti, fu però anche quello che, operando a New York, si impose con ferrea volontà di sradicare quell’associazione a delinquere che nel tempo prese il nome di Cosa Nostra e che attecchì in America grazie all’immigrazione di mafiosi italiani. Fra questi, senz’altro di spicco per aver saputo strutturare e organizzare questa congrega criminale fu Vito Cascio Ferro.
La biografia che ha scritto Arrigo Petacco cerca di uscire dal mito vero e proprio, per soffermarsi sui fatti, ma è indubbio che la personalità di questo poliziotto di origine campana, giunto con la famiglia negli Stati Uniti quando ancora era un ragazzo, è una di quelle che non può che destare ammirazione. In un’epoca in cui nel Nuovo Mondo gli italiani non erano benvisti, trovarne uno che appassionò milioni di americani resta un caso unico, anche perché è il tipico uomo che si fa da sé. Da netturbino a poliziotto, da graduato a tenente comandante della squadra italiana, attraverso una serie di successi dovuti al metodo seguito e alla totale dedizione, appaiono evidenti i motivi di così tanta fama. Era un onesto e con la vocazione di eliminare i disonesti, era uno capace di organizzare, dando l’esempio, era insomma l’uomo giusto per l’incarico che gli era stato conferito: combattere il crimine organizzato. Se gli si può attribuire un difetto, che è difficile da trovare, uno, particolarmente pericoloso, si manifestò nell’ultima missione di cui era stato incaricato. Arrivato in segreto in Italia per creare appunto un servizio segreto volto a identificare i mafiosi prima che si imbarcassero per l’America, la sua dedizione fu tale che continuò nell’impresa benché, a seguito di incaute dichiarazioni del capo della polizia di New York, la sua presenza nella nostra nazione fosse diventata notoria; quel che è peggio, però, è che nonostante questo grave handicap, lui finì per fidarsi di qualcuno, qualcuno che incontrò in una piazza buia e che lo uccise. Quel qualcuno – ma lo si apprenderà dopo molti anni – era nientemeno che Vito Cascio Ferro.
Resta, però, un chiaro esempio di uomo di legge, sempre accorto, tranne che nell’ultimo giorno della sua vita, e che riuscì a mettere in luce il collegamento in Italia fra mafia e polizia, nonché fra mafia e potere politico. Non si può sapere se sarebbe riuscito nell’impresa, ma c’è più di un dubbio, vista la fine fatta da chi, indagando su questa associazione criminale, stava per avvicinarsi al suo vertice.
Da leggere, senz’altro.
Indicazioni utili
Per noi stessi
L’oro del mondo è un romanzo atipico nella produzione letteraria di Sebastiano Vassalli, un lungo racconto che a volte entusiasma e altre invece sconcerta, sospeso com’è fra ironia, satira, dissacrazione, il tutto accompagnato da una vena anche di struggente malinconia. Dovrebbe essere anche una parziale autobiografia, con particolare riguardo agli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, in un’Italia distrutta, un paese in cui si muove come tante ombre un popolo di cenciosi, disposti a fare qualsiasi lavoro pur di trovare qualcosa da mettere sotto i denti. Vassalli, abbandonato da un padre imbroglione e infame e da una madre che sogna un’eredità assistendo un capitano di marina invalido, è in pratica allevato dallo zio Alvaro, un candido che tuttavia ha compreso, a sue spese, come vada il mondo. Al riguardo è particolarmente significativo un dialogo con il nipote che si trova a pagina 150: ‹‹Perché viviamo?››, domandai. ‹‹Per noi stessi, – rispose lo zio Alvaro. – ‹‹Per la nostra memoria: e per che altro?›› Spiegò: ‹‹Per quelle poche pagliuzze di felicità che rimangono in fondo alla memoria, come l’oro sul fondo della bàtea…››. Può sembrare una filosofia spiccia, a buon mercato, ma il senso della vita è poi questo, né più, né meno, e qualunque cosa se ne dica, è proprio di tutti noi. É solo la memoria che ci fa capire di aver vissuto, una serie di ricordi spesso impalpabili, sovente per nulla piacevoli, ma che, nei pochi casi in cui abbiamo toccato, magari per un attimo, la felicità, sono la misura di quanto la vita meriti di essere vissuta. Ma non c’è solo questo orientamento filosofico, perché è pure presente e determinante un’impietosa descrizione di noi italiani, capaci in un giorno e anche meno di trasformarci tutti da fascisti in antifascisti, restando però sostanzialmente quel popolo arruffone, menefreghista e in cui ognuno guarda solo se stesso. Se la figura del padre di Vassalli, grande fascista prima e durante la guerra, e rimasto sostanzialmente tale anche dopo è esemplarmente negativa, non lo sono di meno altri personaggi che si agitano, scalpitano, sgomitano per conquistarsi un posto al sole. In tal modo quella che doveva essere una sia pur parziale autobiografia, diventa l’analisi del trascorso di un’intera nazione, vista nel dramma del passaggio dal fascismo alla democrazia, e caratterizzata, allora come oggi, da un endemico malcostume e da un diffuso trasformismo, il quadro di una collettività che sembra incapace di una evoluzione positiva. Oggi, come un tempo, si seguono i miraggi, si sogna un capo a cui affidare incondizionatamente il proprio destino, e il desiderio principale è quello della ricchezza facile, quello del denaro, dell’oro, come era cercato da dei poveri disperati negli anni tristi del dopoguerra, ore e ore di lavoro per delle pagliuzze che non ripagavano la fatica, ma che perpetuavano l’illusione.
Con la fine del conflitto sembrava tutto cambiato, ma, come la polvere, sollevata e non raccolta che poi si deposita nuovamente, senza aver fatto i conti con il passato nulla può cambiare; siamo sempre stati così e così saremo sempre, sembra dirci Vassalli, un amaro giudizio di cui nemmeno ci vergogniamo.
Da leggere, ovviamente.
Indicazioni utili
Mai dimenticare
Mi viene da sorridere se penso che, quando ero giovane, i vecchi erano soliti dire che con la mia generazione tutto era cambiato, e ovviamente in peggio. C’era in me un’incredulità che mi impediva di comprendere, c’era invece quel desiderio di gettarmi a capofitto nel futuro, cancellando il passato. E invece ora, a distanza di tanti anni, pure io incanutito mi rendo conto che quell’affermazione era veritiera e che nell’arco di poco tempo una civiltà millenaria, quella contadina, era scomparsa. Fissare i ricordi, non tanto per se stessi, ma per chi verrà dopo di noi è l’unico modo per fare un empirico giudizio della nostra vita, ma riportare le memorie raccolte dai nonni quando si era piccoli è molto di più, è concatenare delle epoche, è verificare ciò che c’era di buono e ciò che c’era di insano. Ci ha provato Franca Oberti con questa raccolta di racconti, Il tempo del castagno, che prende il titolo da uno di essi, per la precisione l’ultimo.
L’autore, legato per tradizione familiare all’attività agricola, in forza degli squarci che gli si aprono nella memoria propone delle prose brevi in cui il respiro di un tempo andato e che mai ritornerà è forte, tale da far comprendere che se la vita condotta dai suoi avi a coltivar la terra non era di certo paradisiaca, non era tuttavia da sminuire o denigrare. Il lavoro manuale era preminente, il tenore di vita, per lo più, era tale da garantire i pasti, se pur magri e poco vari, insomma quando non era proprio miseria, era ciò che oggi definiremmo una povertà diffusa, assai più marcata del concetto che adesso abbiamo di povertà. Eppure, a quei tempi, a quelli della civiltà contadina probabilmente si viveva meglio di oggi, perché non rientravano nel paniere della ricchezza quei mezzi materiali per cui ogni giorno lottiamo, ma erano bensì presenti i valori, le canoniche basi che in quest’epoca frenetica in cui viviamo sono spariti completamente, sostituiti da un unico scopo per il quale valga la pena di vivere: la continua ricerca del denaro per soddisfare bisogni che accortamente ci vengono inculcati.
La scrittura dell’Oberti è semplice, priva di fronzoli, così che si ricava l’impressione che i racconti siano uguali a quelli ascoltati da bambina dalla bocca del nonno o della nonna. E in questa letteratura orale, di cui da molto tempo non si nota più nemmeno l’assenza, è piacevole, pagina dopo pagina, immaginare di stare ad ascoltare davanti a un camino con un bel fuoco , su cui, in un paiolo, viene rimestata la farina gialla per quello che era un alimento diffusissimo: la polenta.
Così si sogna, si sogna a occhi aperti, e non si può non condividere quanto a pagina 12 scrive l’autore: “……/ A guardare bene sono sempre stati loro, i contadini, che ci hanno insegnato la sopravvivenza: insegnavano alle nuove generazioni come tramandare la vita, in ogni sua forma”
E’ vero, tanto che, scomparsa questa civiltà, oggi siamo come alberi a cui hanno tagliato le radici e, senza memoria del passato, continuiamo a correre verso un futuro nebuloso, incapaci di saper vivere il presente.
Da leggere.
Indicazioni utili
L’amore ai tempi di Stalin
Georges Simenon, nella primavera del 1933, fece un viaggio nell’Unione Sovietica, toccando diverse località sulle sponde del mar Nero e fermandosi per otto giorni a Odessa, dove, accompagnato da una guida locale, ebbe modo di toccare con mano gli spaventosi effetti della carestia che travagliò a lungo quella nazione. Ritornato in Francia, intese parlare di quella sua esperienza , scrivendo un romanzo intitolato Le finestre di fronte che costituisce un preciso e non propagandistico atto di accusa contro il regime staliniano. In quest’opera l’autore è riuscito a rendere con straordinaria abilità una condizione di vita spersonalizzante, cupa, tenebrosa, in cui parlare era pericoloso, ma lo era anche stare zitti, in un grigiore di giorni ripetitivi in cui la popolazione locale si trascinava stancamente alla ricerca di un cibo, che già in quantità inadeguata, sovente mancava del tutto. E’ così’ una folla di cenciosi che popola le vie di Batum, la località dove è ambientata la vicenda, e non sono sufficienti gli slogan del partito comunista per incantare individui che ormai hanno perso ogni speranza. Ovunque è presente la polizia politica che vigila e schiaccia, che imprigiona e uccide, e in questo contesto avviene la vicenda del nuovo console turco Adil bey, arrivato per sostituire il precedente morto improvvisamente; lui, i consoli iraniano e italiano, e il direttore americano della Standard Oil che gestisce la raffineria di petrolio sono gli unici stranieri che risiedono in città e, a dispetto delle convenzioni internazionali, sono essi stessi prigionieri dell’invisibile ragnatela con cui le autorità li hanno avvolti. Il diplomatico turco cercherà di uscirne, coinvolgendo anche la segretaria russa di cui è innamorato; ce la farà, ma ciò che ha visto, ciò di cui è stato testimone, attore e vittima al tempo stesso, lo accompagnerà per il resto dei suoi giorni.
Le finestre di fronte non si può considerare un noir tipico, anche se c’è un tentativo di omicidio, ma è una sorta di apologo sull’incapacità dell’uomo di essere completamente libero, anche nell’amore, qui riproposto secondo il classico dualismo di eros e thanatos. É incredibile la capacità di Simenon di descrivere il “paradiso” staliniano, di farci scendere progressivamente nella cripta degli uomini senza domani, senza oggi e senza ieri, esseri che vegetano in una condizione chiusa e senza speranza.
Da leggere, è un capolavoro.
Indicazioni utili
Tanti muscoli e poco cervello
Se ci fu un uomo che incarnò la figura del perfetto fascista fu proprio Ettore Muti. Bello, aitante, audace, sempre pronto a gettarsi nella mischia, amante della velocità e delle belle donne, mai domo e anzi sempre determinato questo ravennate, nato il 22 maggio 1902 e morto il 24 agosto 1943, era ancora un ragazzo quando cercò di arruolarsi per partecipare alla Grande Guerra. Scoperto, fu rimandato a casa, ma esperì un ulteriore tentativo e questa volta gli andò bene, tanto che prese parte al conflitto nei reparti degli Arditi, meritando encomi e medaglie. Partecipò poi all’impresa fiumana, conclusasi infelicemente, e fu uno dei primi ad aderire al partito fascista, dandosi non poco da fare nelle lotte contro i “rossi”. Da perfetto fascista, difettava un po’ di materia grigia, ma ciò non gli impedì di fare una rapida carriera nel partito, nonostante l’attentato del 13 settembre 1927 in cui rimase gravemente ferito, una vicenda oscura e mai completamente chiarita, in cui tuttavia pare assodato che il mandante del sicario fosse da cercare fra i suoi camerati del ravennate.
Partecipò gloriosamente in qualità di aviatore alla guerra d’Etiopia e a quella di Spagna, dopo di che, grazie all’appoggio dell’amico Galeazzo Ciano, venne nominato da Mussolini segretario del partito in sostituzione dell’inviso Achille Starace. Benchè poco disponibile al ruolo amministrativo, si diede da fare non poco per svecchiare il partito dagli imbolsiti gerarchi, epurando anche i numerosi funzionari corrotti. Era onesto e, giustamente, non poteva sopportare i disonesti. L’incarico però gli andava stretto e chiese allora di partecipare, sempre come aviatore, alla seconda guerra mondiale; accontentato, anche qui diede prova del suo grande valore, almeno fino a quando, per problemi di vista, fu costretto a non alzarsi più in volo. Nel frattempo era stato sostituito alla segreteria del partito e aveva ricevuto il modesto incarico di membro del Servizio informazioni dell’aeronautica. Era poco intelligente, ma ciò non gli impedì di accorgersi che a quella guerra partecipavamo del tutto impreparati e che Mussolini aveva tradito da tempo l’originario ideale, tanto che con i congiurati del 25 luglio 1943 si era dichiarato disposto di far fuori il duce e sicuramente alla famosa seduta del Gran Consiglio avrebbe votato l’ordine del giorno Grandi se fosse arrivato in tempo. Dopo l’arresto di Mussolini, si ritirò in una villetta a Fregene in riva al mare e nei pressi della stessa, nella pineta, fu assassinato il 24 agosto 1943 in circostanze oscure, tipiche del delitto di stato, su cui non si volle mai far luce anche a guerra finita. Le ipotesi al riguardo sono diverse e vengono ben esplicitate nel libro di Petacco, ma ognuna è plausibile, senza che tuttavia possa essere suffragata da prove concrete.
La vita di Muti fu spezzata da un proiettile nella nuca, una vita condotta sempre con sprezzo del pericolo; era un uomo stimato perfino dagli antifascisti, ma sovente odiato da alcuni dei suoi stessi camerati, insomma un personaggio ampiamente meritevole della biografia stilata con la consueta equidistanza e serietà da Arrigo Petacco.
Da leggere, quindi.
Indicazioni utili
L’essenza di Dio
Di Mariangela De Togni avevo già letto un’altra silloge (Frammenti di sale), che mi aveva colpito in modo particolare per l’abbandono mistico che la caratterizzava, frutto di interazione con il Creato, una sorta di sensazioni ed emozioni derivanti non solo dall’osservazione della natura, ma dalla continua ricerca di compenetrarsi in essa. Stupore, meraviglia, ma soprattutto una grande serenità emergevano dai versi delle sue poesie. Anche in questa nuova raccolta ho potuto constatare quanta gioia interiore traspaia nelle singole poesie e come l’autore abbia saputo cogliere indirettamente l’essenza di Dio in tutto ciò che naturalmente ci circonda. Non si può che essere partecipi di questa emozione quando ci si accosta a versi come questi: “Si fece leggera la sera / nel penetrare l’ombra /della volta antica, / i candelabri accesi / dall’oro del tramonto. /...”. Di fronte ai miei occhi si è materializzata un’immagine ieratica, ma al tempo stesso semplice, quale può essere quella dello spettacolo di un tramonto, e mi sono sentito pervaso da un romantico languore, mi sono sentito trasportare in un’altra dimensione diversa da quella del mondo frenetico a cui appartengo. Nulla sfugge all’analisi della poetessa e così anche il tempo, il fuggevole tempo, diviene protagonista (Fugace il tempo / appare come sospeso / fra bianchi petali di pruno / in contrappunto / al silenzio dei cipressi. /…). Credo proprio che Mariangela De Togni abbia colto l’essenza di Dio, quel Suo esserci ovunque, nell’umile fiore come nella cima innevata, una presenza che si può avvertire a ogni passo, purché lo si voglia, purché non si dimentichi che anche noi siamo parte della natura, in un equilibrio talmente perfetto, in un disegno talmente complesso che se ci risulta troppo difficile per capirlo, però ci consente di gioirne perché anche noi vi rientriamo. E sono dell’idea che in una specifica poesia di pochi versi Mariangela sia riuscita a sintetizzare tutto il suo pensiero. Si tratta di Il mio cuore (Il mio cuore é rimasto / fra le onde del mare. / Conchiglia piena / della sua voce.) E in questo cuore immenso c’è tutto il mondo, lei compresa, e c’è anche Lui, il Dio Creatore di tutto.
Da leggere, senza dubbio.
Indicazioni utili
Assai inferiore al primo della serie
Ira Domini, il seguito di Il segno dell’untore, non smentisce il fatto che, normalmente, in un ciclo di opere con la stessa tematica e i medesimi protagonisti, tutte quelle successive alla prima ne sono inferiori.
Nel caso specifico, poi, si evidenzia un netto peggioramento sotto tutti gli aspetti e una disarmonia fra le varie parti che lascia supporre che l’autore si sia accinto a scrivere il romanzo senza aver prima steso un adeguato progetto.
Pure in questo ci sono due indagini che procedono appaiate, ma una, relativa a un rapimento con tanto di ostaggi, é banale e mal supportata; l’altra afferente la ricerca di un misterioso balestriere che con la sua arma uccide diverse persone a Milano è in nuce ben più interessante, ma l’autore non le dà né il giusto risalto, né un interessante sviluppo.
Il risultato è francamente deludente, tanto più che le soluzioni dei due gialli sono ben poco logiche e paiono affrettate, come se Forte volesse concludere alla svelta quel romanzo che anche per lui cominciava a venire a noia.
Ed é proprio la noia che accompagna il lettore più o meno dalla metà dell’opera fino alla fine, vista come una liberazione. Rispetto a Il segno dell’untore la descrizione della città in preda alla peste é raffazzonata e anche i protagonisti sono solo abbozzati, anzi il notaio criminale Niccolò Taverna perde molto del suo smalto, mentre un’eccessiva importanza viene data alla sua fidanzata Isabella, fin troppo volitiva e intrepida e senz’altro fuori dai canoni delle donne dell’epoca, ma gli eccessi, come sempre, danno fastidio e contribuiscono non poco a stancare chi legge, perché il personaggio diventa ben poco credibile.
L’impressione complessiva che ho ricavato è che l’autore, visto il successo di Il segno dell’untore, abbia deciso di dare un seguito prima non preventivato e in tutta fretta, per battere il ferro finché era caldo. Il risultato è purtroppo quello che si evince da quanto ho finora scritto e se è tale da non sconsigliarne la lettura, non è però meritevole da consigliarne la stessa.
Indicazioni utili
- sì
- no
Il rivoluzionario e il tiranno
Più leggo le opere di questa straordinaria narratrice, più mi stupisco, e non solo per la qualità indubbia delle stesse, ma per la versatilità dell’autore, capace di passare dal romanzo storico (Suite francese) a quello dissacrante, e che ora, con L’affare Kurilov, affronta un genere che tutto sommato dovrebbe esserle ostico, vale a dire un vero e proprio thriller. Ma, quando si è capaci di scrivere, quando si è dotati di un grande talento naturale, nulla è impossibile e si può eccellere in tanti campi. La vicenda del rivoluzionario Lev M. e del ministro zarista dell’istruzione Valerian Aleksandrovi? Kurilov, quest’ultimo un uomo crudele soprannominato il pescecane, non è di per sé nuova, cioè che ci sia un intellettuale che intenda sopprimere un tiranno non è infrequente, ma qui ciò che fa la differenza è che il primo vive abbastanza a lungo a stretto contatto del secondo, addirittura in casa sua, a cui ha approdato nella sua qualità di medico. Che sia per effetto del giuramento di Ippocrate, che sia per il conoscere a lungo e negli aspetti più intimi la vittima designata, sta di fatto che i propositi di Lev vacillano. Entrambi malati, di malattie che non perdonano, poco a poco si avvicinano e trovano di avere non pochi elementi caratteriali in comune. Ogni tanto si strappa qualche cosa nella corazza dietro cui si nascondono, ma poi si rattoppa tutto, perché in fin dei conti i due personaggi, se non uguali, sono perlomeno simili. La loro analisi psicologica é un gran pezzo di bravura della Némirovsky, che non parteggia per nessuno dei due, ma cerca di mostrarceli così come sono. Lev riuscirà a compiere la missione? Non anticipo nulla, per non far cadere la palpabile tensione che cresce a ogni pagina. Il romanzo comincia in sordina, ma con un colpo ad effetto, in una Nizza anni ‘30, poi progressivamente il ritmo cresce e si viene avvinti dalla trama e dalla straordinaria semplicità del linguaggio che, pur tuttavia, non è acerbo, ma assai maturo, capace di avventurarsi in approfondimenti di non poco spessore con una facilità disarmante.
Da leggere, lo merita.
Indicazioni utili
Inferiore alle attese
Se c’è un fatto che mi provoca particolare dispiacere è trovare l’opera di un autore, che stimo molto, notevolmente inferiore alle aspettative e ben al di sotto delle sue potenzialità. É questo il caso di Nel chiarore della notte, una raccolta di racconti in cui Tomizza descrive i propri sogni, tema in cui si sono cimentati altri narratori con risultati ben più apprezzabili. Infatti, da chi ha scritto romanzi di grande valore come La miglior vita, Franziska, Materada e Gli sposi di Via Rossetti, prose originali e dai contenuti di assoluto rilievo, é lecito attendersi ben altro e pertanto trovarsi di fronte a racconti per lo più banali è francamente disarmante. Ci sono brani di non più di una paginetta, senza capo e coda, e mi sono chiesto a cosa servano, visto che risultano scialbi e incomprensibili. Qualcuno mi potrà obiettare che sovente i sogni non ci sono chiari e che non a caso un certo Sigmund Freud ha a lungo dissertato sulla loro interpretazione; d’accordo, ma io non sono uno psicoanalista, e anche nel caso dei miei, qualora arcani, non vado oltre un semplice “boh”, né si può pretendere che diventi un esperto di cabala, visto che ho non ho l’abitudine di giocare i numeri al lotto. Per onestà, tuttavia, mi corre l’obbligo di evidenziare che, a mio parere, un racconto si stacca dagli altri, il primo (il che invoglia molto, ma ben presto arriva la delusione). La vicenda di questo trio Mystic, da baraccone, lui mangiatore di fuoco, la moglie dotata di poteri esoterici e la figlia desiderabile, in perenne spostamento da un paese all’altro, più zingari che esuli, ha una sua originalità che credo avrebbe potuto interessare un grande regista come Federico Fellini, fra le cui opere non poche sono una commistione fra realtà e fantasia (I clowns, Roma, E la nave va e La voce della Luna). Altri elementi di pregio non sono tuttavia presenti e la lettura, non affaticante, ma certo non gradevole, prosegue fino all’ultima pagina ingenerando un progressivo senso di noia. Ho inoltre percepito, fra le righe, una malinconia pronunciata, che non è quella che si trova in diversi suoi romanzi e che è tipica di un uomo senza terra, di uno spirito di frontiera legato indissolubilmente al suolo dove è nato, ma sballottato, di qua e di là dal confine, dai venti impetuosi della storia; è una malinconia ben diversa, una specie di rassegnazione al tempo che inclemente scorre e implacabile trascina la vita al termine.
Avrei voluto scrivere queste note con l’emozione e la gioia che mi sono state proprie in occasione delle recensioni delle sue opere migliori, ma purtroppo non è così; ne prendo atto, ma il mio giudizio sulla grandezza di Tomizza non cambia per un lavoro assai inferiore, scritto da un narratore che nulla più aveva da dare se non il suo incondizionato amore per la scrittura.
Ed é per questo che il mio giudizio se non può essere positivo, non può risultare nemmeno negativo.
Indicazioni utili
- sì
- no
Beata la diversità
Ci voleva poco un tempo perché una donna, già considerata essere inferiore e tentatore, fosse marchiata come strega: bastava che rivendicasse il suo naturale diritto di esistere e di condurre una vita non uniforme agli ottusi dettami religiosi, a una ridda di comportamenti a cui tante, per timore, ma anche per assuefazione, invece si uniformavano. L’essere diversi, insomma, era non solo un peccato, ma addirittura un reato. Superati i confini del tempo, arrivando fino a quasi i giorni nostri, nell’anno 1938 a Lenzavacche la storia sembra ripetersi, facendo tornare alla memoria quelle femmine, che nello stesso paese, nel 1600 furono chiamate streghe perché, nella loro condizione di mogli abbandonate, ripudiate o più semplicemente in fuga da un’esasperante emarginazione, si riunirono in una casa alla periferia dell’abitato, iniziando a condividere un’esperienza di vita comunitaria e anche letteraria. In quell’anno fascista vive una strana famiglia, composta dal piccolo Felice, che a dispetto del nome, disabile come é, sembra riassumere su di di sé tutte le possibili disgrazie, sua madre Rosalba e la nonna Tilde, con entrambe le donne che rivendicano di essere discendenti dalle streghe del 1600. E certo il loro comportamento, così inusuale, finisce con il dar credito a questa asserzione: donne che non si sposano, che rivendicano una personale libertà e che attribuiscono, giustamente, alla conoscenza, alla cultura un ruolo fondante non possono che destare ampi sospetti in un mondo chiuso e ancora feudale quale quello della Sicilia dell’epoca. Non intendo, però, andare oltre, nel senso che non voglio anticipare la trama, preferendo soffermarmi sugli aspetti salienti dell’opera e in primis sul messaggio nella stessa contenuto. La salvezza dell’umanità é riposta nella convinzione che solo una cultura che non si esaurisca nel semplice atto dell’apprendimento, ma vada oltre diventando un atto creativo, teso a liberare l’animo da ogni preconcetto, consente, nell’accettare noi, anche di accettare gli altri, permettendo di cogliere nella diversità ciò che non si ha, rompendo il circolo delle apparenze e facendo rinascere due sentimenti che da soli elevano l’uomo: la purezza dell’amore e la pietà. L’epoca, come detto, é quella fascista, che vive e vegeta sull’uniformità, ma che attecchisce in modo perfetto laddove, per ignoranza, per un errato concetto di religione, tutto deve essere immutabile e scritto da regole tramandate di generazione in generazione. Allora era senz’altro così, ma siamo sicuri che ancora oggi, in altri luoghi, ben lontani, non sia presente in modo corrosivo questa distorta mentalità?. Ed ecco che allora quello che a prima vista potrebbe sembrare un romanzo storico travalica il suo tempo e appare ancora attuale e con ogni probabilità sarà così anche in futuro. La carne al fuoco non é poca, perché ricorrono temi cari all’autore, quali la diversità, la difesa dei più deboli, il valore salvifico di una cultura che non sia fine a se stessa, ma la mano è sicura e anche se le prime pagine richiedono un certo grado di assuefazione, poi la lettura si fa più veloce e anche più appagante, tanto che posso dire che ci troviamo di fronte all’ennesima prova positiva di Simona Lo Iacono, che di certo offre, ancora una volta, tanta sostanza.
Indicazioni utili
Il sospetto
E’ difficile arrivare all’ultima pagina senza essere presi dall’ansia di chi vuol sapere, di chi paventa una fine che magari non sarà come quella immaginata, perché La scala di ferro è un vero e proprio thriller che riserva non poche sorprese e l’ultima di certo è quella meno prevedibile, anche se logica. Étienne, entrato nel cuore di un’avvenente, ma più anziana donna, che sospetta aver avvelenato e in tal modo ucciso il marito, poco a poco si convince che la prossima vittima designata non potrà che essere lui. Certi atteggiamenti della moglie, che ha sposato dopo un anno della sua vedovanza, e soprattutto le analisi di un medico gli confermano la fondatezza dei suoi sospetti. Già accusa dei disturbi causati dall’arsenico che gli viene propinato gradualmente in alcuni piatti ed Etienne, invece di andarsene, rimane perché senza quella donna non può più vivere e anche perché la nuova situazione rende più attiva la sua vita. Il tema del sospetto é un classico in questo genere di letteratura ed é stato introdotto con notevole successo nel cinema da Alfred Hitchcock, tanto da dirigere una pellicola intitolata appunto Il sospetto con interpreti Cary Grant e Joan Fontaine. E come nei film del grande regista inglese, nelle pagine di La scala di ferro troviamo una progressiva e crescente tensione che nel caso specifico non direi causata dalla paura perché ciò che si instaura fra Etienne e la moglie è un conflitto, con lei che procede nel suo disegno omicida e lui che cerca di salvare la pelle; inoltre, se lui sa dei propositi del coniuge, non è improbabile che anche lei si sia accorta che il marito nutre dei sospetti. É quasi una partita a carte scoperte, i cui contendenti tuttavia preferiscono nascondere, proprio per il sottile piacere provocato dalla tensione. Chi uscirà vincitore? Ovviamente non dico nulla lasciando a chi leggerà l’affannosa ricerca della verità.
La trama é particolarmente avvincente e l’analisi psicologica dei personaggi è assai approfondita, come è d’uso con Simenon; si entra piano in questa spirale di sospetti, ma poi tutto scorre rapidamente sotto ai nostri occhi, con sullo sfondo sempre quella scala di ferro, quella che porta dal negozio all’appartamento, l’ideale congiunzione fra la vita pubblica di tutti i giorni e le violente passioni private, che i protagonisti si sforzano di occultare.
Da leggere, ovviamente.
Indicazioni utili
All’avventura
Poeta al comando parla degli ultimi giorni dell’avventura fiumana di Gabriele D’Annunzio, l’unica in cui si cimentò da politico e capo di stato, senza essere tuttavia convincente sia nell’uno che nell’altro ruolo, e del resto lui stesso, il Vate, ne era consapevole. Si era gettato nell’impresa con l’impeto che gli era usuale quando riteneva di aver trovato il mezzo e il fine per suggestionare folle e accrescere il proprio mito; con lui partecipò un‘accozzaglia di reduci della Grande Guerra, per lo più Arditi, ben lieti di avviare un periodo all’insegna della massima libertà, senza che fosse necessario prendersi sul serio. Incapace di restare inattivo, D’Annunzio, nel periodo dell’occupazione della città (dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920), senza che ne prevedesse i futuri sviluppi, curò i rituali di cui poi si sarebbe appropriato il fascismo, ma scrisse anche una costituzione assai libertaria. Colto nel romanzo di Barbero nell’ultima parte dell’impresa, ormai in evidente declino, prima ancora che gli occupanti dovessero smobilitare, troviamo D’Annunzio nella sua tipicità di essere tutto e il contrario di tutto, con l’aggiunta però della malinconica consapevolezza che gli anni sono trascorsi e che quindi è già entrato nell’incerto e gramo periodo della vecchiaia. Pur nell’incoscienza di questa combriccola, che non è un’ Armata Brancaleone, ma che tuttavia si è gettata nell’impresa solo per spirito d’avventura, a Fiume si vive alla giornata in una sorta di baldoria in cui utopie, desiderio di ebbrezza e anche libero amore sembrano un anticipo di Woodstock 1969.
L’impressione che ne ho ricavato é che il mito abbia finito per travolgere il personaggio e che questo, che comincia a ricordarsi che la vita non é eterna, si immalinconisca, facendolo diventare più umano, così da scendere fra noi, comuni mortali, dal piedistallo su cui si era posto. L’idea di Barbero é geniale e porta a una lettura assai gradevole, tanto più che chi narra non é D’Annunzio , ma il suo segretario Tom Antogini, che nel 1944, in un bar di Salò ritrova dopo molto tempo e nelle vesti di ufficiale delle ausiliarie della RSI Cecilia, una ragazza più brutta che bella e che tuttavia a Fiume riuscì a irretire il poeta, divenuto da cacciatore di donne a preda. Fra l’altro, il fascino di Cecilia, che viene soprannominata da D’Annunzio Cosetta, é tale che doveva aver fatto breccia anche nel cuore dell’Antogini, tanto che a distanza di più di venti anni quella brace si ravviva e così ottiene quell’ amplesso che non gli era riuscito nei giorni dell’occupazione di Fiume.
Occorre riconoscere a Barbero la capacità non indifferente di presentarci un evento e dei personaggi in modo del tutto convincente e senz’altro gradevole, tanto che la lettura è da me consigliata.
Indicazioni utili
Quante croci nella neve!
Sulla nostra tragica partecipazione alla Campagna di Russia, nel corso della seconda guerra mondiale, hanno scritto in molti, soprattutto sul suo drammatico epilogo, quasi tutte testimonianze dirette di chi là c’era e che riuscì fortunosamente a mettersi in salvo. Ma di come ebbe inizio, di come si svolse e finì, e del seguito della stessa per quanto concerne i nostri soldati prigionieri dei russi, non vi sono molte opere e quindi L’armata scomparsa di Arrigo Petacco é da considerarsi un saggio storico indispensabile per comprendere tante cose.
Il libro, articolato organicamente in diversi capitoli, per lo più temporali, ha il notevole pregio di evidenziare da subito la scelleratezza di Mussolini che, benché consapevole della nostra impreparazione, non esitò a gettare allo sbaraglio migliaia di uomini, confidando nelle capacità militari dei tedeschi, i quali all’inizio non accolsero favorevolmente la nostra offerta di partecipare all’impresa, ma poi, viste le insistenze del duce, Hitler dovette cedere. Mancavamo di tutto: il fucile era il vecchio Carcano-Manlicher del 1891, l’artiglieria risaliva alla prima guerra mondiale, i carri armati erano semplicemente ridicoli, i mezzi di trasporto erano pochi e per lo più superati, il vestiario e le scarpe erano del tutto inadatte al clima, insomma fu inviata un’armata Brancaleone, in cui non pochi si distinsero per coraggio e abnegazione, ma tali caratteristiche furono del tutto insufficienti per colmare un divario che si può definire senz’altro enorme..
Quello che contraddistingue soprattutto la campagna di Russia fu la tragica ritirata, in cui non solo si verificarono numerosi casi di congelamento, ma che si concluse con una vera e propria strage della nostra armata. In pochi riuscirono a tornare in Italia, molti di più restarono sulla neve, anche fra quelli presi prigionieri e avviati ai campi di prigionia in Siberia. Lì, nei gulag, il freddo, il vitto insufficiente, il tifo petecchiale fecero il resto al punto che, a guerra finita, ritornarono in ben pochi, più o meno uno su dieci. E c’è da considerare che gli italiani furono trattati meglio dei tedeschi, in quanto non colpevoli di odiose violenze!
Alla fine viene quasi naturale porsi una domanda, sorretta più da speranza che da logica: fra quelli non ritornati, può essere che non pochi siano rimasti là di loro spontanea volontà? Forse è il ricordo del film I girasoli, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren che influenza questa idea, ma secondo la razionalità la probabilità che qualche disperso sia di fatto in vita e in Russia è molto limitata, se non altro perché per diversi anni dopo la fine della guerra nel Paradiso sovietico l’esistenza era molto difficile e il tenore di vita ben inferiore a quello italiano, quest’ultimo se pur condizionato dalle distruzioni della guerra.
Da leggere, quindi, per non dimenticare.
Indicazioni utili
Il prezzo del silenzio
E’ l’estate del 1936, Benito Mussolini trascorre le vacanze nella sua villa di Riccione e poco distante viene rinvenuto in spiaggia, dietro una duna, il cadavere di una nota prostituta, uccisa con un colpa di pistola di piccolo calibro penetrato in uno dei suoi occhi. Le indagini sono rapide e febbrili e nel corso dello stesso giorno portano all’arresto del colpevole, con tanto di meritato plauso del duce. Tutto semplice, quindi si direbbe, ma uno degli investigatori, l’ispettore Marino, un uomo umile e appassionato del suo lavoro, che vive un momento difficile poiché la moglie l’ha lasciato, non è convinto e, nonostante l’esplicito divieto del commissario, decide di intraprendere un’indagine non ufficiale. Da quel momento si sviluppa una vicenda intricata, con sviluppi che porteranno ad altre morti, in cui i sospettati sono diversi e tutti elementi di spicco del partito fascista. Fra adunate oceaniche e anche incontri intimi Marino procede spesso annaspando, talvolta vittima della sua intraprendenza, ma sempre deciso a far luce su quello che diventa a ogni ora un caso misterioso. C’è tanta carne al fuoco, tanta gente che da questo delitto cerca di ritrarre i massimi vantaggi e così, se anche si riesce poi a scoprire il vero colpevole, questi non verrà assicurato alla giustizia e il nostro ispettore, per una volta, converrà che è meglio tacere, che anche lui potrà avere così la tanto agognata promozione, tanto che nelle ultime pagine lo troviamo trasferito a Roma, in qualità di vicecommissario aggiunto al casellario politico centrale della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, un posto di tutta tranquillità, ma di rilevante importanza.
Lucarelli imbastisce un giallo politico in un’epoca del tutto particolare in cui i fatti di sangue dovevano avere il minor risalto possibile, tanto più questo che viene a toccare elementi del regime. La vicenda, pur se intricata, presenta una soluzione logica, ma si fa apprezzare soprattutto per i ricorrenti colpi di scena e per l’ambientazione, veramente ben rappresentata. Quella che invece é un po’ carente è l’analisi psicologica dei personaggi, appena abbozzata, protagonisti che sovente sembrano delle ombre che si affacciano sul palcoscenico. Nondimeno il romanzo é di gradevole lettura, vista la preminente finalità di svago, per quanto si strizzi un po’ l’occhio alla situazione attuale, in cui le rivalità fra politici portano ad attriti sovente indolori. Insomma, il giallo è piacevole da leggere, ma non è che si possa pretendere di più se non alcune ore di puro e solo moderato divertimento .
Indicazioni utili
Da evitare come la peste
Mi piace la storia, senza un preciso riferimento a un determinato periodo, così come sono appassionato di biografie di grandi protagonisti del passato. Ed è per questo che sono stato attratto irresistibilmente da questo libro di John Man sul famoso Gengis Khan, il capo mongolo che, novello Alessandro Magno, di conquista in conquista creò un impero che andava dall’Oceano Pacifico alle porte dell’occidente europeo. Purtroppo la lettura mi ha deluso, già dall’inizio, perché l’autore dà all’opera una struttura caotica, con frequenti e spesso inopportune digressioni, quasi che volesse far di tutto per non avvincere chi si avvicina a queste pagine sperando di conoscere qualche cosa di più di quello è ancor oggi un mito. Andare avanti, di capitolo in capitolo, finisce con il diventare particolarmente greve e, soprattutto, irritante, così che si giunge al termine con un lungo sospiro di liberazione. Ed è per questo che non mi sento di consigliarlo.
Indicazioni utili
La riscoperta dei sentimenti
Ci sono dei libri, che senza essere dei capolavori, hanno il pregio di lasciare traccia nel lettore, testi che vanno oltre il semplice scopo dello svago, ma che, pur consentendo di trascorrere piacevolmente qualche ora, portano a uno stato d’animo di pacata e corroborante serenità. Non sono molte queste opere, anzi sono poche, tutte contraddistinte da una scrittura semplice, da una capacità di saper toccare quei sentimenti che sono propri di ogni essere umano e che spesso giacciono assopiti dentro di noi. E questo il caso di Celestina, una raccolta di racconti di cui uno dà il titolo all’intero libro. Sono storie non fuori dall’ordinario, né ci sono protagonisti dalla forte e coinvolgente personalità, ma sono capaci di coinvolgere, nonostante alcuni marcati toni di tragedia, grazie a una vena malinconica che smussa, attenua e, anziché imporre, chiede che siano accolte. E soprattutto insegnano ad amare la vita, nonostante tutto, una lezione che fa leva sull’ancora di salvezza di ogni uomo: la pietà, per gli altri, ma soprattutto per noi stessi. Anche nelle situazioni più difficili, così come nei piccoli-grandi drammi domestici, la riscoperta dei sentimenti dirada le tenebre e fa trionfare la luce. Giocare sugli stati emotivi può essere rischioso, può far cadere facilmente nel déja vu, ma l’abilità dell’autore è nel proporli con un disarmante candore, senza la sensazione di un qualcosa di artefatto, con una spontaneità tale da sembrare che quelle parole escano direttamente dal cuore. É piacevole commuoversi di fronte a certe storie, come quella della bimba nata cieca e che ha la forza di vedere nel puro e reciproco sentimento dell’amore, o di Celestina, che lascia il suo piccolo mondo per andare a vivere in un ospizio e che trova una ragione per continuare a esistere in Anita, sua compagna di stanza. Sono storie minimali, forse, ma hanno tutta la parvenza di essere vere e soprattutto attuali, scritte con delicatezza, con rispetto, oserei dire in punta di penna, e che con umiltà e timidezza bussano alla porta del nostro cuore.
Indicazioni utili
Divertenti ed educative
Questo libro, di non poche pagine, presenta il non trascurabile vantaggio di riportare tutte le favole di Fedro a noi pervenute, in una nuova traduzione dal latino, comprensiva di note esplicative, effettuata da Lorenzo Montanari, nonché un saggio di Paola Corradini teso a farci conoscere un po’ di più di questo antico autore e della sua arte.
Per quanto, analogamente a Esopo e a La Fontaine, Fedro venga giustamente considerato uno dei maggiori favolisti è ancora oggi ben poco conosciuto, non tanto la sua produzione quanto invece la sua vita, elemento per certi aspetti indispensabile per inquadrarlo con esattezza nel panorama letterario. Del resto se molti hanno letto, tanto per fare un esempio, Il lupo e la gru e Il lupo e l’agnello e sanno che sono state scritte da Fedro, quando ci si chiede chi sia stato questo autore si entra nel campo del totalmente vago. Incerte sono le sue origini, forse elleniche, certo invece è il fatto che fosse uno schiavo liberato, cioè un liberto. E in tale condizione, cioè di uomo solo in parte affrancato, le scrisse, probabilmente per conquistare, se non il successo economico, quella fama che non solo gli consentiva di essere almeno pari agli uomini liberi, ma di risultarne addirittura superiore. É probabile che almeno in parte abbia raggiunto tale ambito traguardo, più in epoche successive alla sua esistenza che in quella in cui operò, anche perché a Roma il genere favolistico era considerato “minore”, pur possedendo un carattere tipicamente pedagogico e una finalità educativa. A noi sono pervenuti, incompleti, cinque suoi libri in versi senari (dunque si tratta di poesie) e, come scrive lui stesso nel prologo al primo libro, lo scopo é di far ridere e di fornire dei saggi consigli sul modo di vivere. Così animali e piante parlano in una consecuzione di metafore che celano comportamenti umani e che sono propri della favola, quindi da non confondere con la fiaba, popolata quest’ultima da folletti e orchi, cioè da creature di pura invenzione. Qualcuno potrà obiettare che questi testi potrebbero celare intenti satirici e in effetti i comportamenti umani narrati potrebbero lasciarlo intendere, ma il genere satirico, altro genere minore nell’antica Roma, non rientrava nelle intenzioni di Fedro, e comunque più che un riferimento a singoli personaggi si tratta sempre di una descrizioni di vizi, o difetti, tipici di non pochi uomini. Il rischio tuttavia che qualche potente potesse identificarsi in qualche animale o pianta c’era sempre e infatti Seiano, il potente ministro dell’imperatore Tiberio, lo fece processare, ipotizzando delle allusioni non gradite a chi allora contava; Fedro fu fortunato, poiché ne uscì senza danni, probabilmente per l’improvvisa scomparsa del suo accusatore, tanto che continuò a scrivere indisturbato i suoi amati senari.
Se mi può sembrare superfluo, oltre che dispersivo, parlare di tutte queste favole, che nel libro in questione sono riportate nella bella traduzione di Lorenzo Montanari con il testo latino a fronte, mi corre invece l’obbligo di evidenziare che i fruitori della lettura non devono essere considerati solo i bambini, ma anche e soprattutto gli adulti, in tempi come gli attuali dove è possibile trovare gli stessi difetti di allora, spesso più tipici dei potenti che degli umili, come era Fedro, il che starebbe a giustificare il ripetersi, immutabile, della storia.
Comprensibili, grazie anche alle note, e pure divertenti , le Favole di Fedro non hanno perso nulla del loro antico smalto e la fantasia dell’autore è accattivante, invoglia a leggere, a scoprire, a verificare, cogliendo così quello scopo educativo originario e tributando all’autore quella fama ormai imperitura di cui ai suoi tempi non poté essere gratificato.
Indicazioni utili
| 1070 risultati - visualizzati 201 - 250 | « 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 22 » |