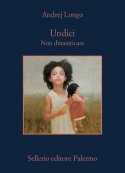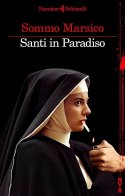Opinione scritta da Valerio91
| 447 risultati - visualizzati 151 - 200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Il trono di sangue
Il duca di Gloucester (in seguito Re Riccardo III) è senza alcun dubbio il personaggio più sanguinario della produzione shakespeariana. O almeno, di quella che ho analizzato finora.
Subdolo come Iago in "Otello", egli è un uomo capace di eliminare senza remore tutto (e tutti) ciò che si frappone tra sé e il suo obiettivo: il trono.
Tutto, in quest’opera, ruota intorno a colui che le presta il nome, il quale giustifica le sue cruente azioni attribuendole al suo mostruoso aspetto, all’inclemenza della natura che non gli ha concesso un’esteriorità apprezzabile impedendogli di condurre una vita normale e, dunque, di sviluppare un animo buono.
La decisione di cominciare ad agire in armonia con la propria bruttezza, dunque, è la premessa che da inizio al “Riccardo III”, considerata una delle tragedie più forti del Bardo.
Per quanto mi riguarda, nonostante i picchi poetici che riesce a raggiungere in certi tratti, essa non arriva alle altezze raggiunte da altre opere come "Amleto”, o anche "Macbeth" e "Otello”. Questo perché, mentre in altre opere buona parte dei personaggi ha qualcosa da dire e uno spessore apprezzabile, qui quello che spicca su tutti è solo il protagonista. Certo, la sua maestosa e inquietante figura non può che oscurare un po' tutti gli altri, ma ho avuto comunque l’impressione che i suoi comprimari (a parte pochissime eccezioni come Buckingham) fossero di per sé stessi un po’ deboli. Basta prendere in considerazione i personaggi femminili che per mano di Riccardo hanno subìto sofferenze e ingiustizie imperdonabili: nonostante i gravissimi torti subiti, dopo doverose ma fin troppo brevi resistenze finiscono tutte per cedere al fascino delle parole e dei motivi del duca.
Nonostante non sia la coerenza narrativa quel che più ci interessa in un’opera shakespeariana, in questa tragedia più che in altre si nota qualche forzatura di troppo che toglie potenza ai versi. Nessuno nutre dubbi sulle malefatte del duca di Gloucester né tantomeno lui si preoccupa di negarle a lungo, ma questi orrendi crimini che toccano persone molto care ai diretti interessanti vengono ben presto accantonate, come non fossero abbastanza gravi da rifiutargli concessioni anche importanti. Giusto per fare un esempio e sempre soffermandoci sui personaggi femminili, Anne concede la propria mano all’assassino del proprio marito, mentre accompagna la bara di quest'ultimo verso la sepoltura: mai vedovanza fu così breve. Nondimeno, la regina offre la mano di sua figlia all’assassino dei suoi bambini, consapevole anche che quell’uomo è oltretutto responsabile della morte della sua precedente consorte: Anne.
Fatte queste considerazioni, come ogni opera letteraria anche “Riccardo III” va contestualizzato e in parte giustificato, perché certe licenze vengono concesse per permettergli di esprimere la propria poetica e il proprio messaggio nel migliore dei modi. Ai miei occhi tuttavia, queste scelte hanno finito per mettere questa tragedia un gradino sotto alle altre citate sopra, che restano salde sul trono a dispetto dell’usurpatore Riccardo, che avrà anche spodestato il Re, ma non scalza gli altri capolavori creati dal grandissimo William Shakespeare.
"Andate, signori! Ognuno al suo posto. I vani bisbigli dei sogni non atterriscano le nostre anime. La coscienza è una parola usata dai vili, inventata per impaurire i forti. Le nostre braccia potenti siano la nostra coscienza, le spade la nostra legge. Avanti: combattiamo con coraggio, buttiamoci nella mischia; se non saremo adatti per il cielo allora, tenendoci per mano, andremo all'inferno."
Coinvolgente e, in certi tratti, esilarante
Pino Imperatore mi ha ispirato subito simpatia. Certo, c'è da dire che uno scrittore che fa dell'umorismo il suo cardine e che fallisca in questo fondamentale non varrebbe poi molto. Beh, partiamo dal presupposto che oggi non è poi così scontato che chi debba far ridere effettivamente ci riesca. Pino Imperatore ha tuttavia qualcosa in più: quella napoletanità genuina che dalla sua penna emerge in maniera evidentissima. Umorismo colorito, vivacità, amore viscerale verso la propria terra e l'autoironia necessaria per ridere degli stereotipi che a Napoli vengono affibiati ogni giorno. Da napoletano l'ho apprezzato molto.
La storia di base, che alla fine è un giallo piuttosto ordinario, si colora di personaggi super-simpatici, divertenti, che si rendono protagonisti di siparietti divertentissimi, che servono a stemperare il clima di tensione che un giallo necessita per chiamarsi tale. Faremo la conoscenza del nostro protagonista, l'ispettore Scapece: poliziotto Dongiovanni che le stende tutte con la sua avvenenza e intelligenza; del commissario Improta che col suo ispettore crea una coppia riuscitissima; della variegata famiglia Vitiello, proprietaria della trattoria Parthenope in cui Scapece ama trattenersi per un lauto pasto ma anche per godersi con la bella figlia di uno dei proprietari. Una famiglia variegata ed esilarante (soprattutto nonno Ciccio e il cane: Zorro) che darà il suo ufficioso contributo alle indagini di Scapece, che in “Con tanto affetto ti ammazzerò” si concentrano sulla scomparsa di una nobile napoletana.
La storia ha inizio durante i festeggiamenti del novantesimo compleanno della baronessa Elena De Flavis, in villa Roccaromana a Posillipo. Nel bel mezzo della festa tutti sembrano diventare preda di malori e svenimenti. Nel caos che ne consegue, la baronessa e il suo maggiordomo spariscono misteriosamente. Scapece e Improta, presenti alla festa come semplici ospiti, si troveranno anche in quel caso a vestire i panni dei poliziotti, per scoprire che fine ha fatto la De Flavis.
Tra momenti di pura investigazione e scene scritte appositamente per stemperare e divertire il lettore, saremo spettatori della risoluzione di un caso che alla fine ci porrà di fronte a un vero dilemma morale, spingendoci a interrogarci su cosa è giusto e cosa non lo è, così come lo faranno i nostri protagonisti.
"Io ho quasi sempre vissuto qui, fin dalla nascita. Questa residenza è stata la mia culla e il mio fortino; mi ha protetta, mi ha allietata, mi ha tenuto al riparo dalle tempeste della vita. Ora però è venuto il momento di tirare i remi in barca; gli anni dell'ardore sono lontani. È cosa saggia riposarsi, quando la debolezza si fa onerosa e i ricordi sono fuor di misura. Essere vecchi è un brutto mestiere."
Indicazioni utili
Il volto che ci viene imposto
Parlare di un'opera teatrale è molto diverso dal parlare di un romanzo. La bravura dell'autore di un testo teatrale si evince soprattutto dalla sua capacità di far parlare e interagire i personaggi in scena, in modo da metterne bene in risalto i caratteri, i pensieri e le contraddizioni. Nel caso de "Il dio del massacro" questo discorso è valido più che mai, essendo palese l'obiettivo di" montare e smontare" gli stessi protagonisti; affibbiargli una maschera e poi farla decadere miseramente, facendo venire fuori i lati più gretti della natura umana.
Le maschere che la società ci costringe a indossare sono tante e diverse per ogni occasione, ed è proprio questo il tema trattato da Yasmine Reza che, devo dire, lo fa in maniera molto efficace. Vedere il graduale (ma veloce) mutare dell'atteggiamento dei protagonisti è difatti la cosa più interessante: prima affabili e accomodanti, poi furiosi al punto da sembrare posseduti da un vero e proprio "dio del massacro”.
Le maschere sociali vengono giù e altro non resta che l'essere umano (im)puro e semplice. Risolvere la controversia tra i due ragazzini non è mai stato il vero obiettivo; l'obiettivo era imporre il proprio ego, mettere in risalto il proprio valore in quanto genitori, e quindi in parte in quanto individui. Il litigio tra i due ragazzini passa in secondo piano, lasciando il posto alla personalità delle quattro figure che, in un modo o nell'altro, vogliono prevalere e imporre i propri pensieri e ideologie. È interessante anche vedere come, nonostante i litigi, vengano fuori naturalmente delle complicità di genere (marito-marito, moglie-moglie), che risultano essere la cosa più genuina e spontanea. A parte l'ira incontrollata, ovviamente.
Due coppie sposate si trovano nel salotto di una delle due, per risolvere una controversia nata tra i loro due figli: uno dei due infatti ha fatto saltare gli incisivi all'altro, in seguito (pare) a una provocazione. Inizialmente guidati (almeno in apparenza) da ogni buona intenzione, presto lasceranno fuoriuscire le prime divergenze d'opinione, inizialmente generate dal proprio "istinto di protezione genitoriale", ma in seguito inasprite da tutte le insoddisfazioni continuamente represse, sia personali che di coppia. Un dipinto brutale del nostro reale aspetto interiore, quello senza filtri. La sensazione che si prova durante e alla fine della lettura è quella che darebbe l’atto di mettersi avanti allo specchio e togliersi una maschera col proprio volto, scoprendo che aveva sempre celato un mostro.
Vi consiglio di guardare anche la trasposizione cinematografica di Roman Polanski, che offre qualcosa in più all'esperienza trasmessaci da quest'opera, oltre che a dare un ulteriore spunto di riflessione che il testo scritto non ci offre. Tranquilli, non è una libera interpretazione del regista, essendo stato affiancato nella sceneggiatura dalla stessa Yasmina Reza.
Buona lettura (e visione).
"Vèronique, io credo nel dio del massacro. È il solo che governa, in modo assoluto, fin dalla notte dei tempi."
Indicazioni utili
Formarsi sotto mille influenze
“Presunzione” è la seconda pubblicazione di Luca Mercadante, che gli è valsa una menzione alla trentesima edizione del prestigioso Premio Calvino.
È stato interessante confrontarmi con il lavoro di un autore che è stato mio concittadino e che ha ambientato questo romanzo proprio nel contesto della provincia di Caserta, nella quale sono cresciuto. Pur appartenendo a due generazioni diverse ho provato una sensazione di familiarità non solo nei luoghi da lui descritti, ma anche nel contesto e nelle situazioni che tratteggia con la sua penna, devo dire, piuttosto buona e scorrevole. Questo mi ha aiutato a empatizzare soprattutto col protagonista, anche se lui viene dal contesto di Villa Literno in cui più si sente l’impronta della camorra, qui un po’ più celata (ma comunque presente). Il romanzo si concentra infatti sulla crescita di questo ragazzo, investito dalle influenze più disparate: quella di suo zio Piero, che lo incita a più riprese a scappare dalla sua terra; quella dello zio Nicolino, rappresentante neanche tanto celato di Quelli-llà, che si può facilmente immaginare chi siano; quella di suo padre, che di tutti è forse il più ambiguo e infine l’influenza che inevitabilmente investe ogni ragazzo negli anni dell’adolescenza. Tutti questi influssi porteranno Bruno Guida a crescere in una situazione turbolenta, per nulla aiutata dal suo carattere che, in fondo, nasconde un po’ di quella Presunzione evidenziata dal titolo.
Bruno Guida si reputa diverso da tutti i ragazzi con cui ha avuto a che fare nei primi anni nella sua vita. I ragazzi di Villa Literno sono soggetti a pregiudizi: confinati nella terra che per tutti è quella della camorra e della malavita finiscono per esserne additati come componenti, pur essendone spesso staccati. Bruno non accetta questa “etichetta”, ed è per questo che decide di frequentare il liceo Benedetto Croce di Caserta, pur essendo piuttosto lontano da casa sua. Bruno vuole distinguersi dai suoi compaesani; lui è tutt'altra persona e sente in sé un’ambizione che lo proietta verso grandi cose.
Quali siano queste grandi cose, però, non gli è poi così chiaro.
Lo scossone che cambia totalmente la vita al protagonista è la morte dello zio Piero, fratello gemello di suo padre, che per questa perdita si lascerà andare alla più completa follia. Essendo convinto che dietro la morte di suo fratello ci siano Quelli-llà, il padre di Bruno formerà un’organizzazione anti-camorristica che lo assorbirà totalmente proprio quando suo figlio ha più bisogno di lui. Alla figura paterna proverà a sostituirsi quella dello zio Nicolino, quello rispettato da tutti, perché dai suoi affari è meglio stare alla larga. Tra questi eventi piuttosto difficili da affrontare per la psiche di un adolescente, ci sarà spazio anche per quelle situazioni che ogni adolescente affronta: la scuola, gli amici, l’amore.
Un romanzo di formazione interessante in un contesto piuttosto inedito, che può valere la pena approfondire.
“Fu così che la mia famiglia, dopo aver smarrito il timone (che era mio padre fino a qualche tempo prima) perse anche l’ancora. Cosa che mi faceva più paura, perché senza una direzione si ha pur sempre la speranza di arrivare da qualche parte. In assenza dell’ancora, l’unica certezza è che la barca sarà per sempre in balia delle onde.”
Indicazioni utili
Madre potenziale
Ed eccomi qui, a recensire la talentuosa (e prolifica) autrice Valentina Belgrado. “Reborn” è la sua ultima creatura, che conserva lo stile distintivo dell’autrice: forbito, preciso, e nel caso del suo ultimo lavoro arricchito da una scorrevolezza che gli dà qualche punto in più.
Nel corso di queste quasi settanta pagine veniamo accompagnati in un viaggio nella psiche della nostra protagonista, Prisca, che si rivela un personaggio interessante e controverso. E’ questo secondo me il punto di forza di questo romanzo, ma dell’autrice in generale: quello di essere capace di portare in vita personaggi che si rivelano realistici nel loro essere anomali; molto spesso, nella letteratura, ci si imbatte in uomini e donne che sembrano troppo coerenti per far parte dell’umanità, che agiscono in maniera troppo lucida e i cui pensieri seguono fili troppo immacolati per appartenere a esseri umani carichi di sofferenze, fobie, insicurezze. Prisca è invece carica di quelle contraddizioni, di quei tratti distintivi che la rendono unica come potrebbe essere una donna in carne e ossa.
Come dicevo, la storia di “Reborn” è incentrata su Prisca e sulla sua volontà di avere un figlio, che lei desidera chiamare Tancredi; un figlio che vuole avere in ogni modo. Tuttavia, la sua vita sentimentale non le permette di intraprendere questo percorso, essendosi silenziosamente separata da un uomo con cui ha condiviso vari anni di vita, pur non avendo con lui condiviso nulla, non realmente. Da una storia sterile, Prisca non poteva ricevere il frutto del suo desiderio; tuttavia, lei sembra scovare un altro modo per poter avere quel figlio tanto atteso. Questa scelta la porterà a trasferirsi per un certo tempo in Emilia Romagna, dove una serie di eventi la costringerà a guardarsi dentro, a confrontarsi col suo passato e con la spaventosa realtà che ci circonda.
Prisca intraprenderà un viaggio dentro sé stessa, e noi con lei.
“Una tenace cortina di struggimento per ciò che non ero ha avviluppato tutti i primi periodi della mia esistenza, con scarsi e fugaci barlumi di leggerezza. La ricerca ostinata di un grimaldello di sofferenza per essermi guadagnata davvero tutto quell’agio e quel benessere che, in termini societari, ritenevo dovuti. Quindi, da fuori, mi si percepiva viziata e capricciosa; da dentro, io mi sentivo misurata e insignificante al punto di necessitare continui tormenti per potermi dire in pace.”
Indicazioni utili
Chi è VALIS?
Probabilmente si tratta di una cosa che ho già detto, ma a costo di ripetermi la dirò ancora: Philip K. Dick è uno degli autori più geniali mai esistiti. O forse sarebbe meglio dire che è uno degli autori che ha avuto le idee più geniali, pur non essendo sempre riuscito a renderle nel migliore dei modi.
Anche l'idea che sta alla base di "Radio libera Albemuth" è una di quelle belle, che danno spazio a infinite opportunità, ma questo autore mi lascia sempre questa sensazione di incompiutezza; una sensazione che mi suggerisce che quest'idea si sarebbe potuta sfruttare meglio.
Lo stile dell'autore, in quest'opera, è tra i migliori che ho incontrato nei suoi vari romanzi: Dick era un autore piuttosto discontinuo, riguardo a brillantezza dello stile; qui non eccelle, ma è in buona forma. A parte ciò, devo dire che questo romanzo parte discretamente, si ammoscia nella sua parte centrale per poi andare a razzo nella sua conclusione; una conclusione che ho trovato piuttosto bella e che gli ha fatto guadagnare qualche punto.
Al centro di questa vicenda ci sono Nicholas Brady, un venditore di dischi che si ritroverà a contatto con un'entità aliena non meglio specificata (che lui chiamerà VALIS, e sarà protagonista della successiva trilogia che prende il suo nome) e l'alter ego dello stesso Philip K. Dick, che inserisce sé stesso nella storia qui raccontata (approfittandone per respingere la calunnia di chi lo considerava uno scrittore che scriveva sotto effetto di stupefacenti).
Il romanzo tocca vari temi, a partire dalle riflessioni sull'esistenza e la natura di un'entità divina, passando per altri prettamente fantascientifici come l'eventuale esistenza di universi paralleli e di forme di vita aliene superiori a noi.
La storia si svolge in un'America che è caduta in balia di un tiranno: Ferris F. Fremont, che ha instaurato un regime di terrore e controllo simile in certi tratti a quello del "1984" di Orwell. Pur non raggiungendo la degradazione e l'oppressione del regime del Socing, quello di Fremont è comunque un governo che limita le libertà personali e si attiva, anche con subdoli stratagemmi, per eliminare qualsiasi nemico: reale o anche potenziale. I nostri due compagni sono tra i bersagli sia della polizia sia di vari gruppi di volontari patriottici, che si preoccupano di tenere d'occhio i propri concittadini e rivelare qualsiasi attività sospetta.
In questo scenario di terrore, il nostro Nicholas Brady entra in contatto con VALIS, strana entità che gli apparirà in sogno mostrandogli quello che dovrà essere il suo destino e il suo ruolo nella liberazione dell'umanità dall'oppressore. Ma chi è davvero VALIS?
"La morte degli uomini, pensai, è una cosa orribile. La morte degli uomini buoni è ancora peggiore. Una tragedia. Specialmente quando è inutile."
Indicazioni utili
Buoni propositi dissolti nell'alcool
Un libro di poche pagine che mi ha portato a scoprire un autore che posso potenzialmente amare. “La leggenda del santo bevitore” è un racconto molto breve, l’ultimo scritto da Roth e pubblicato dopo la sua morte; molto di suo sembra esserci nel protagonista: Andreas Karnak, clochard che vive sotto i ponti di Parigi e col vizio dell’alcool.
Questo racconto ci espone la situazione di quest’uomo che, ormai abbandonatosi completamente alla propria vita miserabile, si trascina in avanti dimentico di sé stesso e di quello che gli sta intorno. All’inizio di questa storia, tuttavia, sembra aprirsi uno spiraglio di luce: si presenta a lui un uomo che gli offre un’occasione per riprendere in mano la sua vita e rimettersi in carreggiata, tramite l’offerta di duecento franchi. Andreas, pur essendo un disperato, si reputa tuttavia un uomo d’onore e inizialmente rifiuta l’offerta, non avendo indirizzo e non potendo dunque restituire la somma prestatagli. Lo sconosciuto gli offre allora l’opportunità di restituirla offrendola a Santa Teresa, che a quanto pare lo ha portato sulla strada della vera felicità; una strada che l’ha condotto a offrire quell’aiuto ad Andreas.
Andreas accetta, cercando di far fruttare quell’occasione che la Provvidenza gli ha generosamente offerto.
Il clochard protagonista di questa storia è un uomo al quale la vita offre più di un’occasione, nel giro di pochissimo tempo; i miracoli (sotto forma di crediti) di cui si trova a “subire” gli effetti sono tutte le occasioni che la vita può offrire a un uomo come tanti, che tanto può esserne grato e sfruttarne i benefici per portare la sua vita a un livello superiore (così come ha evidentemente fatto il benefattore all’inizio del racconto); tanto può concentrarsi sui suoi bisogni immediati, scialacquando quell’occasione per riassaporare brevemente quelle cose di cui è stato privo per tanto tempo. In questi archetipi d’uomo Andreas si colloca in una posizione particolare: quella dell’uomo che vuole assolutamente sfruttare l’opportunità che gli viene offerta, che non dimentica mai il debito che ha contratto e che non pensa mai di sottrarvisi, ma che non ha abbastanza forza d’animo e di volontà né per rispettare l’impegno all’estinzione del debito né per dare alla sua vita una spinta decisiva. Basta poco a farlo desistere dai suoi propositi, e nella maggior parte dei casi questo “poco” si identifica con un invito a bere.
Saremo dunque spettatori delle azioni di un uomo reso impotente dalla sua scarsa lungimiranza, troppo schiavo dei suoi bisogni nel tempo presente per pensare a costruirsi un futuro degno d’esser vissuto.
Un gran bel racconto, che mi fa venir voglia di approfondire l’opera di Joseph Roth.
“Perché a nulla si abituano gli uomini più facilmente che ai miracoli, se si sono ripetuti una, due, tre volte. Sì! La natura degli uomini è tale che subito vanno in collera se non capita loro di continuo tutto quanto sembra aver loro promesso un destino casuale e passeggero.”
Indicazioni utili
Che stia davvero tornando il King di una volta?
Intendiamoci, "L'istituto" non è un'opera esente da difetti e probabilmente non è neanche lontanamente accostabile a quei capolavori che sono "Il miglio verde", "22/11/'63" oppure "It"; ma è comunque un romanzo che ci fa risentire il sapore del King migliore, quello che l'ha portato a essere quello che è.
Mentre in seguito alla lettura di "The Outsider" poteva sussistere il dubbio che fosse solo una buona uscita in mezzo alle tante recenti delusioni, la lettura di quest'ultimo romanzo ci rivela un King in grande spolvero e fa recuperare speranze ai suoi fan che sperano in altri capolavori che siano al livello delle opere del passato, anche perché a rigor di logica un autore dovrebbe essere come il vino e migliorare col passare degli anni. Ai tempi di della trilogia che aveva inizio con "Mr. Mercedes" sembrava che questo discorso non si applicasse in questo caso, e che il Re fosse precipitato in un rovinoso declino senza uscita.
Questo timore potrebbe essere infondato.
Lo stile di King è coinvolgente e scorrevole come sempre, capace in certi tratti di tenerti incollato alle pagine, anche se ci sono dei momenti in cui la storia tende a rallentare e l'autore a ripetersi. L'originalità della storia e il mistero che la impregna, tuttavia, riescono a stimolare la curiosità del lettore e a spingerlo a non demordere anche nei tratti più lenti.
Come dicevo all'inizio però, quest'opera non è esente da difetti; anzi, direi che ce n'è uno piuttosto evidente che nella mia testa ha un po' sminuito il valore di tutta la storia, perché è su questo presupposto che si regge tutta la trama tessuta dall'autore. Non posso essere più specifico, altrimenti rischierei la lapidazione per "spoileraggio" acuto, ma posso dirvi che un lettore attento e più schizzinoso di me che si accorga della stessa incrinatura narrativa, potrebbe avere una reazione molto meno pacata della mia, che mi sono limitato ad abbassare di un'unità il voto al contenuto.
La storia si concentra su Luke Ellis, ragazzino dodicenne dall'intelligenza talmente straordinaria da portarlo anche a una così giovane età, a presentarsi per i test d'ingresso di due importanti università. Contemporaneamente.
L'intelligenza, tuttavia, non è l'unica peculiarità a rendere speciale questo ragazzino, e saranno proprio le sue altre doti a spingere una squadra di rapitori a uccidere i suoi genitori, rapirlo e portarlo in una struttura detta "L'istituto". Luke si risveglierà in una stanza in tutto e per tutto simile alla sua, se non fosse per la totale assenza di finestre.
In questo Istituto Luke conoscerà tanti altri ragazzi come lui, che vengono sottoposti ai trattamenti più brutali pur di far emergere le loro capacità, che a quanto sostengono i direttori di quell'inferno vengono utilizzati per "il bene della nazione". Cosa può capirne un bambino, per quanto dotato, del bene di una nazione? Come può un bambino anche solo pensare di sacrificare la propria spensieratezza nel nome di qualcosa che non è ancora in grado di capire?
King mette in piedi una storia originale, che potrebbe concludersi con questo tomo o anche dipanarsi in nuove pubblicazioni. Certo, occorrerà impegno per dare nuova linfa a una storia che sembra averci già detto molto di quel che aveva da dire, ma potrebbe valerne la pena.
"C'era un aggettivo per definire le persone come lei, ed era: fanatica. Eichmann, Mengele e Rauff erano scappati, seguendo la loro natura di codardi e di opportunisti, ma quel fanatico del loro Führer era rimasto e aveva preferito suicidarsi. Luke era quasi certo che, avendone l'opportunità, quella donna avrebbe fatto altrettanto."
Indicazioni utili
Un semplice primo amore
Quando ho letto la trama di questo libro sono rimasto piuttosto incuriosito: mi fa sempre un certo effetto veder citare determinati autori, e leggere il titolo “Mattatoio n.5” di Kurt Vonnegut mi ha fatto ben sperare riguardo questa storia, spingendomi a leggerla. Tuttavia, come succede con marchette, fascette e affini, anche la trama può essere ingannevole. Mentre nella mia mente immaginavo una storia di formazione in cui i libri(quelli belli) hanno un ruolo fondamentale, mi sono ritrovato a leggere niente altro che la storia di un primo amore adolescenziale, che non ha molto di originale e in cui i libri non hanno il ruolo che avevo sperato.
Certo, lo stile dell’autore è scorrevole(e ci mancherebbe, considerando il genere a cui si è rivelato appartenere), ma manca di quel qualcosa che può distinguerlo dalla miriade di altri libri simili. Non ho letto l’altro libro dell’autore che, stando alla fascetta dovrebbe aver venduto milioni di copie, ma dovesse essere simile fatico a spiegarmene il motivo.
Non si può dire che Nicholls sia stato una rivelazione, insomma, tuttavia c'è da dire anche che non prediligo il genere.
La storia è completamente incentrata sulla figura di Charlie Lewis, fresco diplomato e non certo con lode. Ragazzo che si autodefinisce piuttosto anonimo, che vive una situazione familiare non facile e non fa altro che vivere la vita piuttosto passivamente, senza una vera passione che gli infiammi l’anima. Il suo unico passatempo è divertirsi in modi piuttosto "estremi" in compagnia del suo gruppetto di amici.
L’estate in cui la scuola finisce, tuttavia, si rivelerà piuttosto densa di avvenimenti: lo porterà ad allontanarsi dai suoi vecchi amici e, casualmente, incontrare quello che sarà il suo primo amore: Fran Fisher. Quella che inizialmente sarà una cotta lo spingerà a far parte di una compagnia teatrale, la Compagnia del Bardo, che sta lavorando per mettere in scena Romeo e Giulietta. Qui Charlie incontrerà anche molti dei suoi ex compagni, con i quali stringerà rapporti che durante la scuola non si sarebbe mai sognato. Questa nuova esperienza porterà Charlie a sbocciare, non senza difficoltà, introducendolo nel nuovo mondo dell’età adulta.
"[...] per me il primo amore è come una canzone, una stupida canzoncina, la senti e pensi, non voglio sentire più nient'altro, qui c'è già tutto, questa è la melodia più bella che sia mai stata scritta. Poi cresci e non lo metti più quel disco, ora sei più tosta, e smaliziata, e hai dei gusti più raffinati... Ma quando la senti per radio, be', è ancora una bella canzone. Proprio bella."
Indicazioni utili
- sì
- no
Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono
Da un saggio pregno di riflessioni interessanti, contenente un’attenta analisi della natura umana e della società in cui quest’ultima si trova a vivere, non ci si dovrebbe stupire nel ritrovarsi davanti a pensieri e temi già riscontrati in opere di altri scrittori. Oltre alla soddisfazione di “collegare i fili”, rendendosi conto che probabilmente Palahniuk ha preso qualche idea da quest’opera e lo stesso Fromm trova qualche analogia analitica nel precedente “Il tallone di ferro” di Jack London, durante la lettura ci si presenta la piacevole sensazione di un puzzle che comincia lentamente a riempirsi; un puzzle che contiene in sé un’immagine degli uomini e della società moderni. Certo, come ogni opera “Avere o essere?” va contestualizzato; va compreso come il pensiero dell’autore sia pregno di quel terrore “atomico” tipico della piena Guerra Fredda, e dunque di quel sentimento condiviso di catastrofe imminente. Tuttavia, molti dei pensieri trattati da Fromm trovano ancora pieno riscontro nell’essere umano contemporaneo e nella società odierna, entrambi tendenti a vivere una vita basata su quella che il filosofo chiama “modalità dell’avere”.
Ma cos’è la modalità dell’avere?
“Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli, non sei i tuoi vestiti di marca”. Questo pensiero espresso da Tyler Durden in Fight Club è l’esatto contrario di quanto sostenuto (consciamente o meno) da chi vive secondo la modalità dell’avere, ed è facile capire quanto il mondo moderno sia pregno di questa illusione di felicità derivante dal possesso di cose materiali. Non lavoriamo per poterci permettere sempre più lusso? per avere una nuova auto, per avere l’ultimo ritrovato tecnologico, e per avere una bella casa? Avere, avere, avere. Eppure, non è vero che poco tempo dopo l’acquisto tutte queste cose perdono di valore? non è vero che subito dopo sentiamo il bisogno di acquistare altro, di avere altro? Dunque qual è la soluzione?
Secondo Erich Fromm, la soluzione sta nella modalità dell’essere; una soluzione sostenuta anche da quelli che lui definisce i più Grandi Maestri della storia dell’uomo, tra i quali figurano Gesù Cristo, Buddha, fino ad arrivare a Karl Marx, il cui pensiero è stato talmente precoce da venire snaturato e utilizzato per perorare la causa dell’avere. Ma cos’è la modalità dell’essere, invece?
La modalità dell’essere è slegata dal possesso. Certo, per sopravvivere l’uomo ha bisogno di “avere” certe cose, ma non è a questo scopo che dovrebbe essere volta la sua esistenza. L’uomo dovrebbe dedicarsi alla sua evoluzione interiore, a una vita contemplativa che gli consenta di essere dinamico, pregno di un’attività che non si intenda come un semplice “fare le cose”, ma come costante evoluzione della propria umanità che faccia del proprio perno l’amore verso sé stessi e di conseguenza verso gli altri. Vivere secondo la modalità dell’essere significa vivere con l’obiettivo di avvicinarsi ogni giorno di più alla effettiva natura umana, che è libera da ogni egoismo e che trova il suo benessere definitivo nella completa condivisione con gli altri e con l’amore reciproco. L’egoismo, infatti, non è insito nella natura umana come molti credono, bensì il prodotto della mentalità di un mondo che ha fatto della modalità dell’avere e del consumismo il suo centro.
La salvezza dalla catastrofe verso la quale si dirige il mondo, dunque, si troverebbe nel completo cambio di rotta dell’uomo e della società verso un modo di vivere improntato sull’essere; un cambiamento della cui difficoltà è lo stesso autore a rendersi conto, pur tentando di fornire qualche linea guida. Mentre l’individuo può tentare più “facilmente” di provare a vivere staccandosi dall’illusione che i beni materiali lo rendano ciò che è, e che quanto più ha tanto più sarà felice, un’altro paio di maniche è far invertire la rotta al mondo intero. Potremo mai essere in grado di mettere in atto tale cambiamento? Forse solo quando la catastrofe sarà imminente, sperando che a quel punto non sia già troppo tardi.
“Secondo la modalità dell’avere, non c’è rapporto vivente tra me e quello che io ho. Questo e l’io sono divenuti cose, e io ho le cose perché ho la forza di farle mie. C’è però anche una relazione inversa: le cose hanno me, perché il mio sentimento di identità, vale a dire l’equilibrio mentale, si fonda sul mio avere le cose (e quante più è possibile). La modalità dell’esistenza secondo l’avere non è stabilita da un processo vivente, produttivo, tra soggetto e oggetto; essa rende cose sia il soggetto sia l’oggetto. Il rapporto è di morte, non di vita.”
Indicazioni utili
"Fight Club" di Chuck Palahniuk
"Il tallone di ferro" di Jack London
Solo il mimo canta al limitare del bosco
Quello di sopra è il titolo con il quale mi si è presentata questa storia: un titolo piuttosto intrigante e che trova il suo senso nelle pagine che ci si ritrova a leggere, pur mantenendo il suo criptico significato.
E' una Terra piuttosto strana, quella descritta dall'autore in questa storia: un luogo in cui tutto vuole apparire normale, in cui gli esseri umani conducono la stessa vita di sempre, ma la cui falsità si percepisce fin dal principio. Tutto è andato in malora, eppure si fa fatica a identificare le cause che hanno portato al decadimento; si fa fatica a "scovare il nemico". La terra si è trasformata in una sorta di macchina in cui tutto procede meccanicamente, riproducendo uno spettacolo che prova a simulare il calore della vita e dell'esperienza umana ma in realtà non riesce a celare la propria freddezza.
Walter Tevis riesce, col suo stile, a fare in modo che la storia continui a essere piuttosto piacevole nonostante i temi difficili che si ritrova ad affrontare: suicidio, soffocamento dei sentimenti, declino del genere umano.
Il racconto viene affidato a tre punti di vista diversi. Il primo è quello dell'automa Spofforth, spaventosamente simile a un essere umano nella sua versione più perfetta, sia fisicamente che intellettualmente. Il suo cervello è stato costruito sulla base di una delle menti più brillanti dell'epoca in cui è stato assemblato, ma di cui non è stato isolato ed eliminato quello che potremmo chiamare "inconscio". Spofforth non è una macchina fredda, che esegue semplicemente le sue mansioni; è un essere umano in tutto e per tutto, che tuttavia non è soggetto al decadimento e quindi alla morte. Nella sua lunghissima vita non è riuscito a trovarne un senso e più di ogni altra cosa brama la morte; una morte che gli viene tuttavia impedita dalla sua programmazione.
Il secondo e il terzo punto di vista sono quelli di due esseri umani, Paul e Mary Lou. Il primo è un uomo che ha riscoperto l'antica arte della lettura, ormai non più praticata da alcun essere umano e addirittura vietata dalla legge (ricorda un po' "Fahrenheit 451"). Gli esseri umani vengono allontanati da tutto quello che può far scaturire una riflessione, costretti ad abbandonarsi ai piaceri che derivano dalla continua assunzione di droghe, che tuttavia gli impediscono di vivere un'esistenza minimamente umana. Mary Lou è una donna che Paul incontrerà per le strade di New York; una donna dalla spiccata intelligenza alla quale insegnerà a leggere e con la quale scoprirà la bellezza di tutti i sentimenti che la società ha bandito, compreso il più grande di tutti: l'amore.
La riscoperta della loro umanità gli permetterà di incamminarsi lungo la strada della scoperta di sé stessi, ma anche della vera natura di quel mondo falso e degradato, che si avvia verso la sua rovinosa fine.
"E allora ho cominciato a sentire tutta l'enormità di quello che era cominciato nell'antichità tenebrosa degli alberi e delle caverne e delle pianure dell'Africa, l'umanità, scimmiesca ed eretta, che si diffondeva dovunque e costruiva i suoi primi idoli e poi le città. E la riduzione a una razza drogata, a un relitto, per colpa di una macchina rotta. Una minuscola parte di una macchina. E un robot sovrumano che non voleva tentare di ripararla."
Indicazioni utili
1984 di George Orwell
Noi di Evgenij Zamjatin
Il mondo nuovo di Aldous Huxley
Tragico e terrificante
Se non ricordo male, lo stesso Stephen King definisce il suo "Pet Sematary" come uno dei libri più spaventosi da lui scritti. Ora, non so dire se sia realmente tra i più spaventosi, ma tra quelli che ho letto è sicuramente uno di quelli più tragici (insieme a "Il miglio verde"). Una lettura non facile, dunque, che presenta senza mezze misure eventi davvero devastanti, che potrebbero facilmente distruggere la psiche di un essere umano e gettarlo in un oblio senza via di uscita. Questo implica il trattamento di temi piuttosto spinosi e difficili da digerire, su tutti la morte; che da quando siamo sulla Terra è di certo la cosa che accettiamo meno facilmente: sia per quanto riguarda la nostra, sia quando si parla della morte di qualcuno che ci è caro, sia esso un animale o una persona. La domanda che sorge durante la lettura è: se dovessimo perdere una persona cara e ci venisse concessa la possibilità di riportarla indietro, ma quella persona non fosse più del tutto sé stessa e anzi mostrasse istinti aggressivi e malvagi, lo faremmo?
Lo stile del Re è quello dei tempi d'oro, capace di tenere in tensione e trasmettere perfettamente gli stati d'animo dei personaggi (in particolare del protagonista), che si ritrovano in mezzo a vicissitudini da brivido; travolti da tragedie inaspettate che cambieranno radicalmente la loro vita.
Tutto ha inizio quando la famiglia Creed (quattro persone più il gattino Winston Churchill) si trasferisce in una casetta nel Maine, alle cui spalle si estende una foresta dove risiede il "Cimitero degli animali", nel quale tutti i bambini del paese portavano a seppellire i loro animaletti tanto amati.
Macabro, ma finora tutto normale, fino a quando il nuovo vicino di casa non presenta al nostro protagonista (Louis) un luogo piuttosto speciale: una specie di cimitero indiano che si nasconde non lontano dal Pet Sematary, che pare essere in grado di riportare indietro chi ci ha lasciato.
Ma con uno spaventoso prezzo da pagare.
"Probabilmente sbaglia chi crede che vi sia un limite all'orrore che la mente umana può sperimentare. Al contrario, per quanto possa dispiacere ammetterlo, l'esperienza umana tende, per molti aspetti, a confermare che, quando l'incubo diventa sufficientemente cupo, orrore dà origine a orrore, un male fortuito genera altri e spesso più deliberati mali, finché la tenebra sembra ricoprire tutto. E l'interrogativo più agghiacciante potrebbe essere, forse, quanto orrore la mente umana può sopportare pur conservando un equilibrio vigile, attento, implacabile."
Indicazioni utili
Un'inquietante lettura estiva
Sebbene in copertina vengano menzionati Stephen King e Bev Vincent, loro sono soltanto i curatori di quella che è una raccolta di diciassette racconti a tema "viaggi ad alta quota", alla quale hanno contribuito entrambi con un racconto a testa, in mezzo ad altre storie raccontate da autori di tutti i tipi e tempi. Dunque troverete autori leggendari come Arthur Conan Doyle e Ray Bradbury, contemporanei più famosi come lo stesso King oppure Dan Simmons, insieme a penne meno conosciute.
E' ovviamente superfluo soffermarsi sullo stile, data la varietà di autori che differiscono molto tra loro sia per linguaggio, sia addirittura per genere: perché nonostante si soffermino su un tema in comune, alcuni si soffermano più sull'orrore, altri sulla fantascienza, altri sul realismo. Questo però è un punto a favore per quanto riguarda la varietà delle storie: si passerà infatti da storie ambientati in vecchi aerei monoposto, ai grandi uccelli d'acciaio per trasportare decine e decine di passeggeri. Anche la piacevolezza dei racconti è molto variabile: alcuni mi sono piaciuti parecchio... altri avrebbero potuto, secondo me, essere saltati a piè pari. Ci sono alcuni racconti davvero degni di nota che, come è prevedibile, sono quelli scritti dalle penne autorevoli che ho citato prima. Pur non raggiungendo picchi di eccellenza superlativa, questa raccolta può essere un'ottima scelta per delle letture mordi e fuggi tipiche della stagione estiva.
Dunque, se siete persone che hanno già paura di volare, forse questo libro non è proprio quello che fa per voi, considerato che si tratta sempre di storie che non presentano premesse incoraggianti per quanto riguarda il volo; in realtà si può dire che ci vengano presentate tutte le possibili cause che possono portarlo a finire male, nei limiti del normale e anche oltre. Dunque aspettatevi storie cariche d'ansia e tensione; preparatevi a fronteggiare viaggi nel tempo, mostri d'ogni tipo e guasti meccanici di vario genere.
Un'opzione valida per chi cerca qualcosa di leggero da portarsi dietro in spiaggia.
"Se i pionieri dell'aviazione potessero vedere la bellezza e la perfezione dei meccanismi di cui disponiamo oggi grazie al sacrificio delle loro vite!"
Quasi un trattato sul capitalismo
"Il tallone di ferro" mi è sembrata una storia piuttosto anomala, considerate anche le mie precedenti letture su questo autore. Pur presentandosi come una specie di distopico in cui l'entità tirannica è rappresentata proprio dal Tallone di ferro, il romanzo si presenta più come una lunga riflessione su capitalismo e socialismo, portata avanti principalmente dai dialoghi che Ernest Everhard (protagonista di questa storia) porta avanti con vari esponenti della società prettamente capitalistica in cui si ritrova a vivere. Leader del proletariato dalla cultura sconfinata e dalla spiccata intelligenza, si insinuerà nel contesto dei potenti facendosi portavoce del popolo e della sua voglia di rivalsa.
Soprattutto nella prima parte, dunque, questo romanzo si presenta come una lunga analisi politica e sociale del contesto in cui sono immersi i protagonisti; un racconto in cui sono dipinte le loro diverse reazioni, che riveleranno il loro vero carattere.
L'ingresso in scena del Tallone di Ferro (che a quanto sembra è rappresentato dalle grande associazioni, da tutta quella serie di trust che si alleeranno tra loro per la conquista completa del potere e fagocitando tutto il resto) avviene in maniera graduale, instillando nel lettore un'inquietudine che cresce sempre di più col procedere della lettura, fino ad avvolgerlo completamente e infine catapultandolo nella nuova realtà di cui sarà padrone.
Parlando della trama, dunque, occorre precisare che non ci troviamo davanti a un distopico in cui l'entità tirannica è già entrata in gioco e al potere, bensì a un racconto che ci spiega come quest'entità ha cominciato a formarsi e a impadronirsene; come una sorta di "prequel" che ci spiegasse come il Grande Fratello o una società come quella di Fahrenheit 451 abbia potuto formarsi.
Per tre quarti, la storia non presenta quasi alcun tipo di azione: gli eventi si susseguono, ma misteriosamente e sullo sfondo, perché in primo piano ci vengono presentati i punti di vista delle varie fazioni che si preparano alla guerra civile e al sovvertimento di una società che comincia a mostrare segni concreti di cedimento. L'ultima parte è quella in cui comincia l'azione, unico momento in cui vengono messe da parte le elucubrazioni politiche e i monologhi per lasciare spazio alla reazione del "popolo dell'abisso", che di quelle parole non se ne fa nulla, ma che a causa di esse si trova nella più completa miseria; una miseria che, alla lunga, non può portare ad altra conclusione se non alla violenza atta a sfuggire a una vita che non gli ha lasciato più nulla.
"È meno terribile veder morire uomini forti, che sentire un vile implorare per aver salva la vita."
Il miglior Conrad
Dopo la lettura di "Tifone", un capolavoro per quanto riguarda la descrizione della potenza della natura e dei suoi fenomeni, mi sono ritrovato davanti a questa storia che brilla per motivi diversi.
Storia in buona parte autobiografica (o quantomeno ispirata a eventi e personaggi che hanno fatto realmente parte della vita dell'autore), "La linea d'ombra" è esattamente quello che promette il suo titolo, ovvero il momento in cui il nostro protagonista oltrepassa la sua personale linea d'ombra, ovvero quel confine che separa la giovinezza dall'età adulta. Con il suo solito stile inconfondibile, Conrad riesce a trasmetterci il malessere dei personaggi e del protagonista in particolare, riuscendo a mettere in risalto questo momento molto instabile della sua vita. Si percepisce infatti distintamente il graduale cambiamento che avviene nel suo animo, inizialmente volubile e tormentato, in seguito più deciso e controllato. Assisteremo dunque all'evento traumatico che determina il momento della maturazione di un uomo, che rappresenta un perfetto simbolo del passaggio che si trova ad affrontare ognuno di noi, chi prima e chi dopo.
Seppure questa storia possa lasciar presentire un'aria soprannaturale, come specifica anche lo stesso autore nella sua prefazione, non contiene in sé nulla che vada oltre i semplici misteri della vita, che possiede già fin troppi lati inspiegabili. Dunque non ci si aspetti una storia che indugi su strane presenze e affini, pur essendo pregna di mistero e di suggestione. Si rivedono anche, in alcuni tratti, le immense capacità dell'autore di descrivere gli ambienti e determinate situazioni, anche disperate.
Il protagonista è un marinaio che si è distinto per la sua competenza e capacità, che improvvisamente decide di lasciare il suo posto tranquillo su una nave, senza un apparente motivo. Si ritrova dunque ad affrontare un periodo delicato dove un uomo non è più sicuro di quello che ha, di quello che vuole, e si ritrova a fare delle scelte che possono essere condivisibili o meno, ma che alla fine si rivelano necessarie per la maturazione. Dunque decide di lasciare il suo posto tranquillo per tornare a casa; tuttavia, si ritrova travolto da una serie di eventi casuali che lo travolgeranno e lo porteranno a ritrovarsi capitano di un veliero. Una svolta irrinunciabile che lo porterà ad affrontare un'avventura che richiederà fermezza e sangue freddo, su di una nave orfana del suo capitano, morto a causa della sua pazzia, con la quale ha contagiato anche il suo secondo e il cui ricordo avvolge la nave in un'aura di fatalità.
Il primo viaggio da capitano del protagonista (che in fondo è proprio il nostro Conrad) è assolutamente un'esperienza da non perdere.
"[...] e il tempo pure procede - finché si scorge di fronte a sé una linea d'ombra, che ci avverte che bisogna lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù."
Indicazioni utili
Una conclusione senza il botto
"Il confine" rappresenta il finale della trilogia per la quale Don Winslow è più famoso: quella incentrata sui cartelli della droga e che ha come protagonisti l'agente Art Keller e il Patròn Adàn Barrera.
Quest'ultimo capitolo presenta lo stesso problema che presentavano anche i capitoli precedenti: è troppo, troppo lungo. Mentre in passato questo problema era meno marcato e pesante, in questo caso l'ho avvertito tutto. Troppi dettagli, eventi, ripetizioni, ma soprattutto, troppe storyline parallele.
Vorrei soffermarmi proprio su quest'ultimo aspetto.
Nessuna delle storyline create dall'autore in questo libro possono essere considerate per nulla interessanti, ma devo dire che sono probabilmente superflue nello svolgimento degli eventi che si vengono a raccontare nel romanzo. Avrebbero potuto costituire materiale per dei romanzi a sé stanti (ovviamente arricchiti da altro), ma lasciano in certi casi una spiacevole sensazione, che riesco a spiegare solo in questo modo: rendono ancor più pesante una lettura che è già stracarica di avvenimenti e personaggi. Credo che se non fosse stato per lo stile piacevole di Winslow, la cosa avrebbe potuto provocarmi istinti suicidi. Certo, capisco che un autore voglia creare un mondo tutto suo e che nel capitolo conclusivo voglia concludere degnamente, ma lo si può fare anche senza scrivere pagine su pagine.
Oltretutto, nonostante la storia sia piacevole, a tratti adrenalinica e interessante, non è la conclusione "epica" che mi aspettavo dalla trilogia che ha principio con "Il potere del cane". Una storia piacevole, ma non uno di quei finali indimenticabili che restano impressi nell'immaginario del lettore.
La storia comincia con la morte di Adàn Barrera, protagonista indiscusso del precedente capitolo "Il cartello". Il libro rimane dunque immediatamente orfano di uno dei suoi personaggi più carismatici, durante una spedizione atta a eliminare i leader dei Los Zetas, violentissimo rivale del cartello di Sinaloa, il Patròn resta ucciso e il suo corpo non viene ritrovato. Quest'ultimo particolare genera il dubbio che ci seguirà per la prima parte del libro: Barrera è davvero morto?
Nel clima di dubbio riguardo a quest'ultimo aspetto, si cominciano a creare i primi movimenti di tumulto all'interno dei cartelli messicani, privi di un leader e agitati dalle eventuali questioni di successione. Nel frattempo, Art Keller viene nominato direttore della DEA, incarico che accetta dopo un'iniziale titubanza, convinto dalla possibilità di fare davvero qualcosa per estirpare il cancro della droga negli Stati Uniti.
Tuttavia, Keller si ritroverà faccia a faccia con delle verità scomode, che coinvolgono non solo criminali conclamati e riconosciuti, ma anche persone che normalmente sono considerate al di sopra di ogni sospetto. Dunque, si troverà a combattere con nemici diversi che, in fondo, sono la stessa cosa.
"Alcuni vogliono zittirlo e mandarlo in galera; sa che ci sono anche altri, pochi, che vogliono ucciderlo. Quasi si aspetta di udire il rumore di uno sparo mentre sale i gradini per andare a testimoniare, perciò la risata di quel bambino è un sollievo, un promemoria del fatto che fuori dal mondo della droga, delle menzogne, del denaro sporco e dell'omicidio, c'è un'altra vita, un'altra terra, dove i bambini ancora ridono."
Indicazioni utili
Felice e triste come la vita
Tra le opere del prolifico Simenon, “La camera azzurra” è certamente tra le più famose. Lo stile dell’autore belga è perfetto per il genere a cui appartiene, e quest’opera ne è forse tra gli esempi più lampanti. Mirabilmente costruito, riesce a tessere il corso degli eventi con maestria e a spingere il lettore verso la soluzione, pur lasciandolo con qualche dubbio fino alla fine. Tra i personaggi, forse è solo il protagonista quello veramente approfondito, ma in fondo è lui a essere il fulcro della vicenda e dell’idea che Simenon ha voluto trasmettere: straniero in un paese della campagna francese, dove ognuno sa tutto di tutti.
La cosa che impressiona di più, in questa storia, è come la vita di un uomo possa cambiare tragicamente, da un momento all’altro. Ma non è sempre un evento tragico e improvviso a causare questo cambiamento; spesso anche le parole o dei gesti che ci sembrano insignificanti possono innescare una reazione a catena, che porta inevitabilmente verso l’oblio e la distruzione di tutto quello che, ogni giorno, avevamo dato per scontato.
Tony Falcone è uno straniero, mai esattamente ben visto dal resto della popolazione, tuttavia tollerato. È riuscito ad avviare un’attività che gli permette di vivere una vita dignitosa, insieme a sua moglie Gisèle e sua figlia Marianne. Una vita tutto sommato normale, che esce fuori dai propri binari una volta al mese, nella camera azzurra: una stanza dell’albergo di suo fratello nella quale incontra la sua passionalissima amante, Andrée, sua vecchia compagna di scuola e anche lei sposata. Per Tony, in fondo, quelli non sono altro che piacevoli incontri nei quali sfogare i propri istinti, per poi ritornare nel porto sicuro di casa sua, nella quale lo aspetta la sua amata famiglia. Ma per Andrée le cose non stanno esattamente così.
La storia raccontata ne “La camera azzurra” ha inizio proprio durante uno di questi incontri, il 2 Agosto, uno di quei giorni che può sembrare dimenticabile nel momento in cui lo vivi, ma che nasconde il subdolo innesco per la distruzione di tante esistenze.
“Tony non avrebbe saputo dire se lo facesse con la sensazione di compiere un dovere, per farsi perdonare una debolezza, per riscattare una colpa. Sapeva solo che quella passeggiata sotto il sole, accompagnata dalla vocetta di sua figlia, era dolce e malinconica al tempo stesso. Si sentiva felice e triste. Ma non a causa di Andrée né di Nicolas. Non ricordava di averci pensato. Felice e triste come la vita, così avrebbe voluto dire.”
Indicazioni utili
Memorie d'un falso Giuda
La seconda guerra mondiale è in assoluto la più grande fucina di opere, letterarie e non. Questo perché sono talmente tante le sfaccettature di questo conflitto, che il materiale da trattare non si esaurirà probabilmente mai.
"Madre notte", così come altre opere di Kurt Vonnegut, è anch'essa figlia degli sconvolgimenti che il secondo conflitto e i suoi maggiori interpreti hanno portato nel nostro già abbastanza tormentato mondo.
Lo stile di Kurt Vonnegut è, come al solito, velato di una sottile ironia alla quale è impossibile resistere; un'ironia che in questo caso viene veicolata dal punto di vista di Howard W. Campbell jr: personaggio piuttosto particolare, che anche il lettore fa fatica a collocare in un quadro preciso: uno scrittore che sembra serbare in sé un'incredibile profondità di pensiero, ma che allo stesso modo sembra incapace di guidare i propri passi in autonomia. In tutto il corso della sua vita, infatti, è influenzato da qualcosa che lo colpisce dall'esterno e vuole guidarlo in una certa direzione, nella quale lui si incammina pur non essendone persuaso. Così si ritroverà a diventare una delle più grandi spie americane in terra tedesca, che tuttavia non verrà mai riconosciuta come tale e verrà costretta, dopo la sconfitta dei tedeschi, a essere ricoperta d'infamia e biasimo dalla stessa comunità e dal paese per il quale si è sacrificato. Sì, perché questo era il suo ruolo: impersonare il commentatore radiofonico americano più antisemita e filo-nazista che si sia mai visto sulla faccia della terra, in modo da essere ben visto dai tedeschi e poter trasmettere messaggi segreti agli alleati, durante le sue trasmissioni, senza destare alcun sospetto. Campbell assolverà talmente bene al suo compito, che anche alla fine della guerra continuerà a essere considerato, dai pochi nazisti sopravvissuti, come uno dei più grandi sostenitori di Hitler e compagnia; una figura da venerare. Nel frattempo ebrei e americani, che ignorano assolutamente la sua vera natura, non vorranno altro che vederlo morto.
Quello che più lascia interdetto il lettore è l'indifferenza con cui Campbell subirà tutti gli eventi paradossali che gli travolgeranno la vita; una vita che indifferente non si può assolutamente considerare. Eppure, Campbell sembra essere travolto dalle circostanze suo malgrado, senza battere ciglio, svuotato di quasi tutta la sua linfa vitale dalla morte della moglie. Da questo contesto viene fuori, velatamente, l'assurdità della guerra e di come abbia travolto un'umanità che, in fondo, non era assolutamente preparata a fronteggiare una cosa così violenta e insensata.
"Io, come speaker radiofonico, avevo sperato di essere soltanto ridicolo, ma viviamo in un mondo in cui essere ridicoli non è facile; ci sono troppi esseri umani che non vogliono ridere, che non riescono a pensare; vogliono soltanto credere, arrabbiarsi, odiare. Troppa gente aveva voluto credere in me."
Indicazioni utili
Racconti di cruda realtà
Ultimamente, Einaudi si sta dedicando abbastanza alla pubblicazione di racconti e raccolte di racconti di scrittori apprezzati, con più o meno successo. L’ultimo caso è quello di John Maxwell Coetzee, premio Nobel per la letteratura nel 2003, con questa raccolta: “Bugie”. Devo dire che in questo caso, i sette racconti contenuti in questo libro di nemmeno 100 pagine sono perlopiù interessanti, alcuni addirittura belli: penso a “La vecchia e i gatti” e lo stesso “Bugie”,
che hanno protagonisti e temi in comune così come altri due, suggerendo come forse contenessero il germe per un vero e proprio romanzo. I primi tre racconti, invece, sono completamente scollegati dal resto, dando l’impressione (pur restando piacevoli) di essere un semplice riempitivo.
Lo stile dell’autore mi è sembrato particolarmente efficace nella composizione di racconti brevi, forse anche migliore di quello che ho riscontrato nell’unico romanzo di sua penna che ho letto. Forse il “mezzo racconto”, nel suo imporre la necessità di condensare, ha permesso all’autore di essere più conciso e a strutturare i pensieri in maniera più efficace, regalandoci vari spunti di riflessione e pensieri di grande profondità.
I temi che risaltano di più sono quelli evidentemente più cari a Coetzee, considerato che sono messi in risalto anche in “Vergogna”, una delle sue opere più famose; sto parlando dell’inesorabile avvicinarsi della vecchiaia, della morte, e la considerazione della vita animale.
Coetzee ha una particolarità che solitamente apprezzo in ogni autore: non ha paura di affrontare argomenti spinosi; argomenti che potrebbero anche disturbare un lettore che ha paura di guardare in faccia la realtà. Non nascondo che, in certi tratti, affrontare temi che non sono particolarmente piacevoli (come la brevità e limitatezza della nostra vita) non è assolutamente piacevole, ma quale vantaggio c’è nella negazione dell’ovvio? Certe cose fanno parte della vita e occorre contemplarle e rifletterci, ogni tanto. Non sempre; non occorre essere masochisti, ma ogni tanto affrontare autori come Coetzee (o McCarthy) è educativo e può ampliare i nostri orizzonti.
Se non si fosse capito, vi consiglio di leggere questa raccolta di racconti, riservando un’attenzione speciale agli ultimi quattro.
"Ai confini dell'essere - è così che me lo figuro - ci sono tutte queste piccole anime, anime di gatti, anime di topi, anime di uccelli, anime di bambini non nati che si affollano e chiedono di poter entrare, supplicano di potersi incarnare, e io voglio farle entrare. Tutte. Anche se è solo per un giorno o due, anche solo per un rapido sguardo a questo nostro mondo meraviglioso. Perché chi sono io per negare loro la possibilità di incarnarsi?"
Indicazioni utili
La grande farsa
Quando mi soffermo a leggere le trame dei libri di Philip K. Dick, non posso fare a meno di pensare alla sua testa come a un’immensa fucina di idee originali. Certo, alcuni temi, ambientazioni e contesti si somigliano tra loro, ma in ognuno dei suoi scritti ci sono idee uniche che nessun altro autore del suo tempo riusciva neanche lontanamente a partorire. Non è un caso che, negli ultimi anni, dalle idee di questo autore nascano sempre più romanzi, ma anche serie televisive e pellicole cinematografiche.
“La penultima verità” non è certo uno dei suoi romanzi meglio riusciti, ma anche in questo caso abbiamo delle idee interessanti che hanno certamente ispirato molti autori di ogni tipo, negli ultimi decenni.
La maggior parte dell’umanità, a seguito di una guerra nucleare che ha devastato quasi tutta la superficie terrestre, è costretta a vivere in dei rifugi sotterranei chiamati “formicai”. Ogni formicaio ha il dovere di assemblare degli automi, detti plumbei, che sono necessari per il proseguimento della guerra in superficie, tra le due fazioni solite: Stati Uniti e Russia, rispettivamente chiamate Dem-Occ e Bloc-Pop. Ad aggiornare gli abitanti dei formicai è il loro protettore, Talbot Yancy, che periodicamente si collega tramite video con tutti i formicai per tenerli aggiornati sui progressi della guerra e per incitarli a dare il massimo nella costruzione di quelli che dovrebbero essere i soldati che la combattono, ovvero i sopracitati plumbei. Ogni formicaio ha infatti una quota di automi da consegnare in un tot di tempo, pena la limitazione delle risorse spedite per la sopravvivenza del formicaio.
È proprio l’eventualità di non essere in grado di rispettare questa quota a spingere Nicholas St. James a tornare in superficie, allo scopo di recuperare un pancreas artificiale da sostituire a quello del capo meccanico ormai in fin di vita. Senza di lui, il formicaio è finito. Peccato che, una volta risalito, scoprirà una bruciante verità che metterà in discussione tutto quello in cui hanno creduto negli ultimi quindici anni.
“Siamo una razza dannata, si rese conto Adams. La Genesi ha ragione: c’è un marchio su di noi, il segno delle stimmate. Perché solo una specie dannata, marchiata e viziata userete le sue scoperte come stiamo facendo noi.”
Da leggere due volte nella vita
Nel momento in cui ho cominciato a leggere questo libro e qualcuno si è soffermato a leggerne il titolo, anche persone che non conosco come grandi lettori mi hanno detto di averlo letto da ragazzi, o quantomeno ne avevano sentito parlare. Sì, in fondo, chi non conosce “I ragazzi della via Pàl”? Anche io lo conoscevo e ne possiedo in casa più di una copia; eppure, devo ammettere di non averlo mai letto prima d’ora, con mia assoluta vergogna.
Tuttavia, la prima domanda che mi sono fatto quando ho voltato l’ultima pagina è stata: davvero questo è un libro che si legge principalmente da ragazzi? Non mi fraintendete, non è assolutamente una lettura difficile e mi è piaciuto tantissimo... ma soprattutto nel finale fa lo stesso effetto di un treno che ti arrivi dritto in faccia.
Profondo, ma assolutamente devastante.
Comunque, pensandoci su per un po’ di tempo, mi sono dato una mezza risposta: in fondo, “I ragazzi della via Pàl” é un libro apprezzabilissimo anche quando si è dei ragazzini; un libro in cui trovare tante similitudini con il periodo della vita che ci si sta trovando a vivere; un libro il cui finale può intristire, ma che non ci devasta come fa durante una lettura fatta in età adulta. Da grandi, inoltre, si colgono bellissime sfumature e messaggi nascosti che da piccoli possono facilmente sfuggire; veniamo colpiti dalle tantissime analogie che questi ragazzini e la vita che conducono hanno anche con gli adulti e da come incarnano le qualità onorevoli che ognuno di noi dovrebbe mostrare, ma che forse un bambino non arriva a capire e forse mostra in maniera spontanea.
Dunque, “I ragazzi della via Pàl” è un libro che nel corso della vita va letto almeno due volte, in due età molto diverse.
Molnàr ha delle incredibili capacità di descrizione dell’ambiente ma anche dell’azione: impossibile infatti non rimanere colpiti dalla descrizione della battaglia del Campo di Via Pàl, resa assolutamente vivida è caricata di un’epicità che ci aspetteremmo solo da una vera battaglia. Cosa più importante, ha caratterizzato i suoi protagonisti in maniera perfetta, permettendoci di affezionarci a molti di loro e in particolare ad alcuni; mentre uno di loro non può far altro che restarci nel cuore in eterno.
Credo che dilungarsi sulla trama di un simile capolavoro sia solo un riempitivo di cui non c’è alcun bisogno. Leggetelo, indipendentemente da tutto; lo merita.
“[...] Giovanni Boka guardava fisso davanti a sé: e, per la prima volta, la sua anima di fanciullo intuì quel che è veramente la vita, per la quale noi, suoi schiavi ora tristi ora lieti, lottiamo.”
Indicazioni utili
L'uomo ha anche qualità nobili
Per introdurre questa mia recensione devo confessare una mia truce colpa. Di tutte le letture che ho fatto nel corso della mia vita, “Il piccolo principe” è stata sicuramente una di quelle che ho amato di più, che mi sono rimaste nel cuore e della quale parlo sempre a chiunque voglia accostarsi alla lettura. In questo caso la domanda sorge spontanea: “perché allora non hai letto altro dell’autore che l’ha partorito?”
Ecco la mia assurda colpa.
Davvero non so darvi una risposta, ma devo confessare che “Il piccolo principe” mi dava l’idea di un’opera inimitabile anche dal suo stesso autore; che fosse stato l’unico acuto della sua breve vita (spentasi troppo presto) e della sua carriera letteraria. Non so davvero cosa avesse potuto generare in me questo pensiero, oltre alla sconfinata bellezza della sua opera più famosa; sta di fatto che mi sbagliavo di grosso.
“Volo di notte” è un romanzo brevissimo, di appena ottanta pagine, che tuttavia serba in sé tanti di quei temi, tante di quelle riflessioni e messaggi da far impallidire tomoni che per trasmettere un pensiero hanno bisogno del sacrificio di tantissimi alberi innocenti. Antoine de Sainte-Exupéry era evidentemente un amico delle foreste, perché riesce a creare immagini di una straordinaria bellezza e profondità con pochissime parole, senza ricorrere a periodi arzigogolati né difficili da comprendere; riesce a tratteggiare la psiche dei personaggi in un battibaleno, semplicemente descrivendo gesti semplici e dando voce ai loro brevi pensieri. La cosa incredibile è che, in questo modo, riesce a rivelare tantissimo del loro carattere. Oltretutto, aspetto da non sottovalutare, riesce a mettere in risalto gli aspetti più nobili dell’animo umano e riesce a donargli una speranza; riesce a fornire una testimonianza in contrapposizione alla miriade di autori che nel corso della storia si sono divertiti a soffermarsi solo sugli aspetti turpi, che si celano nelle nostre viscere.
“Volo di notte” è ambientato in quel periodo storico in cui gli aerei postali stavano imponendo la loro supremazia su tutti gli altri mezzi di comunicazione postale. Diversi piloti si mettevano in viaggio per rendere questo servizio sempre più efficiente, e per farlo è nato anche il bisogno di effettuare dei voli durante la notte, così da guadagnare un vantaggio sulle ferrovie e sulle navi. All’inizio, tuttavia, questi viaggi erano alla stregua di esperimenti e celavano sempre nuovi pericoli che venivano scovati giorno dopo giorno, anche a costo della vita di diversi piloti: i pionieri dell’aria.
La storia raccontataci dall’autore si sofferma su tre di questi corrieri che devono fare rientro a Buenos Aires e il cui carico deve essere poi smistato su un corriere che partirà per l’Europa. Mentre due degli aerei rientrano senza alcun tipo di problema, quello proveniente dalla Patagonia deve affrontare una tempesta improvvisa, che metterà a repentaglio la sopravvivenza dell’equipaggio. Ma il vero protagonista è il responsabile della rete aerea, Rivière: uomo inflessibile che non ammette alcun tipo di errore da parte dei suoi uomini. A primo impatto potrà sembrare un uomo cattivo, inflessibile, che pensa soltanto al proprio lavoro e alla propria posizione, e che invece si rivelerà una figura molto più complessa e per la quale si finirà per provare pietà ed empatia. Pur essendo il personaggio centrale, Rivière non sarà tuttavia il protagonista delle scene più belle, che sono quelle descritte durante il volo dell’aereo che affronta la tempesta: l’aereo di Fabien. Faremo anche noi parte di questo viaggio sublime e terribile allo stesso tempo, cullati dalle immagini straordinarie tratteggiate dall’autore, che riesce a elevare la figura dell’essere umano a un livello quasi sublime.
Adesso ho la certezza che il successo de “Il piccolo principe” non è stato un caso isolato, una di quelle idee uniche che ti vengono soltanto una volta nella vita. Antoine de Saint-Exupéry è probabilmente un autore il cui nome brillerebbe ancor più luminoso, se solo avesse vissuto di più. Una cosa è certa: non ripeterò lo stesso errore e leggerò tutto quello che, nel breve tempo in cui è stato con noi, ci ha regalato.
Da leggere assolutamente.
“Quei contadini a tavola non sanno quale sia la loro speranza: non sanno quanto lontano arrivi il loro desiderio, nella grande notte che li racchiude. Ma Fabien lo scopre, quando giunge da mille chilometri di distanza e sente ondate profonde sollevare a abbandonare l’aereo che respira; quando ha attraversato dieci temporali, come paesi in guerra, e tra l’uno e l’altro radure di luna; e quando raggiunge a una a una quelle luci, con la sensazione di avere vinto. Quegli uomini credono che la loro lampada brilli per l’umile tavolo intorno a cui siedono, ma, ottanta chilometri lontano, qualcuno è già toccato dal richiamo di quella luce, come se loro la agitassero disperati da un’isola deserta, davanti al mare.”
Indicazioni utili
Manuale per avere e mantenere il potere
Penso proprio che George R. R. Martin abbia letto “Il principe” di Machiavelli, prima di dare alla vita alla sua serie di libri sul “Trono di spade” e di conseguenza anche alla sua trasposizione televisiva. Essendomi cimentato nella visione di tutta la serie dal suo principio proprio in questo periodo, non ho potuto non accorgermi di come gli accorgimenti suggeriti da Machiavelli in quest’opera trovino delle analogie nei regnanti che popolano la storia di Martin e che sono il riflesso dei regnanti dell’epoca machiavelliana. E non solo, probabilmente.
“Il principe” di Machiavelli è una sorta di trattato su come debba comportarsi un sovrano di qualsiasi titolo per poter conquistare e, successivamente, mantenere il dominio sul suo regno. Citando una moltitudine di esempi, suoi contemporanei e non, Machiavelli cerca di considerare varie situazioni in cui un principe (o un aspirante tale) si ritrovi a fronteggiare il “fardello del potere” e gli suggerisce una via di scampo per varie situazioni. Chi si aspetti un libro di consigli buonisti, che esorti il sovrano a mostrare solamente buone qualità, probabilmente non conosce Machiavelli e nemmeno l’essere umano; ed è proprio questo che rende interessante quest’opera: il suo non voler addolcire la pillola e far credere che tutto si raggiunga con la virtù e la bontà.
Un principe ha da essere astuto, machiavellico. Un principe deve possedere molte virtù, nella speranza che Fortuna si volga in suo favore; e se non dovesse farlo deve essere in grado di far fronte alle avversità del destino. Un principe deve essere previdente, temuto, mostrare misericordia quando è possibile e crudeltà quando necessario; essere amico del popolo e cercare il favore delle sue milizie: che possibilmente siano sue e non d’altri o ancor peggio dei mercenari. Un sovrano deve essere in grado di prevedere le disgrazie e porvi rimedio in anticipo; deve circondarsi di consiglieri eccellenti ed essere avido dei loro consigli, ma essere sempre lui a chiederne e mai accettarli quando questi arrivino senza che li abbia chiesti.
Credo che, per un sovrano, avere accanto un consigliere come Machiavelli potesse essere una fortuna inestimabile; chissà se Lorenzo di Piero de Medici ha fatto tesoro dei consigli che, in quest’opera a lui dedicata, Machiavelli gli ha dispensato generosamente.
“E esaminando le azioni e vita loro non si vede che quelli avessimo altro da la fortuna che la occasione, la quale dette loro materia a potere introdurvi drento quella forma che parse loro: e sanza quella occasione la virtù dello animo loro si sarebbe spenta, e sanza quella virtù la occasione sarebbe venuta invano.”
Indicazioni utili
Shame, Shame, Shame.
Non so, questo è un libro che non sono riuscito a capire a fondo, e non a causa di uno stile ostico; anzi, lo stile di Coetzee è assolutamente scorrevole, comprensibile, senza comunque scadere nel semplicistico. “Vergogna” è un libro che si lascia leggere, tuttavia quello che mi è riuscito più difficile è entrare in sintonia coi personaggi, che in fondo sono quello che dovrebbe animare questo romanzo. Sarà che le sensazioni provate da David e sua figlia Lucy sono qualcosa di piuttosto lontano da me, ma questo capita con buona parte dei romanzi che un lettore si trova tra le mani. Ho trovato gli atteggiamenti dei personaggi piuttosto irritanti, soprattutto per quanto riguarda Lucy: è un personaggio che non capisco, che si intestardisce nel radicarsi in un determinato luogo, quando questo luogo fa di tutto per farle capire di non essere sicuro. Certo, qualcuno vorrà dirmi che non bisogna arrendersi di fronte alle prime difficoltà che ci si trova ad affrontare, che rinunciare sarebbe una sconfitta… e io gli rispondo: mah. Se un determinato contesto si rivela inadatto o ancor peggio pericoloso, non c’è alcuna sconfitta né vergogna nell’abbandonarlo e provare a ricominciare da qualche altra parte. La freddezza e la testardaggine di Lucy sono davvero frustranti.
Per quanto riguarda il protagonista, invece, è un uomo alquanto controverso; completamente distrutto psicologicamente dall’incedere della vecchiaia. Incapace di portare avanti delle relazioni di coppia, cerca di appagare i suoi istinti in qualsiasi modo. All’inizio ci riesce con i suoi appuntamenti settimanali con una escort: sempre la stessa, con la quale riesce a mantenere un distacco ma allo stesso tempo crea un legame che, una volta spezzato, lo getta nell’oblio. È proprio in questo momento che ha inizio la storia raccontata da Coetzee, nel momento in cui David perde quel punto di riferimento che gli permetteva di andare avanti e di non lasciarsi andare al declino. Tuttavia, proverà un ultimo gesto disperato per sentirsi giovane: abborda una sua studentessa, Melanie, e proverà a instaurare con lei un rapporto che si rivelerà malsano fin dal principio, fino a sfociare in una denuncia per molestie. Questo lo porterà a perdere il lavoro di professore all’università, spingendolo a passare alcuni mesi in casa della figlia Lucy, in campagna a Città del Capo.
David è un uomo che fugge dalle relazioni, ma che in fondo ne è disperatamente alla ricerca. Tuttavia, non si riesce a comprendere cosa, tra istinto e ricerca d’un affetto, abbia la meglio: in certi tratti abbiamo l’impressione che, una volta soddisfatta la sua fame sessuale, le donne tornino a essere dei semplici oggetti degni di pochissima attenzione; in certi altri, appare come un uomo che vuole legarsi a una sola donna alla volta, con la quale instaurare qualcosa di duraturo. Eppure, non si evince mai in David il desiderio di condivisione che è naturale volere in un rapporto di coppia.
I personaggi di questo romanzo sono certamente particolari; eppure, sento che c’è qualcosa che mi sfugge, forse una chiave di lettura. Sarà questo che non mi ha permesso di apprezzare questo romanzo appieno? Non lo so, sta di fatto che in certi tratti Coetzee mi ha fatto anche rabbia, soprattutto con la testa dura dei suoi personaggi.
“È solo uno dei postumi, si dice, uno dei postumi dell’aggressione. Fra non molto l’organismo si rimetterà in sesto, e io, il fantasma che lo abita, sarò di nuovo me stesso. Ma sa che la verità è un’altra. Qualcuno ha soffiato sulla fiammella del piacere di vivere. Come una foglia nella corrente, come uno sbuffo di fumo nel vento, ha cominciato a fluttuare verso la fine. Davide se ne rende conto con chiarezza, e questa visione lo riempie di disperazione. Parola appiccicosa che non riesce a scacciare. Il sangue della vita sta abbandonando il suo corpo per essere sostituito dalla disperazione, sostanza simile a un gas, inodora, insapora, priva di proprietà nutritive. La inspiri, le membra si distendono, cessi di lottare, anche nel momento in cui senti il freddo dell’acciaio sulla gola.”
Pensieri in forme di città
Con questo libro, che desideravo leggere da molto tempo ma che solo ora sono riuscito a recuperare, ho avuto la conferma della genialità di Calvino; una genialità che, tuttavia, in certi casi è difficile da afferrare. A qualcuno potrebbe apparire come un pregio, ma per quanto mi riguarda è quello che non mi ha permesso di amare totalmente “Le città invisibili”. Per come la vedo io, il genio completo è colui che riesce anche a rendere al meglio al mondo il frutto di questo dono. È assolutamente apprezzabile il modo in cui l’autore si abbandoni ai viaggi della sua mente; sono ammirevoli i voli pindarici che esegue nella sua immaginazione e che prova a esprimere col padroneggiamento assoluto della nostra lingua. Tuttavia, è difficile entrare in un mondo e in una concezione di esso che, a volte, diventa quasi comprensibile soltanto alla mente che l’ha partorito.
“Le città invisibili” è una raccolta di pensieri che prendono la forma di città, o di città che prendono forma di pensieri. Non si tratta di un romanzo, ma di descrizioni estetiche e allegoriche di alcune città di fantasia, per la maggior parte surreali. Alcune descrizioni sono favolose: queste città prendono improvvisamente vita nella mente del lettore grazie all’immensa maestria di Calvino, che riesce a materializzare città assurde, che nulla hanno delle città che siamo abituati a osservare giorno dopo giorno; eppure ci appaiono quasi reali, assolutamente possibili, e cariche di una suggestione che nessuna città terrestre potrebbe avere. Oltre alle vivide immagini però, ci troveremo ad affrontare i pensieri che le forme di quelle città fanno nascere, con la figura dei suoi abitanti, che possono rappresentare vari lati della natura umana.
Ogni descrizione è collegata dai dialoghi tra l’imperatore Khan e Marco Polo, che è il narratore e descrittore delle città di cui ci ritroveremo a leggere, visitate nel corso dei suoi viaggi. Ma sono viaggi reali? Chissà.
“Le città invisibili” è un esperimento audace, unico, che probabilmente andrebbe letto con l’attenzione che riserveremmo a dei componimenti poetici. La loro brevità, in effetti, è uno degli aspetti che suggerirebbe questo approccio. Credo proprio che lo rileggerò, in futuro, per provare a cavare di più da queste parole che Calvino ha messo insieme, e che lo elevano comunque su un gradino più alta sulle scale della mia stima letteraria.
“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”
Indicazioni utili
Religione e scienza
Premio Hugo come miglior romanzo nel 1961, “Un cantico per Leibowitz” è una storia post-atomica piuttosto particolare, perché incentrata su temi che sono diversi da quelli normalmente considerati da opere di questo genere; su tutti, il conflitto tra scienza e religione. Il paradosso che ci è chiaro fin dal principio e che diventa palese nella conclusione della storia, è come un ordine religioso (quello di San Leibowitz) sia l’entità che si carichi dell’onere di conservare quel che resta della scienza umana, quella sviluppata prima del “Diluvio di fiamma”. Il diluvio di fiamma altro non è che la guerra atomica, che ha lasciato pochissimi resti e ha trasformato alcuni esseri umani in mostri deformi. Tutto quello che è accaduto e che appartiene al periodo precedente la guerra ha acquisito un’aura di sacralità: le storie che descrivono il conflitto hanno preso una connotazione biblica, i personaggi che l’hanno vissuta diventano i nuovi santi (compreso Leibowitz), e semplici liste della spesa e fogli di carta diventano le nuove reliquie sacre.
Subito dopo il conflitto, gli scienziati vengono considerati i principali responsabili dell’autodistruzione degli uomini: la cultura e le scienze hanno fornito ai prìncipi e ai re i mezzi per radere tutto al suolo e perciò, in un evento che viene chiamato la Semplificazione, vengono banditi per sempre dalla faccia della terra. In questo periodo, un gruppo di uomini che presto si evolverà nell’ordine di San Leibowitz, si sacrifica per salvare quanti più libri possibile anche se questi sono diventati oramai incomprensibili, nella speranza che in un futuro non troppo lontano l’Uomo torni a essere in grado di capire, per recuperare ciò che ha perso.
La storia de “Un cantico per Leibowitz” è divisa in tre parti che comprendono un periodo di parecchi secoli e che ci rendono partecipi della “seconda evoluzione” umana; una evoluzione che ripercorre in tutto e per tutto la prima e che sembra avere la medesima conclusione. L’essere umano sembra incapace di imparare dai propri errori, indipendentemente dalle conseguenze tangibili della sua cattiva condotta. L’uomo non impara mai dal suo passato e, con il dovuto tempo, sprofonderà sempre nello stesso abisso.
La domanda più spinosa che l’opera ci sbatte in faccia, e alla quale è effettivamente difficile dare una risposta è: la scienza è veramente la causa degli orrori che ci ritroviamo a vivere? Sarà la causa della nostra rovina definitiva? Oppure è l’Uomo a tenere serbare in sé una spaventosa propensione ad autodistruggersi?
“Quando si risponde al genocidio con il genocidio, alla violenza con la violenza, all’odio con l’odio, non serve più chiedere quale ascia sia più insanguinata. Il male sul male, ammucchiato sul male.”
Una struttura inefficace
La domanda che ho cominciato a farmi a più o meno metà del libro è stata: “dove vuole andare a parare l’autrice?” Niente, non ne sono venuto a capo neanche adesso. “Mars Room” è un libro particolare, che credo possa appartenere alla schiera “o ti piace molto, o non ti piace per niente”. Appartengo decisamente alla seconda fazione, anche se non me la sento di stroncarlo completamente. Perché? Perché in fondo è ben scritto e l’autrice ha uno stile particolare e forte, che difficilmente assoceresti a una donna. Non sono sessista, badate, semplicemente non avevo ancora avuto modo di affrontare autori di sesso femminile che descrivessero scene di cruda violenza e che non si fanno scrupolo nello scendere in particolari scabrosi anche nell’ambito sessuale. C’è da dire che l’autrice non poteva certo evitare di farlo, considerato che in “Mars room” ci racconta la storia di una detenuta al carcere femminile di Stanville: spogliarellista che si trasforma in assassina e che lascia nel mondo un bimbo piccolo, Jackson.
La struttura narrativa è la cosa che probabilmente mi ha lasciato più perplesso: il narratore cambia di continuo e si sposta su diverse linee temporali, che partono dal presente per fare capolino nel passato, per poi tornare nel presente e così via. Questo rende tutto piuttosto frammentato; certo, è chiaro l’intento dell’autrice di chiarire come si siano arrivati a verificare determinati eventi, ma spesso si ha la sensazione che di questi chiarimenti si possa fare tranquillamente a meno. Conoscere poi come la nostra protagonista sia arrivata a fare quello che ha fatto soltanto nel penultimo capitolo… non mi ha convinto. L’unica spiegazione che mi sono dato per quest’ultima scelta è stato una volontà di chiarire, soltanto alla fine, quanto la nostra protagonista sia meno innocente di quanto sembri; su questa volontà, tuttavia, non sono pronto a mettere la mano sul fuoco. Oltretutto, ci sono alcune scene scritte con un carattere (font) differente, raccontate da in personaggio sconosciuto e della cui utilità non sono riuscito a venire a capo. Un’idea ce l’ho, certo, ma l’autrice non è molto chiara e se la finalità è quella che penso, non c’era bisogno di aggiungere queste scene; bastava aggiungere un breve paragrafo e avrebbe raggiunto il medesimo obiettivo. Dunque, scelte narrative che mi hanno lasciato con un grosso punto interrogativo, pagine probabilmente superflue e dalla dubbia utilità mi hanno accompagnato in un percorso che non è riuscito a colpirmi. Ci sarebbero stati i presupposti per raccontare una realtà difficile, che ti offre la possibilità di scatenare innumerevoli riflessioni… ma purtroppo Rachel Kushner, almeno con me, ha fallito.
Romy Hall è una spogliarellista del Mars Room, un locale di San Francisco. Come spesso capita a persone che fanno questo mestiere, si ritroverà faccia a faccia con diversi tipi di persone, che per la maggior parte non sono esattamente raccomandabili. Ha un figlio che vede pochissime ore al giorno, un figlio avuto in un rapporto occasionale con un dipendente di un altro locale simile al Mars Room.
Quasi ogni spogliarellista ha il suo “cliente fisso”, e quello di Romy alias Vanessa è Kurt Kennedy, reduce del Vietnam che si affezionerà a Romy in un modo praticamente ossessivo, al punto da costringerla a scappare; al punto da spingerla a ucciderlo nel momento in cui lui scoprirà dove si è nascosta. Tranquilli, non è uno spoiler, perché questo lo saprete fin dal principio. Alla fine dubiterete un po’ di tutto ma, ripeto, non so se questa fosse una precisa intenzione dell’autrice. Dunque Romy verrà rinchiusa nel carcere femminile di Stanville, nel quale verremo a conoscenza delle dinamiche che regolano quella che in fondo è una comunità di donne che, colpevoli o meno, conservano intatta la loro fragilità e soffrono, come ogni essere umano.
“Almeno in prigione lo sai come vanno le cose. Cioè, non lo sai per davvero. È imprevedibile. Ma in un modo noioso. Non è che può succedere qualcosa di tragico e tremendo. Cioè, può succedere, come no. Può succedere eccome. Solo che in prigione non puoi perdere tutto, perché l’hai già perso.”
Differenze e comunanza dell'umanità
Dopo la mia prima esperienza con "Lo straniero" (una vita fa, a dire il vero) Camus mi aveva colpito, ma non abbastanza da spingermi ad approfondire la sua opera nel breve periodo, così come mi è successo ultimamente con Steinbeck. Eppure, dopo anni, ecco che mi cimento con la lettura de "La peste", che devo dire mi ha folgorato e ha fatto rinascere in me il desiderio non solo di approfondire quel che mi manca dell'opera dell'autore, ma anche di rileggere nuovamente "Lo straniero".
Questa è un'opera di una profondità fuori dal comune, che riesce col pretesto del morbo a riflettere su molte sfaccettature dell'animo umano, che un flagello come questo può far salire in superficie in un modo che sarebbe impossibile, in condizioni normali. Camus prende il lettore e lo scuote, lo prende per le orecchie e gli gira il volto, costringendolo a osservare tutto quello da cui tende a distogliere lo sguardo.
Gli uomini si ritrovano a combattere qualcosa che è infinitamente più grande di loro, qualcosa che ne controlla quasi totalmente il destino; un destino oltremodo tormentoso in quanto è affidato totalmente al caso e alla volontà della malattia, che stronca chi vuole, quando vuole. È interessante osservare le diverse reazioni allo stesso male, allo stesso terrore; Camus ha trovato un modo incredibilmente realistico di mettere in risalto le differenze ma, allo stesso tempo, di mostrare quel che accomuna tutti gli esseri umani. Questo è secondo me un lavoro che solo un grande autore e una grande mente potevano mettere in piedi.
Messi a confronto e in lotta con tale flagello gli esseri umani diventano un turbinio di emozioni, divisi tra speranza e rassegnazione; tra riscoperta delle piccole gioie e profonda disperazione; tra la gabbia di terrore del presente e liberazione dalle preoccupazioni del futuro e i tormenti del passato. La peste, la prospettiva della morte, porta gli uomini a contemplare cose che nel torpore dei tempi quieti non avrebbe mai considerato, cose che un essere umano dovrebbe contemplare in ogni caso, a prescindere dal dolore che esse comportano, ma che si ritrova a considerare solo nel momento della fine, che nella maggior parte dei casi arriva troppo tardi nel percorso della vita. La malattia, invece, li porterà ad affrontare tutto questo prima del tempo, costringendoli a un cambiamento graduale ma permanente e che, paradossalmente, ha molti risvolti positivi: perdita delle illusioni, consapevolezza, conoscenza, tempra.
Tutto questo è reso in maniera eccelsa, pur essendo una lettura che richiede una buona soglia di attenzione per essere compresa e apprezzata appieno.
Orano è una cittadina francese in cui, da un giorno all'altro, si cominciano a scovare cadaveri di topi a ogni angolo di strada; nei palazzi, nelle cantine, nei ristoranti. Quello che all'inizio si presenta solo come un fatto insolito che scuote leggermente la monotonia della vita di una città piuttosto noiosa e spenta, diventa il presagio di un flagello che la devasterà per più di un anno; perché quello che uccide i topi comincerà a uccidere anche gli uomini, e certo non con numeri più generosi.
Il dottor Bernard Rieux si troverà ad affrontare questo morbo che si credeva ormai sparito, perso in un sonno eterno; che ha devastato la vita degli uomini nei secoli passati ma che ormai aveva smesso di tormentarci. È difatti difficile ammettere che sia tornato, nei primi tempi in cui si presenta; è difficile addirittura pronunciarne il nome: peste. Ma alla fine non si potrà più negare e avrà inizio una lotta in cui gli esseri umani non possono fare altro che provare ad assorbire i colpi nel modo migliore possibile, senza mai avere la possibilità di sferrare un attacco: come si può, infatti, colpire il morbo della peste? È una cosa che si può soltanto sopportare, e che se dovesse lasciarci vivi potrebbe ancora tormentarci col ricordo della sua spietatezza. Dunque tutto quel che resta da fare all'uomo è subire e cercare di non soccombere, sopravvivere e, in tale fortunato caso, bendarsi le ferite e ricominciare.
"Il male presente nel mondo viene quasi sempre dall'ignoranza, e la buona volontà, se non è illuminata, può fare altrettanti danni della malvagità. Gli uomini sono più buoni che cattivi, e in realtà il problema n on è questo. Ma sono più o meno ignari, e questo è ciò che chiamiamo virtù o vizio, dove il vizio più desolante è l'ignoranza che crede di sapere tutto e si concede per questo il diritto di uccidere. L'anima dell'assassino è cieca e non c'è vera bontà né vero amore senza tutta la chiaroveggenza possibile."
Indicazioni utili
Il canto dell'uomo
Altro romanzo post-atomico, altra sfaccettatura interessante della questione.
Nevil Shute ha deciso di trattare quello che sarebbe il risvolto più drammatico che una guerra nucleare potrebbe generare: quello in cui non rimane scampo. “L’ultima spiaggia” non è il racconto ci come la razza umana provi a ricominciare dopo il disastro, non è il racconto di come alcuni uomini riescano a salvarsi da una morte inevitabile; “L’ultima spiaggia” è il racconto di come la razza umana si possa ritrovare a far fronte a un male impossibile da evitare e di come possa decidere di spendere gli ultimi momenti che gli restano sulla faccia della terra. È interessante, perché non tutti gli scrittori possiedono l’audacia del non lasciar scampo; non tutti riescono a resistere all’impulso di donare all’umanità quello spiraglio che gli permetta di preservarsi. Nevil Shute ci riesce, ma dipinge un quadro che nonostante l’ineluttabilità della fine risulta più piacevole di molti di quelli in cui la razza umana scampa alla morte, ma si abbandona alla barbarie. In questa storia non c’è scampo, ma non c’è nemmeno barbarie: ci sono esseri umani che decidono come spendere gli ultimi istanti, ci sono persone che tentano di conservare la propria dignità nonostante tutto e che si abbandonano a tutto ciò che hanno amato e ci si spendono fino all’ultimo secondo.
Un’umanità che solo nel momento della propria fine riesce a mostrare il meglio di sé, a esibirsi nel proprio personale “canto del cigno”.
La guerra è ormai al termine ed è stata una guerra breve, oltretutto degenerata per puro caso. Il destino dell’uomo sarebbe davvero appeso a un filo, nel momento in cui strumenti di distruzione di tale portata si ritrovino nelle mani di tutti; la probabilità che finiscano nelle grinfie di uomini disturbati aumenterebbero sensibilmente. È così che è andata a finire e i pochi sopravvissuti attendono che arrivi il proprio momento; attendono che le radiazioni sospinte dal vento raggiungano, alla fine, anche loro. Nonostante questo proseguono nella propria vita come se l’avessero ancora davanti nella sua interezza; certo, fino a un certo punto. Il racconto si focalizza su vari personaggi, che ruotano tutti sulla figura centrale che è Dwight Towers: comandante del sottomarino Scorpion, che si imbarcherà in varie spedizioni verso le zone già “ammazzate” dalle radiazioni, nella speranza di confermare teorie scientifiche che possano regalare un minimo di speranza. Ma non sono le spedizioni del sottomarino a essere al centro di questa storia: al centro ci sono i rapporti che si creano tra quegli uomini che non sono stati ancora raggiunti dalle radiazioni, ma che lo saranno presto e sentono quella nube di morte avvicinarsi giorno dopo giorno.
Una storia che riesce originale, discostandosi da una massa che tende a ripetersi.
“Sapete, ora che mi sono abituato all’idea, preferisco che sia così. Dobbiamo tutti morire un giorno o l’altro, presto o tardi. Il guaio è che non siamo mai pronti, perché non sappiamo quando toccherà a noi. Bene, ora lo sappiamo e non ci possiamo fare nulla. L’idea non mi dispiace. Mi va di pensare che rimarrò in buona salute fino alla fine di agosto e poi… buona sera. Meglio così, piuttosto che vivere una vita da invalido dai settanta ai novanta anni.”
Indicazioni utili
Alas, Babylon
Dopo “Cronache del dopobomba” di Philip K. Dick, eccomi qui a recensire il secondo romanzo post-atomico della mia lista che, tra le altre cose, sembra aver in certi tratti ispirato l’opera dickiana.
È molto interessante scoprire opere degne di nota che ormai sono anche difficili da reperire; “Addio Babilonia” di Pat Frank è sicuramente una tra queste, uscita per l’ultima volta per mezzo della collana fantascientifica di Mondadori, “Urania”, che secondo me nasconde più di una perla che vale la pena di considerare. “Addio Babilonia” è un romanzo ben scritto, curato, con uno stile piuttosto scorrevole; certo, non potrà vantare una profondità di contenuto invidiabile o dei personaggi caratterizzati in modo da restare indelebili nel cuore, ma è comunque una storia piacevole che si concentra sulla realizzazione di quella che era la paura principale del secondo dopoguerra: lo scoppio di una nuova guerra che non avrebbe lasciato scampo a nessuno, stavolta. È interessante come l’autore non lasci nulla al caso e dipinga una delle possibili pieghe che potrebbe prendere una parte della società umana, in seguito a un disastro di tal sorta.
Di cosa si farebbe scorta, se si sapesse di un disastro imminente? È incredibile e interessante vedere come le cose che diamo quasi per scontate (come acqua, sale, caffè) in un mondo disastrato acquisiscano un valore sproporzionato; lusso e necessità subiscono un brusco capovolgimento, e ci si potrebbe ritrovare a scambiare una Jaguar con nemmeno mezzo chilo di caffè o per qualche bottiglia di whisky. Solo il disastro e la tragedia può far luce su quello di cui abbiamo davvero bisogno e su quello che, invece, è superfluo?
“Addio, Babilonia” è ambientato a Fort Repose, una cittadina fluviale della Florida centrale, popolato da una comunità di persone in cui, bene o male, ci si conosce. Un abitante di questa cittadina, un certo Randy Braggs, un giorno riceve un messaggio da suo fratello Mark, che lavora per il governo. Il messaggio si conclude con la frase: “Ahi, Babilonia”. Sembrerebbe una cosa senza senso, ma non per Randy, che capisce immediatamente che la tensione tra Stati Uniti e Russia è ormai ai limiti e si prepara a scatenare la guerra più terribile che l’umanità abbia mai vissuto. Dunque, Randy si attiva per ricevere la famiglia di suo fratello, che non potrà più prendersi cura di loro perché incaricato di restare in una base governativa.
Un evento casuale sarà la goccia che farà traboccare il vaso, a dimostrazione di quanto l’equilibrio della pace possa essere instabile e di come la sopravvivenza dell’uomo sia appesa a un filo che può essere spezzato anche dall’errore dell’essere umano più insignificante. Un missile colpisce accidentalmente una base portuale, e questo darà inizio ai grappoli di bombe a idrogeno: una dopo l’altra le città americane più grandi e importanti spariranno, gettando l’umanità in una nuova, spaventosa realtà. Sarà interessante assistere allo spirito di adattamento dei protagonisti, che proveranno a ripartire e a preservare la vita della comunità anche in seguito a un evento che potrebbe simboleggiare la fine della razza umana.
Ma la razza umana è dura a morire.
“La natura sta realizzando la legge di Darwin sulla selezione naturale. L’ape difettosa, incapace di reggere al suo ambiente, viene respinta dalla natura prima della nascita. Credo che questo valga anche per l’uomo. Si dice che la natura sia crudele. Io non la penso così. La natura è giusta, addirittura misericordiosa. Per mezzo della selezione naturale, la natura cercherà di disfare ciò che l’uomo ha fatto.”
Indicazioni utili
Nelle mani del fato
Dopo aver letto non molto tempo fa “La variante di Lüneburg” dello stesso autore, mi accingo a recensire quella che è la sua più recente uscita. Da entrambe le letture si evince che, oltre a essere un profondo conoscitore del mondo degli scacchi, Paolo Maurensig ne è davvero un amante appassionato, che accosta questo gioco a qualcosa di quasi divino. Come suggerisce il titolo di questo libro, dopotutto.
Devo dire che lo stile di Maurensig si è confermato di buona fattura: chiaro, scorrevole, capace di emozionare nei momenti giusti; soprattutto nel finale mi è sembrato capace di smuovere qualche corda del mio animo. Anche “Il gioco degli dèi", dunque, si è rivelata una bella lettura, che ci rende partecipi di una storia che, oltre a essere un piacere da leggere, ci regala anche qualche momento di sana riflessione. Certo, Maurensig dovrà essere bravo in futuro nel continuare a variare molto le sue storie, se vuole mantenere come cardini gli scacchi (e anche qualche altro elemento, come la guerra), ma mi sembra che finora ci sia riuscito bene.
Il realismo di Maurensig non concederà tuttavia molte soddisfazioni al lettore amante dei risvolti sempre positivi degli eventi; per quanto mi riguarda questo è un punto a favore dello scrittore, che riesce a dipingere la vita in maniera autentica e senza forzare la mano per “accontentarci”.
Tuttavia, c’è sempre spazio per la speranza.
In questo libro diventiamo spettatori di quella che è stata la vita di Malik Mir Sultan Khan, indiano di umili origini che si ritrova un dono: è un vero e proprio campione del chaturanga, ovvero l’antenato del gioco che noi chiamiamo scacchi. Da ragazzino, nel suo villaggio, farà la sua comparsa una tigre che lo priverà di entrambi i genitori, lasciandolo completamente solo. In soccorso dei suoi servitori arriverà il principe Sir Umar Khan. Il nobile Khan, conosciuto per essere un uomo buono che si preoccupa dei suoi sudditi, allestirà un accampamento e, nelle pause che ci saranno tra una battuta di caccia alla tigre e l’altra, ascolterà le richieste di aiuto degli abitanti del suo villaggio. Tra questi il piccolo Malik, che gli farà una richiesta insolita: vuole diventare un campione di chaturanga.
Da qui si scateneranno una serie di eventi che porteranno Malik a confrontarsi con i più grandi campioni di scacchi; ad affrontare e sconfiggere il più grande giocatore del mondo: Capablanca; a vincere più di una volta il titolo di campione di scacchi britannico. Tuttavia, come al solito, la guerra verrà a sconvolgere la vita e il futuro di Malik, che si ritroverà trascinato in una serie di eventi che gli segneranno la vita, in certi casi episodi piuttosto amari.
Una volta chiuso il libro lo riporremo con la consapevolezza di aver appreso una storia che valeva la pena di essere raccontata.
“Essere supportati dagli dèi non è poi quella gran cosa che tutti credono; non è un merito muoversi appesi alle loro fila, diventare una loro pedina. È appena poco più dici che fa un servo nell’obbedire ai desideri e ai comandi del proprio padrone.”
Indicazioni utili
La società del dopobomba
Trovandomi in una fase in cui devo accumulare quante più idee e informazioni possibile per il prossimo libro che scriverò, questa sarà solo la prima recensione, di varie che seguiranno, su opere narrative che hanno al centro della propria trama le conseguenze di un probabile conflitto atomico, immaginate da autori diversi.
Come non cominciare allora da uno degli autori che di una Terra devastata ha parlato in moltissime opere e in tante salse diverse? Philip K. Dick è stato certamente uno degli autori più visionari di tutti i tempi, e ancora oggi dalle sue opere sono tratti infiniti spunti per realizzare film, serie televisive e anche altre opere narrative. “Cronache del dopobomba” non è forse una delle sue opere meglio riuscite, ma contiene certamente vari spunti di riflessione riguardo al probabile destino degli esseri umani. Nei confronti dell’umanità, Dick ha sempre nutrito dei sentimenti contrastanti: pur nutrendo una forte sfiducia nei loro confronti, non manca mai di fornirci un pizzico di speranza riguardo la sua redenzione e sopravvivenza. In questo libro, oltre a concentrarsi sulla sopravvivenza, l’autore sembra concentrarsi sulla capacità che hanno gli esseri umani di risorgere dalle proprie ceneri, di saper ripartire e rimettere in piedi quanto di buono hanno conquistato nel corso dei secoli, ma anche la loro innata propensione a ripetere gli stessi errori del passato.
Per quanto il mondo possa cambiare, gli uomini in fondo sono sempre gli stessi, nel bene e nel male.
Questa storia ha inizio poco prima dello scoppio della guerra nucleare che metterà in ginocchio l’umanità. Stuart McConchie, impiegato di un negozio di televisori, sta spazzando il marciapiede di fronte al suo luogo di lavoro e osserva un uomo che entra nello studio di uno psichiatra. Questo personaggio misterioso sarà la chiave degli eventi che si scateneranno subito dopo, ma l’autore si divertirà a giocare con il lettore facendone vacillare ogni certezza.
Dopo il conflitto atomico, i sopravvissuti si organizzano in delle specie di comunità dove i ruoli che ogni uomo possedeva prima della tragedia possono essere profondamente mutati; possono aver perso completamente importanza o aver acquisito una funzione vitale. Tra questi ultimi c’è il focomelico Hoppy Harrington, un ragazzo senza braccia e senza gambe che però è un tuttofare strepitoso. I tuttofare sono la figura più ricercata di tutta la società umana del dopobomba. Dunque Hoppy Harrington, che prima della guerra nucleare era considerato alla stregua di uno scherzo della natura, si ritrova a possedere un’influenza e un’importanza che lo porterà a coltivare un’ambizione smodata. Oltre questo, Hoppy ha sviluppato delle mutazioni che gli permettono di fare delle cose incredibili e che lo rendono temibile agli occhi di tutti.
“Cronache del dopobomba” è la palese dimostrazione che l’uomo è una specie difficile da estirpare, così come sono difficili da estirpare i suoi lati negativi: non importa quanto sia stata dura la lezione, l’uomo possiede nella sua natura qualcosa di inspiegabile che lo porta a compiere errori su errori.
In fondo a quel tunnel che è l’anima umana, tuttavia, a volte può nascondersi una luce.
“I problemi che ai vecchi tempi ci sembravano importantissimi, pensò… l’impossibilità di sottrarsi a una relazione umana infelice. Adesso apprezziamo qualsiasi relazione umana. Abbiamo imparato molto.”
Indicazioni utili
Ritorno a un paese scomparso
Chi mi conosce, sa che come lettore sono un esterofilo di quelli veramente patologici. Durante i primi anni della mia carriera di lettore sono davvero pochi gli autori italiani che mi sono ritrovato a leggere: sarà per le esperienze scolastiche traumatiche (tra cui “I promessi sposi” e il galeottissimo “Il fu Mattia Pascal”), ma fino a poco tempo avevo davvero di che vergognarmi quando un convinto “nazionalista” si faceva avanti e mi poneva la fatidica domanda: “e di autori italiani? chi hai letto?”
Ansia, panico.
Beh, devo dire che negli ultimi tempi mi sto rimettendo in riga e pur rimanendo un esterofilo convinto sto scoprendo autori di assoluto valore: Calvino, Sciascia… e conto di aggiungere altri alla lista. Si può dire che Pavese possa rientrare tra questi? Nì; almeno per quanto mi riguarda.
“La luna e i falò” è una storia che ha al centro il ritorno di un uomo, chiamato Anguilla, nel suo paese natale; un uomo che in questo paese non era altro che un servitore e un lavoratore per una famiglia più facoltosa, che possiede questa proprietà chiamata Mora. Dopo la sua esperienza “oltre Canelli”, fino in America, l’uomo si aspetta di tornare in paese quasi come un eroe; invece trova un paese che a stento si ricorda di lui e che all’apparenza ha conservato tutte le sue caratteristiche, variando solo gli interpreti: quello che lui era anni prima, adesso lo è il giovane Cinto; quello che era il sor Matteo ora è il Valino… o almeno così sembra all’apparenza. Nel frattempo è venuta la guerra a cambiare tutto, sotto la superficie.
Lo stile dell’autore in certi tratti è magnetico, ti cattura e la lettura scorre che è un piacere; in certi altri si fatica un po’ ad andare avanti. Devo dire che in certi tratti il procedere degli eventi suscita curiosità, e accadranno alcune cose (una in particolare) che lasceranno il lettore spiazzato: un crudo colpo di scena che davvero non mi aspettavo e che ha ravvivato moltissimo il mio interesse. Tuttavia, non c’è un grande approfondimento della psicologia dei personaggi: quello che più di tutto viene messo in risalto è il contesto del paese, la differenza che passa tra le classi sociali e come la guerra ha influito e si è insinuata in questo ambiente, lasciandovi un segno indelebile. Quello che più colpisce, durante i numerosi flashback che vedono il protagonista lavorare nella Mora, è la netta divisione che vi è tra i lavoratori e i proprietari terrieri: il nostro Anguilla non penserebbe neanche lontanamente a una storia romantica con una delle figlie del suo padrone; nemmeno l’amore potrebbe distruggere una simile barriera, nonostante gli spasimanti di quelle giovani donne siano perlopiù degli imbecilli e dei poco di buono. Il distacco è netto, si avverte distintamente; solo in pochi e brevi attimi si sente uno scricchiolio, ma non sarà altro che una breve illusione. Quella linea non la si può varcare, e a nulla conta il fatto che “il sangue è rosso dappertutto”.
L’autore descrive questo contesto con vera maestria, eppure non posso dire che mi sia trovato davanti a una lettura indimenticabile.
Pavese: rimandato.
“E Nuto a dirmi: - Cosa credi? la luna c’è per tutti, così le piogge, così le malattie. Hanno un bel vivere in un buco o in un palazzo, il sangue è rosso dappertutto.”
Indicazioni utili
L'INCOMUNICABILITÀ DEGLI UOMINI
Avevo una paura matta di cominciare la mia esperienza con John Steinbeck da “Furore”. “E se non mi piace?” dicevo a me stesso, pensando che poi mi sarei dovuto sciroppare un bel mattoncino che avrei fatto fatica a finire (ma che avrei certamente finito, se ho finito Anna Karenina, posso finire tutto). Non mi linciate per questa ultima parentesi, sono gusti.
Tornando a Steinbeck, mi sono detto che avrei dovuto cominciare con qualcosa dalla mole un po’ più ridotta, come faccio un po’ con tutti gli autori; dunque ho deciso di acquistare “Uomini e topi” e cominciare da questo. Conclusione? Non vedo l’ora di leggere Furore, ragazzi, e credo che non vedrò l’ora di leggere tutto quello che questo autore ha scritto. Non so se questo libro sia perfetto come asserisce Nick Hornby, ma posso tranquillamente dire che sia un gioiello di rara bellezza. I motivi? Bene, vi farò un elenco: personaggi caratterizzati alla perfezione, ambienti che nella mente del lettore prendono praticamente vita con descrizioni che non risultano ostiche né inutilmente lunghe, dialoghi assolutamente efficaci. Ma andiamo oltre. Steinbeck riesce a regalarci uno spaccato d’umanità che secondo me altri autori non sarebbero in grado di mettere insieme nemmeno con un libro di mille pagine: il messaggio passa forte e chiaro, il pensiero dell’autore ci arriva forte tramite analogie che lui non spiega esplicitamente ma che sono più che chiare.
Devo dire che alcuni tratti mi sono sembrati un po’ crudi, ma è dovuto alla mia sensibilità soprattutto quando ci sono di mezzo cani e cagnolini. Non ci sono torture, state tranquilli, né violenza gratuita. Ogni cosa in questo libro ha il suo perché, la sua spiegazione, e ci rendiamo conto che per quanto triste da leggere era comunque necessario scriverla.
Il messaggio che mi è arrivato più forte è l’incomunicabilità fra esseri umani. Per quanto possiamo conoscerci a fondo spesso non riusciamo a capirci; spesso veniamo fraintesi; spesso veniamo accusati di fare cose che non sono neanche lontanamente nei nostri pensieri ma che il pensiero comune ha contribuito a far diventare verità incontrastabili. Sono tanti i personaggi che, a un occhio superficiale, possono apparire in un modo; ma basta essere disposti ad ascoltare per capire che oltre la facciata può esserci molto di più. Emblema di questo aspetto sono i personaggi dello stalliere di colore e della signora Curley, senza dimenticare uno dei due protagonisti: Lennie. Non posso essere certo che questo aspetto volesse essere messo in risalto intenzionalmente da Steinbeck, ma a me questo messaggio è arrivato in maniera prepotente insieme a quello più esplicito dell’incapacità di stare al mondo; dell’impossibilità di vivere insieme ad altri, per alcuni uomini particolari. È un argomento controverso, che Steinbeck porta alla nostra attenzione.
Ci sono cose che un uomo deve fare. Probabilmente.
I protagonisti di questa storia sono George e Lennie, due braccianti che lavorano stagionalmente nei ranch. Il primo è un uomo sveglio, intelligente e gran lavoratore; il secondo è un uomo grande e grosso, scemo ma innocente e semplice come un bambino, che nelle sue intenzioni non vorrebbe far mai male a una mosca ma che a causa della sua mole si ritrova anche a uccidere topi che tiene nel palmo della mano, per accarezzarli. All’inizio di questa storia sono in fuga dall’ultimo ranch in cui hanno lavorato, a Weed, proprio perché Lennie voleva accarezzare il soffice vestito di una ragazza che viveva lì. Non aveva altre intenzioni, solo accarezzare la morbidezza di quel vestito. Ma, come dicevamo, l’incomunicabilità è una piaga e quello che appare viene quasi sempre considerata verità. Dunque George e Lennie scappano e cominciano a lavorare in un altro ranch, dove fanno amicizia con gli altri lavoratori e si scontrano con Curley, manesco figlio del loro datore di lavoro e marito di una donna piuttosto controversa, che sembra essere lì appositamente per portare guai. Ma George e Lennie non contano di stare lì per molto; hanno un sogno che perseguono con tutte le proprie forze: avere un posto tutto loro in cui vivere una vita tranquilla, coi frutti della propria terra; vogliono solo essere liberi e non doversi spaccare la schiena per qualcun altro. Una vita semplice: stare di fronte a una grande stufa e ascoltare il ticchettio della pioggia. Badare ai conigli, come direbbe Lennie.
Il tempo che trascorreranno in questo ranch porterà alla luce tante di quelle cose, che davvero non so dire come l’autore ne sia stato capace in così poche pagine.
Davvero un capolavoro, probabilmente.
“«Beh, Curley è abbastanza manesco,» disse lo scopino con aria scettica. «Non mi è mai sembrato giusto. Poniamo che Curley salta addosso a uno grosso e gliele suona: tutti a dire quant’è in gamba Curley. Ma poniamo che fa la stessa cosa e viene suonato: allora tutti a dire che quello grosso doveva menare uno della sua stazza, e magari lo aggrediscono tutti insieme. Non mi è mai sembrato giusto. È come se Curley non desse scampo a nessuno.»”
Indicazioni utili
Sul filo di una scacchiera
Contare i libri e le opere di narrativa che hanno come argomento centrale nazismo e sterminio ebraico è un'impresa praticamente impossibile, ormai. Nonostante siano passati più o meno ottant'anni è sempre un argomento trattato tantissimo; un'argomento che continua ad attrarre lettori su lettori. Perché? Perché conviviamo con lo spauracchio che questi orrori possano ripresentarsi e, oltretutto, siamo sempre attratti da quello che fatichiamo a comprendere. Sì, perché come degli uomini possano essersi macchiati di tali atrocità resterà sempre e comunque un mistero; un mistero che ci attira molto più del normale perché è scaturito dall'animo di esseri umani che, in teoria, dovevano essere come noi.
In questa moltitudine di opere quelle che riescono a spiccare devono avere dei tratti distintivi; devono avere qualcosa di unico che possa raccontarci qualcosa che non conosciamo già o che lo faccia con una maestria invidiabile. Lontano dalla bellezza senza tempo di opere come "Se questo è un uomo" di Primo Levi, "La variante di Lüneburg" di Paolo Maurensig si distingue dalle altre opere con le quali condivide il tema principale perché mette in collegamento quest'ultimo con qualcosa che non avremmo mai immaginato: il mondo degli scacchi. Sì, gli scacchi sono i veri protagonisti di questo libro e dominano la scena diventando alla fine artefici anche del destino di molti esseri umani.
La storia ha inizio con la morte di un certo Dieter Frisch, un uomo facoltoso amante degli scacchi. Tutte gli indizi sembrano portare alla conclusione che l'uomo si sia suicidato, ma i motivi che possano averlo portato a quest'ignobile risoluzione sembrano essere quanti i suoi nemici: zero assoluto.
Le verità che scopriremo saranno molto diverse e con una struttura che ricorda un po' "Uno studio in rosso" di Conan Doyle ci imbatteremo in una storia spaventosa che ci appare terribilmente reale e verosimile, come se potesse trattarsi di una vera e propria testimonianza. In questa storia Frisch appare piuttosto poco, ma le sue apparizioni sono come dei fulmini a ciel sereno, che faranno luce su un passato e una personalità scabrose e che chiariranno gli eventi che poi avranno luogo nel corso degli anni.
Eventi che hanno un unico denominatore: gli scacchi.
"Gli scacchi, come le arti, sembrano darci la possibilità di sopravvivere alla morte fisica, di avere fama eterna. Cosa non daremmo perché il nostro nome venisse ricordato negli annali del gioco: basterebbe una sola partita, una variante, uno sprazzo di originalità."
Indicazioni utili
Stralci d'umanità di un genio
“Nella vita mirava solo a tre cose: scrivere, pubblicare, e sposare il suo grande amore. In quest’ordine.”
Questa la citazione che dovrebbe riassumere l’essenza de “Il giardino dei Cosacchi” di Jan Brokken, ma che da quanto emerge dalla lettura non sembra corrispondere del tutto a verità, almeno riguardo all’ordine di preferenza. Cominciamo con l’identificare questo libro: non è una biografia di Fëdor Dostoevskij, bensì il racconto dello stralcio più drammatico della sua vita, ovvero quello che comprende il suo arresto, la condanna a morte e la mutazione della pena ai lavori forzati in Siberia. Il tutto è ricostruito e romanzato tramite le lettere che l’autore russo ha scambiato con quello che in quel tempo era il suo migliore amico: l’ufficiale Alexander Von Wrangel, che è anche il narratore di questa storia. Il racconto dovrebbe essere accurato, considerate le fonti utilizzate per metterlo insieme, e riesce a mettere in luce il lato più umano di Dostoevskij e allo stesso tempo a sfatare qualche mito.
Tutto ha inizio proprio nel momento della commutazione della pena: Dostoevskij è sul patibolo e sta per essere fucilato insieme ad altri “sovversivi”. Tuttavia, proprio mentre si trova solo in attesa della parola “fuoco!”, arriva a cavallo un ufficiale per comunicare la grazia dello zar: niente più fucilazione, ma lavori forzati in Siberia e in seguito servizio nella città kazaca di Semipalatinsk. Proprio qui il nostro scrittore farà la conoscenza di Alexander von Wrangel, che da ragazzino ha assistito alla sua “quasi” esecuzione e che ne è stato segnato profondamente. Avrà qui inizio una profonda amicizia che li porterà a condividere tutto, portandoli ad aggrapparsi l’uno all’altro e a ritagliarsi un rifugio nel “Giardino dei cosacchi”, una vecchia dacia in mezzo alla steppa in cui potranno condividere riflessioni, gioie, dolori, e dalla quale saranno lontani spettatori del contesto politico della Russia di quell’epoca.
Questo fino a quando le vicissitudini li porteranno a separarsi, arrivando a una conclusione che mette in risalto la brutalità della vita; che mette in risalto come alcuni legami che credevamo indissolubili possano rompersi senza preavviso e a volte senza neanche un grave motivo. La vita dà, la vita toglie; ma mentre quello che riceviamo richiede molto spesso uno sforzo non indifferente, nel caso di un’amicizia anche un profondo impegno nel coltivarla, tutto ci può essere tolto anche in maniera brutale.
Tornando a quello che accennavo all’inizio della recensione, paradossalmente non credo che scrivere e pubblicare si trovino un gradino più su dello “sposare il suo grande amore”, per il nostro caro Fëdor. Perché? Perché nelle pagine di quest’opera si mette continuamente in risalto l’ossessione che Dostoevskij ha per quella che sarà la sua prima moglie: Marija Dimitrievna Isaeva, che nel momento in cui incontra lo scrittore è sposata e con un figlio. Questo amore malato (perché di questo si tratta, soprattutto a causa del carattere a dir poco folle di lei e dell’ossessione di lui) è in fondo il protagonista dell’intera vicenda, insieme all’amore altrettanto impossibile tra Von Wrangel e un’altra donna sposata. Perché dico che questo amore era più importante della scrittura, per Dostoevskij? Perché nei momenti in cui questo rapporto viveva i suoi momenti no l’autore era letteralmente incapace di scrivere. È strano fare questo tipo di constatazioni riguardo a uno dei più grandi autori di tutti i tempi, oltre che tra i miei preferiti in assoluto. In questa storia viene fuori tutta la fragilità, i suoi difetti (tra cui un’innata tendenza a elemosinare, che si tratti di soldi o di favori), il suo essere profondamente umano.
Certo, bisogna sempre considerare che si tratta del punto di vista (espresso tramite lettera) di un'altra persona; ma una persona che comunque gli è stata molto vicina per lungo tempo.
“«Grande è la gioia dell’amore», mi scrisse, «ma i dolori sono così terribili che sarebbe meglio non amare mai.»”
Indicazioni utili
Inno alla lettura
“Ogni coincidenza ha un’anima” di Fabio Stassi è quasi un inno all’amore per la lettura.
Tra le sue pagine si nascondono innumerevoli consigli di lettura, che molto probabilmente vengono dallo stesso autore. In certi tratti ci sembra quasi di trovarci a leggere una lista di consigli di lettura (in realtà, in appendice ce n’è uno), anche se non associati a una diagnosi così come si diverte a fare il nostro protagonista: Vince Corso. Ho provato una forte empatia nei confronti del protagonista ma anche del vecchio su cui si ritrova a “indagare”, entrambi devoti alla letteratura e coi quali ho trovato vari punti in comune con me stesso. Probabilmente è proprio questo che l’autore voleva mettere in risalto: come i lettori forti in fondo appartengano tutti a un’unica razza che condivide in certi aspetti lo stesso modo di pensare; lo stesso modo di approcciarsi alla carta stampata; le stesse fisime, a volte.
L’autore poi non perde l’occasione di soffermarsi su temi di forte attualità, come l’evidente tendenza alla discriminazione razziale che stiamo riscontrando negli ultimi anni, come se stessimo già dimenticando gli errori e gli orrori del passato; gli episodi del corteo e del vecchio egiziano sono emblematici, in questo senso. Fa riflettere anche la visita a Vince Corso da parte di un personaggio che è lo stereotipo dell’attuale italiano medio, tutto rabbia e attivismo malsano, che ha identificato “l’unico nemico” ben conosciuto da Goebbels in chiunque sia “diverso”. Oltre a questi argomenti scottanti ci sono varie altre riflessioni forse un po’ più soft, come il ritratto che Stassi fa dello “scrittore esordiente”, esemplare sempre meno raro al giorno d’oggi e che nella maggior parte dei casi ha un modus operandi che l’autore coglie in pieno. Lo posso dire perché ci sono dentro.
C’è forse un evento che lascia un po’ l’amaro in bocca e che ha come protagonista Feng, una ragazza cinese incontrata da Vince Corso, e che si è ritagliata anche lo spazio in copertina. Certo, è stata “sacrificata” per rafforzare un messaggio… ma era davvero così necessario? Beh, ma queste sono le opinioni del lettore che lasciano il tempo che trovano.
Vince Corso è un biblioterapeuta, ovvero una specie di psicologo che riceve i suoi pazienti, si fa raccontare quelli che sono i loro problemi, e in base al caso consiglia delle letture da fare per provare a risolvere il problema. La porta del suo ufficio (che è anche la porta di casa sua), è varcata da ogni genere di persone: persone coi problemi più ovvi: lavoro, amore; ma anche con problemi strambi. C’è infatti chi chiede a Vince se esista un libro che possa fare in modo di smettere di essere stonati, giusto per fare un esempio.
Ma la situazione trova la sua svolta quando una donna varca la soglia per chiedere a Vince Corso di portare avanti una specie di “indagine”: il fratello della donna, esperto linguista e lettore più che vorace, è affetto da Alzheimer e ormai non in grado nemmeno di parlare; pronuncia solo frasi sconnesse, sempre le stesse. La donna ha il forte sospetto che le frasi appartengano a un libro e chiede a Corso di capire quale sia. Da qui, le ricerche del nostro protagonista che porteranno a una verità inusuale, che solo a un uomo pazzo d’amore per la lettura poteva covare, e che solo un uomo pazzo allo stesso modo poteva scovare.
Noi lettori parliamo una lingua tutta nostra.
“Non ho nessuna religione del ricordo, mi dispiace. Non ha senso mettere a fuoco il passato. Il tempo è una porta che si chiude e ha un solo verso.Tutto accade una volta e basta, e genera conseguenze, episodi totalmente occasionali, eventualità che potevano girare in un altro modo.”
Indicazioni utili
La memoria è ingannevole
Ultimamente mi sto cimentando più del solito in quelle letture che in fondo non hanno una trama, ma che sviluppano la psicologia di personaggi che hanno vissuto determinati traumi e che si sono ritrovati in determinati contesti. “La coscienza di Andrew” di E.L. Doctorow è proprio un libro di questo genere, in cui il protagonista Andrew (scienziato cognitivo) si trova a portare avanti dei discorsi con un interlocutore sconosciuto (uno psichiatra? Una parte di sé stesso? Un aguzzino?). A quest’uomo racconterà di vari traumi che hanno segnato la sua esistenza: il divorzio dalla sua prima moglie, in gran parte causato dalla morte accidentale della sua prima figlia; la morte della sua seconda moglie durante l’attacco delle torri gemelle e l’affidamento della figlia avuta con quest’ultima proprio alla prima moglie e al suo nuovo marito.
Lo stile di Doctorow è uno stile che mi ha colpito tantissimo, comprensibile, per nulla pesante ma allo stesso tempo potente; uno di quegli stili che è piacevole leggere anche ad alta voce. Quello che mi ha stupito è il fatto che sia un’opera relativamente recente; devo ammettere infatti che non avevo idea dell’anno in cui era stata scritta, quando ho cominciato a leggere. Se avessi dovuto dare una mia opinione considerando soltanto lo stile di scrittura e il tipo di racconto che mi sono trovato davanti, avrei detto di stare leggendo un’opera scritta nella metà del Novecento. Quando alcuni elementi mi hanno suggerito che l’opera era stata concepita negli anni Duemila, ne sono rimasto piacevolmente colpito; dunque non tutti gli autori capaci di scrivere in questo modo si sono estinti con l’arrivo del nuovo secolo.
È un libro che si legge in poco tempo e che in certi tratti dà più di uno spunto per riflettere. Forse l’empatia che si crea con il personaggio di Andrew non è forte come in altre opere che mi è capitato di leggere ultimamente (ad esempio, l’Hans protagonista di “Opinioni di un clown” di Heinrich Böll), ma è comunque una personalità interessante e che partorisce pensieri interessanti. È un libro che non risparmia velate critiche alla politica americana, che insinua qualche dubbio sulla tragedia dell’11 settembre, ma che si sofferma più su quanto la memoria dell’uomo sia ingannevole.
In conclusione devo dire che E.L. Doctorow è un autore che ho intenzione di approfondire assolutamente.
“L’amore è il sordo trauma cranico che ci rende insensibili alla disperazione.”
Indicazioni utili
Le favolette del Re
Negli ultimi anni siamo abituati a vedere almeno un paio di nuove uscite, partorite da una delle penne contemporanee più amate. Mentre la fine del 2018 era stata segnata da "The Outsider", prima nota piacevole (a dir poco) dopo anni di oblio, nel 2019 King fa il suo esordio con un piccolo libricino; un racconto, che secondo me è più una favoletta con tanto di piccole morali. Nel momento in cui mi sono reso conto che "Elevation" era un libro di questo genere, devo dire che ero piuttosto fiducioso: uno dei migliori autori contemporanei che si cimenta in qualcosa che può trasmettere un bel messaggio, era qualcosa che mi entusiasmava. Ho addirittura pensato: "vuoi che abbia deciso di partorire qualcosa di fortissimo, che si tramandi ai posteri come il Piccolo Principe è arrivato a noi?"
Sì, ragazzi, d'accordo, ho esagerato; ma non mi date addosso.
Inutile aggiungere che le mie speranze erano totalmente vane, e che in fondo questo non è altro che un raccontino neanche troppo bello. C'è la mano di King, e questo si nota soprattutto dall'elemento fantastico (del quale non ho capito molto l'utilità) che è di impronta assolutamente kinghiana, ma che secondo me non è stato ben sfruttato. Si poteva fare molto meglio.
Scott è un uomo di mezza età che un giorno scopre di avere uno strano problema: sta perdendo tantissimo peso, ma la sua stazza fisica rimane sempre la stessa. È come se semplicemente la forza di gravità stesse smettendo di esercitare la sua influenza su di lui. Scott si confronta con un medico in pensione, che gli consiglia di farsi visitare da alcuni esperti, ma entrambi sanno che diventerebbe una cavia da laboratorio; un fenomeno da baraccone. Allora la nuova condizione di "malato terminale" spinge Scott a vivere la sua vita svestendosi di ogni paura, cercando di lasciare un buon ricordo di sé. Castle Rock è un paesino pieno di pregiudizi che lui proverà a combattere a beneficio delle sue nuove vicine di casa. Una di loro è tutt'altro che benevola, nei suoi confronti, ma Scott proverà in tutti i modi a fare breccia nel suo cuore; a farle capire che tra gli uomini ci saranno anche bestie della peggior specie, ma ci sono anche persone buone.
Il tema dei pregiudizi, che alla fine è quello centrale del racconto, è un po' abusato al giorno d'oggi. Oltretutto, i personaggi sono quasi bidimensionali. Certo, non è facile caratterizzare bene un personaggio in poche pagine, ma da King ci si aspetta qualcosa di più di: una donna lesbica arrabbiata con un mondo pregiudizievole, che rifiuta a prescindere anche la gentilezza di un vicino totalmente disinteressato. Oltre a essere un po' forzato il modo d'essere dei protagonisti, è un po' forzato anche il loro stravolgimento.
Forse è blasfemia citare autori come Dostoevskij e Thomas Mann, ma loro certamente ci dimostrano che dar vita a personaggi forti in poche pagine si può, come dimostrano i loro "Le notti bianche" e "La morte a Venezia"; certo quest'ultimo non l'ho amato, ma non si può negare che il protagonista sia ben tratteggiato.
Ora, caro Stephen, tu sei a un bivio: ci hai lasciato tante opere memorabili, ma io so che puoi scrivere la tua "storia definitiva", quella per la quale sarai sempre ricordato. Lo pretendo, perché so che ne sei capace. Non è un obbligo verso i lettori, ma verso te stesso. Qualcuno mi dirà che questa storia è già stata scritta e mi citerà i titoli più disparati... e forse è vero. Forse "la storia definiva" è già stata scritta, ma ogni volta che comincio un nuovo libro del Re sento dentro di me questa strana sensazione.
Sarà il tempo a dire se mi sbaglio o se King ci sta solo facendo aspettare.
"Tutto converge in questo continuo levitare, pensò. Se è questo che si prova morendo, ognuno di noi dovrebbe essere ben lieto di fare il passo estremo."
Bellezza e decadenza
"La morte a Venezia" è un'opera particolare che anche a distanza di giorni, avendo rimuginato su quello che ho letto, non riesco a dire se ho apprezzato o no. L'unica cosa certa è che non è stata indimenticabile, almeno per quanto mi riguarda.
Sicuramente al centro di questa vicenda ci sono la psiche e i pensieri del nostro protagonista, scrittore famoso che stato quasi fatto oggetto di idolatria e che con le sue idee si è fatto guida di diverse correnti di pensiero anche contrastanti tra loro, nel corso del tempo. La cosa ancor più certa è che quest'uomo è anche simbolo di integrità, per quanto riguarda certi valori morali e sociali; un'integrità che nel corso di queste poche pagine vedremo sgretolarsi fino a diventar nulla.
La molla che fa scattare il tutto è un giovanissimo polacco, Tadzio. Il nostro protagonista rimane folgorato dalla bellezza di questo ragazzino; una bellezza che sembra degna di essere decantata dalle muse e che per come appare agli occhi dello scrittore sembra quasi l'incarnazione del protagonista di molti dei Sonetti di Shakespeare. Curiosa coincidenza, che mi sia ritrovato a leggere questi ultimi proprio in seguito a questo libro; mi sembra quasi che la devozione del Bardo per il suo amico sia una stretta parente dell'ossessione del protagonista di questa storia.
Il nostro scrittore è un uomo che non ama stare lontano dalla sua "comfort zone", eppure si tratterrà a Venezia per restare perennemente vicino all'oggetto della sua ammirazione. Mentre in passato al primo cenno di un problema non perdeva occasione per decidersi a rientrare a casa, in questo caso nemmeno la pestilenza che travolgerà Venezia sarà abbastanza da spingerlo a tornare.
Assisteremo dunque alla graduale decadenza di quest'uomo in nome della Bellezza; una devozione cieca che lo spingerà a far cose folli che tempo prima non si sarebbe mai sognato di fare: prenderà decisioni impulsive, si abbandonerà al sentimento, si lascerà andare a un atto meschino pur di non doversi allontanare dalla vista di Tadzio.
Il finale non è altro che l'epilogo inevitabile di uno spaventoso e improvviso declino.
"Aschenbach aveva affermato una volta in una sua pagina, alla sfuggita ma senza ambagi, che quasi tutto ciò che esiste al mondo di grande è una manifestazione di resistenza, è sorto cioè nonostante il dolore e la sofferenza, nonostante la povertà, l'abbandono, la debolezza fisica, il vizio, la passione e mille ostacoli."
Asylum Generation
Ho comprato questo romanzo diviso tra curiosità e timore. La curiosità era dovuta alla massiccia ristampa delle opere di Jack Kerouac, soprattutto da parte di Oscar Moderni Mondadori, che possiede tra le sue file tantissimi autori che amo; il timore era una sensazione non meglio definita, ma che comunque ha determinato il passaggio di un buon periodo di tempo dall’acquisto del libro alla sua effettiva lettura.
Il mio timore ha trovato un nome solo una volta cominciato a leggere.
Non sono mai stato un lettore che si delizia con le storie di puro e semplice viaggio; sarà che sono un tipo a cui i viaggi piace farli in prima persona, ma non sono un estimatore di questo tipo di “storie”. Poi, riflettendo, mi sono reso conto che tra i miei libri preferiti ci sono anche lunghi tratti in cui i protagonisti sono impegnati in viaggi del genere. Allora, qual è stato il mio problema con “Sulla strada” di Jack Kerouac?
Che è solo viaggio e non molto di più.
Certo, in molti lo prendono a manifesto della famigerata “Beat generation”, la gioventù bruciata di cui Kerouac ha fatto parte e si è reso portavoce, ma devo dire che questa generazione mi è risultata insensata, folle e per niente intrigante; sicuramente priva del fascino della “Lost generation” di Hemingway e Fitzgerald. Dunque quasi quattrocento pagine di viaggio da una costa all’altra dell’America (per ben tre volte), accompagnate da intermezzi in cui i protagonisti si danno a un’insensata pazza gioia in cui mettono tutto a ferro e fuoco (compresi sé stessi) mi sono risultate piuttosto ostiche. Non ho provato empatia per i personaggi, se non per brevi tratti. È chiaro che sia una generazione anch’essa perduta, che cerca incessantemente il suo posto nel mondo senza mai trovarlo, ma detto in tutta sincerità mi è parsa una generazione di bambinoni incapaci di crescere, che fuggono incessantemente dalle proprie responsabilità.
Oltretutto c’è una cosa che mi sono chiesto: il personaggio di Dean Moriarty è quello che, a quanto mi è parso di capire, meglio incarna la “Beat generation”. Com’è possibile che un personaggio che viene preso a simbolo di una lunga schiera di persone risulti inverosimile? È forse volutamente esagerato e portato al limite? È sempre super accelerato, sembra che vada al triplo della velocità rispetto agli altri; grida all’improvviso senza motivo; te lo ritrovi nei locali a sbavare dietro ai musicisti, incitandoli a suonare come un pazzo scatenato. Cambia moglie come cambia i pantaloni, sembra amare una più di tutte, un minuto dopo cambia idea, quello dopo torna indietro, poi cambia ancora. Altro che “Beat generation”, questa è roba da manicomio.
Mettendo da parte l’incapacità di trovare una connessione coi personaggi, devo dire che è tutto davvero troppo lungo e ripetitivo. Questa “storia”, forse, avrebbe potuto essere raccontata con meno della metà delle pagine e sarebbe stata apprezzata di più, almeno per quanto mi riguarda. Non vi nascondo che ogni volta che il protagonista, Sal Paradise (che non è altro che l’alter ego di Kerouac), decideva di partire di nuovo verso la costa opposta dell’America, sentivo un colpo al cuore. “Ancora? Oh no”, pensavo, perché sapevo che mi apprestavo a leggere qualcosa di molto simile a quello che avevo appena finito di leggere. Paesaggi (ben descritti, per carità, ma una volta mi basta), sbronze allucinanti nei locali di varie città, follie inspiegabili.
Come dicevo prima, la mia opinione è sicuramente influenzata dai miei gusti di lettore: posso leggere anche pagine e pagine di caratterizzazione psicologica, ma non riesco a immedesimarmi in pagine e pagine di descrizione dell’ambiente. C’è sicuramente un tipo di lettore che è tutto l’opposto, ed è forse a questo tipo di lettore che è più consigliabile la lettura di questo romanzo.
Dimenticavo; la mia curiosità era dovuta anche al fatto che io amo letteralmente gli autori, i paesaggi e le storie americane. Ma un grande autore, per me, è anche chi riesce a dare un equilibrio, a non eccedere in un aspetto a dispetto di un altro; che riesce a calibrare bene tutto: descrizioni dell’ambiente, caratterizzazione dei personaggi, tessitura di una buona trama (anche se questo non è un aspetto fondamentale). Vedevo in Kerouac un autore che potenzialmente avrei potuto aggiungere ai miei preferiti. Purtroppo, il primo approccio è stato traumatico e non so se leggendo altro io possa cambiare idea. Considerato che “Sulla strada” è considerato il suo capolavoro, la vedo dura.
“A quel tempo danzavano per le strade come pazzi, e io li seguivo a fatica come ho fatto tutta la vita con le persone che mi interessano, perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano, bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno «Oooooh!»”
Opinioni di una vittima
“Opinioni di un clown” di Heinrich Böll è quello che il titolo ci promette: il flusso di pensieri di un uomo (che per l’appunto, fa il clown) nel momento più difficile della sua vita. È proprio nei momenti più difficili che gli uomini cominciano a rievocare il passato, a interrogarsi su quelle che sono le cause che li hanno condotti a tale miseria.
È proprio questo che Hans Schnier, il nostro protagonista, fa in questo libro.
Abbandonato dalla sua donna (che lui considera sua moglie, ma che tale non è), si abbandona alla malinconia e lascia che anche la sua professione vada in malora; una professione inusuale per il figlio di una famiglia ricca (e controversa), ma nella quale sembrava poter avere un brillante futuro.
Il libro scorre bene nonostante non accada quasi nulla; rimaniamo difatti soprattutto nei pensieri del nostro clown: riviviamo alcuni dei suoi ricordi, sporcati dal suo punto di vista; ci destreggiamo tra le sue opinioni della società e dei cattolici; assistiamo al suo continuo vittimismo, al suo piangersi addosso, al suo continuo scaricare la colpa del suo stato sugli altri; ci arrabbieremo a causa dei suoi gesti impulsivi, dei quali a volte anche lui stesso si pente.
Heinrich Böll tratteggia un uomo controverso, complesso, rendendolo profondamente umano; nel bene e nel male, e nonostante sia un uomo pieno di difetti non possiamo fare a meno di empatizzare con lui, di lasciarci emozionare dal suo dolore. Un personaggio a tutto tondo che prende vita; "Opinioni di un clown" sembra quasi l’autobiografia di una persona che ha vissuto per davvero, segno che Böll ha fatto un lavoro egregio, in questo senso.
Oltre a partecipare allo sconvolgimento dei suoi sentimenti, verremo messi a conoscenza anche delle sue opinioni: sul cattolicesimo, che molto spesso viene adoperato come una semplice etichetta; sull’entusiasmo e la rigidità dei tedeschi appartenenti a un partito nazista agli albori, e sull’ipocrisia di quegli stessi tedeschi quando quest’ultimo incontrò il suo spaventoso fallimento e la condanna da parte del mondo. È forse anche questo quello che tormenta Hans: l’essere circondato da uomini pieni di difetti proprio come lui, ma che se la passano molto meglio perché li nascondono dietro falsità e ipocrisia. Lui, il clown che una maschera è costretto a indossarla per lavoro, è più genuino di tutti gli uomini che quella maschera la indossano per apparire “giusti” in una società malsana e falsa. Hans è l’unica persona genuina, vera; non ha problemi a mostrare a tutti il suo vero io, i suoi pensieri; anche quelli che lo mettono in cattiva luce.
Un paradosso che lascia il lettore spiazzato, all’inizio; amareggiato nel momento in cui si rende conto di quanto quello che legge è vicino alla realtà delle cose, a un mondo in cui se la passano meglio gli ipocriti, coloro che assecondano le convenzioni senza nemmeno comprenderle; mentre chi è vero, chi si interroga sui motivi celati dietro ogni cosa si trova gettato nella disapprovazione e nella miseria.
Dopo aver “osservato” e ascoltato quest’uomo durante tutta la lettura, in molti angoli della sua personalità, il finale non potrà far altro che emozionarci.
A me, ha emozionato.
"I momenti della vita non si possono ripetere e neppure si possono dividere con altri [...] Tanto diaboliche possono essere le conseguenze del sentimentalismo. Gli attimi bisognerebbe lasciarli così come si sono vissuti, mai tentare di ripeterli, di riviverli..."
Indicazioni utili
Gli ingiusti al potere
Sono sempre restio nel cominciare letture di autori italiani. Che ci posso fare, il trauma che mi porto dietro dai tempi della scuola fa fatica a dileguarsi del tutto. Sì, perché i professori di italiano hanno una capacità invidiabile, nello scegliere testi da far leggere ai ragazzi per fargli avere un'idea malsana della letteratura (soprattutto italiana). Per fortuna, lentamente sto scoprendo autori nostrani che meritano apprezzamento e, dopo la scoperta di Calvino, ora ho scoperto Leonardo Sciascia.
Il suo stile è indubbiamente unico e si potrebbe distinguere tra mille, anche se in certi tratti può risultare ostico per i periodi molto lunghi, pieni di virgole e spesso contorti. Tuttavia, tirando le somme, devo dire che è uno stile che ho apprezzato.
"Il contesto" è un libro particolare, che vuole mandare il lettore in confusione. Sì, avete capito bene: è una cosa esplicitamente voluta dall'autore per rendere l'idea del contesto (ma tu guarda un po' il caso) piuttosto confusionario in cui l'Italia si trovava, nel momento in cui questo libro è stato messo su carta. L'autore ci riesce egregiamente, tenendo il lettore appeso tra supposizioni, false certezze, verità inconfessabili e imperscrutabili. Lo stesso finale rimane aperto a interpretazione; un'interpretazione che non è mai stata data ufficialmente.
Oltretutto, i personaggi disegnati da Sciascia hanno un carattere forte, una propria visione del mondo e delle cose che risulta molto chiara al lettore. Oltretutto, la cosa che rende il tutto più interessante è l'interazione che ci sarà tra i vari protagonisti, che daranno vita a dialoghi memorabili; come ad esempio quello tra il nostro protagonista, l'ispettore Rogas, e il presidente della Corte Suprema.
L'evento che dà il via alla storia è l'assassinio del procuratore Varga, solo il primo di una serie di omicidi di magistrati e giudici. Per risolvere il mistero verrà chiamato il famoso ispettore Rogas, poliziotto molto abile sul lavoro e che si porta dietro la fama di "letterato". Le indagini di Rogas lo porteranno sulle tracce di uomini condannati ingiustamente dai giudici assassinati, fino a indicargli come possibile colpevole un farmacista di nome Cres, incastrato dalla moglie e condannato a passare cinque anni in carcere per tentato omicidio. Un uomo innocente trasformato in carnefice dall'ingranaggio imperfetto della giustizia.
Molto presto, nelle indagini si inseriscono forze molto più potenti di un semplice ispettore di polizia, rivelando una strana situazione in cui si percepisce l'idea di un complotto, orchestrato da persone molto influenti e su scala nazionale, per mantenere il potere.
Rogas comincerà a interrogarsi su chi sono i buoni, chi i cattivi, e in base alla propria visione del mondo si muoverà in un contesto che si fa di momento in momento più pericoloso, anche per lui.
"E da questi quattro casi, che non lo interessavano direttamente, che non si situavano sulla linea della sua investigazione in quanto non coinvolgevano la malafede dei giudici ma, se mai, quella della polizia o dei testimoni, trasse la convinzione di quanto non fosse difficile, in fondo, distinguere anche sulle morte carte, nelle morte parole, la verità dalla menzogna; e che un qualsiasi fatto, una volta fermato nella parola scritta, ripetesse il problema che i professori ritengono s'appartenga soltanto all'arte, alla poesia."
Indicazioni utili
Quel tifone che è la vita
Conrad è uno di quegli autori che con me ha un rapporto controverso. Mi piace molto il suo modo di scrivere e credo sia un maestro soprattutto nel descrivere gli ambienti e gli avvenimenti che coinvolgono i protagonisti delle sue storie; tuttavia non riesce mai a colpirmi tanto da amarlo, nonostante riconosca in lui le potenzialità per farlo. È incredibile la capacità che ha di descrivere lo sconvolgersi degli eventi, dell’ambiente e dei protagonisti, che si trovano sballottati qua e là su una nave che viene devastata a poco a poco dalla forza irrefrenabile della natura.
Questo breve racconto si svolge per la maggior parte del tempo durante il tifone citato nel titolo, che travolge una nave diretta in una località cinese, se non ricordo male. Il capitano di questa nave non è altro che un uomo normale, taciturno, che non si è mai trovato ad affrontare una situazione di pericolo così importante quale può essere un tifone o una tempesta. I libri sull’argomento, inoltre, non gli sono di aiuto; perché una cosa è trovarsi di fronte al pericolo e un’altra è analizzarlo freddamente, dietro una scrivania. Oltretutto la natura è imprevedibile e mai uguale a sé stessa.
In certi tratti Conrad ci strapperà un sorriso amaro, mettendoci di fronte a vari affreschi di umanità: uomini che litigano per del denaro anche quando la loro vita è appesa a un filo, uomini che perdono totalmente la testa, ma anche uomini che riescono a mantenere l’integrità e la fiducia nel proprio capitano.
È evidente che dietro questo racconto si nasconda una metafora; che il tifone rappresenti un po’ quelle difficoltà della vita che ci sembrano insuperabili e devastanti. Eppure anche un uomo normale può trovare dentro di sé la forza per affrontarle e, alla fine, uscirne vincitore.
Un breve racconto che consiglio anche solo per ammirare la maestria dello scrittore.
"Jukes incoscientemente fu lieto di avere vicino il capitano. Ne era sollevato come se quell'uomo, colla sua sola comparsa in coperta, si fosse preso sulle spalle il peso maggiore della burrasca. Tale è il prestigio, il privilegio e il peso del comando. Da nessuno al mondo il capitano MacWhirr poteva attendere un simile sollievo. Tale è la solitudine del comando."
Indicazioni utili
Una piacevole sorpresa
C'è da premettere che non sono una persona che si scervella troppo sugli avvenimenti politici che avvolgono l'Italia. Certo, non provo molta simpatia né stima per le persone che attualmente guidano il Paese, persone che non si fanno il minimo problema a nascondere la propria ignoranza su determinati argomenti, spesso sparando giudizi o facendo proclami che non hanno alcun fondamento logico né che denoti una minima conoscenza di ciò di cui si parla; ma questo è un atteggiamento che mi urta indipendentemente dalla politica. Oltretutto, la disumanità che queste persone stanno dimostrando giorno dopo giorno non fa altro che rendere il quadro più squallido e preoccupante.
Questo libro si concentra proprio su questi aspetti, su qualcosa che oggi stiamo vivendo e toccando con mano, e credo lo faccia in maniera efficace, mettendoci in condizione di ridere ma anche di riflettere. Ci sono tantissimi rimandi alla nostra attualità: ci sono i "buonisti" e i "pietisti"; c'è la propaganda feroce e disinibita tramite social e l'offendere quel che non si può contrastare con la logica; c'è un Ministro dell'Interno amato dal popolino che ragiona con la pancia (chissà chi è); c'è un Italia che ormai si è disabituata a ragionare con la propria testa per seguire i propri istinti e coloro che questi istinti sanno scatenare.
Giacomo Papi si rivela una buona penna, con uno stile fluido e piacevole da leggere; ma credo proprio che i sostenitori di Salvini e company (ops, ho detto il nome, vabbè chissene) non apprezzeranno molto questa lettura. Chi ha un minimo di sale in zucca la apprezzerà o quantomeno saprà prenderla con un po' di filosofia.
Gli intellettuali sono le prossime vittime delle ire del governo e del popolo. Dopo gli immigrati, i rom e gli omosessuali è il turno di quelli che "si sentono più intelligenti degli altri": i radical chic.
La cultura è difficile, noiosa, complica le cose; dunque va eliminata.
Il primo a fare le spese di questa forma mentis è il professor Giovanni Prospero, insegnante che viene ucciso a suon di botte per aver citato Spinoza durante un talk show. L'assassinio di Prospero è soltanto l'inizio di quella che sarà una vera e propria soppressione della cultura, delle parole e dei concetti difficili che il popolo non può e non vuole comprendere. Dato che il popolino viene prima di tutto, queste cose vanno eliminate. Parte dunque una censimento degli intellettuali, che dovranno iscriversi a un programma di protezione (che sarà pagato di tasca loro, il popolo non deve cacciare un euro per i "diversi").
Giacomo Papi ci racconta una realtà scomoda e ai limiti del surreale, ma che al lettore accorto risulterà spaventosamente familiare. La non tanto velata citazione a Fahrenheit 451 fatta nelle ultime pagine (ti ho scoperto, Papi) è quasi un grido d'allarme, per farci comprendere che noi esseri umani non solo siamo capaci di ripetere gli stessi errori del passato, ma siamo in grado di farne anche di peggiori.
"Perché le emozioni sono facili, elementari. Se impari i trucchi, le puoi governare, mentre i pensieri rimangono liberi, vanno dove dicono loro e complicano le cose. Dove comanda la ragione, la statistica muore."
Indicazioni utili
Fantascienza filosofica
Dalla mia ancora breve carriera di lettore ho ricavato una certezza: i romanzi (ma sarebbe meglio dire le storie in generale) che sviscerano e trattano efficacemente temi filosofici sono quelli che apprezzo più di tutti. Le storie che ti portano a riflettere sul destino e sulla situazione degli esseri umani, anche nei suoi lati più oscuri, sono quelli che più mi avvincono e mi restano impressi. Non c’è da stupirsi dunque se leggendo la trama di “Solaris” ne sia rimasto quanto mai impressionato, aggiungendo alla curiosità che questa suscita anche il genere che gli viene attribuito, ovvero la “fantascienza filosofica”. Mi è venuto in mente “Cronache marziane”, ed ero quanto mai euforico.
Ho quindi acquistato questo libro carico di aspettative e non ho potuto attendere troppo prima di cominciare la lettura. C’è da dire che Stanislaw Lem è una penna davvero eccelsa e la storia che ha messo in piedi è davvero originalissima; tuttavia non è un’opera esente da difetti. Ci sono alcuni capitoli in cui ci si perde in lunghi dettagli sulla storia del pianeta Solaris, sulla storia degli studi che vi sono stati condotti e sulla sua morfologia; capitoli che da quanto ho capito erano stati per l’appunto tagliati nella prima traduzione inglese perché rallentavano la lettura. Non posso dar torto agli editori, in questo caso.
Oltretutto, credo che fosse una storia con potenzialità ancora maggiori e che i temi trattati non siano stati sviscerati al massimo, né con la migliore efficacia. Un libro dunque che promette più di quanto riesce a mantenere, pur mantenendo buoni meriti.
Fin dall’inizio della lettura ho avuto l’impressione che questo libro fosse perfetto per farne una trasposizione cinematografica e, difatti, ho scoperto che ne sono state fatte ben due, di cui la più recente ha come protagonista George Clooney. L’ho vista e, a parte i cambiamenti sostanziali alla trama e soprattutto al finale, credo non faccia particolare giustizia alla storia partorita da Lem. Magari il film girato negli anni ’70 sarà meglio, vedrò di recuperarlo.
La storia comincia con lo psicologo Chris Kelvin che approda sulla stazione che fluttua sulla superficie del pianeta Solaris: un pianeta che ruota intorno a due soli e si presenta sottoforma di uno sconfinato oceano plasmatico, che si modella autonomamente come se fosse dotato di una coscienza.
Si comprende fin dall’inizio che qualcosa nella Stazione non va: lo scienziato (Gibarian) che avrebbe dovuto accogliere Kelvin al suo arrivo viene trovato morto, e gli altri due sopravvissuti (Snaut e Sartorius) sembrano sulla soglia della pazzia. Nessuno vuole parlare o mettere Kelvin al corrente di quello che è successo, come se temessero qualcosa; come se temessero qualcuno.
Ben presto Kelvin si renderà conto che non sono soli, in quella Stazione.
Ben presto dei visitatori si paleseranno, sotto forma di persone a loro care ormai scomparse.
Cos’è Solaris, e cosa sta accadendo in quella stazione?
"[...] Ma rassegnarsi a essere un orologio misurante lo scorrere del tempo, alternativamente rotto e riparato e nel cui meccanismo, appena messo in moto dal costruttore, cominciavano a scorrere disperazione e amore? Accettare di essere una sorta di carillon meccanico che, a regolari intervalli, scandiva un tormento reso sempre più irrisorio dal suo continuo ripetersi? Un conto era ripercorrere l'esistenza umana, cosa in fondo accettabile, e un conto ripeterla come una tiritera suonata fino alla nausea da un ubriaco che infila sempre nuove monetine nella pianola meccanica."
Indicazioni utili
Di uno spessore non comune
Questo di Ayn Rand è un libro densissimo: denso di contenuti, di descrizioni, di avvenimenti. Forse troppo denso, troppo lungo e a volte ripetitivo; ma è davvero un grande libro. Considerata la duplice natura della scrittrice, era inevitabile che lo scritto avesse solidi fondamenti filosofici, che principalmente si soffermano sulla contrapposizione tra individualismo e collettivismo, con una evidente e forte propensione della Rand verso il primo concetto.
Il nostro protagonista infatti, Howard Roark (che a quanto si dice dalla trama è ispirato all’architetto Frank Lloyd Wright), incarna l’uomo ideale di Ayn Rand: un genio completamente individualista, per nulla disposto a scendere a compromessi, che porta avanti la sua idea e le sue convinzioni anche a costo di perdere tutto e di cadere in miseria materiale e “spirituale”. Intorno a lui, un mondo contrario a tutti quelli che sono i suoi ideali: un mondo conformista e tradizionalista, che rigetta l’ingegno e l’innovazione additandoli come prodotto di menti folli ed egoiste; un mondo di parassiti che hanno bisogno degli altri per vivere, che hanno bisogno della loro approvazione e che fanno dell’altruismo il proprio credo perché è ciò che gli permette di sopravvivere. Simbolo di questo mondo è un altro protagonista: Peter Keating; un uomo che fin da giovane ha bisogno del riconoscimento degli altri per essere felice, che non si rallegra dei risultati conseguiti per il risultato in sé, quanto per l’ammirazione generale. Un uomo che ha continuamente bisogno di conferme perché è un parassita e non un individuo indipendente.
Su questo continuo dualismo prosegue il romanzo, sviscerando gli appartenenti a l’una e all’altra fazione; alla fazione di Roark e alla fazione di Keating. In questo modo si susseguiranno una serie di personaggi memorabili: su tutti Gail Wynand ed Ellsworth Tookey, oltre ai protagonisti.
È difficile condensare in una recensione tutto quello che questo libro contiene, ed è difficile anche presentare una trama che possa rendere l’idea, ma ci provo: questo è un libro che ripercorre buona parte della vita di un genio individualista, Howard Roark, una vita che si presenta difficile fin dal suo principio, perché ha contro il mondo intero; del suo incontro con persone simili a lui e del suo amore con Dominique, una delle poche che riesce a comprendere la sua natura ma che è anch’essa una natura complessa. Come può essere l’amore risultante, se non tormentato e paradossale?
Ascesa e declino di un genio, non sorprendetevi se corrugherete la fronte molto spesso, durante la lettura di questo libro, ma posso dirvi che vale davvero la pena di leggerlo. Non posso non ammettere che poteva essere un po’ più breve, ma diciamo che il gioco vale la candela.
“Io sono qui per dire che non riconosco il diritto di nessuna persona su un singolo minuto della mia vita, né su una sola particella della mia energia. Io desidero dichiarare che sono un uomo che non esiste per gli altri.”
Indicazioni utili
Controverso in ogni suo aspetto
Questo è senza ombra di dubbio uno dei libri più difficili che mi sono ritrovato a recensire.
Non sono in grado di dire che sia un libro bello, né che sia brutto; non posso dire che sia coinvolgente, ma non posso neanche dire che sia una noia mortale. Gli argomenti? Interessanti, ma forse trattati in una maniera troppo oscurata dalla psicologia del nostro narratore, il protagonista, che si trova a descrivere una realtà e degli eventi controversi filtrati dalla sua mente, che controversa lo è altrettanto. Ne viene fuori un romanzo piuttosto contorto, allucinatorio: in certi tratti si fa fatica a capire se ci venga presentata la realtà o l'immaginazione del protagonista: queste due cose si fondono in una massa indistinta che, se ben compresa, può rivelare la maestria dell'autore. Nel mio caso, tuttavia, mi sono ritrovato spiazzato, confuso, incapace di discernere i pensieri e le riflessioni del protagonista per lunghi tratti.
Per quanto mi riguarda l'argomento era anche interessante, ma forse sviscerato in un modo troppo particolare, che si adatta troppo alla psiche del protagonista e che perde della sua universalità. Certo, non mancano le riflessioni sul presente e sul futuro dell'umanità, della tecnologia; non mancano i momenti in cui la nostra mente si affolla di domande riguardo una possibile eternità. Tuttavia... la curiosa visione del mondo del protagonista è stata troppo "inquinante" e ha smorzato un po' il mio interesse. Il protagonista è infatti un uomo profondamente segnato dal suo passato, dall'abbandono di suo padre, e sicuramente portatore di qualche (seppur non troppo accentuato) disturbo mentale e dunque, nella narrazione, molto "invadente".
Una delle cose che, tuttavia, sono stato in grado di carpire è la bravura dell'autore: nonostante il libro non mi abbia entusiasmato, la scrittura di DeLillo mi ha incuriosito e ha fatto nascere in me la voglia di leggere altro, ché dal mio punto di vista l'autore nasconde un buon potenziale per piacermi, e anche tanto. Una cosa simile mi accadde alla lettura de "La strada" che, pur non facendomi impazzire (alla prima lettura) fece nascere in me la curiosità di approfondire McCarthy, che alla fine è diventato il mio autore preferito.
Ross Lockhart è un uomo ricco che un bel giorno della sua vita ha conosciuto l'amore: quello vero, quello che ti porta a rinunciare a tutto il resto per potertici dedicare anima e corpo. Anima e corpo; corpo e anima. Il nome della donna è Artis, una donna che non è la madre del protagonista ma per la quale quest'ultimo prova una profonda ammirazione. Tutto può sembrare bello e felice, se non fosse che conosciamo questa donna quando è già in preda a malattie degenerative, che le danno solo pochi anni di sopravvivenza. A questo punto, gli sforzi economici di Lockhart si concentrano su Convergence, un'azienda tecnologica che sembra aver trovato il modo di criogenizzare i corpi degli uomini e preservarne le coscienze (forse), fino a quando le nanotecnologie non saranno in grado di sanare le malattie e ringiovanire il corpo. A quel punto, gli uomini saranno pronti per il risveglio in un futuro in cui si potrà vivere eternamente.
È questo il procedimento cui si sottoporrà Artis e Ross Lockhart, incapace di vivere senza di lei, pur non soffrendo di gravi malattie sembra voler decidere di mettere in "stand-by" la sua vita, in modo da non vivere neanche un minuto senza l'amore della sua vita.
Spettatore di questa realtà e di queste convinzioni grottesche, fredde e asettiche sarà il nostro protagonista, che si dibatterà tra quel che è e quel che potrebbe essere; tra il vivere il momento qualsiasi esso sia e attendere tempi migliori; tra presente e futuro.
"È nella natura umana voler sapere di più, sempre di più, sempre di più. Ma è anche vero che quello che non sappiamo ci rende umani. E quello che non sappiamo non ha fine."
L'importanza dello stile
"Giro di vite" è sicuramente un romanzo particolare, il cui valore è aumentato notevolmente dallo stile di Henry James. L'autore ha tra i suoi pregi principali le descrizioni precise degli ambienti, che quasi bucano le pagine, e una capacità fuori dal comune di suscitare dubbi e sospetti, permettendo al lettore di sentirsi parte del racconto. Devo tuttavia dire che questa storia non mi ha esaltato: credo che se non fosse per la maestria dell'autore nel rendere viva la sua ambientazione e nel risvegliare le emozioni facendoci immaginare quel contesto cupo, mi sarei ritrovato a leggere un racconto più che normale.
Dunque non è stato "Giro di vite" a fare la fortuna di Henry James, bensì Henry James a fare la fortuna di questo libro.
Una cosa che tuttavia non ho capito molto è l'introduzione: che senso ha presentarci quel conciliabolo di persone a cui viene raccontata la storia, se poi quando questa inizia il narratore è la nostra protagonista in prima persona? Avrebbe avuto senso se, con qualche intermezzo, ci venissero presentati i pensieri degli ascoltatori, o quantomeno un epilogo che ci illustrasse le loro reazioni finali; invece li abbandoniamo fin dal principio e nella storia non trovano la benché minima utilità narrativa. Mi è parsa una cosa piuttosto strana.
Non mi linciate, si tratta sempre e comunque di una mia personalissima opinione totalmente confutabile.
Un uomo molto ricco si ritrova improvvisamente tutore di due ragazzini: Miles e Flora, figli del suo defunto fratello. Essendo un uomo molto impegnato, tuttavia, non può (e non vuole) star dietro ai due pargoli; perciò assume una giovane donna che gli faccia da istitutrice. L'uomo le offre uno stipendio più che generoso, ma le impone un'inviolabile condizione: non dovrà disturbarlo o contattarlo per nessun motivo, per quanto grave possa essere la situazione. (Piccola parentesi: questa mi è parsa una grossa forzatura).
L'istitutrice sarà la nostra narratrice e protagonista in prima persona degli strani eventi che si susseguiranno nella casa di campagna in cui vivrà insieme ai bambini e alla servitù.
Le stranezze si presentano fin dal principio, con l'arrivo di una lettera dal collegio di Miles: il ragazzino è stato espulso per cattiva condotta, seppur non vengano specificati i motivi precisi che hanno portato a questa drastica decisione. Avendo avuto modo di conoscere Miles e sua sorella, l'istitutrice non riesce a spiegarsi come un ragazzino dall'aria così educata, quasi angelica, possa aver fatto qualcosa di così grave da meritarsi l'espulsione.
Tuttavia, questa sarà soltanto la più futile delle stranezze che si troverà di fronte durante il suo impiego in quella casa.
Uomini/gabbiani
Un breve sguardo agli uomini, ma con gli occhi di un gabbiano.
Questo può essere il più breve riassunto con cui identificare questo libro; un libro che ha venduto milioni e milioni di copie e ancora consigliatissimo tra le schiere di lettori. Posso dire che, pur apprezzando alcuni dei messaggi che l’opera vuole trasmettere e provando in certi tratti una profonda tenerezza per questi gabbiani così simili a uomini, non l’ho trovata una storia davvero indimenticabile. Non saprei spiegarvi i motivi precisi, ma l’ho trovato un libro che volesse avere l’ambizione di essere simile a “Il piccolo principe”: breve, semplice ma densissimo di significato; tuttavia, non riesce a raggiungere la sua potenza.
Questa storia può dare sicuramente qualche spunto di riflessione, principalmente per quanto riguarda l’essere diversi nel senso di perseguire uno scopo bello e nobile, anche se quest’ultimo è lontano dalla comprensione delle masse; anche se perseguire questo scopo può portare all’emarginazione, alla solitudine. L’ultima parte rappresenta anche una satira amara alla spiritualità ormai perduta degli esseri umani, che non vogliono sentir parlare di Dio oppure, se ci credono, spesso si limitano a rivolgergli delle lodi meccaniche delle quali non capiscono più i motivi.
Il Gabbiano Jonathan Livingston è diverso dagli altri gabbiani dello Stormo. Tutti credono che i gabbiani siano al mondo solo per nutrirsi e tenersi in vita e che il volo sia soltanto un mezzo per perseguire questo scopo. Jonathan la pensa molto diversamente: secondo lui un gabbiano è nato per volare e solo nel volo può trovare la vera felicità. Dunque, giorno dopo giorno si esercita nella disciplina del volo: impara il controllo, impara a volare più veloce di qualsiasi gabbiano abbia mai vissuto su questa Terra; peccato che tutti gli altri gabbiani lo ritengano un pazzo, compresi i suoi genitori, che gli intimano continuamente di lasciar perdere questa sciocchezza del volo e fare quello per cui è venuto al mondo: procurarsi il cibo. Ma l’idea delle masse non può che far vacillare Jonathan soltanto per un momento; proverà a vivere come tutti gli altri gabbiani ma si renderà subito conto che quella vita non fa per lui, che non lo rende felice; che lui è nato per volare e per insegnare agli altri gabbiani che possono avere un obiettivo più nobile da perseguire nella vita. Queste convinzioni gli costeranno care, lo renderanno un Reietto per lo Stormo, ma la cosa fondamentale per Jonathan è non essere un reietto per sé stesso, non rinnegare mai l’unica cosa che può renderlo felice, costi quel che costi.
Magari, un giorno, gli altri capiranno.
“Il gabbiano Jonathan scoprì che la noia e la paura e la rabbia sono le ragioni per cui una vita gabbiano è così breve, e quando quelle furono svanite dai suoi pensieri visse una vita lunga e bella.”
Indicazioni utili
| 447 risultati - visualizzati 151 - 200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |