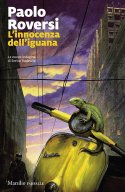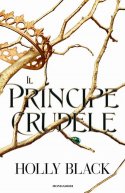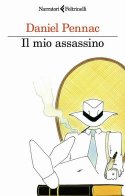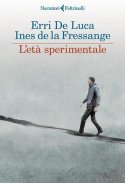Opinione scritta da Renzo Montagnoli
| 1070 risultati - visualizzati 101 - 150 | « 1 2 3 4 5 6 ... 7 22 » |
Alla ricerca di se stesso
L’ombra delle colline potrebbe sembrare, di primo acchito, un romanzo che parla delle inquietudini e della disillusione di un giovane che ha vissuto, quando era ancora poco più di un bambino, la dura e crudele lotta partigiana. Nel viaggio che, attraverso l’Italia riporta Stefano, a guerra ormai finita da tempo, al natio Piemonte in fondo per ritrovare se stesso, si innesta la memoria di quel periodo da adolescente che lo ha così condizionato, soprattutto per un episodio, ricorrente nei suoi incubi notturni, in cui quasi per gioco uccide un tedesco con la rivoltella sottratta al padre, colonnello dell’esercito che ha vissuto l’8 settembre 1943 come il giorno del crollo di ogni certezza. Nel viaggio è accompagnato dalla sua ragazza, Laura, Lu, con cui è instaurato uno strano rapporto, poiché lui è naturalmente portato a non fidarsi.
Come credo sia possibile capire per ogni lettore abituato a fare riflessioni pagina dopo pagina, questo viaggio è certamente geografico, ma soprattutto intimo, è una ricerca di se stesso, è il tentativo di metabolizzare il passato per poter continuare una vita senza l’oppressione di colpe vere o presunte. Il tema non è certo facile da svolgere, perché presuppone una capacità di analisi introspettiva di particolare difficoltà, tanto più che si tratta di esporla in modo da renderla comprensibile ai più. Lo stile è asciutto e questo aiuta non poco; tuttavia, pur riconoscendo ad Arpino indubbie qualità, il tentativo è solo in parte riuscito. Grande merito, invece, gli deve essere attribuito per la descrizione di quel senso di spaesamento che prese gli italiani l’indomani dell’8 settembre, con il crollo di ataviche certezze così ben esposto nel caso del padre colonnello e con le difficoltà di una scelta consapevole fra andare in montagna e combattere i tedeschi, o aderire alla Repubblica Sociale Italiana, tanto è vero che Stefano, mentendo sulla sua età, prima indossa la camicia nera, poi passa ai partigiani soprattutto perché fra questi c’è l’amico d’infanzia Francesco.
Ci troviamo quindi di fronte a un’opera di particolare e rilevante impegno che si presta a diverse interpretazioni, ma quella principale, vale a dire la perdita del senso del tempo, fatto di tanti quadri non combacianti, slegati fra loro, propri di chi è stato catapultato dall’adolescenza alla drammatica realtà di una guerra civile, è solo in parte comprensibile e accettabile nella sua esposizione. Ciò non toglie che L’ombra delle colline sia meritevole di essere letto e proprio per questo mi sento di consigliarlo.
Indicazioni utili
Un Maigret sotto tono
Ho notato che quando Maigret ha a che fare con la malavita perde molto del suo smalto, perché è come se Simenon dimenticasse la sua caratteristica di essere un acuto analizzatore della psiche umana. E’ indubbio che l’autore belga dia il meglio di se stesso quando le sue storie avvengono in provincia, in località che presentano tutte le caratteristiche di un mondo chiuso. Anche Maigret e l’informatore non sfugge alla statistica e ne esce un poliziesco che presenta anche il difetto di far conoscere anzitempo al lettore il nome dell’assassino e pertanto l’indagine si estrinseca esclusivamente nella ricerca delle prove per incastrarlo, ricerca invero un po’ faraginosa e non del tutto supportata dalla logica. Inoltre i gangster sono i malavitosi che ben conosciamo e che sembrano prodotti di una unica fattrice e, come se non bastasse, è presente il classico triangolo amoroso, alla base di tanti delitti, fra in quali anche questo. In buona sostanza Simenon nel romanzo privilegia l’intreccio, tuttavia un po’ debole, e si dimentica di tutte quelle caratteristiche che hanno fatto di lui quel grande scrittore a tutti ben noto. Per esempio c’è la ricerca di un individuo che si sviluppa a Parigi fino a Montmartre e questa sarebbe stata l’occasione per descrivere il quartiere degli artisti non come da cartolina, ma l’occasione non è stata colta; sì, Maigret si agita, si muove, in auto e addirittura in aereo, ma è un protagonista sotto tono, un commissario quasi anonimo, senza quei guizzi di umanità che così spesso lo contraddistinguono. Il libro si legge, certo, ma la delusione non è poca e così anche questo viene cassato fra quelli non riusciti di Simenon, pochi per fortuna in verità.
Indicazioni utili
- sì
- no
Non tutto è perduto
Nelle ultime pagine del libro c’è una nota dell’autore, unitamente ai ringraziamenti, che a mio parere meriterebbe di essere visionata prima di procedere alla lettura del romanzo vero e proprio. Cosa dice in pratica Guido Cervo? Parla delle difficoltà di scrivere un’opera avente per tema la tragica vicenda di Caporetto, il che giustifica la poca narrativa al riguardo, mentre invece, pur non molta, ma comunque di discreta entità sono la saggistica e la memorialistica; in effetti la ritirata dell’esercito italiano dalle posizioni dell’Isonzo, avvenuta per la quasi totalità dell’evento in modo disordinato, perché si trattò di una vera e propria rotta, si è concretizzata in un numero piuttosto rilevante di episodi, di atti di eroismo, in alcuni casi di viltà che non potendo essere descritti tutti possono falsare la visione d’insieme. Aggiungo poi, e questa è una mia opinione, che c’è una naturale ritrosia ad affondare il bisturi in una ferita che, a distanza di un secolo, se non ancora viva, risulta però sempre bruciante. Al di là delle difficoltà oggettive e soggettive Cervo, con questa sua opera, è riuscito nell’intento di far conoscere al lettore quel tragico evento, con una prosa asciutta, per nulla retorica e scegliendo di privilegiare, pur senza trascurarne altre, due vicende con dei protagonisti azzeccati che destano immediata simpatia. Troviamo così la giovane e graziosa maestra Ersilia, vedova di guerra, che nella fuga da Udine prossima a essere occupata dagli austriaci si lega e si accompagna ad Anita, una bimba del locale brefotrofio. E’ una vera e propria odissea, sotto la pioggia incessante, con presente sempre la fame e in cui si fanno tanti incontri, fra cui uno con un tenente degli arditi che lascia sperare che possa aver un seguito di natura sentimentale. L’altro protagonista è un sergente, Tarcisio, un contadino bergamasco, pure lui in fuga con alcuni soldati del suo reparto. Anche qui pioggia a catinelle e tanta fame, a cui si aggiungono frequenti scontri con un nemico incalzante (a proposito, molto belle sono le pagine in cui si descrivono i fatti bellici). L’obiettivo per i soldati in rotta e per i civili in fuga è il fiume Tagliamento e i suoi ponti, per passare dall’altra parte, certi che il corso d’acqua sarà una difesa naturale (sappiamo che poi invece si dovette arretrare fino al Piave, peraltro meglio difendibile). E in prossimità di uno di questi ponti le vicende di Ersilia e di Tarcisio si incroceranno, anche se per pochissimo tempo in quelle che sono le pagine più toccanti del romanzo, che stempera la tensione del lettore in vera e propria commozione. Non aggiungo altro, il libro mi è piaciuto molto perché l’autore non si limita alle sole vicende vere e proprie, ma tenacemente, pagina dopo pagina, lancia un sincero messaggio di pace, che senza essere urlato, entra piano piano nei nostri cuori, perché in fondo le storie di Ersilia e di Tarcisio, due persone del tutto normali, ma nel loro piccolo autentici eroi, sono la ragione e l’amore che prevalgono sull’insensatezza e sulla ferocia.
Da leggere, pertanto.
Indicazioni utili
L’ultimo anno della Belle Époque
Il 1913 è l’anno che precede quello dello scoppio del primo conflitto mondiale ed è anche l’anno in cui finisce la Belle Époque, quel periodo di inebriante vivacità in cui tutto sembrava possibile e che sarà spazzato via dalla Grande Guerra. Florian Illies, un giovane storico dell’arte tedesco, ha voluto ripercorrere il 1913 dal primo gennaio al 31 dicembre, elencando, in ordine cronologico (l’opera è divisa in tanti capitoli quanti sono i mesi) vicende, notizie, anche chiacchiere che si susseguono, soprattutto in Europa, e che hanno come protagonisti artisti, letterati e scienziati. Ci sono personaggi dall’improvvisa ed effimera apparizione e altri invece che l’autore seguirà per tutto l’anno, in un turbine, peraltro ben ordinato, di accadimenti anche di modesta rilevanza, ma che sono utili per comprendere meglio il carattere di chi ne è parte. Se l’aspetto storico è predominante, ciò non evita di lasciare spazio a una innocente fantasia e che vuole essere anche tale nelle intenzioni di Illies, come quando lancia l’ipotesi che Stalin e Hitler, entrambi presenti a Vienna in quel periodo e amanti di lunghe passeggiate al parco di Schönbrunn abbiano avuto magari l’opportunità di incrociare i loro passi, in pratica di vedersi, proprio loro protagonisti e nemici nella storia del secondo ventennio del secolo scorso. Sono tanti i personaggi che si affacciano sulla scena e del resto non si deve dimenticare che la Belle Epoque fu un periodo proficuo per le arti e per la scienza e così sul palcoscenico si affacciano Freud perennemente in lite con Jung, il timido Franz Kafka, uno scrittore che scopre una sua naturale inclinazione sessuale, vale a dire Thomas Mann, uno spiantato irlandese che vive dando lezioni di inglese a Trieste e che risponde al nome di James Joyce, Robert Musil, che perde il posto da bibliotecario per un accertato disturbo mentale, ma che così avrà tanto tempo a disposizione per poter scrivere “L’uomo senza qualità”, Gabriele D’annunzio, in perenne fuga in quanto inseguito dai creditori, e una miriade di artisti, di intellettuali che qui sarebbe impossibile anche solo nominare. Gli episodi, gli aneddoti sono innumerevoli e hanno il pregio di essere descritti dall’autore con leggerezza e ironia, il che rende la lettura per nulla affaticante e particolarmente gradevole. Si potrebbe anche dire che Illies mescola abilmente il sacro al profano, arte e pettegolezzi salottieri, grande storia e particolari di miserie vissute da grandi protagonisti del secolo nel bene e nel male. Ne esce un campionario di varia umanità, capace di far rivivere un’epoca, anzi la Bella Epoca, quella che da lì a poco, nel corso dell’anno successivo si sfalderà con le prime carneficine sui fronti occidentale e orientale, con quella tempesta di fuoco e di acciaio che strapperà le illusioni dell’umanità, richiamandola brutalmente a una realtà di lacrime e sangue.
Ci si domanda solo se il 1913 sia stato un anno particolare, un anno da ricordare per qualche cosa di eccezionale e la risposta è che fu solo l’anno prima della tempesta, l’ultimo anno della Belle Époque .
Da leggere, ne vale la pena.
Indicazioni utili
Tutto ebbe inizio con i telai
Corre l’anno 1930 quando un pomeriggio di un freddo gennaio scendono alla stazione di Bellano sei uomini, vestiti poveramente e con la barba lunga, lì convocati per montare una linea di telai elettrici del cotonificio. E’ un periodo di crisi e la proprietà, per contenere i costi, non trova di meglio che procedere a una parziale automazione che però comporterà il licenziamento di una ottantina di dipendenti. Da quell’arrivo di un campionario umano tipico del sottoproletariato di cui fa parte anche un giovante prestante dal nome famigerato di Landru Angelici, non certamente un assassino, ma nemmeno uno stinco di santo, nasce un’intricata vicenda in cui Vitali si butta a capofitto, muovendo pedine e incastri, tutti direttamente o indirettamente collegati al cotonificio. Il direttore dello stabilimento, il competente e umano ing. Galimberti, la sua impeccabile e desiderabile segretaria Emilia Personnini, il capostazione e confidente dei carabinieri Amedeo Musante, la bella e astuta Mirandola Gilardoni, il segretario del locale fascio Aurelio Pasta, tanto intraprendente quanto facile agli smacchi, Eumeo Pennati, fascista con non nascoste mire di prendere il posto di Pasta, il buon parroco Don Ascani – tanto per citare i personaggi almeno più importanti del romanzo, ma ne ve sono molti altri in veste di comprimari – si agitano, in verità ben diretti da quell’abile burattinaio che è Andrea Vitali e che sembra divertirsi nel proporre continuamente nuovi inserimenti, nuove vicende nell’ambito di quella originaria della famosa installazione dei telai che non avverrà mai e non vado oltre. Spasimi d’amore, più o meno ricambiati, screzi, vecchie rivalità, piccinerie di una piccola realtà come Bellano, ma che assumono generali caratteristiche di un popolo che da sempre sembra vivere alla giornata sono il companatico di questo racconto, che presenta talmente tanti spunti che un altro autore, invece di scrivere un solo romanzo, probabilmente ne avrebbe stilati almeno due. E del resto sono 370 pagine, non certo poche, ma che si leggono, se non proprio d’un fiato, comunque alla svelta, soprattutto per la curiosità di sapere come verrà sbrogliato il nodo di tanti gomitoli. E’ ovvio che tutto finirà per aggiustarsi, anche per il contributo, del tutto involontario, di Landru. Il romanzo si chiude il giorno dopo dell’avvenuta liberazione, in cui già i fascisti si sono abilmente riciclati con un veloce cambio di camicia, da nera a rossa, facendo così venire in mente l’insegnamento del Gattopardo, e cioè che da noi tutto cambia per ritornare poi sempre uguale.
Da leggere, anche per trascorrere gradevolmente alcune ore.
Indicazioni utili
Un pacifismo non di maniera
Educazione europea è il romanzo con cui ha esordito nel 1945 Romain Gary, dopo l’esperienza bellica come aviatore della Francia libera e nel corso della quale si meritò la Legion d’Onore. Dunque ci troviamo di fronte a un eroe di guerra che scrive una storia di guerra finalizzata però a un pacifismo non di maniera. Gary racconta le vicende di un gruppo di partigiani polacchi assillati dalla fame e dal freddo, oltre che dalla crudele e sempre presente repressione nazista. Fra questi il personaggio di primo piano è Janek, un ragazzino che ha già perso i fratelli, e che perderà anche il padre, strappato troppo presto alle fantasie di una gioventù e precipitato nel baratro della violenza e dell’orrore, in una serie di esperienze in cui apprende che gli uomini hanno due facce, che se c’è il tradimento ci può anche essere l’altruismo, che se c’è l’odio può esserci anche l’amore. Così la sua maturazione, il passaggio dall’età della pubertà a quella adulta avverrà in brevissimo tempo, durante il quale tuttavia apprenderà l’autentico significato della parola libertà e nascerà in lui la speranza per un mondo migliore, per un’Europa unita e pacifica. Dopo due lunghi, interminabili inverni di fame e di freddo, dopo aver visto morire tanti compagni, dopo avere avuto l’orrore e la necessità di uccidere Janek fa il conto di quell’esperienza con queste semplici parole, che tuttavia sono stilettate nell’animo di chi legge: “In Europa abbiamo le cattedrali più antiche, le più vecchie e celebri università, le più grandi biblioteche, ed è qui che si riceve l’educazione migliore, sembra che vengano in Europa da tutti gli angoli del mondo per istruirsi. Ma alla fine, quel che ti insegna tutta questa famosa educazione europea è come trovare il coraggio e delle buone ragioni, valide e convenienti, per ammazzare un uomo che non ti ha fatto nulla e che se ne sta seduto sul ghiaccio a testa china, ad aspettare la fine”.
Sinceramente il nome di Romain Gary non mi diceva niente fino a quando mi sono imbattuto in un suo romanzo, Gli aquiloni; si è trattato di un’autentica scoperta, l’opera mi è piaciuta moltissimo, così ho voluto leggere qualcosa d’altro, soprattutto questo Educazione europea che mi è stato consigliato da un’amica. Aveva ragione a dirmi che era qualcosa di straordinario, quasi di indescrivibile, tanto le era piaciuto; concordo pienamente con quel giudizio, perché difficilmente ci si può imbattere in un’opera in cui la cruda e tragica realtà e la purezza dell’animo convivono sullo stesso piano, in cui è possibile verificare come in ogni uomo sia presente il male e il bene, ma senza condannarlo definitivamente e senza appello se prevale il primo, perché basta spesso poco perché quel buio che è dentro possa essere rischiarato dalla limpida luce di un umano sentimento.
Indicazioni utili
Oggi come ieri
Il romanzo è ambientato a Bellano nel ventennio, ma per certe sue caratteristiche è senz’altro attuale in una provincia che, ampliata al quadro nazionale, evidenzia vizi (molti) e virtù (poche). Si deve dare atto a Vitali che, senza scrivere opere di grandissimo pregio, riesce ad avvincere il lettore come pochi autori sanno fare, tanto che i suoi libri, come le droghe, finiscono con il creare dipendenza e io stesso, benché scettico agli inizi, ne sono la prova. Sarà per la sua abilità nel congegnare una commedia degli equivoci, sarà per la sua fantasia, che sembra non avere limiti, ma sta di fatto che una volta preso in mano un suo libro è difficile staccarsene. In questo La figlia del podestà accade di tutto: un matrimonio in cui, al momento della domanda di rito, anziché sillabare il fatidico “sì” la sposina pronuncia un laconico “no” , il testimone dello sposo che, dopo un po’ di tempo, impalma la fanciulla che aveva così impedito la cerimonia, il figlio di loro due che si innamora della figlia del podestà (che altri non è se non lo sposo del matrimonio andato in fumo), il podestà stesso che briga per un colossale affare (una linea di idrovolanti per collegare alcuni paesi del lago) che si rivelerà una truffa, insomma un’Italia in miniatura, tale e quale doveva essere all’epoca il nostro paese e come è anche adesso. Se a volte ho imputato a Vitali una mancanza di coraggio per non aver colto occasioni per una satira, limitandosi al più a una bonaria ironia, con questo romanzo e, almeno limitatamente allo stesso, mi devo ricredere. La figura del podestà, del politico fascista tronfio, abituato a essere obbedito, con la naturale inclinazione a far ciò che torna gradito senza porsi tante remore è disegnata in modo perfetto e assomiglia tanto a non pochi politicanti del giorno d’oggi. Insomma, da qualsiasi lato lo si voglia vedere, sotto tutti i piani di lettura, La figlia del podestà avvince e diverte e soprattutto nei trascorsi giorni di tempo pessimo ha rappresentato per me un eccellente mezzo di svago.
Indicazioni utili
Processo alla diversità
Essere diversi ha sempre comportato una serie di svantaggi, di cui il principale è senza dubbio l’emarginazione, la cosiddetta morte civile, ma in passato, complice anche una distorta morale religiosa che non riusciva ad ammettere che ci potessero essere individui al di fuori della norma per quanto attiene l’inclinazione sessuale, la morte non era solo l’isolamento individuale, ma poteva anche essere fisica, con la condanna al rogo per il reato di sodomia. Di questo e di un fatto accaduto veramente ci parla Marco Salvador con la consueta precisione storica, non disgiunta da un umano senso di pietà, in questo Processo a Rolandina, pubblicato da una una piccola, ma dinamica e competente casa editrice, Fernandel. L’autore, basandosi sugli atti del processo, ci narra la vicenda accaduta nel lontano 1353 a Venezia e di cui protagonista e vittima è un transessuale, tale Rolandino Roncaglia, più conosciuto come Rolandina, che di giorno vive a stento vendendo uova e alla sera si prostituisce facendo intendere d’essere donna, atteggiamento che gli riesce con facilità, alla luce dei tratti fisici, della voce e delle movenze che sono proprie di una femmina. Nel segreto dell’alcova, poi, con vari artifici vede di soddisfare i clienti in modo che gli stessi continuino a credere di avere a che fare con una donna. L’implacabile giustizia di Venezia, forte con i poveri diavoli e benevola con i nobili, non si lascia scappare l’occasione per imbastire un processo per sodomia, che prevede una condanna con un supplizio feroce che si conclude con la morte fra le fiamme del rogo. Rolandina forse potrebbe salvarsi facendo i nomi dei clienti, passibili di condanna per lo stesso reato, ma non lo fa e allora è il tribunale che cerca di conoscerli in altro modo e tutto ancora non sarebbe perduto se non emergessero fra i frequentatori dei nobili influenti, fra cui un figlio del Doge. Occorre allora mettere tutto a tacere e l’unico modo di farlo è sopprimendo il soggetto più debole, cioè Rolandina.
La penna di Salvador, come sempre, descrive in modo perfetto l’ambiente, i calli sporchi e puzzolenti, i bordelli dove consumano le loro esistenze le prostitute, il clima di continuo sospetto tipico della Repubblica di Venezia, la sventura di un individuo nato anagraficamente maschio, ma che psicologicamente e anche in parte anatomicamente è femmina, una doppia identità a cui ha cercato invano di sfuggire con un matrimonio giovanile non consumato.
La vicenda di Rolandina è una storia triste, di dolore, di sopraffazione, di ricerca di una propria identità che avrà termine solo fra le fiamme del supplizio, una storia antica, ma che, per certi aspetti, presenta caratteristiche di attualità. Sì, certo al giorno d’oggi i transgender non hanno paura di finire sul rogo, sono anche legalmente presenti, ma accettarli senza remore, come fatti naturali non è ancora pratica diffusa, così che in effetti c’è una emarginazione, meno evidente che in passato, ma esiste, è lì che sta a ricordare a questi diversi la loro differenza, una pregiudiziale tale da condizionare tutta una vita.
La lettura di Processo a Rolandina è quindi senz’altro consigliata.
Indicazioni utili
Contento il morto, contento il lettore
Per Vitali aver abbandonato per la sua narrazione il periodo del “ventennio” per inventare una storia datata circa un secolo prima deve essere stato quasi un trauma, ma, ciò nonostante, i risultati sono stati più che positivi. Bellano in piena dominazione austriaca (ma del periodo asburgico si ha solo un vago sentore) è sempre il ridente paesino che si affaccia sul lago di Como, uno specchio d’acqua questa volta traditore, visto che imprudentemente vi si avventurano con una barca il figlio dell’uomo più ricco del paese in compagnia di un giovane milanese, unico rampollo di un ingegnere dell’Alto Adige. La giornata sembra propizia per una gita, vista la calma piatta, ma c’è chi, appassionato di meteorologia e presente al molo per caso, è quasi certo di un prossimo e improvviso cambiamento del tempo, con vento forte, anzi fortissimo. Cerca di dissuadere i due giovani, ma si sa che a quell’età poco si ascoltano quelli un poco più in là con gli anni e così partono per quello che sarà il loro ultimo viaggio. Questo potrebbe essere definito l’antefatto perché la storia vera, la trama avvincente comincia lì ed è una di quelle narrazioni in cui Andrea Vitali pare divertirsi, quasi fosse partecipe della vicenda e forse con la non recondita intenzione di rendere tale anche il lettore. Così ci troviamo di fronte a un campionario di varia umanità che finisce con il rappresentare gli emblemi della società, personaggi pennellati, descritti una volta tanto con dovizia, curando perfino una certa analisi psicologica. La descrizione del paesaggio e la riproduzione di certe atmosfere sono già qualità innegabili dell’autore e così poco a poco, pagina dopo pagina si sviluppa una storia allettante, perché con quel titolo si è desiderosi di sapere come andrà a finire, che sorprese ci saranno riservate. E Vitali non delude, è capace di far stare sulle corde chi ha gli occhi incollati alle pagine, strappando di tanto in tanto ben più di un sorriso.
Insomma, La leggenda del morto contento mi è piaciuto, anche perché, a differenza di altri romanzi dell’autore comasco, mi è rimasto dentro qualcosa, c’è una morale perseguita fin dall’inizio e che dimostra che passano i secoli, cambiano gli amministratori degli stati, ma l’animo umano è cristallizzato dalle origini e che la ricerca del proprio tornaconto prevale sempre su tutto.
Indicazioni utili
La Campagna d’Italia degli Anglo-americani
Nel corso della seconda guerra mondiale gli alleati sbarcarono in Sicilia il 10 luglio 1943, prima indispensabile fase dell’operazione Husky e che segnò l’inizio della Campagna d’Italia, una vera e propria invasione che avrebbe portato gli angloamericani, risalendo la penisola, alla completa conquista del nostro paese, con la resa delle truppe tedesche avvenuta formalmente il 29 aprile 1945. Si trattò quindi di ben ventidue mesi di battaglie cruente con inevitabili ripercussioni sulla popolazione civile, già stremata da una guerra che ci aveva visto sempre in estrema difficoltà. Peraltro, ad aggravare situazione, dopo l’armistizio italiano dell’8 settembre 1943 ci fu la pesante occupazione tedesca e la nascita della Repubblica Sociale Italiana che diede l’avvio a una crudele e sanguinosa guerra civile. Se è indubbio che il fronte italico era da considerarsi secondario nell’ottica del grande sbarco preparato e poi realizzato in Normandia, e che quindi le truppe alleate impegnate nello stivale non erano né particolarmente consistenti, né di rilevante qualità, fatte salve alcune divisioni, non si trovano giustificazioni logiche per un così lungo periodo di combattimenti, se non in due aspetti che possono ben spiegare la circostanza: il comandante tedesco, il maresciallo Albert Kesserling, riuscì, con notevole abilità, a ritardare l’avanzata alleata, nonché a contrastare efficacemente le due operazioni di sbarco, la prima nel golfo di Salerno, la seconda ad Anzio; contro un simile avversario i comandanti dei corpi di spedizione americano e inglese, rispettivamente i generali Mark Ckark e Harold Alexander (quest’ultimo responsabile delle operazioni), pur di capacità non inferiori e con mezzi senz’altro superiori, mostrarono ampie carenze dovute soprattutto alla rivalità esistente fra di loro. Per spiegare quanto di negativo abbia comportato la litigiosità fra i comandanti alleati basta ricordare che Clark venne meno all’incarico ricevuto nell’ambito del grande attacco alle linee tedesche imperniate su Cassino solo per arrivare primo a Roma, impedendo così l’accerchiamento di una rilevante entità delle forze nemiche. Comunque vi furono anche errori involontari, ma indubbiamente assai perniciosi, come quello, una volta sbarcati ad Anzio, di non procedere celermente verso l’interno, attesa l’assenza di tedeschi, ai quali fu lasciato tutto il tempo necessario per organizzarsi e intervenire.
Purtroppo, la guerra, che è già un’orrenda realtà, è fatta dagli uomini e quando i capi di questi non sono adeguati, oppure non vanno d’accordo, inevitabilmente se ne pagano le conseguenze, conseguenze che si tradussero in grosse perdite degli alleati e nelle migliaia di vittime della popolazione civile.
Il saggio storico di Gianni Rocca parla appunto di questa invasione, del lento progredire dell’avanzata alleata, delle sofferenze degli italiani che si accentuarono indicando eventi, personaggi, cause, conseguenze. Si tratta di uno dei periodi più tragici della nostra storia che i giovani oggi sovente non conoscono e di cui invece dovrebbero essere resi edotti, perché il nostro cammino verso la libertà non fu una passeggiata, fu un percorso di lacrime e sangue.
Indicazioni utili
Il volto del potere
Credo che sia opportuna una premessa, onde evitare di cadere in un facile equivoco: l’autore, Gianluca Ferrara, non è un vetero comunista, tanto più che è un senatore fresco di nomina facente parte del movimento 5 stelle; dunque se il titolo può sembrare roboante, tipico di una certa sinistra estremista di diversi anni fa, e l’argomento trattato è scottante, non c’è nulla di strano, non c’è nessun partito preso, perché Ferrara ha scritto numerose opere di rottura con cui ha messo in luce insanabili contrasti di tante istituzioni, da quelle finanziarie a quelle religiose, in ciò perfettamente in linea con le finalità di Dissensi, la casa editrice di cui è il principale esponente e che è nota per pubblicare libri che affrontano in modo serio e organico temi non facili, o addirittura tabù.
Inoltre, credo anche necessario evidenziare che io sono quasi sempre delle stesse opinioni dell’autore; per quanto concerne il saggio in argomento, pur condividendolo in toto nei suoi contenuti, ritengo opportuno fare tuttavia una considerazione: è nell’animo umano la prevaricazione e uno stato, per diventare una potenza, quasi sempre lascia dietro di sé una scia di cadaveri, morti, anche figurate, che continuano per il mantenimento del potere raggiunto, e se un tempo era l’impero romano, oggi c’è quello americano, in futuro, forse, quello cinese, ma nulla cambia nei metodi, se non gli affinamenti dovuti all’esperienza.
Il libro ha una bella introduzione di Ferdinando Imposimato, scomparso agli inizi del corrente anno, e che in poco, cioè in termini succinti, e pur in modo esauriente, dice tutto di questo saggio, ovviamente in quelle che sono le linee generali e che partono dal sanguinoso inizio degli Stati Uniti per arrivare ai giorni nostri, lasciando questo lasso di tempo costellato da innumerevoli tragici eventi, quali guerre, cospirazioni, il tutto in nome della democrazia, parola che non è nemmeno citata nella costituzione americana. Per ironia della sorte il termine Impero del male fu coniato da Ronald Reagan per definire l’Unione Sovietica, che non era certamente il regno del bene, ma che non era al livello di cinismo degli USA che alla stessa epoca finanziavano in Nicaragua i Contras, famosi terroristi, e in Afganistan i radicali islamici. Fu comunque al termine della seconda guerra mondiale che la vocazione di stato egemone contagiò gli Stati Uniti, tanto che da allora sono intervenuti in una settantina di paesi, condizionandone pesantemente la politica nazionale, come, tanto per citare un caso, il colpo di stato di Pinochet con cui fu rovesciato il legittimo governo di Allende in Cile, ma ce ne sono molti altri, altrettanto eclatanti. Fra l’altro, se per l’espansionismo sovietico si può dire che alla base ci fosse un’ideologia, cioè un’interpretazione sbagliata del marxismo, nel caso americano c’è indubbiamente un fondamento di carattere economico che sta dilagando (il neoliberismo), ma non è estranea a certi comportamenti anche una concezione religiosa calvinista secondo la quale la ricchezza di alcuni è un segno della volontà di Dio; da qui l’assenza, o comunque la limitatezza di uno stato sociale, e il continuo aumento della miseria nel paese, perché è bene precisare che gli americani non sono tutti ricchi, come l’abile propaganda ci ha induce a credere. Con due soli partiti e una élite economico-finanziaria in grado di sconvolgere il mercato non solo nazionale, è evidente che la democrazia piena non esiste e che è una chimera. Secondo i principi neoliberisti un paese “deve” accrescere la propria ricchezza, altrimenti muore (il motivo di questa necessità è in realtà un altro, nel senso che tutta l’economia poggia su una illimitata fiducia dei consumatori, stimolati continuamente ad acquistare; se cade la fiducia, perché per esempio le banche non sono più in grado di erogare ai privati i prestiti necessari per consumare, l’impalcatura crolla); per questo motivo, anche per impedire l’inevitabile caduta della notevole produzione bellica una volta finito il secondo conflitto mondiale, è stato scelto di alimentare nuove guerre esterne, in modo da evitare una consistente riduzione degli ordini alle industrie degli armamenti. Ovviamente sono continue le pressioni affinché i paesi amici, ma è meglio dire sottomessi, acquistino frequentemente nuovi strumenti bellici, magari coinvolgendoli nelle cosiddette missioni di pace volte, ufficialmente, a portare la democrazia dove non c’è, ma dove sono comunque presenti rilevanti interessi economici o geo-politici. Quindi, se pur Abramo Lincoln abolì la schiavitù, gli americani ne hanno imposto un’altra agli europei e comunque a tutti i paesi del globo: o essere in diverse misure asserviti, o diventare teatri di guerre.
E’ un ritratto impietoso quello di Ferrara che magari può anche trovare il lettore non in sintonia, ma è innegabile che correlati tutti gli eventi citati dall’autore, peraltro documentati, la conclusione a cui si arriva è che gli Stati Uniti si comportano come padroni assoluti, quindi dimostrando che la democrazia, più volte dagli stessi osannata, è una vuota parola.
Agli scettici, che non sono pochi, perché siamo cresciuti a pane e America, dico solo che ognuno fa sempre i propri interessi, anche quando dice di fare quelli degli altri; lo stato egemone non è una novità, la novità è che in passato si conquistava solo militarmente, oggi si conquista anche psicologicamente, si indottrina senza che ce ne accorgiamo e quindi siamo in fondo schiavi senza saperlo.
Leggete questo libro, per acquisire un po’ di consapevolezza, per comprendere che il percorso dell’uomo verso un’autentica libertà e una completa democrazia è ancora lungo e ben lontano dall’essere compiuto.
Indicazioni utili
Una disfatta non inattesa
Credo che sia difficile trovare un evento nella ancor pur breve storia dell’Italia che abbia colpito il nostro popolo in modo così evidente, al punto di definire ogni risultato particolarmente negativo come “una Caporetto”. Del resto, in quelle giornate di fine ottobre del 1917 poco ci mancò perché le truppe tedesche e austriache arrivassero a dilagare nella pianura padana, determinando di fatto la fine del nostro stato.
Ma come è potuto accadere che un esercito come il nostro, quasi sempre in numero ben superiore all’avversario e dotato di moltissime artiglierie venisse di fatto ridicolizzato da un nemico che dopo undici battaglie sull’Isonzo si riteneva incapace di sostenerne una dodicesima? Proprio per questo motivo, nel timore di un crollo con un altro scontro diretto, l’alto comando austriaco si risolse di chiedere aiuto all’alleato tedesco e insieme elaborarono un piano che, se nelle intenzioni era volto ad alleggerire la tensione sul fronte, di fatto arrivò quasi a ottenere una nostra irreparabile sconfitta, insomma una Waterloo o una Stalingrado. Data la tematica non pochi storici hanno provato a dare una risposta, più o meno convincente, ma comunque non così attentamente elaborata come ha invece fatto il prof. Alessandro Barbero. L’impegno nell’opera è stato notevole, se si considera che il volume, edito da Laterza, consta di ben 645 pagine, ivi comprese quelle dedicate alle carte geografiche, poche in verità, ma utilissime; non mancano poi alla fine corpose parti dedicate alle indispensabili note e alla ragguardevole e ben scelta bibliografia. Il lavoro è stato ben strutturato in XIII capitoli, che vanno dall’ideazione dell’offensiva alla nostra ritirata in Friuli, affrontando tutta una specificità di aspetti che se non riescono a dare una risposta certa al 100% su chi fu colpevole del disastro, chiariscono però non poche cose. In particolare, e qui Barbero è piuttosto esplicito, ritiene che la colpa non può essere attribuita solo a Cadorna, a Badoglio o al suo comandante dell’artiglieria colonnello Cannoniere, perché la responsabilità, come esposto nel saggio storico, è condivida da tantissimi altri. Lo sfacelo del fronte, con il collasso del nostro esercito, fu il fallimento di un’organizzazione posticcia, in cui le direttive erano a dir poco nebulose, le decisioni importanti erano prese in modo intempestivo, la professionalità latitava, la paura di assumere provvedimenti, con l’assunzione quindi di responsabilità, era la norma, la stanchezza di quasi tutti i soldati era giunta a un punto tale da far preferire loro la fuga o la resa. Inoltre, il distacco fra comandanti e militari semplici era tale da lasciar chiaramente intendere che i primi costituivano una casta, mentre i secondi erano solo carne da macello, e del resto in quest’ottica si preferiva nominare ufficiali, dopo un corso affrettato, giovani inesperti, ma figli della borghesia, invece di ricorrere ai subalterni (sottufficiali) che avevano maturato una grande esperienza in anni di guerra. Cadorna, che non era uno stratega scadente, anzi era un buon comandante sotto questo aspetto, aveva poi il difetto di considerare i componenti del suo esercito come semplici strumenti in mano a lui, artigiano della guerra, strumenti da spremere senza alcun riguardo. E pensare che aveva avuto a portata di mano la possibilità di vincere la battaglia risolutiva, se avesse preceduto, di poco, l’offensiva nemica, cogliendola nella fase di attesa, quella più delicata, con tutte le truppe in prima linea. Il nostro Servizio informazioni gli aveva detto dove sarebbero avvenuti gli attacchi, le forze utilizzate, i mezzi che sarebbero stati impiegati, il giorno e l’ora, ma come già accaduto in passato il comandante supremo non si fidò del nostro spionaggio, con le conseguenze che tutti conosciamo.
Quindi, ricapitolando, l’opera di Barbero, ben strutturata organicamente, è in grado di offrire una visione a 360° dell’intero evento, e ciò viene fatto con rigore storico, ma anche con dinamismo e a volte con quelle punte di ironia che sono proprie dell’autore, così che la lettura risulta agevole e anche avvincente, tanto di avere sovente l’impressione di essere presenti, come spettatori, sul palcoscenico che ospita il tragico fatto. Tale coinvolgimento è di particolare rilievo ove si consideri che l’analisi comprende anche la situazione della grande massa di prigionieri che fecero le forze nemiche, nonché gli aspetti, meno strettamente militari, di quella che può essere considerata la più grande ritirata della storia, in cui non pochi soldati in fuga diedero sfogo agli istinti più repressi. Si accenna appena, invece, ai motivi per i quali migliaia di militari sconfitti e demoralizzati riuscirono da subito, giunti sulla linea del Piave, ad arrestare l’offensiva nemica; infatti, e giustamente, Barbero scrive che per far questo occorrerebbe un altro corposo libro.
Mi sembra superfluo aggiungere che la lettura di questo approfondito saggio storico non solo è consigliata, ma è da me vivamente raccomandata per la completezza con cui viene trattato l’argomento e per l’equilibrio dell’autore nella ricerca delle colpe, da cui emerge anche una caratteristica italica, quell’improvvisazione, non disgiunta da menefreghismo, che purtroppo ci portiamo dietro e che nei momenti più delicati emerge chiaramente, come anche avvenne nella seconda guerra mondiale.
Indicazioni utili
Un lenone non spregevole
Il termine procuratore potrebbe far intendere che si tratta del magistrato inquirente che perseguita i criminali o al massimo che è riferito alla figura di una persona che agisce in nome e per conto di un’altra sulla base di un preciso mandato scritto; non è così, perché Marco Perini, il personaggio principale di questo romanzo, procura ragazze giovani e molto disponibili sia per le case chiuse che per l’esercizio del meretricio in proprio. Un tipo così potrebbe essere definito giuridicamente come un protettore, un lenone, un magnaccia; la differenza è che lui non rischia di essere incriminato, perché siamo nel ventennio virile del fascismo in cui il perfetto italiano doveva essere considerato come un toro da monta e quindi qualsiasi attività volta al raggiungimento dello scopo non poteva essere considerata illecita. Il romanzo, il primo dell’autore comasco, trae origine, come specificato dallo stesso nella prefazione, da un episodio raccontatogli dal padre e da lui, grazie alla innata creatività, ampliato con soluzioni, situazioni ed eventi volti a descrivere un certo mondo in una ben precisa epoca. In effetti, di tutte le opere di Vitali che ho fino a ora letto, questa, pur con certe carenze rivenienti da una naturale inesperienza, mi sembra forse la migliore, perché ha il pregio di soffermarsi sulle caratteristiche dei protagonisti, descrivendoli in modo chiaro con semplici e concise parole, tutti attori ben inseriti in una vicenda tutto sommato non trascendentale, ma che è proprio nella riproduzione dell’ambiente e dell’atmosfera che trae il maggior pregio. Intendiamoci, se è vero che si sorride, anche perché la satira politica non è nelle corde dell’autore, non è che a lettura ultimata ci si lasci trascinare dall’entusiasmo per i particolari contenuti, o per il messaggio portato, no, sarebbe pretendere troppo, mentre invece la valenza va cercata nella capacità di far trascorrere piacevolmente alcune ore, che è poi la caratteristica dei lavori di questo autore, un buon artigiano della penna, ma non di certo un artista di particolare spessore. Del resto, costretto in casa da una fastidiosa bronchite, ho trovato una via di fuga al tedio giornaliero proprio in questo romanzo, ripromettendomi di leggerne altri dello stesso autore quando avrò la necessità di staccare, quando riterrò opportuno non impegnarmi in letture difficili, bensì di abbandonarmi al puro e semplice piacere di un teatrino frivolo e rasserenante.
Indicazioni utili
Un notevole imbarazzo
Mi ricresce dirlo, ma questo autore mi mette in un notevole imbarazzo, alternando opere di ragguardevole valore con altre invero modeste. Reduce dalla lettura di Prima dell’alba e di Sul Grappa dopo la vittoria, opere entrambe che a mio giudizio sono dei capolavori, mi sono trovato per le mani I mercanti di stampe proibite, titolo già di per sé infelice (data la vicenda e i protagonisti avrei visto meglio I perteganti), come certamente non felice, o meglio non piacevole, mi è risultata la sua lettura. Le differenze di stile fra i due libri aventi per oggetto la Grande Guerra o gli anni immediatamente successivi (snello, conciso, ma non asciutto, per i primi, pesante, barocchesco invece per questo) sono tali da far pensare che non siano stati stilati dalla stessa mano, oppure che ci troviamo di fronte a uno scrittore che, alle prese con un evento più recente (la Grande Guerra) imposta una struttura ben diversa da quella di fatti accaduti parecchio tempo fa (i protagonisti di I mercanti di stampe proibite operano negli anni sessanta e settanta del Settecento). Le differenze non sono di poco conto, perché non è certamente piacevole trovare un autore così spiazzante, in negativo. Ora, non intendo dire che questo libro oggetto di mia critica sia un’opera scadente, ma più semplicemente che è di molto inferiore ai due che ho sopra cennato, forse troppo ben riusciti al punto da rendere impossibile, o comunque non logico qualsiasi raffronto. Ho peraltro da osservare che anche La reliquia di Costantinopoli presentava caratteristiche comuni a questo libro, un’opera verbosa e di una particolare grevità che mi ha accompagnato pesantemente nella lettura fino all’ultima pagina, vista in tutta sincerità come una liberazione.
Mi spiace scrivere certe cose, ma come ritengo giusto porre in risalto ciò che per me può essere considerato un capolavoro, del pari credo sia doveroso evidenziare anche ciò che non è riuscito o che comunque è inferiore alle aspettative.
Indicazioni utili
- sì
- no
Crescere insieme
Ammetto di aver affrontato un po’ prevenuto la lettura di questo libro, a causa delle delusioni che ho provato con non pochi altri testi premiati allo Strega. Prevenuto sì, ma non pregiudizialmente avverso, anche perché l’idea che si parlasse della montagna, che così tanto amo, mi stimolava ed è perciò con interesse che ho proceduto nella lettura, che dopo le prime pagine è divenuta avvincente grazie a un incipit che, pur senza essere trascendentale, già confermava le mie aspettative. Le otto montagne, nonostante il titolo, non è un libro sulla montagna, che peraltro è il palcoscenico in cui si misurano gli attori, è la storia invece di due ragazzi, Pietro il cittadino e Bruno il montanaro, che crescono insieme, così diversi e al tempo stesso così uguali; diversi ho detto, eppure uguali, perché le loro anime denotano un’affinità che quasi li fa sembrare fratelli. Il primo è soggiogato da un padre che vede nelle escursioni in montagna una continua sfida con se stesso, il secondo è già svezzato da una vita dura e di fatica, con un genitore violento e per nulla paterno, in un confronto fra una piccola borghesia che può permettersi anche le vacanze sui monti e un sottoproletariato, in cui ferie è un termine sconosciuto. Finiranno con il crescere insieme, sia pure nel breve periodo delle vacanze estive, in un’amicizia che li cementerà per tutta la vita. Assieme affronteranno le escursioni fra panorami talmente belli e così ben descritti che fanno venire le lacrime agli occhi; non sarà tuttavia sempre così, perché trascorsa la pubertà ognuno andrà per la sua strada, Bruno sempre legato intimamente alla montagna, Pietro a cercare un suo percorso, un senso da dare alla vita. Sarà la morte improvvisa del padre di Pietro a riavvicinarli, a farli sentire un unico individuo e insieme cercheranno di dare una svolta alle loro vite: Bruno sempre legato alla sua montagna, Pietro in giro per altre montagne, nel lontano Nepal; qui gli giungerà una tragica notizia, che preferisco non svelare per rispetto di chi leggerà, ma che è la indovinata conclusione di un’opera senz’altro convincente. Mi limito, pertanto, a dire che Pietro continuerà a cercare lo scopo della sua esistenza, probabilmente su e giù per altre montagne, quello scopo che Bruno ha da tempo e definitivamente trovato.
Il romanzo è scritto benissimo, con uno stile per niente ampolloso, ma nemmeno scarno, venato sovente da una malinconica nota poetica; in sé non sembrerebbe particolarmente degno di nota, ma, come mi era capitato per Stoner, tutti gli equilibri strutturali sono stati raggiunti con un’apparente facilità che stupisce ed entusiasma il lettore, ora accompagnato dal sottofondo del rumore di un ruscello alpino, ora immerso nel silenzio delle alte cime.
Le otto montagne è senz’altro un bel romanzo, una di quelle opere che, pur non facendo gridare al capolavoro, lasciano al termine della lettura completamente soddisfatti e, ciò che più conta, pervasi da un grande senso di serenità.
Indicazioni utili
Uomini o bestie?
Animali o bestie, anzi animali e bestie è quello che viene da chiedersi leggendo questi racconti da cui l’homo sapiens, per lo più, non esce bene, vera bestia in un campionario di esseri viventi in cui gli animali rappresentano un’atavica purezza, nell’uomo ormai da tempo definitivamente dimenticata. Tuttavia sono attribuiti a quattro zampe e anche a bipedi reazioni che sono tipicamente nostre, ma che hanno origini diverse, nel senso che le nostre sono quasi sempre frutto di un’azione in cui c’è un do ut des, una volontarietà che implica una relativa reazione. Anche noi ci vendichiamo per i torti subiti, dimenticando però che sovente ci macchiamo della stessa colpa; nell’animale questo non accade, perché nel suo comportamento non ci sono secondi fini. Ecco allora che la vendetta, per esempio dell’orsa, ha connotazioni diverse, è la reazione del tutto naturale di una madre a cui hanno sottratto il cucciolo ed è proprio l’orsa che dà il nome all’intera raccolta, questo vecchio plantigrado che fa un lungo viaggio per ritrovare il suo piccolo e per vendicarlo, in una battaglia finale che ha un dono cinematografico, nel senso che si materializzano le immagini davanti agli occhi del lettore. Di diversa tematica, ma non per questo meno bello è il commovente Serague, la storia di una mula bianca che lavora tutta una vita, cambiando più volte padrone, e che quando è ormai vecchia e inadatta a faticare viene venduta a dei macellai per una fine impietosa, quasi la metafora di alcuni anziani che quando non sono più in grado di dare vengono di fatto scaricati.
E’ indubbio che il rapporto con la natura di Pardini sia paritario, nel senso che lui sia convinto, e mi trova d’accordo, di essere solo una parte dell’immensità del creato, in cui ogni essere vivente ha una sua funzione, ben delineata e insostituibile; in quest’ottica pertanto noi non siamo né più né meno degli animali, con questi però che, a differenza dell’uomo, non vengono mai meno al loro ruolo. Sta nel reciproco rispetto delle parti il segreto affinché l’equilibrio naturale non venga sconvolto, sta nella consapevolezza della precisa identità del proprio ruolo la chiave per interpretare e dare un senso alla vita, parti di un universo a cui noi siamo indispensabili, come indispensabili sono gli altri esseri viventi. Sotto questo aspetto Pardini ha pertanto una sua visione che non trova riscontro in nessun altro autore e che, partendo da un microcosmo dimensionalmente ridotto, è però estensibile all’intero pianeta, con un proprio il messaggio non legato a qualche cosa di ristretto, a un fenomeno endemico, ma ben più ampio nella sua universalità. Se nel leggere questi racconti, tutto preso dalle vicende notevolmente avvincenti non me ne ero accorto, adesso, a mente lucida, e a libro chiuso mi rendo conto di quanto pregnante sia l’insegnamento dell’autore, per nulla retorico, ma capace di scuotere la coscienza, di mostrarci come la nostra incrollabile fede di sentirci superiori a tutto e a tutti sia un vuoto atto di vanità, il risultato di un’inconscia frustrazione che ci porta a non rispettare nulla e men che meno noi stessi, fragili parti di una natura che ci illudiamo di soggiogare, venendo però inevitabilmente puniti per quest’atto di superbia.
Il viaggio dell’orsa e gli altri sette racconti (per me il migliore è Il fratello del lupo, relativamente corto, ma dalla preziosa atmosfera crepuscolare) che compongono questa raccolta sono quindi senz’altro meritevoli di lettura.
Indicazioni utili
La forza del mito
Dopo due volumi (L’oro di Napoli e San Gennaro non dice mai no) con cui Giuseppe Marotta è riuscito a mostrare al lettore l’autentico spirito di Napoli e più ancora il carattere peculiare e unico dei suoi abitanti, pagine che in alcuni casi possono anche strappare più di un sorriso, ma che in ogni caso sono venate da una malinconia di fondo, ecco un’opera la cui finalità, pur restando sempre nell’ambito partenopeo, è umoristica.
Federico Sòrice, per ben trent’anni bidello del liceo di Piazza Dante, da cui in seguito era stato forzatamente allontanato a causa di un suo particolare vezzo che consisteva nel ritocco con tenui inchiostri dei disegni della stoffa dei logori soprabiti degli insegnanti, forte delle conoscenze acquisite ascoltando sui malgrado, o anche per suo piacere, le lezioni, partecipa la cultura così conquistata a un eterogeneo pubblico. E’ così che ogni giorno raduna intorno a sé, dove capita, e sempre per la strada, il fattorino telegrafico Vincenzo Aurispa, il barbiere don Antonio Pagliarulo, il calzolaio don Catello Debbiase, il gobbo don Rosario Nèpeta e il fruttivendolo guappo e becco Salvatore Cademartori.
Di che parla Federico Sòrice? Racconta, in forma colorata, la mitologia greca e romana, dalle origini del tutto, cioè da Saturno in avanti. E non è un caso se si ride, sia per degli ameni accostamenti che per gli interventi degli alunni, interessati alla narrazione forse più dei liceali, ma che di tanto in tanto trovano che c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che sfugge alla logica. A ben guardare è proprio questo l’insegnamento del libro, vale a dire che per la comprensione della mitologia occorre ricordare che la logica corrente del mondo non è l’unica esistente, perché con la mitologia appunto è ancora possibile credere che un toro rapisca una fanciulla e che attraversi tutto il mar Mediterraneo per poi giacere con lei. E don Federico racconta, come in preda a un’ossessione, fino all’ultimo giorno, quando muore, con gli amici-alunni intorno al suo letto che s’aspetterebbero una sorta di miracolo, magari che un cocchio celeste irrompa dal soffitto e se lo porti via. Ovviamente non accade nulla di tutto questo, ma “ e il Tondo di Capodimonte, poi il suo guanciale, come la sfera di cristallo dei negromanti, si screzia di varie immagini che sembrano navigarvi. Don Federico, è Napoli. Sono via Cagnazzi e il Tondo di Capodimonte, Piazza Dante e il Carmine, San Ferdinando e Santa Lucia, ...”. La mitologia, il sogno che ci permette di volare, ma sempre con i piedi per terra, non abbandona mai il mondo reale.
Grazie, don Federico Sòrice, per averci portato un po’ con te nei tuoi sogni a occhi aperti.
Indicazioni utili
Un piccolo “grande” libro
Delle volte credo di essere proprio strano, talmente pregno di soddisfazione da essere quasi incapace di spiegarne la ragione; non accade di frequente, ma capita ed è successo proprio nel momento in cui, arrivato all’ultima pagina, ho chiuso il libro. Il cuore palpitava, davanti a me si succedevano, nitide, le immagini dei protagonisti, con sullo sfondo Lui, il monte sacro, l’ultimo baluardo della patria, il Grappa. A ripensare a quel momento mi emoziono ancora, il mio corpo è percorso da un fremito lieve che sembra irradiarsi dal cuore, una sensazione unica che solo un libro così bello come questo è stato capace di darmi. E pensare che il mio primo contatto con questo autore non era stato per nulla soddisfacente, poiché La reliquia di Costantinopoli, di cui avevo lamentato l’eccessiva verbosità, non mi era piaciuto. Ma questo libro è tutta un’altra cosa, è una di quelle opere che presenta più di un piano di lettura, ma tutti egualmente validi e confezionati in modo impeccabile. L’esodo delle famiglie di Bassano a seguito della ritirata di Caporetto, la provvisoria residenza nel ferrarese, il ritorno alla propria casa alla fine della guerra, la miseria opprimente, il padre che scampa al conflitto, torna alla sua famiglia profondamente ferito nell’animo, il figlio che gli chiede notizie di quella guerra, lui che non risponde per non soffrire ulteriormente, ma anche perché non ci sono parole che possano spiegare l’orrore, il padre che, con la scusa di recuperare quanto di possibilmente utile, accompagna il figlio fino alle prime balze del Grappa, invitandolo a proseguire da solo, sono tutte immagini in bianco e nero, virato seppia, che scorrono implacabili davanti agli occhi. Ma queste pagine non potrebbero ancora spiegare il pathos che creano nel lettore; è invece il percorso in solitario del giovane sulla montagna che si incide profondamente nell’animo, con le trincee divelte, il puzzo nauseabondo e dolciastro dei cadaveri in putrefazione, i corpi, spesso smembrati, raggruppati quasi in cataste, il dramma che, nella tensione del combattimento non si svela in pieno, assume ora, nel silenzio di una pace ritrovata, l’aspetto di un’ecatombe. Girare in un terreno martoriato, dove non cresce più nemmeno un filo d’erba, imbattersi in crani dalle occhiaie vuote, ma che ancora conservano qualche ciuffo di capelli, quella natura così violata da apparire per sempre distrutta mi hanno fatto venire in mente un grande capolavoro della cinematografia, il giapponese L’arpa birmana. Ci si commuove, ci si emoziona, ma Malaguti è abile nel non tirare troppo la corda e quindi passa a epoche, anche se di poco, successive, a quella descrizione del mondo contadino di cui il giovane protagonista, benchè studente, è intima parte. E così ci vengono mostrati il difficile periodo del dopo guerra, l’avvento del fascismo con una felice annotazione, in una delle poche e opportune digressioni (Il nostro modo di essere fascisti, perché lo eravamo, era essenzialmente formale. L’Italia era fascista, il paese era fascista, noi eravamo fascisti. Non esserlo significava porsi al di fuori di una condizione forse non condivisa, ma accettata da tutti, almeno in superficie.), i primi turbamenti amorosi e infine l’amore vero e proprio. Tutto procede secondo un ordine logico, gli avvenimenti si susseguono, il mondo cambia, tranne Lui, il monte sullo sfondo, il Grappa, ritornato a verdeggiare e ad accogliere mandrie sui suoi pascoli.
Paolo Malaguti ha una mano sicura, procede per gradi senza incertezze, è capace perfino di interessare quel lettore che non conosce il dialetto veneto (non è il mio caso, ma penso che qualcuno avrà difficoltà a comprendere dei colloqui in volgare, beninteso più che mai opportuni in un ambiente rurale dove l’analfabetismo era assai diffuso), insomma riesce a completare un’opera che nelle sue 168 pagine dice tanto e lo dice bene.
Di conseguenza, reputo che la lettura sia non solo consigliata, ma anche raccomandata, visto che ci si trova di fronte a un autentico capolavoro.
Indicazioni utili
La speranza non deve morire
a prima emozione, quel primo sentimento che è ancora impossibile definire amore, ma semplicemente trasporto verso altri è per un bambino francese di dieci anni un’occasione irripetibile, unica, in cui i suoi turbamenti sono di gioiosa trepidante felicità e di quella sensazione avrà sempre memoria, ma non solo ricordo, perché è in un giorno d’ombra e di sole degli anni ‘30 che Ludo, orfano di entrambi i genitori e che vive con uno zio un po’ picchiatello che si diverte a fabbricare aquiloni, conosce Lila, una biondissima ragazzina polacca.
Non si tratterà di un’infatuazione passeggerà, perché la promessa d’amore di Ludo finirà con il costituire la ragione stessa della sua esistenza, gli imporrà scelte decisive, lo aiuterà a maturare nonostante gli eventi che vedono la Francia occupata e l’assenza di notizie da parte di Lila, ritornata precipitosamente in Polonia a seguito di un tracollo finanziario del padre.
Ludo diventa partigiano e verrà coinvolto nella guerra spietata fra i maquis e i nazisti, ma senza mai perdere quel senso di umanità che gli è proprio, che gli impedisce di odiare e che lo induce a credere fermamente che l’amore non potrà che trionfare. E infatti la Francia tornerà libera, la guerra che ha sconvolto l’Europa finisce, chi era dovuto scappare, chi era stato disperso ritorna e così ritorna anche Lila. Il cerchio si chiude; era tutto iniziato in quel giorno d’ombra e di sole con l’incontro di due bimbi, ora cresciuti, diventati adulti, provati dalla guerra, ma non sconfitti. Gary sembra volerci dire che quando tutto si fa nero, quando il nostro mondo crolla, non si deve mai perdere la speranza, soprattutto se alla base di questa c’è un amore da coltivare, da difendere, da raggiungere.
La mano dell’autore è lieve, muove i personaggi con dolcezza, ma non si creda che sia un romanzo d’amore, perché è un romanzo sull’amore, su quel sentimento che dovrebbe affratellare gli uomini.
Gli aquiloni mi è parso senz’altro meritevole di lettura, anche se un’amica mi ha fatto presente che ha scritto di meglio e considerato il livello di questo romanzo il meglio può essere solo quello del capolavoro.
Indicazioni utili
L’anima di Napoli
E’ l’immediato dopo guerra, in un Italia distrutta, povera e affamata, e Giuseppe Marotta ritorna alla sua Napoli, sconvolta dalle bombe, in attesa di una ricostruzione che non si sa quanto lunga sarà, con la gente che si arrangia con quel poco che ha per sopravvivere, ma sempre con la speranza che possa cambiare.
In questo contesto gli occhi dell’autore colgono realtà disarmanti, ma al tempo stesso uniche, in cui il dramma non arriva mai al suo acme, perché c’è sempre qualcosa che permette di stemperare l’atmosfera, che consente persino al derubato di accennare a un timido sorriso. I vetturini, che in mancanza di clienti, si portano a spasso l’un altro, per dare al loro lavoro quella parvenza di normalità che impedisce di arrivare alla disperazione, e che per rimediare ai miseri incassi se trovano un cliente sprovveduto gli fanno pagare per dieci; i borseggiatori di penne stilografiche, quasi sempre cenciosi monelli, imperversano nei vicoli, ma nel caso che la vittima li impietosisca restituiscono il maltolto; il mercato nero domina sovrano, si compra e si vende di tutto, ma in un certo senso non è illegale, perché si svolge alla luce del sole ed è il toccasana per una città che altrimenti si spegnerebbe. I percorsi per le vie, per i viottoli, lo sfondo del mare, le caratteristiche trattorie, i venditori ambulanti, tutto fa meraviglia in questa città e Marotta ha la straordinaria abilità di renderci in uno stile impeccabile una serie di quadri che uniti consentono di vedere Napoli, ma soprattutto di capire il carattere dei suoi abitanti, di immergerci in un’atmosfera unica che non è possibile trovare in nessun altro agglomerato urbano, quell’atmosfera che ha tanto incantato i turisti nordici, precisi, ordinati, ma privi di fantasia. E’ un microcosmo questo così variegato che credo sia impossibile descriverlo tutto, un microcosmo animato, pieno di vita, in cui l’amarezza di fondo è stemperata da una speranza, dalla speranza che San Gennaro ritorni, un San Gennaro che non può mancare di venire incontro alle preghiere dei suoi fedeli, perché altrimenti non sarebbe un santo.
San Gennaro non dice mai no è una raccolta di racconti di elevata qualità, che si leggono con vero piacere e che lasciano molto dentro, facendoci anche capire che la vita può essere bella, nonostante tutto.
Indicazioni utili
Un anelito di speranza
Da sempre convinto assertore della necessità che l’uomo, nella sua sfrenata corsa al progresso, si fermi un attimo per pensare a quanto abbia perso della sua umanità privilegiando la civiltà delle macchine, non potevo restare insensibile a una silloge in cui si vagheggiano i ricordi di un tempo andato, allorché le relazioni con il mondo circostante, soprattutto con la terra, erano alla base di un’esistenza certamente più avara di benessere economico, ma più prodiga di accrescimento spirituale. Ma se è evidente il richiamo bucolico o comunque a una poesia agreste di illustri predecessori quali Pavese e Bertolucci, la visione delle campagne di Biondi non è fine a se stessa, ma è improntata a una più generale stratificazione di una società in cui l’influsso del pensiero religioso cristiano è una determinante per niente secondaria. Al riguardo ci sono simboli che evidenziano quanto ho appena detto e mi riferisco alla poesia L’agnello errante (… / sta l’agnello / col vello sbiancato nel sangue / e canta: consolate l’agnello, consolate il mio popolo” ), agnello che ritorna anche in altre liriche e che, come ben sappiamo, simboleggia il Cristo. Ma la terra non è necessariamente proprietà di una religione o di un’altra, perché proprio essa, nella sua natura primigenia, è stata fonte ispiratrice di diverse fedi, ed è la stessa terra delle Bucoliche di Virgilio e della Sora nostra madre terra di San Francesco. Con questa visione in cui predomina l’attenta analisi, non semplicemente idillica, delle manifestazioni di tutto quanto vive sulla terra e della terra stessa, emergono una serie di immagini che ben possono far comprendere quel Le campagne hanno bocche, titolo della silloge. In realtà, benché l’autore ci venga a proporre il ricordo, magari dilatato nel fantastico, di un mondo che è stato nostro fino a poco tempo fa, lascia trapelare un desiderio inconscio di recupero che prelude a un’attesa che sembra far spazio a una certezza. Sebbene le visioni prospettate siano intensamente oniriche, con una estensione fantastica di un ricordo sbiadito e ancora velato, non è possibile non notare che questi fantasmi che si agitano sono sì i nostri rimorsi per un mondo perduto, ma anche la base indispensabile per un recupero delle nostre radici e con esso di quel mondo. Quindi la poesia di Biondi non è, come potrebbe invece apparire di primo acchito, la dolorosa testimonianza di uno spasimo lacerante per qualcosa che mai più ritornerà, per un valore così elevato da rendere gramo o addirittura insopportabile il futuro, è invece una presa di coscienza grazie alla quale può nascere una speranza, ma che anche consente di ripescare nel ricordo quanto può essere utile per andare avanti.
La silloge non è certamente di facile comprensione, ma ritengo che ciò che vale possa meritare una più che attenta disamina e quindi non mi resta che augurare una buona e approfondita lettura.
Indicazioni utili
Una piacevole lettura
Da un libro si può pretendere molto o poco, ma in ogni caso quello che gli si richiede è che sia capace di interessare, magari facendo trascorrere piacevolmente alcune ore.
Questo breve preambolo è solo per dire che le opere di Andrea Vitali non saranno di quelle che restano impresse e indelebili nella storia della letteratura, ma che talvolta hanno invece il pregio, mai scontato, di divertire il lettore.
Anche questo La mamma del sole si legge che è un piacere, le pagine scorrono veloci con ambienti e personaggi ben delineati, anche se non è mai presente un particolare approfondimento e l’analisi psicologica è appena abbozzata.
Il paese della storia è sempre quello, Bellano, l’epoca è il Ventennio, i protagonisti principali sono i carabinieri della stazione di paese, la vicenda, o meglio le vicende, perché sono due, hanno solo il sapore del giallo, perché non sono di questa tinta, con due donne al centro dell’attenzione che sembrano personaggi usciti da una pagina di fumetti, ma che pur con le loro caratterizzazioni fin troppo accentuate destano simpatia.
Un’anziana signora che sbarca a Bellano e di cui si perdono le tracce, salvo poi trovarla cadavere nel bagno della motonave Nibbio avviata alla demolizione, un’altra donna più giovane, di conclamata dubbia reputazione, madre di 14 figli che diventa l’attrattiva principale del fascio provinciale, un caldo torrido che implacabile soffoca gli abitanti, un vetraio che muore dalla voglia di lavorare e che quando gli viene l’estro opera a orari impensabili, un sacerdote, ormai anziano, custode di un segreto, il locale federale, uomo tutto d’un pezzo, ma con insospettabili gusti sessuali sono gli attori di una commedia in cui gli equivoci scandiscono gli eventi. Si potrà dire che i romanzi di Vitali hanno una matrice comune, e anche più di quella, ma è altrettanto vero che questa, se ben lavorata – e non è detto che sempre lo sia, anzi… - può dare i suoi frutti e così è stato, almeno in questo caso, per quanto continui a restare scettico sulle qualità letterarie dell’autore, un po’ troppo frettolosamente definito da certa critica come l’erede di Piero Chiara; infatti, almeno con La mamma del sole, posso dire, senza remore, di essermi divertito, di aver trascorso alcune ore piacevolmente anche se, chiuso il libro, non mi è rimasto nulla dentro, ma questo è un altro discorso, perché se avessi riscontrato un mio accrescimento culturale avrei dovuto, necessariamente, rivedere il mio giudizio sull’autore, di discreto stile, buona fantasia, ma piuttosto superficiale e comunque mai capace di dimostrare di essere un grande della letteratura.
Indicazioni utili
Il rimorso
E’ una domenica d’estate, si pranza e i commensali sono i due fratelli Donge con le rispettive famiglie. La moglie di Francois Donge, Bébé versa i caffè per tutti, compreso quello per il marito che, appena l’ha bevuto, si precipita fra le mura domestiche in preda a violenti dolori. Si tratta di avvelenamento, con l’arsenico, e la vittima la scampa per miracolo; fin da subito è evidente che l’avvelenatrice è la moglie che, tradotta in carcere, rende ampia confessione, senza tuttavia spiegare i motivi del suo gesto. Del resto, anche Francois, mentre è ricoverato in ospedale, si arrovella per comprendere cosa possa aver scatenato la furia omicida della moglie e anticipo che troverà la risposta alle sue domande, al punto da perdonare la consorte, condannata a cinque anni di lavoro forzati, di cui lui attenderà con ansia la fine, sempre più convinto che l’insano gesto sia da attribuire al suo comportamento, in un matrimonio da subito fatto di abitudini, di gesti ripetuti con una passione solo iniziale.
Con queste premesse definire un giallo La verità su Bébé Donge mi appare inappropriato, perché in effetti ciò che interessa all’autore è di far capire al lettore il perché del tentato omicidio e così pagina dopo pagina, con ricorrenti flashback sul passato della coppia, emerge una storia di profonda solitudine, quella di una donna ridottasi ormai a essere un soprammobile e di un marito che non è mai riuscito a comprenderla perché non si è mai comportato da marito, né ha mai cercato di appurare i motivi della sua ritrosia nei rapporti sessuali. Solo dopo il tentato omicidio, casualmente, appurerà dalla sorella di lei di un fatto traumatizzante per Bébé quando era ancora bambina che da solo può spiegare tante cose e in primis la sua frigidità. La capacità di Simenon di sondare l’animo femminile trova anche in questo romanzo conferma, mentre la figura del protagonista, che disperatamente cerca di rimediare agli errori passati, può sembrare per certi versi una sorta di pubblica confessione. É noto, infatti, che l’autore è sempre stato un impenitente donnaiolo, incapace di un legame affettivo completo. In ogni caso, su qualsiasi piano di lettura la si voglia vedere, è un’opera di indubbio valore, forse non uno dei molti capolavori a cui Simenon ci ha abituato, ma comunque valida e a un livello, se non di assoluta eccellenza, di ampia e riscontrabile qualità.
Indicazioni utili
Il furto del Sacro cuore
Più volte paragonato a quel gran narratore che è stato Piero Chiara, Andrea Vitali tuttavia non ne è che una pallida imitazione; sì, certo, entrambi scrivono del piccolo mondo della provincia italiana, il primo di Luino sul lago Maggiore, il secondo di Bellano sul lago di Como, ma, a parte questa caratteristica, non c’è nulla che li accomuna. Piero Chiara rivela un acume particolare nel parlare di vizi e virtù di un piccolo mondo, sondando l’animo umano e restituendoci un quadro sovente ilare, ma che viene descritto con affetto, come di un qualcosa che nel tempo si è perso e che mai più ritornerà. Anche Andrea Vitali descrive personaggi che sono tipici di una realtà circoscritta, ma resta in superficie, non approfondisce, preferendo invece narrarci di fatti e circostanze particolari e cercando di invogliare il lettore al riso. Anche in La signorina Tecla Manzi, una sorta di giallo senza omicidi e assassini, ambientato in epoca fascista, intesse una trama che a tratti scorre liscia, mentre in altri si inceppa. C’è uno spiccato intento di far ridere, ma al più sono arrivato al sorriso, proprio perché la discontinuità del ritmo, i capitoli particolarmente brevi e, se vogliamo dirlo, anche un intreccio non particolarmente avvincente di più non riescono a fare. Con ciò non intendo dire che il romanzo sia mediocre, ma che non ha molte pretese, se non forse quelle di far trascorrere alcune ore senza pensieri, soprattutto se si cerca di arrivare di persona alla soluzione, fra i patemi d’animo di un brigadiere innamorato, l’invidia di un appuntato che si sente vessato dai superiori, la timidezza di un carabiniere semplice che ha sempre paura di sbagliare e lei, il personaggio più riuscito, la signorina Tecla Manzi, la cui descrizione fatta dall’autore merita di essere riportata: “Secca da far paura e non più alta di un metro e cinquanta, stava compostamente seduta sulla sedia, la schiena bella diritta e la borsetta afferrata con due mani. Aveva un leggero tremito del capo e il vezzo di contrarre a intervalli regolari le ali del naso, dopodiché emetteva uno sbuffo, rumoroso e singolare”.
Spero che altri romanzi di Vitali che avrò l’opportunità di leggere possano appassionarmi maggiormente, fermo restando che questo, come ho sopra precisato, consente comunque di essere classificato come un innocuo e tutto sommato gradevole passatempo.
Indicazioni utili
Un mondo che non c’è più
E con questa sono tre le opere di Vincenzo Pardini che ho letto, il che mi consente anche, in corso di analisi critica della presente, di parlare un po’ di più di questo autore toscano.
In questa raccolta di racconti si respira l’atmosfera di Il postale e di Gran secolo d’oro e di dolore, un’atmosfera che sa di un tempo andato in cui si stava peggio economicamente rispetto a ora, ma anche in cui c’era una diversa tipologia di rapporti fra gli uomini, e soprattutto fra gli uomini e la natura. Un essere umano non più dominante sul mondo che lo circonda, ma capace di interagire con esso, di recepire i messaggi che spesso la natura ci manda, in possesso ancora di una parte di quel sesto senso che nell’evoluzione della specie, con l’accentuazione della conoscenza, si è persa per strada. C’è un aspetto favolistico nelle opere di Pardini, visto il rilievo che assumono gli animali, ma non mi lascerei tentare di pervenire a definizioni avventate, poiché sono dell’opinione che, nonostante una rilevante presenza del mondo animale, nella scrittura dell’autore toscano fulcro centrale sia l’uomo e la sua condizione di essere privilegiato, ma imperfetto, superiore, ma pieno di paure, personaggio, ma anche comparsa che si lascia trascinare dal destino, protagonista di un viaggio sulla terra lungo come un battito dì ali di farfalla se confrontato con l’infinito tempo dell’universo. Sì, Pardini è portatore di un suo pensiero filosofico che si ripete, si evolve, assume forme diverse, ma è sempre lo stesso in tutte le sue opere. Prendiamo questa raccolta di racconti e cerchiamo di comprendere i personaggi di un mondo che emerge a stento dalle nebbie dei ricordi, tanto da apparire fantastico, proprio di una mitologia di un’epoca forse felice che non è solo di qualche anno fa, ma è propria di un periodo ben preciso, e assai lungo, quello che precede la seconda guerra mondiale, quel conflitto dopo il quale il mondo non fu più lo stesso, il modo di pensare cambiò radicalmente, un antica civiltà, quella contadina, venne a sparire.
Il mondo di Pardini è un mondo di montanari, di gente talmente radicata sulla terra da esserne parte, un microcosmo che va dal pastore al tipico balordo di paese, una realtà purtroppo scomparsa in una umanità che corre sempre più veloce senza un perché; il mondo di Pardini ha ritmi lenti, più a misura d’uomo e infatti non emergono nei personaggi problemi psicologici, quali le depressioni; il mondo di Pardini è un mondo che non abbiamo mai conosciuto o che nella migliore delle ipotesi abbiamo dimenticato, un modo di vivere, una civiltà, oserei dire, improntata alla sacralità della natura, scandita dal ritmo delle stagioni.
I racconti sono in tutto sedici, qualcuno breve, altri assai più lunghi, e, come sempre succede in questi casi, pur a fronte di un livello qualitativo di eccellenza ce ne sono che piacciono di più, o di meno. Dal mio punta di vista dico che se dovessi scegliere mi troverei in imbarazzo anche se, in fondo, preferisco una prosa in cui siano presenti tutte le caratteristiche dell’autore, quel suo fil rouge che ripropone sotto svariate forme, e allora sono dell’opinione che quello che più mi ha colpito sia uno abbastanza breve, Il carrettiere dei monti, che scorre davanti agli occhi come un dipinto sfumato, un qualcosa di semplice, ma al tempo stesso pregno di significato perché, a ben guardare, nella vicenda di Sassie, che da una vita trasporta il carbone con il carro trainato dal cavallo e con la compagnia di un cane, si intromette nel tempo il cosiddetto progresso che lo porterà a concludere, non solo come constatazione, che la sua vita non ha più un senso. Mancherei, tuttavia, di rispetto all’autore se non ponessi in opportuna evidenza l’ultimo racconto del libro, La morte del mulo, poiché questo sancisce in modo inequivocabile il legame con la natura, e in particolare con gli animali, che è sempre presente in ogni opera di Pardini; è una prosa che scandisce l’ultimo periodo di vita di un compagno silenzioso con cui fin dall’origine è stata avviata un’azione di reciproca comprensione; Giovale, così si chiama il mulo, con il suo silenzio e il suo comportamento parla molto di più di un individuo ciarliero e le pagine dedicate ai suoi ultimi giorni di vita, mai tese a ingenerare commozione, tuttavia lasciano il segno, tanto che, almeno a me, è capitato di affezionarmi quasi che fosse lì davanti a me; Pardini non sollecita lacrime facili, il suo è un dolore intimo, ma è inevitabile che nel vedere spegnersi un amico, un compagno di esistenza, si sia presi da un sentimento non facilmente definibile, un misto di commozione, di pietà e anche un po’ di dolore.
I periodi sembrano scaturire dalla penna dell’autore con assoluta naturalezza, poiché è sua la stessa lingua dei personaggi che popolano i racconti, è suo lo stesso ritmo del tempo che scandisce le loro esistenze, sono suoi gli occhi che si addentrano nella nebbia del tempo per mostrarci ciò che è stato e che mai ritornerà. Ed è per questo che la lettura, oltre che gradevole, è densa di significati, piano piano coinvolge chi ha la fortuna di scorrere queste pagine, di immergersi in una realtà sconosciuta di cui, giunti a fine libro, non potremo che avere nostalgia.
Indicazioni utili
L’ultimo Maigret
Questo romanzo ha una particolarità: stilato agli inizi del 1972 è l’ultimo in assoluto scritto da Simenon. E che l’ultima fatica dell’autore belga abbia come protagonista il celebre commissario Maigret non penso proprio sia un caso; il personaggio che lo fece conoscere al grande pubblico nel lontano 1931 chiude, nel migliore dei modi, una carriera letteraria ricca di successi e di soddisfazioni. Devo anche dire che il cosiddetto canto del cigno è senza ombra di dubbio uno dei migliori gialli scritti da Simenon, una vicenda strana, una storia di solitudini, con il commissario che, nel consegnare alla giustizia il colpevole di un omicidio non prova soddisfazione, anche per la pietà che ha nei confronti del reo e forse, ipotesi per nulla trascurabile, perché è consapevole che quella che ha appena concluso è stata la sua ultima indagine.
La vicenda, ambientata nei quartieri alti di Parigi, è quella di una coppia che si ignora, lui un ricco e famoso notaio che frequenta assiduamente i locali notturni, assentandosi da casa a volte anche per diversi giorni con una entraineuse che ha rimorchiato, lei, la moglie, una delle sue conquiste notturne, che si stordisce con l’alcool. Il marito non torna da una delle sue avventure, la moglie si preoccupa e interessa la polizia, e infine l’uomo viene ritrovato, morto ammazzato. Non vado oltre per non togliere il piacere della scoperta, ma ho dovuto anticipare questo succinto parziale riassunto per far comprendere l’ambiente e l’atmosfera in cui opera Maigret, un Maigret prossimo alla pensione e che rifiuta l’ambitissimo posto di direttore della polizia giudiziaria, un lavoro più da burocrate che da investigatore, in cui un peso non trascurabile ha la capacità di saper mediare, di essere diplomatici. Che il nostro commissario non accetti l’offerta mi appare scontato, perché è impossibile figurarselo dietro una scrivania tutto il giorno, a firmare carte, a distribuire incarichi, a tenere i rapporti con il ministro degli Affari interni. No, lui è un uomo d’azione, ama quel piacere perverso che prova chi indaga nel seguire una traccia, nel braccare un delinquente. Poi, come peraltro è accaduto altre volte, è uomo che non solo non ama infierire su chi assicura alla giustizia, ma rivela un profondo senso di pietà che se non ammette la possibilità di ignorare la verità e di lasciare andar libero un colpevole, tuttavia nemmeno lo induce a trarre motivo di soddisfazione dall’esito positivo della sua indagine. Direi, anzi, che questa caratteristica di Maigret lo rende unico fra i tanti investigatori creati dagli autori del genere, un brevetto quasi che gli dona una carica di umana simpatia. Maigret e il signor Charles è un romanzo molto bello, venato da una malinconia frenata a a stento, la malinconia che può prendere chi sta per lasciare una persona amica, una sua creatura che l’ha accompagnato per una quarantina di anni, meglio di una moglie, assai meglio di un figlio, perché in fondo non è altro che lo specchio dell’anima del suo autore.
Indicazioni utili
Due eroi piccoli piccoli
In occasione del centenario della ritirata di Caporetto si avvertiva la necessità che qualcuno si prendesse la briga di scrivere un romanzo su questo tragico evento ed era da troppo tempo che durava l’attesa, quasi esistesse un timore reverenziale di ideare una trama che facesse ben comprendere, oltre a quello che fu la realtà storica così ben tracciata in Caporetto di Alessandro Barbero, come accadde e anche perché avvenne. Non nascondo che le difficoltà di realizzare un’opera simile sono notevoli, un po’ per la naturale ritrosia nell’ammettere una nostra sconfitta, un po’ per il rischio di scrivere, anziché un romanzo corale, la massificazione di un evento disperso in tanti rivoli, tali da non consentire al lettore di farsi almeno un’idea. Bravo è stato Malaguti, anche grazie a un’impostazione che vede in alternanza capitoli ambientati in quei tragici giorni di fine 1917 e altri spostati nel tempo di non pochi anni, addirittura nel 1931, in cui si dipanano le indagini sulla misteriosa morte (incidente o omicidio) di un generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, rinvenuto cadavere lungo i binari della linea ferroviaria Firenze – Bologna. L’autentico colpo di genio è però di aver trovato, per ognuno di questi capitoli, un personaggio, un protagonista, il Vecio che è un militare ormai rotto alla guerra e l’ispettore di polizia Ottaviano Malossi, a cui è stato affidato il caso, una patata bollente che può sancire il suo avanzamento di carriera, come può anche travolgerlo. Si tratta di personaggi indovinati, assai ben descritti, con una analisi psicologica fine e approfondita, due individui che si riveleranno, pagina dopo pagina, dei piccoli eroi, gente che compie atti di grande significato in totale silenzio, senza enfasi e che soprattutto non avrà medaglie. Nei capitoli relativi alla ritirata, ognuno dei quali è dedicato a una vittima della repressione poliziesca che ha rappresentato una delle caratteristiche della Grande Guerra, la figura del Vecio, nel suo silenzio, esprime tutta la sofferenza di chi è rassegnato a morire ogni giorno; ci sono pagine che riescono a trasmettere al lettore, palpabilmente, lo sfacelo di quelle giornate di fine ottobre e inizi novembre, le nefandezze di cui l’uomo può essere capace quando tutto si disgrega, la carne da cannone che si ribella per ridiventare subito di nuovo bestia destinata al macello. Nelle parti invece spostate nel tempo si riesce a percepire tangibilmente l’atmosfera oppressiva di una dittatura, capace di distruggere i suoi strumenti, uno dei quali è appunto l’ispettore, per fini oscuri e comunque non nell’interesse del popolo. Sembra quasi un destino, e infatti lo è, che questi due personaggi vengano a incontrarsi, a trasmettersi i reciproci dolori, lo sdegno per aver compreso che la loro vita è quella di pedine manovrate da altri. Sono pagine stupende, che mi hanno commosso profondamente, e che concludono nel migliore dei modi un romanzo che non ha nulla da invidiare a due capolavori della letteratura sulla prima guerra mondiale: Niente di nuovo sul fronte occidentale e Un anno sull’altipiano.
Non credo sia necessario che aggiunga altro, se non la raccomandazione a leggerlo, per comprendere che in guerra ci sono anche eroi della pace.
Indicazioni utili
Sacrificio rituale
Il vecchio della montagna apparve nell’anno 1900 edito da Roux e Viarengo e quindi prima di altre opere che potremmo definire maggiori come Elias Portolu, Cenere, Marianna Sirca e soprattutto Canne al vento. All’epoca Grazia Deledda aveva 29 anni, ma si era già fatta apprezzare per alcune novelle ispirate alla vita solitaria dei pastori e in effetti anche questo romanzo è di ambientazione e di atmosfera pastorale, in una drammatica vicenda di amore e di gelosia, nonché di morte, che si svolge fra Nuoro e le montagne intorno. Pur se è indubbio che l’aspetto folcloristico costituisca un elemento di attrazione dell’opera, delineando un mondo che era sconosciuto senz’altro a chi risiedeva sul continente, tuttavia a partire da questo scritto l’analisi dell’autore va più in profondità, scoprendo i collegamenti esistenti in un particolare contesto sociale con le pulsioni proprie di ogni essere umano. Se i personaggi sono pochi, questo va tutto a vantaggio di una loro più dettagliata descrizione, in uno sviluppo in cui l’eterno contrasto fra Eros e Thanatos raggiunge aspetti simbolici di notevole effetto, come nel caso del vecchio cieco che, per essere utile al figlio e quindi per testimoniare in suo favore per discolparlo dell’accusa di abigeato, si mette in moto da solo per scendere dalle montagne e raggiungere Nuoro. In un ambiente già di per sé ostile a chi vede bene la cecità costituisce un ostacolo insormontabile, tanto che, vagando fra le rocce, precipita in un burrone. Questa morte, normalmente considerata un incidente, assume tuttavia una valenza del tutto particolare, cioè quella di un rito purificatore, come se il vecchio avesse offerto la sua vita affinché le tensioni venissero meno e le passioni, così estreme, finissero con il placarsi. Quindi, in una storia d’amore travolgente, culminata in una tragedia, si passa dal fortunale alla bonaccia, con la tempesta placata da un sublime atto d’amore, quello di un padre per il proprio figlio, disposto a tutto, anche a morire pur di salvarlo.
Il romanzo appare come una linea di demarcazione fra le sperimentazioni precedenti e le strutturazioni successive sempre improntate a tematiche ben precise, quali la fatalità o il destino che regolano ogni evento della vita, la potenza atavica della passione che conduce inevitabilmente alla colpa, il sacrificio estremo, eroico, disinteressato che rimette le cose a posto. Ecco perché Il vecchio della montagna se può essere considerato un romanzo minore di Grazia Deledda è tuttavia importante, costituendo una pietra miliare nella produzione della narratrice sarda.
Il tal senso e anche per meglio comprendere le opere successive la lettura di questo libro è a mio avviso senz’altro consigliata, con l’avvertenza che è inutile attendersi un capolavoro, ma che già è possibile valutare l’opera sulla base di quei criteri che portano a considerare la narrativa di Grazia Deledda di un livello di eccellenza che non a caso ha costituito la prerogativa per il conferimento del premio Nobel per la letteratura, avvenuto nel 1926, e che fino a ora rappresenta l’unico caso dello specifico riconoscimento per una scrittrice italiana.
Indicazioni utili
Originale, ma non un capolavoro
E’ indubbio che Italo Calvino sia stato uno dei più importanti narratori e intellettuali italiani del novecento, mai fossilizzandosi su una corrente letteraria, ma sempre pronto ad aderire alle nuove tendenze, sia pur tenendo una linea autonoma e volta a ulteriori approfondimenti. Forse più noto al grande pubblico per il periodo fantastico (Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato) riveste successivamente un ruolo di primo piano in un nuovo modo di fare letteratura, interpretata ora come puro artificio, ora come gioco combinatorio; in quest’ultimo caso la scrittura si definisce combinatoria perché il sistema che consente di scrivere non è più un mezzo, ma assume un ruolo prioritario all’interno della produzione letteraria. In poche parole per Calvino l’aspetto linguistico ha di fatto estromesso la realtà e così il romanzo non è altro che un meccanismo risultante da un gioco artificioso praticato combinando le parole stesse. E’ in quest’ottica che nel 1972 scrive Le città invisibili e nel 1979 Se una notte d’inverno un viaggiatore, opera quest’ultima in cui accentua il meccanismo combinatorio, intraprendendo una ricerca sulla scrittura in sé e soprattutto sui vari ed eterogenei rapporti fra autore e lettore. Nel romanzo sono presenti dieci spunti, o meglio ancora dieci indizi, ognuno corrispondente a un diverso tipo di narrazione; la struttura è imperniata su un lettore che tentando di leggere un romanzo dal titolo Se una notte d’inverno un viaggiatore è costretto, per motivi sempre diversi, a interrompere e a passare a un altro testo. L’opera, congegnata in tal modo, diventa un vero e proprio esercizio, o meglio ancora un gioco letterario, in cui ciò che più conta è la schematicità a incastro piuttosto che i contenuti, insomma, a voler ben guardare, è il risultato di un lavoro intellettuale al servizio degli intellettuali. Secondo me, pur ravvisando tanti meriti, questo è il suo limite, perché in effetti si tratta di un lavoro che ha una sola finalità: se stesso. Apprezzabile, indubbiamente, originale, su questo non ci piove, ma la fine arguzia, la satira precisa con le metafore del periodo fantastico per me sono altra cosa; posso apprezzare l’abilità stilistica dell’autore in Se una notte d’inverno un viaggiatore, ma non mi emoziono, come se mi trovassi di fronte a una bella donna, fredda al punto tale da impedirmi di accendere la passione.
Non metto in dubbio la grandissima abilità di Calvino, ma può anche essere che io sia un lettore difficile, con esigenze mie peculiari che non coincidono con quelle di molti altri, ma più di considerare questo romanzo un bel libro non mi sento; non mi va insomma di gridare al capolavoro.
Indicazioni utili
L’ironia di Maigret
Nel 1933 Georges Simenon, autore ormai noto per sua fortunata serie di polizieschi con protagonista il commissario Maigret, consapevole delle sue qualità di narratore, decide di cimentarsi con altri generi, insomma di diventare uno scrittore più maturo e più autorevole. Per far questo deve sbarazzarsi di quell’ingombrante investigatore non scrivendo più di lui e, dato che il momento delle scelte decisive è arrivato, abbandona addirittura quell’editore che fino ad allora aveva pubblicato i suoi lavori e si affida a un mostro sacro, quale era e quale è ancora, vale a dire la Gallimard. L’abbandono però di un personaggio che gli ha tenuto compagnia e che gli ha dato anche fama deve essere stata tuttavia dolorosa, tanto è che decide che è sempre possibile farne ancora oggetto di pubblicazione, però limitatamente a racconti da far apparire sulla stampa periodica. Ed è appunto di quel periodo il fiorire di tante prose brevi che, riunite a gruppi di 4 o 5, a volte anche più, vengono riproposte da Adelphi. Peraltro, questo taglio non definitivo con Maigret farà sì che in seguito il corpulento commissario ritorni oggetto di produzioni più corpose, ovvero di romanzi.
Assassinio all’Etoile du Nord, unitamente ad altre prose brevi, risale appunto a quel periodo di transizione; peraltro tutti e quattro i racconti sono accomunati dal fatto che il commissario è diventato l’ex commissario, essendo andato in pensione. A onor del vero, e mi scuso per l’imprecisione, il primo (Assassinio all’Etoile du Nord) vede ancora Maigret al Quai des Orfèvres, a a 48 ore dal suo definitivo congedo, allorché, nel suo ufficio, ha l’imprudenza di rispondere a una telefonata, avviando e concludendo quella che sarebbe stata la sua ultima indagine ufficiale.
In Tempesta sulla Manica l’ex commissario, in villeggiatura con la moglie in un alberghetto in riva al mare, aiuterà un collega a risolvere un non facile caso di omicidio; con La signorina Berhte e il suo amante avrà modo di sfoderare ancora una volta la sua fine indagine psicologica e di favorire l’unione fra un uomo e una donna che si amano; infine in Il notaio di Chateauneuf si vedrà costretto, suo malgrado, nelle intricate vicende della famiglia di un notaio.
I quattro racconti sono anche accomunati da una sottile vena di ironia con l’ex commissario che sembra fare la parodia del commissario Maigret, gigioneggiando, ma mettendo in ombra, oltre che altri poliziotti, anche ogni personaggio, fatta eccezione per la moglie, tuttavia sempre disponibile a farsi da parte per accontentare il marito.
La lettura risulta veramente gradevole, anche perché non è raro sorridere, con questo ingombrante protagonista che non ha nessuna intenzione di fare la vita del pensionato, pronto a cogliere le occasioni che gli si presentano per rientrare, sia pure ufficiosamente, nei panni del grande investigatore.
Indicazioni utili
Indagini a Liegi
Decimo romanzo con protagonista Maigret La ballerina del Gai Moulin è un giallo del tutto atipico, presentando un intreccio complesso, un groviglio vero e proprio e per dipanarlo il nostro commissario, nella speranza di una mossa falsa di un omicida, dovrà prima farsi rinchiudere in prigione, come presunto colpevole, poi addirittura mettere in scena un finto suicidio nel commissariato di polizia di Liegi, città in cui si svolge l’intera vicenda e che, guarda caso, è dove è nato Simenon.
Ma La ballerina del Gai Moulin, per certi aspetti, pur restando un poliziesco, ha in serbo una prima parte da autentico noir con due soggetti verso cui è indirizzata la sottile e approfondita analisi psicologica dell’autore.
Se l’atmosfera e l’ambientazione sono impeccabili, tuttavia si deve lamentare una struttura abbastanza debole, con una trama che avrebbe meritato ben maggiori attenzioni e che invece finisce con il determinare uno sviluppo traballante della vicenda, quasi che a un certo punto fosse scappata di mano a Simenon. Si arriva certo alla conclusione, a Parigi, da dove era partito Maigret,
ma è un po’ stiracchiata, così che il romanzo merita più per lo sfondo, per le caratterizzazioni, per le atmosfere, che per l’aspetto poliziesco vero e proprio. Poco male, tuttavia, perché così è possibile cogliere le altre qualità dell’autore, fermo restando che la lettura rimane nel complesso soddisfacente.
Indicazioni utili
Un giallo solo discreto
Nono romanzo dedicato al personaggio del commissario Maigret All’Insegna di Terranova fu scritto nel 1931 a bordo dell’Ostrogoth, il cutter con cui Simenon navigava lungo i canali francesi. Forse è anche per questo che romanzo trasuda di marineria benché la trama si svolga esclusivamente a terra e sia relativa a un tipico triangolo amoroso, in cui gli uomini appaiono le vittime in tutti i sensi, visto che uno viene assassinato al ritorno di una lunga stagione di pesca e l’altro tenta addirittura di uccidersi, senza tuttavia riuscirvi. Al di là della vicenda, che si concluderà con un nulla di fatto, nel senso che Maigret preferirà non assicurare alla giustizia l’omicida, vi è da rilevare la posizione del commissario, fuori sede, chiamato da un compagno di scuola per cercare di scagionare un giovane che si ritiene innocente e che condurrà in sordina e non ufficialmente le indagini a Fécamp, amena cittadina di villeggiatura in riva all’oceano, ove si trasferirà temporaneamente unitamente alla moglie con il pretesto di una settimana di vacanze.
Il giallo si lascia leggere, nel senso che non è uno dei migliori di Simenon, anzi a mio avviso è solo discreto, perché i personaggi mancano di spessore, sono un po’ stereotipati e poi francamente la tensione è pressoché assente. Inoltre, siamo ancora lontani da quella straordinaria capacità del narratore belga di sondare l’animo umano fino negli anfratti più nascosti; a ciò aggiungo che la cura, più volte ravvisata, nel descrivere i paesaggi e nel ricreare le atmosfere qui appare un po’ imprecisa, quasi che l’autore non intendesse applicarsi più di tanto.
Comunque il romanzo va più che bene per trascorrere qualche ora di gradevole lettura.
Indicazioni utili
L’apatia dell’omicida
Elie Nagear, un trentacinquenne di origine turca, arriva a Bruxelles con la speranza di far fortuna, ma gli affari non vanno bene. E’ accompagnato da Sylvie, che fa l’entraineuse, ma fra i due non c’è amore, solo tolleranza. Bisognoso di denaro, nel corso di un viaggio notturno in treno da Bruxelles a Parigi uccide barbaramente un olandese, derubandolo di una ingente somma in franchi francesi. Per mettersi al sicuro, accetta il consiglio di Sylvie e si nasconde in una pensioncina familiare di Charleroi, gestita dalla madre della donna.
Questo, in breve, è l’antefatto, necessario per costituire il presupposto indispensabile per narrare una storia in cui il protagonista non è solo Elie, ma anche la variegata e variopinta umanità che popola la pensioncina di Charleroi, un rifugio a tutti gli effetti, dove il giovane turco, per sua natura apatico, si crogiola nel calore della stufa, mentre fuori si gela e il paesaggio è monotonamente rappresentato dall’alternarsi del bianco del ghiaccio con il nero della polvere di carbone. In questa tana, perché in effetti di tana si tratta, Elie, la belva, che ha ucciso con freddezza e che non avverte sensi di colpa, si accorgerà ben presto di non essere così al sicuro come crede e spera; intorno a lui il cerchio si stringe e non basterà l’affetto quasi materno che gli mostra la madre di Sylvie per salvarlo dalla giusta punizione. Del resto l’apatia che lo caratterizza, quel lasciarsi trasportare dal vento della vita gli impediranno perfino di trovare soluzioni alternative, di cercare di sfuggire alla cattura. Ma anche gli altri personaggi, i pensionanti così ben descritti da Simenon, sembrano presenze che solo si sfiorano, sanno che il ragazzo si è macchiato di un orrendo delitto, ma continuano nella solita monotona vita quotidiana come se nulla fosse. Questo fa pensare che lo scrittore belga con questo suo romanzo intendesse stilare un preciso atto di accusa verso una società anonima, dominata dall’indifferenza, e forse è anche così, soprattutto se guardiamo ai nostri tempi dove questo disinteresse per ciò e per chi ci circonda è forse il peggiore dei nostri difetti. Come ho prima accennato l’unica che si dimostra interessata alla sofferenze esistenziale di Elie è la signora Baron, la madre di Sylvie, che è attratta dai racconti di un mondo lontano, quello turco, fatti dal ragazzo, unica possibilità di evasione dal grigiore opprimente di una vita sempre rinchiusa fra quattro mura e testimonierà, a sorpresa, questa specie d’affetto in un finale in cui emergono le grandi capacità descrittive di Simenon.
La trama è quella del noir, ma lo svolgimento rappresenta un tentativo di Simenon, in larga parte riuscito, di cimentarsi non esclusivamente come scrittore di genere e Il pensionante è un po’ il romanzo d’esordio di un autore che non si accontentava più di scrivere di Maigret, che desiderava fare un salto di qualità, lasciando un segno indelebile in campo letterario. Non era ancora il tempo per grandi opere come I fantasmi del Cappellaio o Il Presidente, tanto per citarne solo alcune, ma già si nota che l’autore è sulla buona strada, che quella capacità incredibile di sondare l’animo umano qui c’è, anche se è solo in nuce. Per concludere sono dell’idea che la lettura di questo romanzo sia senz’altro consigliabile e che anzi rappresenti il presupposto indispensabile per poter passare in seguito alle grandi opere di Georges Simenon.
Indicazioni utili
Sotto la cenere il fuoco arde ancora
E’ da un po’ di tempo ormai che ho l’opportunità di leggere la produzione poetica di Vincenzo D’Alessio, produzione che pur presentando tematiche affini denota una continua ricerca di uno stile che sia definitivo e non in continua, e pur positiva, evoluzione. Direi che ciò tuttavia poco importa poiché il poeta campano, pur senza disprezzare la forma, che anzi a tratti è ricercata, è uno che va alla sostanza, in quei continui strali verso una situazione di immobilismo storico di cui la malavita organizzata ha larghe e preponderanti colpe. La tendenza, quindi, è quella di realizzare una poesia civile, sempre dolente, ma mai arrendevole, ben inserita in un contesto territoriale che senza far identificare l’autore come un poeta stanziale, in ogni caso lo fa apparire come notevolmente influenzato da fatti e da atmosfere locali. E così che ritroviamo questo filo comune anche in questa raccolta (Dopo l’inverno e altre poesie), uscita come sempre per i tipi di Fara, tanto più ove si consideri la circostanza che l’opera si è classificata al secondo posto nel concorso Faraexcelsior 2017. Non si smentisce anche questa volta Vincenzo D’Aessio che sembra quasi portare sulla schiena l’eterno malanno dell’immobilismo meridionale, con quella rabbia a stento soffocata per i continui tradimenti subiti, per quella sofferenza talmente radicata che sembra escludere ogni speranza di miglioramento. Eppure, D’Alessio ha un sogno che è concretizzabile ed è quello di un mondo in cui ognuno possa essere artefice di se stesso, senza impedimenti, senza imposizioni da parte di chi si arroga il diritto di decidere della vita d’altri. Ed è per questo motivo che in questa raccolta, forse più sofferta di altre, si passa da versi come questi (Ho visto incedere / nelle loro casacche / tronfi i servi dello Stato / hanno lo sguardo / sprezzante di chi è arrivato / non arrossiscono / hanno pane per i figli / vivono giorni sereni / nell’avvenire / hanno potere senza giustizia / odiano i vinti / tolgono loro il respiro.), in cui lo sdegno, più che la rabbia, è a stento trattenuto, a questi altri (L’estate ritorna / nel fresco mattino, / la nebbia che ovatta. / La gente, i passi, / riprende un lavoro. / Vita in campagna. / In città una noia. / In campagna la vita. / Ogni estate più bella. / Tetti, spicchi d’arancio, / aprono fiati di torri. / Lavoro per sopravvivere. / Ogni anno un’ estate. / Vivere una nuova estate.) in cui è presente una situazione di normalità da cui traspare un senso di bucolica serenità. Appare quindi evidente che la speranza, morta ormai in molti, ancora cova sotto la cenere dei sogni infranti di Vincenzo D’Alessio, che continua imperterrito e mai domo nella sua missione volta a impedire che ci si dimentichi di questa terra che potrebbe essere altra cosa con una presenza forte e decisa dello stato, quello stato così lontano da udirne a malapena la voce fatta di vuota e insana retorica.
Da leggere, ovviamente.
Indicazioni utili
L’ultima dei Longobardi
All’inizio di questo romanzo l’autore riporta la genealogia di Leonide dei Longobardi, principale personaggio dell’opera stessa; si tratta di un numero rilevante di nomi, alcuni dei quali saranno propri di semplici comparse, ma altri invece corrisponderanno a individui capaci di brillare di una luce propria. Se devo essere sincero tutti questi personaggi mi hanno subito portato a un senso di disorientamento, memore dei racconti che mi faceva ogni tanto mia nonna, membro di una famiglia patriarcale assai numerosa, in cui abbondavano fratelli, sorelle, genitori, zii, nipoti, cugini, un vero e proprio esercito di cui lei ben conosceva i nomi che mi sciorinava e che più delle volte mi lasciavano perplesso per la confusione che mi veniva ingenerata. Poi, pensandoci bene, mi sono tolto ogni remora e mi sono detto di leggere senza preoccuparmi tanto di vedere come si ricollegavano i nomi, ma seguendo puramente e semplicemente le vicende, con particolare attenzione a quelle di Leonide Lusetti, la cui scomparsa avvenuta nel 1983 ha posto fine alla casata dei Longobardi. E’ una scelta di lettura, peraltro, che è quasi imposta perché il personaggio è del tutto particolare e intorno a lui ruotano i fatti, piccoli e grandi, di un secolo, il XX. Non è una novità narrare di un’epoca sulla base delle vicende di una famiglia, ma parlarne e riuscire a rendere avvincenti fatti in sé normali e non eclatanti non è facile, anzi denota una grande capacità, tanto più che a fronte di queste piccole storie sullo sfondo si muove la grande storia, la Grande guerra, l’avvento del fascismo, la seconda guerra mondiale, il dopoguerra di fame e di speranza, il benessere economico. Però la chiave di lettura dell’opera non è solo questa, perché prevede anche la descrizione della fine di una civiltà che non tornerà più, quella contadina, con quel legame profondo con la terra che fra timori e superstizioni in individui più sensibili, come appunto Leonide, porta a scoprire facoltà paranormali, ben oltre le asserite capacità di un medium, in quel confine indefinito fra vita e morte in cui tutti si agitano. La creatività di Pardini è indubbia, perché riesce a raccontare tanti fatti, imprigionandoli in una patina di tempo andato, una serie di fotogrammi che sollecitano il lettore ad andare avanti, per sapere, per conoscere. Quella che a un esame superficiale potrebbe sembrare una telenovela, in realtà sono le testimonianze di un’epoca non lontana in termini di tempo, ma ormai antichissima come modo di vita.
Credo che Pardini, con quel suo stile semplice e pur efficace, che definirei da naif, con questo romanzo sia riuscito a dare il meglio di se stesso, realizzando un’opera di sicuro interesse e che merita ampiamente di essere letta, anche perché, nonostante tanti personaggi, è riuscito a differenziarli perfettamente, sempre però facendoli apparire come propri della loro epoca, con i loro difetti, i loro pregi, i loro sogni e le loro speranze.
Per quanto concerne il tema della natura, da sempre ricorrente nelle opere dell’autore, in questa ha assunto un rilievo del tutto particolare, presentata a volte come diabolica, altre come mite e sereno corollario, il tutto solo ed esclusivamente secondo quello che in un determinato momento è lo stato d’animo dei personaggi; in ogni caso la descrizione dei panorami assume toni poetici e le atmosfere sono rese così bene da ottenere la partecipazione del lettore.
Ritornare indietro nel tempo, di cui solo in parte si è avuta esperienza diretta, è un po’ ricercare le proprie radici che non sono dissimili, nella zona toscana in cui è ambientato il romanzo, dalla zona lombarda in cui sono nato e abito. Al riguardo ho notato che, nel ricordo dei racconti di mia nonna, ci sono tanti punti di contatto, per quanto concerne per esempio la superstizione, ma anche per quanto riguarda certe figure che, in possesso di una vena poetica e di uno spirito acuto di osservazione, tanti anni fa vergavano delle pasquinate riferite per lo più a questioni di corna, operette satiriche anonime, ma di cui era possibile intuire il nome dell’autore; ebbene, anche nel romanzo ce ne sono diverse, stilate da Pardini, e devo dire che mi hanno divertito, cogliendo anche il loro scopo o di rafforzare una proposizione, oppure di stemperare la tragicità di certi eventi.
Non aggiungo altro, perché non ce n’è bisogno; l’opera vale molto di per se stessa, come potrà constatare chi avrà il piacere di leggerla.
Indicazioni utili
Un sogno per vivere
Il libro consta di 36 brevi racconti, degli autentici quadri in cui l’autore ritrae splendidamente paesaggi e atmosfere di una città che ogni giorno muore per poi rinascere. Credo che nessun altro libro sia in grado di descrivere così precisamente l’autentico spirito dei napoletani, legati indissolubilmente alla loro città tanto che viene da pensare che Napoli non ci sarebbe se non ci fossero i napoletani. E’ un vincolo talmente stretto che induce la gente a vivere in ristrettezza o quasi di niente per il puro piacere di vivere lì; certo ci sono racconti che sembrano ben poco realistici, tanto dall’indurre a pensare che l’autore se li sia inventati, e invece sono veri, anche laddove possono sembrare falsi, perché in questa eterna città tutto ciò che altrove pare parto di fantasia si realizza sotto gli occhi e se proprio non è esistito l’abitante di una casa bombardata che si è adattato a vivere nella buca provocata dall’esplosione della bomba, si può star certi che nell’arte di arrangiarsi i napoletani sono insuperabili. La Napoli dei miracoli, veri o falsi, in cui tanto la gente vuole credere per fuggire l’amara e dolorosa verità di ogni giorno, la Napoli delle viuzze, delle piazzette dove il sole con estremo sforzo riesce ad arrivare, questa è Napoli: miseria e splendore, intensa sofferenza interiore che esplode in quelle che riteniamo originalità, ma che di fatto rappresentano uno sfogo, come quella dimestichezza con la morte che, se serve a esorcizzarla, consente comunque di rendersi conto che non è altro che una tappa della vita. In tal senso richiamo l’attenzione su Ninna nanna a una signora, in cui Don Alfonso Corrado Mazzullo conversa con la morte e le dice queste profonde parole: “Volevo morire quando nacqui, per avvolgimento del cordone ombelicale intorno al collo, mi fu concesso? Volevo morire di emottisi a tredici anni, ne ebbi maniera? Volevo morire cento altre volte. Ora spetta a me decidere: ora sono io che non voglio.” E’ un capovolgimento dei ruoli, è l’illusione di poter diventare artefici del proprio destino e che nella sofferta condizione di predestinati fa sì che nei napoletani ci sia un filo di speranza, sempre e ovunque presente, con quel desiderio di potersi rialzare dopo ogni caduta, non disgiunto da una pazienza infinita che consente di sopportare tutto pur di non perdere questa speranza. Sono trentasei racconti, sono pagine che, oltre che appassionare, entusiasmano, anche quando si tratta di ricordi personali dell’infanzia povera dell’autore, come nel caso di I parenti ricchi, parenti serpenti verrebbe da dire nel leggerlo, ma la prosa che più di tutte spiega così bene lo spirito dei napoletani è proprio L’oro di Napoli, con Don Ignazio Ziviello che riesce a rialzarsi dopo ogni caduta della vita, che ogni volta sembra sia quella buona, ultima, definitiva, un’autentica morte morale civile, da cui tuttavia ne esce, risorge, come un’ araba fenice.
Da leggere, è più che consigliato.
Indicazioni utili
Un mondo d’acqua
Confesso che più passa il tempo, e più mi accorgo che il mondo è sommerso da un’ondata di materialismo che soffoca emoziona e sentimenti, sono tentato non solo di non scrivere più poesie, ma addirittura di non leggerne ancora. A che pro aprire il proprio animo? Che senso può avere trasmettere sensazioni e sentimenti? E invece è proprio quando l’umanità viene compressa, appiattita che si avverte maggiormente il bisogno della poesia e allora caccio i cattivi pensieri e cerco di trovare un po’ di serenità con i versi di qualche poeta. Non sempre ci riesco, perché, pur riconoscendo l’impegno che un autore profonde nella sua opera, i risultati non sempre sono corrispondenti; però, quando il lavoro è eccellente si avvera il miracolo, si entra in sintonia con il poeta e ci si immerge in un oceano di trepidanti emozioni, come nel caso di questa raccolta di Donatella Nardin. Terre d’acqua è una silloge stanziale, cioè è in dipendenza del luogo in cui l’autore vive e in questo non c’è nulla di strano, perché l’ispirazione è sempre data dal mondo che ci circonda, l’abilità invece è nel saper cogliere e, soprattutto trasmettere, le emozioni che quel mondo suscita in chi è capace di osservarlo e di coglierne l’essenza. Cavallino Treporti, dove è nata e vive Donatella Nardin, è una lingua di terra bagnata dall’Adriatico e dalla laguna nord veneziana, un dito che emerge dalle acque. Se questa superficie liquida può talora dare l’impressione di in una indeterminazione degli spazi, una distesa che si perde in un orizzonte che appare sempre più lontano, pur tuttavia consente a chi lì vive di cercare spazi più ristretti o anche più ampi, ma comunque non piatti, scavando all’interno di se stessi, in una condizione che si può ritrovare anche negli isolani. In buona sostanza, non distolti da un variegato panorama, c’è più ampio spazio per la fantasia che poi si concretizza nella creatività, con visioni magari oniriche ( Ho passato la notte ad ascoltare / il silenzio. Brillava ai vetri la luna. / Era una giovane luna nata / da una terra d’acqua e di sogni, tangibile emblema d’invisibili / pluralità./...) o comunque in un’osservazione incantata di ciò che gli occhi possono cogliere, soprattutto nelle caratteristiche di certe stagioni (Beltà dei geli e delle invernali figure: / a passi brinati, leggeri si muove / il pomeriggio invernale / verso tramonti sempre più corti / punteggiati da un’insanabile / inanità. ). La sua è una poesia evocativa, non disgiunta tuttavia da elementi correnti di concretezza che finiscono per dare meglio risalto a una ben precisa tendenza naturalistica, capace di mostrare paesaggio esterno ed interno, il panorama di un istmo, quale è Cavallino Treporti, e ciò che l’autore porta in sé, frutto di un lavorio spesso inconsapevole e che lui stesso scopre nel momento del travaso di una sensazione, di un’emozione in versi. E’ una poesia d’acqua, sempre presente, avvolgente direi, e l’acqua è sempre stata simbolo di purezza, purezza che qui diventa di sentimenti, in un afflato con il liquido elemento che riesce a rendere partecipe il lettore.
Ne consiglio quindi la lettura.
Indicazioni utili
Voglia di tenerezza
«Mi chiedevo se ti andrebbe qualche volta di venire a dormire da me»
Una donna che propone a un uomo una cosa del genere fa supporre che in caso di accettazione ci si debba imbattere in pagine di erotismo sfrenato. Non è così, però, perché Addie, la donna che fa questa strana proposta, e Louis, il destinatario, sono due vedovi, avanti con gli anni, anzi decisamente anziani, il che non esclude però un risvolto sessuale, ma comunque lo rende poco probabile. In effetti, la solitudine di chi ha raggiunto una certa età impone che si debba trovare una via d’uscita, che si debba porre accanto alla propria persona un’altra, con cui colloquiare, scambiare opinioni, avere un piccolo, ma significativo contatto fisico. Non sarà amore nel senso più ampio del termine, ma di certo è affetto, è convivere i giorni di un’età che non consente di fare programmi a lunga scadenza. Il tema deve essere stato particolarmente sentito da Haruf perché ha scritto l’opera in pochi giorni, prima di morire, dipartita della cui imminenza doveva avere conoscenza, atteso che è riscontrabile nella scrittura una certa fretta che, se nulla toglie al piacere della lettura, però appare inusuale, considerata anche l’età dei protagonisti, più propensi naturalmente a tempi lenti. La stessa sensibilità riscontrata nei tre romanzi del ciclo del Canto della pianura è presente anche in questo testo, un’opera che, per quanto ambientata come le altre nell’immaginaria città di Holt, non può essere assimilata alle stesse, perché nel racconto della breve relazione fra Addie e Louis si avverte l’esigenza di imperniare tutto su di loro, nel senso che non ci sono tante storie parallele, ma un’unica storia, quei giorni, soprattutto quelle notti, trascorse insieme, a dispetto dei pregiudizi degli altri e che verranno interrotte solo dall’esigenza egoista e sciocca di un figlio adulto, ma che non diventerà mai maturo. Può darsi che il libro possa essere più compreso da chi ha una certa età, sta di fatto però che mi è parso che in questo ultimo canto l’autore abbia profuso tutta la sua energia, spremendo fino all’ultima goccia l’estro creativo. Lo stile è quello consueto, sobrio, per certi aspetti distaccato, ma questa volta nei personaggi di Addie e di Louis si avverte un po’ di partecipazione, una più marcata traccia dell’artista che ha vissuto con loro gli ultimi giorni della sua esistenza.
Haruf non vide stampata la sua fatica, perché il libro uscì postumo, e ciò accentua quella sensazione di umana pietà che si prova leggendo quelle pagine, in cui due esseri umani vogliono illuminare l’ultimo tratto di strada, mano nella mano, una voglia di tenerezza che possa dare ancor un senso a quel che resta da vivere.
Indimenticabile.
Indicazioni utili
Una visione originale della guerra
Mi ha incuriosito per il titolo, perché non sapevo che significato avesse la parola balipedio, ma è bastata una breve ricerca sul dizionario per sapere che con questo termine si indica un campo sperimentale per il tiro dei cannoni e comunque per altre esercitazioni a fuoco; inoltre, in occasione della ricorrenza (centenario) della nostra partecipazione alla Grande Guerra il romanzo era indicato da alcuni quotidiani fra quelli in tema meritevoli di lettura. Ciò premesso, mi corre l’obbligo di evidenziare da subito che Il grande balipedio, sebbene ambientato nel corso della prima guerra mondiale, è un po’ atipico e pur nella vicenda di una missione suicida non cerca di esprimere tanto una ferma condanna della guerra, che nemmeno viene esaltata però, ma tende a far apparire il conflitto come uno scontro di classe, secondo una radicata concezione marxista. La figura di questo tenente, di un ceto borghese alto, a cui la vita non ha riservato preoccupazioni e che lui conduce con indifferenza, quasi con apatia, e l’immagine dei soldati che comanda, proletari considerati in guerra come carne da cannone e in pace come carne da sfruttare, segnano un netto contrasto che, pur tuttavia, il fango delle trincee, il martellante tambureggiare dei cannoni, il vitto insapore e inadeguato finiscono per annullare, nella lordura di un mondo che nelle traversie di una guerra rappresenta la peggiore condizione possibile. Il tema non è facile e la politicizzazione di un fatto può risultare controproducente alle esigenze di una interessata e gradevole lettura. Purtroppo l’autore non è riuscito a dare al romanzo una struttura snella, appesantendolo con frequenti riflessioni del protagonista principale, a volte anche superflue, in quanto ripetitive di concetti esposti in precedenza. E non è un caso se le parti migliori sono quelle in cui emerge un contrasto, anche fisico, con i superiori, senza che ci sia necessità di esporre un pensiero sul fatto che il mondo è schematizzato in classi e che ogni classe, in particolari momenti, può imperare sull’altra. Un colonnello che sembra ricordare tanto il generale Leone di Un anno sull’altipiano, e un capitano, pazzo di paura, che crede di riscattarsi rubando le corazze della pattuglia addetta al taglio dei reticolati sono l’emblema dell’ottusità di chi, in un dato momento della storia, è investito di poteri non supportati da idonee capacità. Così se sono frequenti pagine di una particolare grevità, che mi hanno anche stizzito, sono tuttavia presenti altre che stimolano a proseguire nella lettura.
Nel complesso, direi che il libro è meritevole, ma senza alcuna enfasi, senza l’emozione di chi è convinto di aver avuto un consistente contributo al suo livello culturale; ci sono, come sopra precisato, meriti e demeriti, però c’è anche una rappresentazione della guerra un po’ diversa dalle solite ed è questa originalità il pregio maggiore.
Indicazioni utili
L’assurdità del pregiudizio
Fra i difetti degli esseri umani vi è anche il pregiudizio, cioè quel voler etichettare negativamente un altro gruppo di individui sulla base esclusiva dell’appartenenza al gruppo stesso. In proposito, ne sanno qualcosa gli ebrei che nei secoli sono stati quasi sempre discriminati e talvolta massacrati per il solo fatto di essere ebrei. Anche Yakov Bok, il protagonista di L’uomo di Kiev, è un ebreo, un uomo tranquillo, un po’ succube, e che, abbandonato dalla moglie, riesce a trovare lavoro come sorvegliante in una fabbrica di un industriale che lui ha salvato da sicura morte. Nel suo nuovo ruolo viene a inserirsi in uno specifico contesto e ambiente, così che provoca invidia, accentuata dal suo stato di ebreo. Ma ciò sarebbe sopportabile, perché da centinaia di anni gli ebrei, pur non essendo diversi dagli altri, sono emarginati, se non accadesse uno di quegli eventi capaci di scuotere e infiammare l’opinione pubblica: vicino alla fabbrica viene ritrovato il cadavere dissanguato di un bambino. Da lì ad associare il delitto a un presunto, e mai dimostrato, sacrificio rituale proprio degli ebrei il passo è breve e quale migliore rappresentante degli ebrei si può trovare se non il sorvegliante Yakov Bok, così invidiato e anche temuto dagli operai? Nella Russia zarista del 1911 il colpevole non può essere che lui, perché è il capro espiatorio ideale, l’essere capace di far emergere le pulsioni più sfrenate e inclementi dell’animo umano. Inizia così una vicenda kafkiana, perché da una parte c’è un magistrato, ammiratore di Spinoza come Bok e perciò improntato al senso della ragione che cerca di contrastare un’accusa impietosa, attirata da un possibile sviluppo di carriera e sostenuta dalla voce stridula del popolo, e dall’altra c’è lui, l’imputato, l’ebreo segnato a dito, colpevole in effetti di aver lasciato il ghetto per immergersi nel mondo dei “gentili”. Ci sarebbe da impazzire, e in effetti poco ci manca, in quella discesa nell’inferno, ma è proprio in questa occasione che Yakov si riscopre ebreo, e trova conforto nella recita dei salmi, ma, soprattutto, nella lettura dei Vangeli, laddove comprende che la sua posizione è come quella del Cristo in croce abbandonato dal suo Dio. Questa consapevolezza di essere l’ultimo degli uomini, senza l’appiglio di una divinità soccorrente, anziché abbatterlo, gli impone la ricerca di nuovo di Dio e questo gli permette di sopravvivere a anni di dura detenzione, di isolamento, di sofferenze fisiche e psichiche, fino a quando, venuta meno quella pressione politica che lo spingeva a confessare un delitto non commesso, viene posto in libertà. Da questa esperienza Yakov Bok uscirà senza danni, oppure no? L’autore volutamente non si pronuncia, lasciando al lettore la decisione; per parte mia credo che quella ricerca di Dio che l’ha salvato, che ha rappresentato un lumicino di speranza, non potrà che essere benefica, perché l’uomo che aveva creduto e auspicato di essere accolto nel mondo degli altri, ha ritrovato se stesso, non in quanto ebreo, ma come essere pensante e dotato di coscienza, il presupposto indispensabile per sentirsi parte non minoritaria del genere umano.
L’uomo di Kiev, premiato fra l’altro con il Pulitzer, è senz’altro un libro da leggere.
Indicazioni utili
Una biografia stupenda
Si è abituati al fatto che normalmente i testi di storia sono ponderosi e comunque di non gradevolissima lettura. Questo è in generale, ma se il saggio è scritto da Alessandro Barbero tutto cambia e così, pur nel rigoroso rispetto delle tracce storiche, si innesta uno stile, non privo di una salutare ironia, con il quale personaggi, vicende politiche, fatti militari diventano piacevolissimi da leggere. E’ anche questo il caso di Federico il Grande, una stupenda biografia del Re di Prussia del XVIII secolo che gettò le bassi di quella che poi, un centinaio di anni dopo, sarebbe diventata la Germania. E’ indubbio che la politica espansiva di Federico II di Hohenzollern meritasse un’attenta analisi storica, se non altro perché, con il senno di poi, in tutto l’Otto-Novecento si sono confrontate due posizioni diverse, e cioè Federico che ha lasciato un’eredità avvelenata alla Germania con il suo completo assolutismo, il suo militarismo, il suo vero e proprio culto, fanatico, del dovere che sovrasta la questione morale; oppure, all’opposto, Federico è la leggenda intorno alla quale si è costruita l’identità tedesca. Ma al di là di queste posizioni antitetiche che, pur tuttavia, presentano anche dei punti comuni, non mi sembra che a Federico II si abbia da imputare la nascita del nazismo e del terzo Reich; in fondo di monarchi assoluti ce ne sono stati tanti, magari di minor spessore, ma non per questo hanno gettato i semi di quella che sarebbe stata la tragedia del XX secolo. Eventualmente, se di colpe si può parlare, queste dovrebbero essere attribuite al Kaiser Guglielmo, che non contento di aver riunificato i tedeschi in una grande Germania voleva anche espandere in grande i confini della stessa. Ci può essere solo una certa assonanza fra la politica di Federico e quella di Hitler in quella volontà di trovare un nuovo spazio vitale a Est, ma le coincidenze finiscono qui. Quello che è interessante in Federico il Grande è Federico stesso che ci viene mostrato da Barbero nel corso della sua esistenza dall’adolescenza alla morte, un adolescenza che lo vide contrapposto decisamente al padre, salvo poi subentrato lui sul trono adeguarsi a quanto pretendeva il genitore. Era un uomo di controsensi: filosofo, amante dell’illuminismo, ma sovrano assoluto, di un assolutezza completa e rigida, amava leggere e scrivere, era un buon suonatore di flauto e un buon compositore di musica classica, l’altro sesso gli interessava ben poco, ma ciò non significa che fosse un omosessuale, era un gran lavoratore, entrava in ogni questione amministrativa e infine era qualcosa che all’epoca e anche in seguito delineò la sua leggenda, cioè era un grande condottiero. Ma non vinceva sempre, perdeva anche, spesso per ingenuità, e quando vinceva invece rivelava un intuito incredibile. Insomma un personaggio così non può che interessare gli storici, ma anche incuriosire i profani, i lettori alla ricerca di una conoscenza del passato. Barbero, con questo saggio, è in grado di accontentare chiunque voglia sapere chi fosse Federico II, chiamato il Grande, un protagonista assoluto della sua epoca, ma il cui influsso, come ho accennato in precedenza, si è esteso anche ai secoli successivi.
Non mi resta che augurare buona lettura, certo che “buona” lo sarà senz’altro.
Indicazioni utili
Il poeta vede a occhi chiusi
E’ da un po’ di tempo che seguo la produzione di questa poetessa e posso senz’altro dire che si presenta in continua evoluzione, e non solo per le tematiche affrontate, ma anche stilisticamente. Sì, Angela Caccia non è uno di quegli autori che si considerano arrivati, finendo poi con il riposare un po’ sugli allori, bensì ha compreso che c’è ancora tanto da esplorare dentro il suo mondo interiore, così che ogni volta che si accinge a scrivere dei versi è una ulteriore sfida con se stessa, con ciò che sente e che vuole esprimere, con quello di cui ha appena una percezione e che vorrebbe cosi tanto schiarire, fare a uscire da quell’oscurità per avere ulteriori certezze. E’ anche questo il caso di Accecate i cantori, titolo in verità un po’ spiazzante, tanto che prima di leggere le poesie contenute in questa raccolta mi sono immaginato tanti bambini dalle candide voci privati degli occhi, accecati insomma. Ovviamente non è che Angela Caccia sia sadica e pertanto quell’accecate è in senso figurato, quasi a voler dimostrare che il poeta-cantore per vedere chiaro deve chiudere gli occhi. E in un certo senso è vero, perché la realtà dell’artista è un’immagine riflessa nel suo “io”, deformata, rivisitata, sensibilizzata, il tutto in un lavorio, probabilmente di neuroni, di cui il poeta non ha la precisa scelta o volontà; è un qualche cosa che nasce d’improvviso, una scintilla che poco a poco si fa luce; la creatività sembra indipendente, e in effetti lo è, dalla volontà dell’artista, come se dentro lo stesso ci fosse un altro, un puro spirito che si risveglia. In quest’ottica, pertanto, nascono le poesie, si stemperano le sensazioni e le emozioni nella penna che corre sul foglio e infine non è raro che l’autore stesso, a lavoro concluso, si meravigli del suo risultato. Per il resto il mondo di Angela Caccia è fatto di ombre che riemergono dal passato, da quei ricordi che il tempo in noi ha rielaborato e che l’abilità dell’artista ripropone nel loro significato, privo di perniciosi paludamenti, un’integrità di sostanza che sapientemente proposta si fa poesia. A dire ciò può sembrare avulso da una realtà obiettiva, potrebbe anche dare l’impressione di un astruso ragionamento di un pretenzioso aspirante critico letterario, ma per fugare questo dubbio non c’è di meglio di leggere questa raccolta, di assaporare verso dopo verso la prospettiva esistenziale dell’autore e in tal senso credo che un assaggio valga più di mille parole: "Ci vuole una minuziosa / e paziente / esperienza al male / quanto basta / per imparare a difendersi dalle parole / dalle mani spaiate / entrambe dispari incapaci di una stretta / dalla natura servizievole della compassione / dal fiore senza giardino / che vive e muore nello spazio di un vaso / non ci addestra mai al dolore / al male sì / per fronteggiarlo in qualche modo.".
Non mi resta che augurare buona lettura.
Indicazioni utili
Senza capo, né coda
Di questo autore avevo fino a ora letto Gorky Park, un romanzo giallo ambientato a Mosca e con protagonista il capo della Polizia Criminale Arkady Renko che poi sarà presente in altre sue opere. All’epoca il libro mi era piaciuto, pur se avevo ravvisato una certa grevità che ne alterava il ritmo naturale, pesantezza riconfermata nella trasposizione cinematografica del regista Michael Apted con interpreti del calibro di William Hurt e Lee Marvin.
Pertanto, quando ho avuto per me mani La ragazza di Venezia ero un po’ prevenuto, insomma temevo di incorrere in una lettura , magari piacevole, ma non certo snella, e invece mi sono sbagliato, purtroppo. Infatti mi sono trovato alle prese con un romanzo senza capo, né coda, per quanto la vicenda della ragazza ebrea che sfugge ai suoi aguzzini alla fine della seconda guerra mondiale e trova rifugio nella laguna di Venezia avrebbe potuto essere l’occasione per un’opera di spessore in cui venisse evidenziato il cieco fanatismo dei nazisti in prossimità della loro fine con il proposito dell’annientamento di una razza da effettuarsi fino all’ultimo respiro. Invece, non c’è nulla di tutto questo, c’è una storia dal sapore giallo, in cui predomina una fantasia sfrenata dell’autore che fa viaggiare i personaggi da Venezia a Salò e ritorno, con un retroscena che dovrebbe essere di spionaggio, ma che è talmente male abbozzato che anziché interessare rende meno attraente la lettura, che appassionata non può essere, perché l’ambientazione e l’aria che si respira è fasulla, ricorda quella di certe produzioni cinematografiche americane, senza contare alcune ingenuità e anche qualche errore storico. E la conclusione nella laguna, che dovrebbe ingenerare un pathos, fa invece ridere, perché del tutto impossibile.
Non mi sento pertanto di consigliare la lettura di un libro che giudico decisamente mediocre.
Indicazioni utili
Il senso della vita
Già dalla prima pagina mi è sembrato di ritornare a casa, perché Holt, questa cittadina immaginaria che tuttavia assomiglia a tante località americane a carattere prevalentemente rurale, per certi aspetti rispecchia il paese dove abito. Anche lì, come qui, si nasce, si cresce, si fa l’amore e si muore, ma gli abitanti non sono le anonime ombre che si agitano freneticamente in una metropoli, hanno un volto, un nome e anche un carattere. Non c’è nulla di eclatante nelle esistenze descritte da Haruf e proprio per questo, per quanto immaginate, sono palpabilmente vere, ma l’aspetto straordinario è che i semplici eventi che accadono appassionano, però non come in una telenovela, di cui si vuol sapere il seguito di ogni puntata già immaginandolo dapprima, no, tutt’altro. E’ il modo semplice, ma estremamente efficace con cui vengono descritti i personaggi, è la delicatezza con cui vengono mostrati i sentimenti, è quel senso di rispetto, ma anche di umana pietà, verso ciascuno dei protagonisti che fanno di questo romanzo un gioiello. Prendiamo i fratelli McPheron, rimasti orfani da giovani e che conducono un allevamento di bestiame in una vita che è solo lavoro, perché non hanno mai conosciuto la gioia dell’amore; sembrano quasi misogini, rinchiusi in un bozzolo auto-protettivo, eppure accettano di ospitare una ragazza incinta che la madre non vuol più vedere. All’inizio sono preoccupati, ma non tanto per l’impatto che la presenza di un ospite potrà avere nella loro casa, bensì per il timore di essere inadeguati, di non essere capaci di comunicare. Poco a poco i nodi si scioglieranno e la famiglia (sì, la famiglia, perché finiscono per andare oltre una normale convivenza, come quando, se pur impacciati, trepidano nell’attesa del parto) sarà la prova evidente che i legami vanno oltre quelli di sangue, ricomprendendo il reciproco rispetto e un po’ di umano affetto.
Haruf è un grande scrittore, perché il rischio di cadere in una telenovela c’era, ma lui abilmente si è tenuto alla larga, da buon burattinaio che non si vede, ma di cui si intuisce la presenza, ha manovrato i suoi personaggi, ci ha fornito spaccati di vita vera con una serie di piccole storie che finiscono con l’intrecciarsi, con protagonisti che si ritroveranno poi anche negli altri due romanzi della trilogia. La lettura non stanca mai e procede naturalmente secondo il ritmo per lo più blando che l’autore ha impresso alla sua opera.
Così si arriva alla fine senza accorgersi, indubbiamente soddisfatti, ma anche dispiaciuti di non poter andar oltre; non c’è da preoccuparsi, però, perché ci sono ancora Benedizione e Crepuscolo, entrambi egualmente belli, anche loro ambientati a Holt, un luogo che sembra quasi magico perché lì la vita segue il ritmo delle stagioni, perché lì in fondo si vive veramente, perché in ogni azione e in ogni sentimento c’è il senso profondo di sapere in che consiste l’esistenza, in quella strada lungo cui si cammina dall’alba al tramonto, un destino comune che dovrebbe invogliare a soccorrerci, a darci una mano, proprio come fanno tanti personaggi di questa grande trilogia.
E’ un capolavoro, non aggiungo altro.
Indicazioni utili
Non solo annegati
A Georges Simenon non si può di certo rimproverare una scarsa creatività, visto che solo per le prose che hanno come protagonista il commissario Maigret ha scritto 75 romanzi e 28 racconti. Questi ultimi non sono delle semplici e succinte narrazioni, bensì sono piuttosto lunghi e completi, poiché sono relativi a indagini complete, tanto che, molto spesso, mi sono chiesto il motivo per cui l’autore belga non abbia ampliato maggiormente il discorso raggiungendo la dimensione del romanzo vero e proprio. Al riguardo credo che in taluni casi sia subentrata una certa dose di stanchezza, non improbabile in uno scrittore così fecondo. E’ pertanto da affrontare con i soliti criteri di lettura utilizzati per Simenon anche questa raccolta di racconti (in tutto quattro) di cui uno, la Locanda degli Annegati dà il titolo all’intera opera.
Il primo, L’innamorato della signora Maigret è quel che si può definire una spy-story, con il commissario che, quando riesce a trovare il bandolo della matassa, deve passare il caso ai servizi segreti francesi. Si fa apprezzare perché all’indagine partecipa anche la signora Maigret ed è divertente vedere come la collaborazione fra moglie e marito presenti dei risvolti se non proprio comici, almeno ironici.
Nel secondo, La vecchia signora di Bayeux, c’è l’omicidio di un’anziana signora, assai danarosa, con una sostituzione di cadavere, al fine di realizzare un delitto perfetto. E’ ovvio, però, che nulla sfugge al celebre commissario che arriverà pressoché subito alla soluzione del caso.
Il terzo, La Locanda degli Annegati, è un po’ atipico, poiché sotto la parvenza di un incidente automobilistico si cela un efferato delitto. Tutto sembra difficile, per non dire impossibile, e anche Maigret pare annaspare nel vuoto, ma poi lo soccorre la sua straordinaria intuizione e anche questo caso viene risolto.
Il quarto, Stan l’Assassino, conclude malamente una raccolta fin qui di buon livello; in effetti, sembra che in questo racconto Simenon si sia lasciato prendere la mano, esagerando con la fantasia, e presentando personaggi che sono al di fuori di ogni contesto logico.
In conclusione un libro buono per una lettura d’evasione, per essere di compagnia in un viaggio in treno o in aereo, insomma un gradevole passatempo e nulla di più.
Indicazioni utili
Altri tempi
L’idea di narrare un po’ della nostra storia attraverso la vita del conducente di una diligenza postale è indubbiamente originale, anche perché richiama un sapore pionieristico di frontiera che noi ben conosciamo grazie ai film western, dimenticando che negli stessi anni la vita non era dissimile anche in Europa. In effetti, pagina dopo pagina, ci si appassiona alle vicende di Liberio Fraterni, di quest’uomo che alla fine dell’Ottocento recapitava la posta nell’Alta Toscana. I personaggi non sono molti e direi che l’autentico e assoluto protagonista è Balio, un cavallo nero, unico nel suo genere, capace di trainare da solo la diligenza senza apparente sforzo e senza mai stancarsi, una bestia un po’ bizzosa, non del tutto domata e che mi sono chiesto che significato metaforico possa avere. Senza arrivare a una conclusione certa credo che il quadrupede in questione rappresenti il senso di libertà innato in ognuno di noi e a riprova di questa opinione sta il fatto che Balio, che stranamente non invecchia mai, non appena il progresso soppianta il trasporto con la diligenza, fugge e di lui non si saprà più nulla. Peraltro, l’autore a cui non si deve negare il merito di saper descrivere con abilità situazioni e paesaggi, mostra una spiccata attitudine a relazionarsi con la natura, il che può richiamare, ma solo in parte, un’altra figura di narratore, cioè Mario Rigoni Stern. Il romanzo in sé presenta appunto il motivo di interesse in questo rapporto fra Liberio e il cavallo, mentre l’aspetto storico, che dovrebbe costituire l’ossatura, a mio avviso è un po’ carente, nel senso che pur rappresentando un periodo a cavallo di due secoli non approfondisce più di tanto. Purtroppo, più si va avanti con le pagine e con gli anni emergono alcune lacune, come riferimenti fuorvianti a personaggi particolari, come nel caso della suora-madre o di Giovanni Pascoli, oppure anche di Giuseppe Garibaldi, sul quale il giudizio dell’autore è senz’altro opinabile, ma che in ogni caso non si capisce perché venga inserito nel testo. Con lo scoppio della prima guerra mondiale la vena fantastica si amplia e così grazie alla massoneria Liberio farà la conoscenza di Cadorna e di Vittorio Emanuele III, in una casa posta immediatamente a ridosso della prima linea. In seguito, terminato il conflitto, il figlio Amilcare, invalido di guerra, diventerà un protagonista assoluto del fascismo. I tempi sono cambiati, tutto sembra procedere veloce verso il futuro, il passato ben presto sembra un trapassato e Liberio, che è un uomo di un’altra epoca, che non può accettare i fascisti perché così diversi da lui, comprende che il suo tempo è finito e si lascia andare. Le ultime pagine, che lo colgono nel momento della sua dipartita, non sono strazianti, ma nella misura in cui danno il senso dell’inutilità di sopravvivere a un’epoca sono veramente stupende e fanno dimenticare quelle manchevolezze di cui ho prima accennato, contribuendo non poco a un giudizio sostanzialmente positivo.
Indicazioni utili
Il troppo stroppia
A volte mi trovo in imbarazzo nello scrivere le recensioni perché, pur rilevando l’impegno profuso dall’autore nella realizzazione della sua opera, a mio giudizio il risultato non solo non è in linea con gli sforzi, ma è del tutto insoddisfacente.
Non è facile scrivere e non lo è soprattutto quando non si sa perfettamente ciò che si vuole, perché La reliquia di Costantinopoli, che dovrebbe essere un romanzo storico, per l’impostazione che ha e per come in non poche pagine è scritto, assomiglia di più a un saggio storico, di cui tuttavia non ha la struttura.
In questo modo viene fuori un ibrido che in alcune parti appassiona e in altre francamente stanca, proprio perché l’impostazione non è corretta ed è squilibrata. In tutta sincerità è stata necessaria tutta la mia certosina pazienza per sorbirmi la grevità di ben 592 pagine, infarcite da descrizioni talmente approfondite e puntigliose da risultare nauseanti e tali comunque da spezzare di continuo il ritmo della vicenda. Mi chiedo per quale motivo Malaguti si sia voluto dilungare su questioni del tutto inutili, per le quali già un breve cenno avrebbe potuto risultare di troppo. Non nascondo che l’autore si sia documentato, che abbia effettuato ricerche con pignoleria, senza lasciare nulla al caso, ma poi la realizzazione è risultata quella che è, e cioè un verboso macigno che tende a scoraggiare il lettore già dopo una cinquantina di pagine. Che sappia scrivere in un italiano ineccepibile è un dato di fatto, che sia uno che ama il suo lavoro altrettanto, ma ripeto purtroppo il risultato non è soddisfacente e senz’altro non in linea con gli sforzi sostenuti. Comunque è mia intenzione affrontare qualche altra sua opera al fine di verificare se questa, con tutti i suoi notevoli limiti, sia stata un evento del tutto occasionale.
Si può leggere, ma bisogna armarsi di tanta pazienza e della più ampia disponibilità.
Indicazioni utili
- sì
- no
La pietà di Maigret
Scritto nell’estate del 1930, a bordo del suo yacht Ostrogoth, con cui andò su e giù per i numerosi e ben attrezzati canali navigabili francesi, Il cavallante della Providence risente di questa esperienza di navigazione, tanto che il mondo del trasporto e del diporto fluviale è talmente ben descritto da ricreare nel lettore l’impressione di essere presente, di vedere i grossi barconi trainati da cavalli sulle sponde e di udire il cigolio delle porte delle chiuse quando si aprono o quando si chiudono. E’ un perfetto mondo d’acqua, con una vera e propria immersione nel liquido, tanto più che il cielo è ben poco benevolo e lascia trasparire raramente il sole, quasi un’illusione nei continui scrosci di pioggia. E’ un Maigret autarchico quello chiamato a risolvere il caso di una bella e giovane donna, il cui cadavere è stato trovato ricoperto dalla paglia in una stalla, autarchico perché non ricorre, per spostarsi, a un auto, ma preferisce la bicicletta, con cui un giorno arriva a percorrere, con un tempo inclemente, quasi settanta chilometri e su una strada coperta da pozzanghere e con presenza di fanghiglia. Come al solito l’ambiente e l’atmosfera sono resi in modo perfetto, così come di assoluto rilievo è l’analisi psicologica dei protagonisti, persone dell’alta borghesia o piccoli profittatori che ruotano loro intorno per partecipare almeno agli avanzi del banchetto. Maigret cerca un omicida, che ucciderà un’altra volta, ma quando lo trova, grazie al suo infallibile intuito che lo porta a lasciarsi scivolare addosso la storia, trattenendo solo l’essenziale, non avrà motivo di essere soddisfatto, perché, come in altre occasioni, l’assassino è esso stesso vittima, che pagherà le sue colpe con una morte straziante descritta in pagine di rara bellezza. Eh sì, è infallibile Maigret, ma non è un automa, è una perfetta macchina investigativa cucita intorno a un cuore che pulsa e che non si oppone all’umana pietà.
Da leggere, senz’altro.
Indicazioni utili
Il sublime amore delle madri per i figli
Sono due i fatti di cui parla il libro, non collegati fra loro, ma comunque con il medesimo tema, tanto da ritenere plausibile che l’unico racconto in effetti consti di due prose.
Soprattutto nella prima, quella dell’annegamento in Venezia del piccolo Zuanin, con la madre che lo stringe fra le braccia, consapevole della sua dipartita che tuttavia rifiuta, mi è venuto in mente un altro evento, analogo, ma non uguale, immortalato dal nostro Alessandro Manzoni nei suoi Promessi sposi, con quella povera Cecilia che la morte si è portata via. Le analogie finiscono qui, ma quel che più conta è che mi è parso che Fiorella Borin, nella sua narrazione, sia riuscita a cogliere la momentanea discrasia fra la certezza del fatto doloroso e l’autodifesa, volta a non accettarlo, al punto da non considerarlo reale. Indubbiamente gli studi dell’autore costituiscono un valido fondamento, ma resta il fatto che riuscire a rendere narrativamente questo contrasto è una prova di grande capacità, la stessa che poi si ritrova nel personaggio della seconda prosa, cioè di quella madre che ormai alla fine della sua esistenza nell’ospizio si aggrappa disperatamente a ciò che le resta di una sua bambina morta moltissimi anni prima nel crollo di un ponte, unitamente ad altri infanti, fatto, quello del crollo, effettivamente avvenuto e che ha costituito il pretesto o meglio lo spunto per questa narrazione breve, ma di notevole bellezza.
Se pure è un’aria di tragedia che permea il libro, l’aver saputo porre in evidenza, senza ricorrere a luoghi comuni o ad accentuate enfasi, l’amore materno costituisce l’elemento di maggior pregio, tanto più che l’autore, mantenendo un costante distacco dai suoi personaggi, toglie loro quell’artificiosità propria della scrittura d’invenzione, rendendoli veritieri e perciò maggiormente interessanti.
Le putine del Canal Gorzone è un libro senz’altro da leggere, perché è più che meritevole.
Indicazioni utili
Grande delusione
La prima domanda che mi sono fatto, ultimata la lettura, è perché mi sono procurato questo libro. Non è certo perché conoscessi già l’autore, a me quasi completamente ignoto fino a poco tempo fa, né per via del titolo, di quei mammut che avevano una vita segreta nella Pianura Padana. Il motivo è molto più semplice, ma è anche quello che ha condizionato le aspettative fin da subito: La vita segreta dei mammut nella Pianura Padana ha vinto il Premio Chiara edizione 2017. Il nome di Piero Chiara ha spalancato in me ogni porta, atteso che ho sempre stimato molto il narratore di Luino, a mio parere uno dei più grandi scrittori italiani, cantore di quel piccolo mondo provinciale in cui, ma ancora per poco, si riescono a riscoprire il senso e il piacere della vita. Ho immaginato subito che il concorso riguardasse opere relative a queste entità circoscritte, che non sono necessariamente quelle in sponda al lago Maggiore, ma che sono presenti in ogni parte d’Italia, a patto di avere la pazienza di scovarle. Ecco, l’autore del libro premiato, Davide Bregola, è un ferrarese che si è trasferito a Sermide, nel mantovano, e quindi poco lontano dal suo luogo natio. Questo, come il mio, è un paese rivierasco del Po e in genere le caratteristiche di chi vive lungo il grande fiume sono simili, e in ogni caso è possibile cogliere in queste piccole realtà personaggi di particolare interesse, buoni a sviluppare una storia che può oscillare dal drammatico all’ironico e che diventano assoluti protagonisti grazie all’abilità di chi scrive. Quindi, all’inizio le mie aspettative erano molte, aspettative che purtroppo sono andate subito deluse, perché nel libro, di difficile classificazione (sempre narrativa, ma se ha poco del romanzo ha ancor meno della raccolta di racconti), si propongono tutta una serie di fatti, o di eventi se preferiamo chiamarli così, tutto sommato di scarso interesse, o addirittura banali. Ma se la vicenda può avere uno sviluppo modesto, importante resta la figura del protagonista, che grazie all’abilità del narratore, deve diventare un personaggio memorabile. Non si tratta di ricreare l’Emerenziano Paronzini della Spartizione, oppure l’Augusto Vanghetta di Il pretore di Cuvio, né del resto si potrebbe pretendere di raggiungere le vette eccelse di Chiara, ma non ha senso inserire dei protagonisti che non hanno spessore, perché è evidente che, in questo caso, attesa anche la modestia della vicenda, la lettura si trascinerà sempre più penosamente fino alla fine. Anche se devo ammettere che questa civiltà rivierasca del Po sta smussandosi nel tempo, tuttavia soggetti che possono accendere la fantasia esistono tuttora. Insomma, per farla breve, mi è rimasta l’ultima domanda, e cioè come mai un libro di così modesta levatura si sia aggiudicato il Premio Chiara. Non credo che riuscirò a trovare la risposta, né a questo punto mi interessa.
Da leggere questo libro? Mi sembra che la risposta sia implicita in ciò che ho scritto.
Indicazioni utili
| 1070 risultati - visualizzati 101 - 150 | « 1 2 3 4 5 6 ... 7 22 » |