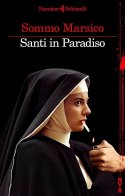- Warning
Opinione scritta da Todaoda
| 110 risultati - visualizzati 51 - 100 | 1 2 3 |
Sprazzi di involontario buon umore
Corsari, pirati, ladri, assassini, politici corrotti e lacchè, malavitosi, farabutti di varia foggia e natura, sadici, profittatori, barboni, ubriaconi, sgualdrine per necessità e sgualdrine per vocazione, avventure leggendarie, missioni impossibili, duelli navali al ritmo delle bordate dei cannoni seicenteschi, mostri marini, fortezze da espugnare, belle e lascive fanciulle da salvare, indigeni guerrafondai e con una serie predisposizione all’idiozia e per finire doppiogiochisti, lurida feccia, traditori di basso retaggio e intrighi politici internazionali e tra tutti questi l’eroe maledetto, l’angelo dalla faccia imbrattata del maleodorante sudiciume da cui proviene, il capitano protagonista e la sua ciurma di sbandanti ognuno tuttavia illuminato da un’insospettabile misericordia e ognuno con una sospetta virtù marinara puntualmente indispensabile all’evoluzione del romanzo. Ho già accennato ai mostri marini? E alle sgualdrine? Probabilmente sì, be non sono il solo: questo romanzo, che si dice trovato con fortuito tempismo nel pc del sig. Crichton proprio mentre, pace all’anima sua, veniva meno alla vita sul pianeta Terra, è ne più ne meno che un enciclopedico elenco di luoghi comuni del genere piratesco. I personaggi che popolano le pagine del libro sono così piatti e così canonici da risultare delle farse, farse di loro stessi. La raccapricciante periodicità delle sventure che il capitano protagonista de “l’isola dei pirati” è costretto ad affrontare, sono leggendarie, ma non come i miti e le storie che si tramandano i vecchi mariani le sere d’inverno nelle locande fumose al limitare dei porti (mi scuso per la banale immagine, ma certe letture sono contagiose), bensì come il primo film del rag. Ugo Fantozzi la cui sfiga colossale è del tutto equiparabile a quella del capt. Hunter, sopracitato protagonista del romanzo di Crichton, o al limite a quella di Paperino altrettanto eroico e sfigatissimo protagonista (vestito per giunta alla marinara! Alle volte le coincidenze…) della fumettistica Disneyana. E l’ultimo paragone forse è ancora più azzeccato: qui, nell’isola dei pirati, si legge di personaggi farseschi, avventure rocambolesche e variopinti mondi, pittoreschi quanto le pagine colorate di un giornalino, e proprio come con un giornalino è impossibile leggere questo romanzo senza riderci su costantemente. Non si tratta però di un riso cattivo, di scherno, ma più di un sorriso bonario, ingenuo e accomodante. Sembra quasi che l’autore abbia apposta voluto lasciarci con questa sua ultima opera (al tempo della stesura della recensione non credevo realizzabile il miracolo che ha fatto sí che si rinvenisse, mimetizzata tra i frondosi meandri del suo portatile, un'altra ultima storia!) per dirci, per consigliarci, di sognare felici e non prendercela troppo per le sventure quotidiane poiché la vita non è una roba seria. Che volete che sia se uno fora di notte due gomme in una strada di campagna a meno dieci gradi con la batteria del cellulare scarico, rispetto all’affrontare niente popò di meno che il kraken armati solo di uno temperino? Cosa volete che sia essere cornificati dalla propria moglie con il vicino, che essere cornificati, sempre dalla propria moglie, ma con il re di Inghilterra, il governatore della Giamaica, un pirata sex symbol, e buona parte della feccia di Port Royal?
Già proprio così, questo è il tenore di sventure (o avventure dipende dai punti di vista) che sono costretti ad affrontare i personaggi del romanzo. Impossibile non riderci su. Crichton con questa sua ingenua e ironica farsa sembra esortarci, spronarci, a prendere tutto per scherzo o almeno con allegria, poiché niente merita la nostra tristezza, niente merita le nostre tribolazioni, niente merita le nostre preoccupazioni… a meno che appunto l’indomani non vi impicchino, a meno che non dobbiate fuggire da un galeone spagnolo incazzoso, a meno che non siate alla resa dei conti con un polipone ipertrofico.
Se questo, quello farsesco, era il reale intento dell’autore il libro merita una considerazione spudoratamente elevata, ma ahimè ho fortissimi dubbi che l’ironia che pervade tutta la narrazione sia volontaria e costruita ad arte. Sembra piuttosto frutto del lavoro incompiuto di uno scrittore che per anni ha conservato la bozza di un romanzo senza decidersi a pubblicarla finché non riuscisse a darle un minimo di credibilità e che poi, al momento della sua dipartita, per via di quella insaziabile sete di danaro degli editori, la medesima opera sia stata rabberciata in qualche modo e mandata in pasto ai lettori che, influenzati dalle tematiche recentemente tornate in auge e dall’ effetto “ultima opera postuma dell’autore recentemente mancato”, immancabilmente hanno abboccato come degli ingordi pescioloni. E il sottoscritto è uno dei più ingordi di tutti!
Questa mia ultima ipotetica considerazione è supportata tra l’altro dalla mancanza d’un fattore che in maniera oggettiva e indiscutibile tutti i più affezionati lettori di Crichton avranno notato: in questo libro a differenza dei suoi altri non c’è l’approfondimento: la dettagliata, specifica, talvolta addirittura estrema ricerca minuziosa alla quale l’autore di Jurassic Park ci aveva abituato con la sua precedente narrativa. Certo in un libro di pirati non ci si può addentrare nei principi della biologia, della genetica o della fisica, ma in quelli della ricerca storico/storiografica sì. Era naturale aspettarselo, ed invece i cenni storici qui sono appena abbozzati, gettati la alla bell’e meglio, proprio come in una prima stesura di un lavoro che deve essere ancora ampliato e rifinito. Michael Crichton come molti suoi colleghi poteva essere definito uno scrittore commerciale, con i soliti pregi e i difetti che comporta questa gretta classificazione, ma una cosa lo differenziava dagli altri, non lo stile, non il ritmo o la profondità dei suoi personaggi, ma l’immaginazione e la ricerca puntigliosa nel reale per supportare e dare credibilità alla sua indole di sognatore.
In questo romanzo purtroppo mancano entrambe queste sue due prerogative e il libro rimane piatto e banale come fin troppi altri.
Non tutto il male però vien per nuocere, è vero infatti che se tutta la letteratura dell’autore è pervasa dalle note della sua fervida fantasia a scapito di uno stile quanto mai canonico, in questo libro è l’esatto contrario e i sognanti voli fantascientifico/fantastici a cui ci aveva abituato lasciano il posto ad uno stile asciutto, brusco, ruvido che si addice talmente bene ai temi trattati che verrebbe naturale definirlo “corsaro.” Purtroppo anche in questo caso la mia natura sospettosa mi porta a riflettere se questo nuovo e affascinante vocabolario dell’autore sia il frutto di una cosciente ricerca nell’affinazione linguistica o ancora un triste effetto collaterale della mancata limatura del romanzo.
In conclusione L’isola dei pirati probabilmente rimarrà nella storia della narrativa esclusivamente per il fatto che si tratta dell’ultimo romanzo di uno dei più celebrati scrittori degli ultimi trent’anni (vedasi parentesi precedente o quella prima ancora), ma quanto a originalità e profondità lascia molto a desiderare. Tuttavia vuoi per il sopracitato stile “innovativo”, vuoi che sarebbe ingiusto dire che non mi ha intrattenuto, specialmente durante le peripezie navali tra i velieri duellanti, così tipiche eppure così divertenti, e vuoi perché, e qui i romantici simbolismi potrebbero veramente sprecarsi, voltando l’ultima pagina di quest’ultima opera mi accorsi che un gabbiano si era appollaiato vicino ai miei piedi e probabilmente era rimasto per diversi minuti ad osservarmi prima di volare via al suono del libro che veniva riposto sul pavimento del terrazzo in riva al lago presso il quale mi trovavo in quel freddo pomeriggio novembrino (anche se sarebbe stato preferibile un pappagallo, magari bendato, e un terrazzo in riva al mare, in un umido ed estivo pomeriggio caraibico, ma non si può avere proprio tutto dalla vita), vuoi tutto questo, vuoi che in fondo Michael Crichton, porca di una miseria!, è pur sempre Michael Crichton, non mi sento di condannare questo libro come illeggibile. Certo non è dei più originali e non è dei più complessi e interessanti, ma al diavolo!, proprio come ai bei tempi: con il re del tecno-thriller il divertimento è assicurato! …anche se a badare solo alla logica mai considerazione finale fu meno azzeccata.
Indicazioni utili
Biancaneve e le ceneri dell'umanità
Marte come redenzione, redenzione dell’uomo dai suoi peccati, dal suo egoismo, dalla sua stupidità. Marte come fuga, via di fuga dell’uomo dalle brutture da egli stesso create, dalla violenza, dalla guerra, dai mostri partoriti dalla sua mente
Marte come utopia del bello, del perfetto, del paradiso.
Bradbury fa osservare al lettore il miraggio della perfezione, di quello che potrebbe essere, di quello che era stato il pianeta prima dell’avvento del genere umano, glielo fa conoscere, capire, vivere con un prodigio di luce riflessa. Nel libro Marte non è più il quarto pianeta dal sole, ma il ricordo della Terra, quello che il nostro caro vecchio Mondo era prima che vi comparissimo, prima che potessimo definirlo “vecchio e caro.”
L’uomo dalla sua Terra, stupida, violenta, assassina osserva e brama l’incorruttibile perfezione del pianeta rosso, è naturale che egli aspiri a raggiungere quella perfezione, quell’equilibrio, che aspiri a raggiungere Marte. E quando finalmente grazie al progresso della tecnica riesce a mettervi piede, tutto inizia… tutto inizia a rovinarsi.
Già perché la stupidità, la brama di potere, la corruzione non sono prerogative della Terra, ma sono prerogative dell’uomo che ha stanziato il suo regno sul terzo pianeta creandolo a sua immagine e somiglianza. Il viaggio, la conquista della nuova terra, non servono a mondare i peccati della natura umana, anzi, caso mai a rinvigorirli, poiché sul pianeta di Bradbury sì può vivere, sì, ma in condizioni estreme e in tali condizioni l’uomo non migliora, si estremizza. Le passioni diventano manie, il rispetto diventa devozione, l’istintiva aspirazione al buono e al bene diventa prevaricante imposizione di una dottrina di vita, di chi pretende di essere nel giusto e costringe gli altri a seguirlo. E’ naturale che sia così, lo si è sempre fatto sulla terra, la storia ci insegna. E’ naturale nel vero senso del termine: è tipico della natura umana imporre invece che accettare, estremizzare la logica del sociale decontestualizzandola e trasformarla in legge da applicare rigorosamente e non più da interpretare con giudizio, o ancor peggio spostare il baricentro di ogni rapporto civile squilibrandolo in proprio favore, camuffando sistematicamente i termini dell’equazione del vivere civile sottraendo sistematicamente gli addendi al prossimo, agli altri uomini, per il successo e la vittoria personale. No, Marte è una chimera che affascina e illude, ma l’uomo di Bradbury (ahimè così simile al vero) è già spacciato poiché non impara dai propri errori, anzi con testardaggine e arroganza non li riconosce neppure portandoseli dietro ovunque metta piede. A nulla serve fuggire dalla Terra constatatene le brutture, a nulla serve ripudiare la propria Creatura: è la mente del dottor Frankenstein che bisognerebbe ripudiare, è da se stesso che l’uomo dovrebbe fuggire.
L’uomo secondo le Cronache di Bradbury arriva su Marte e da quel momento Marte, come prima la Terra, incomincia a morire. I nativi del pianeta, i marziani, dapprima non riconoscono neanche quella assurda forma che è l’uomo, poi imparano a riconoscerlo a conoscerne i semi della follia e così anche per loro, i marziani, sembra non esserci scampo, non tanto perché sono destinati ad estinguersi ma perché (ben peggio) sembrano destinati a diventare come l’uomo. Ma la genetica ha la meglio: loro sono pur sempre Marziani e all’ultimo, in un ultimo atto di inumano altruismo, si redimono e, dagli esseri superiori quali sono, consegnano all’uomo il giocattolo che gli piace tanto: Marte, la proprietà del pianeta.
L’infantilismo e l’ingenuo materialismo umano avevano fatto sì che appena gli astronauti avevano messo piede sul pianeta rosso pretendessero, cerimonie, fanfare e applausi, perfino le chiavi del pianeta e i marziani prima di estinguersi completamente gliele consegnano. Il momento è epico, non perché suona come una resa del marziano al potere terrestre, come una vittoria della specie terrestre, ma come il padre sfinito che accontenta il figlio capriccioso, o meglio ancora (o peggio, a seconda dei punti di vista) come il padrone stanco che consegna l’osso al cane maleducato che continuava ad abbaiare e sbavare per un premio che non merita. Questo sembra dirci Bradbury: noi avremo anche vinto, ma è una vittoria di Pirro, poiché la vera battaglia va combattuta contro noi stessi, contro la nostra stupidità.
Passano gli anni, i marziani “finalmente” si sono estinti ma anche l’uomo sulla Terra è prossimo all’estinzione, pochi, pochissimi riescono a fuggire, fuggire già ma per dove? Ancora verso quel pianeta, ormai abbandonato dal genere umano, che tanto in passato aveva promesso. Quei pochi, una famiglia, forse due, tornano di nuovo all’utopia, ad Utopia, su Marte. Il pianeta è disabitato, deserto sono solo in quattro (forse cinque), forse arriverà qualcun altro, ma son talmente pochi che non si daranno fastidio, che non riusciranno sottrarsi gli addendi dell’equazione del vivere civile in società, sono gli ultimi sopravvissuti di quella che era stata la Terra, gli ultimi uomini, gli ultimi terrestri, anzi ormai gli ultimi marziani.
E le cronache terminano con questa trasformazione finale che implicitamente porta con se l’incertezza del futuro, il dubbio. Gli uomini sono diventati marziani: significa che finalmente si sono evoluti? Che hanno compiuto il passo successivo verso quel cammino che li porta alla deificazione a cui tanto aspirano? O semplicemente significa che ora Marte è spacciato?
Leggendo le cronache non si coglie al volo tutto il significato del libro, è solo riflettendoci a posteriori che si riesce a comprenderne la sua profondità, ma questo è per via della genialità dell’autore o è l’ennesima riprova di quanto affermava Hermann Hesse quando sosteneva che i libri una volta scritti e pubblicati assumono molti più significati di quanti lo scrittore originariamente aveva concepito, uno diverso almeno per ogni lettore?
Forse entrambe le cose, forse ne l’una ne l’altra, tant’è vero che questo dubbio amletico (anzi Hessiano) non si concretizzerebbe neanche se non fosse per un particolare dettaglio che per certi aspetti, da alcuni, può essere considerato un pregio ma che assolutisticamente io sono propenso a considerare un difetto: lo stile.
Lo stile di Bradbury nelle Cronache, come lui stesso afferma in un dialogo del libro, è una personale rivendicazione di libertà della fantasia contro il realismo letterario imperante negli anni cinquanta, sulla Terra. Bradbury descrive Marte con toni favoleggianti, arricchendolo di paesaggi incantati, creature meravigliose, personaggi idilliaci. Forse il suo intento è quello di creare un forte contrasto con la rovina e la miseria della terra, ma se si forza troppo la mano, non solo si rischia di perdere credibilità, si rischia di perdere anche la misura: se due luoghi sono entrambi pittoreschi o entrambi grigi e asfittici uno può essere più bello dell’altro, uno può essere più brutto, ma se uno è un paradiso e l’altro è un immondezzaio il divario è troppo grande, non possono neppure essere paragonati, e chi vive nell’immondezzaio il più delle volte non aspira al paradiso perché non riesce neppure ad immaginarlo.
E’ questo il problema del romanzo, forse figlio della mentalità dell’epoca, è tutto troppo stereotipato: la Terra fa schifo, i prodotti dell’uomo sono delle aberrazioni che sopravvivono all’uomo stesso, la stupidità del genere umano non ha limiti, mentre Marte con la sua florida natura (prima dell’avvento umano appunto) è perfetto, i marziani sono simbionti con ciò che li circonda e vivono in armonia con il pianeta. Stupendo, ma come potrebbe (se così fosse) “un pover uomo” sepolto dalla sua stessa immondizia anche solo sognare un pianeta così, aspirare ad un livello di vita che rasenta la perfezione? O più pragmaticamente in una società in rovina dove trova i soldi per compiere una migrazione di massa verso un altro pianeta? D’accordo è una favola ma è priva di sfumature. Dove sono le mezze tinte del mondo? I toni di grigio della realtà?
Ah già Bradbury è contro il realismo, dunque deve essere tutto bianco o nero, bene o male.
Può essere che abbia ragione, ma se il libro vuole essere una critica alla società contemporanea deve trarre da essa, dalla sua cruda realtà, appunto dal suo realismo, altrimenti diventa una critica qualunquista, demagogica, come quella dell’uomo ben inserito che va dal barbone in strada e gli dice “datti da fare che così diventi ricco.” Possibile forse, ma alquanto improbabile, fondamentalmente corretto, ma alquanto discutibile.
Facile criticare senza mettersi sullo stesso piano. Nel medesimo modo Bradbury sembra che pontifichi sulle miserie dell’uomo senza mettersi sul suo stesso piano, quasi volesse stimolarci a rispondergli: “facile criticare gli uomini se sei Marziano.”
D’accordo poi l’anti – realismo ma Bradbury eccede in fantasia. Se si narra di un’umanità condannata all’estinzione nel prossimo futuro i toni non possono essere quelli di Biancaneve e i sette nani, i toni devono essere scuri, profeticamente lugubri altrimenti il messaggio perde di efficacia, Philip K. Dick lo sapeva bene quando scrisse “Ma gli androidi sognano pecore elettriche” (e molte altre opere).
Se si vuole criticare la società, e con essa dunque la realtà da lei creata, i toni devono essere realistici, non reali, altrimenti non sarebbe fantascienza, ma realistici; se si vuole parlare di Marte come la nuova frontiera, come il punto di riferimento per la società sofferente, occorre un realismo descrittivo che ne esponga il bene con termini passionali, profondi e il male con termini crudi, dolorosi, ma occorre anche che essi siano indissolubilmente legati l’uno all’altro altrimenti il termine di paragone con la nostra Terra non regge.
Bradbury fa nominare ad un suo personaggio delle Cronache Hemingway come esemplificazione di tutto quello a cui egli stesso si oppone: il realismo.
Per carità ognuno ha diritto alla propria fantasia nella misura che ritiene più opportuna, ognuno può creare la propria scrittura ad immagine di quello che ha dentro, vuoi che sia un meraviglioso ed equilibrato mondo incantato, vuoi un vivida, concreta, poco equilibrata realtà , ma Hemingway su una cosa aveva ragione, cito: “…gli scrittori si forgiano nell’ingiustizia come si forgiano le spade.” Nell’ingiustizia, nelle sofferenze, nel dolore e nell’odore della realtà. Senza un minimo di ingiustizia e di dolore il paradiso marziano è incredibile.
Parlare di realtà usando toni fantastici è un controsenso, sperare di convincere qualcuno di una realtà tanto profetica quanto fittizia usando toni irreali è un’assurda illusione.
No personalmente ritengo che se l’intento di Bradbury scrivendo le Cronache è il medesimo che ha mosso Orwell quando ha scritto 1984 o Huxley quando ha inventato il Coraggioso Nuovo Mondo (come suona male in italiano), se l’intento è il medesimo, ritengo avrebbe dovuto mantenere uno stile più equilibrato e comprensivo, se non di tutti, di almeno di alcuni dei molteplici aspetti della vita e al contempo più cupo e disincantato.
Sempre che questo fosse l’intento di Bradbury; se questo non era, se invece valesse completamente la teoria di Hesse, vero, tutta la mia interpretazione delle Cronache crollerebbe ma il romanzo verrebbe relegato a semplice favola della buona notte.
Dunque ben vengano anche le mie critiche poiché ancora una volta sono la dimostrazione che tutto non è bianco o nero, il libro come la realtà può assumere sfumature di grigio in ogni pagina, in ogni secondo della vita, vuoi appunto per le critiche di un signor nessuno, vuoi per quella scintilla di umana comprensione che lo scrittore, in quanto membro del genere umano, ogni tanto ha per i suoi simili. L’uomo che comprende i valori della vita marziana suona quasi come una redenzione, salvo poi impazzire e sterminare i suoi simili, così come l’uomo che rimasto solo sul pianeta crea automi ad immagine e somiglianza dei suoi cari. Sono redenzioni involontarie, sono le fiammelle tra le ceneri di un’umanità auto combusta, fiammelle sufficienti a illuminare un intero mondo, a redimere l’uomo per il motivo stesso di averle concepite, e redimendolo a contraddire quanto Bradbury afferma prima nel libro.
Lo scrittore che si contraddice, com’è umano, così umano da risollevare tutta la sorte della specie che lui critica, peccato non sembri rendersene conto.
Infine, come è vero che non tutto il male vien per nuocere, così tutto il libro non è da scartare, anzi certi passaggi, vedi gli ultimi due o tre capitoli, sono degni di rimanere per sempre nella storia della letteratura per epicità e involontaria umanità. E se dovessi dare un giudizio finale all’opera potrei solo dire che non è un capolavoro ma non è neppure un pessimo libro: è un buon libro con aspetti positivi e altri negativi, che creano uno sfumato e contradditorio insieme esemplificazione di quella che è la molteplicità di sfaccettature della mente umana… peccato solo che Bradbury non si accorga di contemplarla.
Indicazioni utili
Evoluzione e distruzione del Grande Gatsby
E' difficile riuscire a creare un personaggio come quello di Zia Mame e renderlo simpatico, divertente e istrionicamente coinvolgente. Certo la simpatia in realtà e' più un riflesso empatico nei confronti del povero nipote ''condannato'' dal destino a sopportare sua zia che un vero e proprio sentimento positivo nei confronti della protagonista; certo, il divertimento e' più implicito che esplicito, più un sottinteso dell'assurdo mondo di zia Mame che un palese frutto di quegli episodi aneddotici che garrulamente infarciscono il libro ma che al giorno d'oggi verrebbero definiti, e forse ingiustamente condannati, come umorismo da slap stick; certo l'istrionicità del soggetto e' affettata quanto e' artificiale il soggetto stesso; eppure, malgrado tutte queste obbiezioni, il libro funziona ed il personaggio di Mame risulta talmente incredibile da diventare credibile, credibile quanto il frutto della sarcastica constatazione che al peggio forse c'è un limite ma alla pacchianeria proprio no.
Zia Mame, se un personaggio del genere esistesse veramente, sarebbe la più strabiliante figura della società moderna e la più ''terrificante'' sciagura dell’uomo normale: nella realtà è arduo ipotizzare che riuscirebbe simpatica a qualcuno, eppure nel romanzo è perfetta, nella realtá è arduo ipotizzare che riuscirebbe a sopravvivere più di qualche giorno, eppure nel libro si ricava sempre la sua opulente nicchia e se la cava egregiamente in ogni situazione, fino a divenire lei il filo conduttore di tutto lo scritto e il faro che emana una luce sfarzosa anche nei momenti più scuri, tristi e deprimenti.
Tutti i critici hanno affermato che non c'è nulla da fare "Zia Mame" o la si odia o la si ama. Sia il primo caso, sia il secondo una cosa è indiscutibile: l'autore è riuscito a creare un personaggio memorabile, la risposta femminile al Grande Gatsby, o meglio la sua evoluta disintegrazione, l'estremizzazione di quel mondo già conosciuto grazie alla penna di Fitzgerald e la sua polverizzazione, poiché se Gatsby, il personaggio, era frutto di quel mondo, Zia Mame ne è addirittura l'artefice: vi entra, o per meglio dire ci si intrufola in ogni modo, lo stravolge, lo deforma e lo reinventa a suo piacimento, in un continuo gioco di creazione e distruzione coincidente coi suoi capricci.
Per dirla in parole povere insomma Mame è Gatsby all'eccesso, e un simile eccesso per risultare credibile può solo essere ironico. Se il primo dunque è considerato un capolavoro letterario, il secondo essendone l'eccesso può essere contemplato solo come capolavoro della letteratura comica. Relegare il libro alla comicità in questo caso però non significa sminuirlo, di fatti come già ribadito è innegabile che Mame sia un personaggio, nella sua vitalità cartacea, nel suo egocentrismo ingenuo e nella sua inossidabile pacchiana eccentricità, memorabile al pari di quello creato da Fitzgerald.
Si è detto che rendere credibile un personaggio del genere e' senz'altro difficile, ma ancora più complesso deve essere stato riuscire a plasmare questo libro narrandone i fatti con uno stile pulito, divertente, irriverente e mai eccessivo. Sì, ancora più difficile, eppure anche qui l’autore non fallisce anzi riesce persino a fare del suo stile l’altro punto di riferimento del romanzo, a renderlo un adeguato contrappeso all’esuberanza della protagonista. Senza dubbio alcuno infatti, l'ironia che condisce le sue gesta sono l'altro filo conduttore di tutta la storia, ed è il loro intersecarsi che crea l'ossatura del romanzo, o per meglio dire gli antitetici opposti di un unico dipinto: Mame e' l'anormalità', l'eccesso, la variopinta sfrontata eccentricità, mentre lo stile con cui e' descritta e' quello dell'uomo comune, dunque la normalità, la misura e la decenza, il loro apparente contrasto ? ciò che regge in piedi tutta l'opera.
E anche se è solo grazie alla dinamica ironia dello scontro tra normalità ed eccesso che si tiene in piedi tutto quanto non va comunque sminuito lo sforzo di Dennis. Poichè se è difficile creare un libro impegnato e drammatico e' altrettanto difficile scrivere un libro leggero e ironico senza che sembri stupido. Patrick Dennis, o comunque si chiamasse o volesse farsi chiamare, ci e' riuscito e per questo gli va riconosciuto il merito.
Certo, non sempre e' tutto oro quel che luccica, talvolta la narrazione ha momenti di stanca, più che altro dovuti alla ripetitività di certi cliché, altre volte sembra fin troppo slegata facendo presumere, e a ragione, che il libro inizialmente fosse stato concepito come una serie di racconti separati, tuttavia anche in questi momenti, la sfarzosa esuberanza, quasi autoironica, di Mame riemerge dalle scure acque del banale e riprendendo per mano il lettore lo riporta sulla via che lo condurrà in un crescendo di divertimento al degno finale di questa strabiliante farsa.
Quando il libro venne pubblicato a metà anni cinquanta rimase in testa alle classifiche per più di due anni; ci sarà stato un motivo, mi ero detto (quando ne avevo letto la breve storia, poichè per motivi anagrafici non ho potuto essere diretto testimone del fenomeno) Quando e' stato ripubblicato un po' di anni fa e' tornato in testa alle classifiche per diversi mesi; ci sarà stato ben più di un motivo, avevo allora pensato, ma malgrado il presunto ottimismo quando mi accinsi ad acquistarlo ero convinto che il suo successo, antico e moderno, fosse, come quasi sempre, frutto di abili manovre commerciali (di cui per altro l'autore poteva dirsi maestro). Non potevo sbagliarmi di più: Zia Mame nel suo genere e' veramente un romanzo indimenticabile. E lei, Mame, la protagonista, e' altrettanto indimenticabile quanto il libro stesso, tanto che se non esistesse andrebbe inventata... ma solo sulla carta stampata, per carità!
Indicazioni utili
La ripetuta imperfezione dell' on/off
Siddharta, malgrado la notorietà e la moda, non è da considerarsi allo stesso livello delle altre opere di quel grande autore che risponde al nome di Hermann Hesse e la ragione essenzialmente è solo una: la ripetitività. La ripetitività del messaggio che ci vuole trasmettere lo scrittore che rendere tremendamente monotona tutta l’opera.
Il protagonista del libro, è un ragazzo in cerca della sua strada o meglio della strada principale, la via verso l'illuminazione, il nirvana, quello stato cioè di elezione spirituale che è il fine ultimo di gran parte delle filosofie e delle religioni note ai più e che si dovrebbe raggiungere più per intuizione che per conoscenza ma che di fatto si dice inarrivabile senza osservare (e dunque averne conoscenza!) tutte le leggi, i precetti e le regole dettate (talvolta persino imposte) dalle sopracitate filosofie, religioni, culti o scuole di pensiero che dir si voglia. Uno stato insomma in cui si dovrebbe raggiungere la totale (o massima possibile) consapevolezza ed elevarsi al pari di divinità tra gli uomini per insegnar, agli uomini, i restanti non ancora illuminati, il vero, il giusto e mostrar così loro la via.
Certo vien da considerare che, una volta mostrata, normalmente andrebbe compresa e seguita, e se si mostra, se c’è uno che te la indica, non è che sia così necessaria l’intuizione, ma non divaghiamo.
Il libro di per se dunque non è altro che la biografia di Siddharta, la sua vita, le tecniche che impara, che utilizza, i singoli percorsi che intraprende e le sue continue peregrinazioni verso quell'obbiettivo supremo che, nella fattispecie, è lo stato di Buddha. Le strade sono tante, alcune passano per la totale astensione/astinenza, altre per la totale conoscenza, alcune per la mortificazione del corpo come specchio dell'io, altre per l'appagamento completo dei propri bisogni, della propria volontà. Siddharta le prova tutte, e tutte si rivelano corrette e tutte si rivelano inutili. Alla fine le abbandona con negli occhi sempre il miraggio dell'obbiettivo senza mai riuscire a raggiungerlo finché, ormai vecchio e travolto dalla vita reale, comprende la via, anzi no… la intuisce!, capisce i suoi errori e scopre che non c'è nulla da scoprire, nulla a cui tendere, poiché è già tutto lì dove si trova, dove è sempre stato, e scopre che ha passato anni a rinunciare al reale per trovare… il reale e questa realtà, "antropomorfizzata" nel fiume presso cui si stabilisce, non è nient’altro che quella di una vita normale, semplice, comune... appunto reale.
Dunque una vita di ricerca sprecata? No, ci dice Hesse, poiché comunque, come insegna il fiume (che a quanto pare la sa lunga) a Siddharta, anche se la sua è stata una vita di ricerca, più mortificata che appagata, è pur sempre stata una vita, un viaggio, un percorso e come tale non è sprecata ma… be, vissuta. Del resto che altro si può fare con una vita se non viverla?!
La ricerca della realtà nella realtà, lungo una vita vissuta... questo è il messaggio del libro, se vogliamo la sua sintesi ed è un messaggio che potrebbe apparire fin troppo ovvio, lapalissiano, ma a ben cercare, a ben vedere (sempre se vogliamo) potrebbe nascondere una profondità non così scontata, la stessa profondità che talvolta può soggiacere al detto “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.” Poiché è vero che la vita la si vive e cercare la realtà nella realtà sembra un inutile perdita di tempo, ma non è tanto la ricerca, l’azione del vivere, quanto quella del rendersene conto, del singolo soggetto pensante che in una frazione di secondo ha quella “benedetta” illuminazione, quell’epifania che aveva inutilmente cercato per anni e che gli fa dire “io sto vivendo e sono reale perché vivo.” Cosa ne derivi da questo… be è tutto da vedere, alcuni potrebbero diventare come si diceva dei santi, delle divinità in terra e trasmettere questo messaggio agli altri uomini, altri invece potrebbero semplicemente guardarsi allo specchio e maledire la serata precedente durante la quale avevano sicuramente bevuto troppo, altri infine presi dalla caoticità della sopracitata realtà potrebbero semplicemente scordarsene al primo trillo del telefono o al primo “regalino” del volatile di turno sulla macchina appena lavata; questione di personalità, di gusti, di predisposizione, ma il messaggio del libro comunque resta e nella suo ambito particolare rimane importante. Dunque perché definirlo ripetitivo, perché ridondante, e al punto da rendere monotono l’intera opera, tanto più che si tratta di un libretto che pubblicato in un formato normale conterebbe si e no un centinaio di pagine?
Poiché ogni tecnica adottata dal protagonista e ogni fase della sua vita è estremamente somigliante alla precedente, alla successiva e ad ogni altra, e se gli episodi a contorno di queste variano e sono marginalmente differenti, il messaggio, il significato, lo sforzo, e il risultato finale sono sempre gli stessi. Da qui la noia.
Certo qualcuno potrebbe ribattere che il messaggio che reca questo volumetto è talmente importante, talmente realistico e pregno di quella tanto agognata realtà da trascendere le futili critiche che si possono muovere al testo…
Va bene, ma se proprio si vuole mettere i puntini sulle i a ben vedere è sbagliato anche (se non “persino”) l’approccio di Hesse all’evoluzione del personaggio: è vero, è realistico, chiunque intraprenda un cammino simile a quello di Siddharta si ritroverà più volte a sbattere il naso contro dei vicoli ciechi che lasciano solo il rimpianto del tempo sprecato e mortificano il pellegrino con soltanto l'aroma dell'obbiettivo supremo, sono i cocci aguzzi di bottiglia del miraggio di Montale, ma è anche vero che ad ogni tentativo fallito corrisponde un accrescimento personale, e raramente vi è una chiusura totale al periodo, alla fase e alla tecnica precedenti. Al contrario queste alle volte sono una spinta, un coadiuvante, uno stimolo ulteriore a concentrare le forze verso il raggiungimento del proprio scopo. Ogni fase nella realtà, nella vita vera di ogni giorno, (poiché il messaggio di Siddharta vuole essere universale e dunque applicabile ad ogni contesto e dunque raffrontabile persino con l’attuale) è concatenata e i passaggi da una fase all'altra sono importanti quanto le fasi stesse. In Siddharta no, complice anche la disposizione dei capitoli e la loro netta divisione, sembra di assistere ad un lungo elenco di tentativi andati a vuoto e non ad una vita vissuta. Tanti episodi, diversi per dinamiche ma simili per struttura: Siddharta non si trova bene - abbandona la vita precedente – prova una nuova via – sembra funzionare – non funziona – delusione – abbandono e così via fino al termine del libro. E l’evoluzione dell’uomo, l’evoluzione del singolo essere lungo tutta la sua vita in virtù delle esperienze positive e negative si perde, scompare, s’annulla.
Se fosse esistito veramente questo Siddharta non sarebbe stato un uomo che aspira all’immortalità, alla totalità ecc., sarebbe stato un computer, un meccanismo che ad ogni ingrippo si resetta automaticamente e mal che vada si spegne e si riavvia, on/off e di nuovo che ricomincia da capo a cercare la via, ad illudersi, a commettere degli errori, ad impallarsi; ma un essere umano non è così, un uomo ha ricordi, un uomo ha esperienza, possibile che lui non tragga nulla da quelli, possibile che lui non tragga nulla da quella?
Ma non è tanto questo, potrebbe riabbattere ancora qualcuno, è il fine, è l’uomo che è strenuamente volto al perseguimento del suo scopo e il libro ne è la diretta conseguenza.
Vero ed è altrettanto vero che quando ci si pone un obbiettivo si tende a trascurare il contorno, il “tutto il resto”, ma se si è compreso il messaggio del libro si dovrebbe capire che è proprio quel contorno il più delle volte ciò che conta di più, è quel che accade nella vita di ognuno ai margini della sua focalizzata visione il più delle volte ad essere importante perché pur essendo ai margini si interseca costantemente con la vita ed in quanto inaspettato talvolta dona piaceri, talvolta delusioni ma sempre esperienze, sempre evoluzione.
Dov’è l’evoluzione in Siddharta, dov’è il contorno alla sua vita? C’è ma è appannato è in secondo piano, è inconsistente. Hesse è qui che compie il suo errore: non si rende conto che scrivendo così, crea sì un personaggio, crea si un anima alla ricerca di qualcosa, ma è un personaggio inutile, una anima vuota, poiché priva di connotati, priva di involucro esterno, priva di ogni singolo aspetto che lo rende, vivo, umano, normale.
E questa considerazione vale per Siddharta uomo quanto per Siddharta libro, poiché quando si legge il libro più famoso di uno dei più grandi scrittori della storia non ci si aspetta che solo il significato del libro, il suo messaggio e la vicenda siano all’altezza della fama, ma ci si aspetta che lo sia anche la confezione e lo stile, altrimenti ogni più impercettibile sbavatura viene rilevata come una stonatura e tanto più il tema centrale è elevato ed aulico tanto più l’imperfezione, vuoi di forma, vuoi di contenuti vuoi, ancora una volta di contorno, risulta stridente.
A onor del vero parlando puramente di forma non si può non ammettere che lo stile con cui è scritto questo libro inizialmente non sia accattivante, esso infatti è molto diverso rispetto a quello degli altri libri dell’autore, è di fatto uno stile che rimanda a quello dei testi antichi, sacri, ed è uno stile quanto mai appropriato considerata la vicenda in essere. C’è da notare anche che oggi giorno sono pochi gli scrittori che possono vantare uno stile personale e chi riesce, come qui Hermann Hesse, addirittura a trasformarlo a seconda del genere, pur mantenendo intatta la propria essenza non può che essere considerato un maestro. E sempre a onor del vero, non è vero (scusate il gioco di parole) quello che si sente dire in giro da taluni lettori che i contenuti sono difficili, i discorsi incomprensibili, la logica astrusa ecc. ecc. Forse lo erano per l’epoca, per il rigido enviroment cultural – popolare in cui inizialmente s’era inserito questo testo, ma di fatto i temi trattati per quanto aulici sono spiegati con chiarezza e semplicità e sono veramente alla portata di tutti; ne è prova che, al mutare del sopracitato ambiente sociale, il testo venne adottato quasi a manifesto di propaganda di certi neo- nati movimenti volti alla riscoperta (o scoperta) delle filosofie orientali. Tuttavia tanto il “quanto mai appropriato stile” con cui è stato plasmato Siddharta, tanto la semplicità dei contenuti, alla prima ripetizione, alla prima scena replicata, tendono a mimetizzarsi tra i paragrafi e i capitoli mentre il lettore, tra uno sbadiglio e l’altro, conta le pagine mancanti all’ovvio finale in cui certamente (poiché si capisce fin da subito che sarà così) Siddharta scoprirà la via una volta per tutte e non romperà più le scatole con i suoi mal riusciti tentativi.
Mi rendo conto con queste ultime considerazioni di essermi lasciato prendere troppo la mano con le critiche, in fondo si sta parlando sempre di un libro che ha fatto la storia della letteratura ma è veramente avvilente trovare un testo che per chiarezza, cadenza, solennità e talvolta anche contenuti (particolarmente interessante il piano sociologico che accomuna le fatiche del figlio del Bramino ai problemi dell’uomo moderno, la sua costante ricerca e il suo costante sentimento di travagliata inadeguatezza, ai valori imposti dalla società contemporanea.) potrebbe essere annoverato tra i più grandi e per colpa di una patologica mancanza di inventiva, anche se sembrerebbe quasi di voglia, viene classificato da alcuni come noioso, banale, astruso e desueto. E scoprire per di più che per certi aspetti, quegli “alcuni” hanno ragione!
Sarebbe bastata un po’ d’inventiva in più, sarebbe bastata un po’ di logica in più… Ma nella realtà non c’è mai niente di perfetto e la delusione che si prova a trovare l’imperfezione in un testo così famoso è quanto mai fonte di esperienza per ogni lettore. Peccato solo che Siddharta, l’esperienza, non sappia cosa sia…
Indicazioni utili
Prendere o lasciare
Un libro audace, sia per quel che riguarda l'argomento trattato (talmente sfruttato in letteratura che ogni volta che se ne scrive l’autore di turno deve per forza confrontarsi con le decine, centinaia, di suoi colleghi che ne hanno scritto, ne scrivono e ne scriveranno), sia per le dimensioni del volume (il numero di pagine da cui è costituito un libro generalmente è inversamente proporzionale alla voglia che viene di leggerlo), sia infine, perché, diciamoci la verità, Ken Follett un libro così l’aveva già scritto!
Un libro audace dunque ma non per questo privo di appeal. Se uno dei suoi lati negativi infatti è quello di essere veramente troppo simile a I Pilastri della Terra, uno positivo è sicuramente quello che, traendo dalla somiglianza col precedente romanzo, ne riporta anche tutti i pregi : lo stile discorsivo (per chi piace), l’abilità dell’autore di trattare tematiche spesso e volentieri considerate “pesanti” in maniera divertente e accattivante, una trama dal ritmo sostenuto (malgrado le mille e più pagine) e sicuramente la completezza dell’informazione storica in esso racchiusa che svela un accurato lavoro di ricerca.
Certo il grosso del lavoro Follett l’avrà fatto soprattutto prima della stesura dei Pilastri, mentre qui si sarà limitato a rispolverare i vecchi appunti, tuttavia non si può proprio dire che in questo mastodontico sequel manchi qualcosa: guerre, epidemie, estremismo religioso, superstizioni, intrighi politici e passioni promiscue, c’è veramente di tutto, dai più banali cliché del tempo a le trovate più ingegnose, sì proprio di tutto… anzi c’è perfino troppo! Tanto che l’autore per tentare di contenere la sua vena creativa a tratti è costretto ad operare dei veri e propri tagli nella narrazione che coincidono con dei salti di diversi anni nella vita dei protagonisti e che ogni volta lasciano il lettore perplesso e stranito, costantemente in lotta in uno strenuo tentativo di riorganizzare l'idea mentale che si era creato dei principali attori e dei luoghi in cui si svolgono i fatti.
Forse questo doveva essere un effetto voluto, forse proprio in questi bruschi balzi nell’intento dell’autore doveva risiedere la novità rispetto agli altri romanzi di questo genere: una narrazione spezzata che si concentra in singole frazioni di pochi anni lungo un’ intera vita. Bella idea, ma bisogna essere in grado di realizzarla, altrimenti…
D’accordo qui non siamo di fronte a un miscuglio anacronistico di fatti slegati anzi, la trama alla fine regge, tuttavia si ha l’impressione di trovarsi di fronte sempre a un qualcosa di sbilanciato, poco definibile e difficilmente collocabile in un genere o un ambito specifico: il romanzo è scritto con uno stile troppo canonico per concedere una pur minima sperimentazione ma d’altro canto ha un contenuto troppo spezzettato e frastagliato per essere annoverato tra i romanzi comuni. Il risultato finale è quello di un buon libro ma che pare intrinsecamente inclassificabile e difficilmente etichettabile; se l'autore infatti avesse abbracciato un arco di tempo inferiore sarebbe stato un libro più incisivo, se invece si fosse dilungato maggiormente sarebbe risultata una cronaca più fedele e magari ci sarebbe stato spazio per quella introspezione psicologica che, come molti hanno già fatto notare, è praticamente assente, ma così tagliato e stiracchiato invece risulta una strana via di mezzo, ne carne ne pesce.
Dunque che cos’è Mondo senza fine? Come si può definire?
Come si è già detto è senza dubbio un libro audace, ma è anche un libro contradditorio che conta più di mille pagine eppure scorre veloce verso l’adeguato finale, che pur facendo della semplicità descrittiva il suo punto di forza lascia il lettore con insolubili interrogativi circa il suo significato e ancora che, pur parendo “affettato grossolanamente” tra una capitolo e l’altro per questioni probabilmente di spazio, di volume e di tempo, cela tra le righe una cura per il dettaglio fuori dal comune.
Questo è Mondo senza fine, un libro che riporta già nel titolo la risposta alle domande che genera: “senza fine”, già… proprio come la costante contraddizione che pare provocare, proprio come i dubbi che pare suscitare e proprio come l’incontestabile fascino che, nonostante tutto, pare possedere. Prendere o lasciare.
Indicazioni utili
Affossato dallo stile
Sasenka ha la drammaticità dello scorrere del tempo, e non è quella del lineare fluire dei secondi che passano al muoversi della lancetta di un orologio, ma quella statica di chi osserva il passato consapevolmente, conscio di quel che è accaduto e di quel che sta per accadere. E questa drammaticità nel romanzo è essenziale poiché rende l'attesa degli eventi che vanno dalla rivoluzione Russa alla seconda guerra mondiale un elemento portante (nonché l'unico degno di nota) dell'architettura del romanzo.
Gli episodi storici sono noti, così come quelli politici, la tragicità della folle escalation di quel movimento che era nato come sommossa popolare e che si era trasformato man mano in dittatura è infatti ormai ben definito; ciò che rimane in ombra, nascosto, forse solo intuibile è come fossero le persone all'epoca: gli uomini, le donne, le famiglie normali, i singoli individui dentro la macchina di una società in tumulto tra due guerre e una rivoluzione civile. E l'intento dell'autore sembra essere proprio quest'ultimo: dipingere un ritratto delle persone normali dell’epoca intrecciate con gli eventi del grande quadro della storia di quegli anni. Per vivificare il dipinto occorre però un esempio, un campione: Sasenka, una ragazza che fin dall'infanzia sembra predestinata ad una vita in bilico tra borghesia e rivoluzione, tra vantaggio personale e bene comune.
Cosa sarebbe accaduto all'Unione Sovietica è noto, cosa accadrà a Sasenka, e come a lei a tutte quelle altre persone di cui lei è l'esemplificazione, invece no ed è qui, nell'incertezza del singolo di fronte alla concretezza dei fatti reali che si costruisce il meccanismo del libro, che si definisce il ritmo della narrazione e che si materializza la tensione dell'attesa di un qual cosa che si è certi stia per accadere; ed è nella fisiologica incertezza di questo meccanismo di contrapposizione che l'autore raggiunge la sua vetta, ed ancora è grazie a questa, grazie al sopracitato dualismo Russia - Sasenka, certo - incerto, che il romanzo si affaccia all'echelon dei vertici letterari.
Peccato però che tutte le 623 pagine del libro siano irrimediabilmente affossate da uno stile di scrittura piatto e banale, buono sì e no per un romanzetto rosa e assolutamente inadatto a rappresentare l'ampia drammaticità del destino dell’Unione Sovietica e di Sasenka. Uno stile così poco efficace che non riesce scalfire il lettore neppure di fronte alla tragica verosimiglianza degli eventi narrati. Una narrazione così insulsa che neppure se al posto di Sasenka fosse scritto il vostro nome riuscireste a reprimere gli sbadigli.
E i picchi della tensione, del dualismo storia-persona che fine fanno? Sono pur sempre delle vette letterarie, no?
Ahimè no: se la base della montagna infatti origina in una voragine anche la cima, per quanto altissima, rimarrà sempre a livello del suolo: bassa, anonima, ineluttabilmente irrilevante come un filo d’erba nella piana prateria dei libri da quattro soldi. E così purtroppo è Sasenka, un libro che aveva le potenzialità per sbocciare diventando un capolavoro d'altri tempi ma che in realtà per colpa dello stile non è niente di più che un filo d'erba tra gli altri.
"Un romanzo sulla scia della grande tradizione dei narratori russi" (o qualcosa del genere), si diceva per promuoverlo…mi chiedo se chi ha inventato questo slogan abbia mai letto “un grande narratore russo della tradizione.”
Indicazioni utili
Stile, stile e ancora stile!
Brevemente, poiché il librò in sé non necessita un' analisi particolarmente approfondita, (almeno non quanto quella necessaria a descrivere, comprendere e definire l'autore e la sua filosofia di vita) Post Office o lo si odia o lo si ama... o entrambi. Premesso che apprezzare non è sinonimo di condividere e comprendere non lo è di approvare, questa è un'opera comprensibilmente apprezzabile: il soggetto è semplice, il tema biografico comune, ciò che conta tuttavia non è l'originalità dei contenuti, ma l'originalità di come vengono presentati, narrati. Bukowski riesce a fare del disagio sociale e dell'autoemarginazione un punto di forza, anzi "IL" punto di forza e anche quello di partenza di tutta la sua opera e di tutta la sua filosofia di vita.
Quello che Chinaski, trasposizione letteraria dell'autore, ha nei confronti della vita è un comportamento apoptotico: lui sa di vivere così, sa a quello che va incontro con i suoi comportamenti, sa cosa rischia e gli va bene, o meglio non gliene frega niente. Quella è la sua vita, ma non è che se l'è scelta così, è come se fosse già tutta programmata da qualcun altro: lui vi si adatta come può. Contento lui... di fatti poco contano le sue scelte, o meglio quelle che impone ai suoi personaggi, ciò che conta è l'abilità con cui le rappresenta, come le giustifica senza una vera giustificazione, come riesce, in soldoni, a rivoltarti la frittata e farti credere che abbia ragione perché il mondo secondo lui va proprio così!
Ci sono molti modi per leggere un libro e per giudicare un autore, uno è quello di prestare attenzione solo ai contenuti e ritenere quanto più valido uno scrittore, quanto più originali e divertenti sono essi siano; un altro modo è quello di concentrarsi sull'impatto delle parole, su quanto viene detto, quanto sottointeso, sull’eccessivamente esplicito del singolo che racchiude un profondo implicito sociale.
Per concludere e riassumere mi sembra quanto mai appropriato riportare qui un aneddoto:
quando dissi a suo tempo a un amico, anche lui appassionato di letteratura, che mi accingevo a leggere il mio primo libro di Bukowski, lui commentò soltanto, "Ah bellissimo! ...In fondo però dice un mucchio di cavolate."
Come dargli torto? E' vero, in fondo dice un mucchio di cavolate, ma con che stile!
Indicazioni utili
Piacevole anche se sforzato
Zafon sa scrivere: il suo stile, semplice ed accurato, umile ma riccamente pregno di tutti quegli aspetti che colorano la vita, conferisce un sentore di autenticità ad ogni personaggio, situazione, ambiente che la sua penna abilmente descrive. In questo lavoro, che l'ha portato agli onori di quella complicata e talvolta assurda macchina che è la celebrità letteraria, la narrazione a tratti rimanda addirittura alla grande scuola del realismo americano. Come i suoi illustri, (ma intendiamoci: anche molto più bravi)colleghi, Zafon, scrive di storie concrete, di vita vissuta e di fatti che sembrano strappati alla cronaca dell'epoca permeando tutto di quella sottile e mai sgradita ironia che inequivocabilmente da una solida marcia in più al romanzo sostenendo il lettore in certi inevitabili momenti di stanca e rompendo la tensione nei momenti cruciali.
Un plauso particolare poi gli è dovuto per la creazione della figura di Fermin Romero de Torres, così autentica con i suoi vizi, i suoi peccati e le sue doti; così umana nella sua condizione in bilico tra il precario e il pateticamente divino, da suscitare una simpatia incondizionata. Una figura così a suo modo normale e speciale che tutti prima o poi ci riconosciamo in essa e ci sentiamo più uniti, più comprensivi dei fallimenti umani e allo stesso tempo più sicuri dell'immancabile riscatto sociale, contagiati da quella leggerezza con cui Fermin prende la vita, dall'impeto con cui si dedica ai suoi impegni e dalla lealtà che mostra nei confronti degli amici.
Detto questo, con l'Ombra del vento, non siamo di fronte ad un capolavoro eterno, anzi, l'intrigo amoroso da telenovela sudamericana e il gran finale così pirotecnicamente barocco nel suo eroismo da "b-movie", riportano nel giusto ordine delle cose l'intero romanzo, facendo bene intendere al lettore che seppur per stile Zafon strizzi l'occhio ai grandi della letteratura contemporanea, per tutto il resto, dai contenuti, al ritmo, dalla logica all'introspezione, be ne ha ancora di strada da fare per raggiungere certi livelli. Tuttavia si intravede dietro le sue parole lo sforzo per raccontare qualcosa che non sia ne piatto, ne banale, e come ogni persona che compie uno sforzo, anche se non sempre il risultato è quello sperato, anche lui è giusto premiarlo, se non altro anche solo per il semplice fatto di averci provato e di averci concesso così una speranza.
Indicazioni utili
Decadente
Un romanzo decadente, non nell'accezione culturale – artistica del termine, bensì in quella della fisica nucleare: al pari infatti di un instabile atomo di plutonio, che emettendo radiazioni tende al piombo, il “delitto di Montmartre” di pagina in pagina perde energia, potenza, valore fino a raggiungere una stabilità elementare degna del prodotto del decadimento nucleare del sopracitato radionuclide. Se da principio il romanzo affascina per l'ambientazione retrò (va indubbiamente concesso alle autrici il merito di aver compiuto un discreto lavoro di ricerca e ricostruzione storica) è anche vero che tale atmosfera al primo cliché, alla prima banalità, si ridimensiona notevolmente fino a ricalcare una profondità narrativa degna di una fiction familiare. Parigi a fine 1800 è una grande città, magari non quanto adesso, comunque già piuttosto estesa e popolata, possibile che il protagonista indaghi proprio al Moulin Rouge e vi incontri proprio Toulouse Lautrec? Capsico che a certe sfiziosità è difficile resistere, ma per l'autenticità talvolta occorre compiere qualche sacrificio, per non decadere nel piattume talvolta occorre astenersi.
Contenutisticamente, nulla da eccepire al romanzo: un discreto plot, un intrigo ben architettato, pochi e realistici colpi di scena e un'indagine accattivante, persino il ritmo adeguatamente calmo e riflessivo risulta appropriato. Dunque se il problema risiede esclusivamente nella mancanza di credibilità di certi ambienti e di certi personaggi, nella artificiosa banalità dei luoghi comuni, non si potrebbe chiudere un occhio in nome della ricerca storiografica delle autrici? No. Una casa potrà anche essere ben costruita con solide fondamenta e materiali di prima qualità, ma se i muri sono scrostati e la vernice è ingiallita, apparirà sempre come un tugurio, una catapecchia, una bettola: abitabile sì, ma vergognosamente indesiderabile. Dunque un romanzo decadente, come decadente è la voglia di portare a termine una lettura farcita di banali e pretenziosi stereotipi, come decadente è appunto il plutonio. E se il “nostro” atomo durante il suo processo di trasformazione emette radiazioni alla lunga nocive per l’uomo, allo stesso modo questo romanzo durante la sua lettura trasmette vibrazioni negative che alla lunga fanno disinnamorare della letteratura. A differenza del suo corrispettivo atomico tuttavia “il delitto Montmatre” ha un indiscutibile pregio, se infatti il plutonio ci mette circa 24000 anni a decadere (generazione più, generazione meno) questo romanzo ci impiega soltanto 336 pagine, in fondo sopportabile no?
Indicazioni utili
Ma lui si è capito?
Una narrazione netta, pulita ed uno stile sincero, sobrio e tuttavia profondo fanno di questo libro un capolavoro... mancato. Mancato ineluttabilmente e desolatamente, poiché se dal lato tecnico/stilistico Murakami fa sfoggio di tutta la sua classe riuscendo con maestria a mischiare la consuetudine con la desuetudine, il realismo con l'onirismo e in definitiva il fisico con il metafisico, conferendo una solida credibilità ad un personaggio che schematicamente ridotto ai minimi termini sarebbe improbabile quasi quanto un fantozziano puffo pervertito, se da un lato riesce in tutto ciò, dall'altro lato, quello contenutistico, fallisce miseramente. L' affascinante vena letteraria dell’autore infatti si esaurisce dopo pochi capitoli relegando lo spunto e l'ispirata innovazione a pochi sparuti paragrafi (per lo più riconducibili alla realistica cronistoria del Giappone durante gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale.) Il piattume che circonda quei brevi fogli purtroppo è epidemico e neppure gli svolazzi fantastico/fantasiosi (da veggente telefonica o cartomante televisiva) servono a risollevare una trama che sprofonda sempre più nel ridicolo e nel fumoso iperbolico.
Eppure il libro è solido! Eppure avvince! Pagine e pagine di insulsi contenuti, eppure diletta! Come è possibile? A cosa è riconducibile questo stridente paradosso? Sì, la parte storica è interessante ma slegata e povera, gli spunti filosofici sono adeguatamente profondi e per certi aspetti anche peculiari, ma pur sempre fini a loro stessi e "già conosciuti", dunque come è possibile?
L'unica teoria che si può chiamare in causa a supporto di una plausibile spiegazione di questo contrasto fenomenico è ancora quella, la sola e la solita: l'abilità tecnica dell'autore (anche se in questo caso più che di tecnica si dovrebbe parlare d’ arte) che, pur con qualche caduta di stile e pericoloso capitombolo di ridondanza, riesce a creare un testo perfettamente bilanciato in tutte le sue componenti, in equilibrio costante tra il concreto cronico e l’acuto astratto, tra il reale e il metaforico, tanto che tutte le ottocento e più pagine sembrano quasi un pretesto, un pretesto per poter dire qualcosa di diverso, di nuovo.
Un'unica grande parabola per poter svelare ai lettori una profonda verità altrimenti inenarrabile, questa è l’impressione che si ha fin dal principio leggendo l’Uccello che girava le viti del mondo, questa è la sensazione: che tutto sia metaforico, scritto con un preciso obiettivo, con un intendimento finalistico di grande importanza che verrà svelato solo al concludersi della vicenda. Ma qual è dunque questo obiettivo? Qual è la profonda verità che l’autore esorta a scoprire conducendoci per mano fino alla conclusione dello scritto? Qual è l’insegnamento che soggiace a questa apparente metafora di ottocento pagine?
Non è chiaro, forse è volutamente incomprensibile in modo che ognuno possa trarne… be quello che vuole, forse è involontariamente fumoso poiché ad un certo punto neppure lui si ricordava più quello che voleva dire, ma in conclusione una cosa di tutto il libro rimane: “L’uccello che girava le viti del mondo” è un sorprendente esercizio di stile da parte di uno scrittore dal potenziale incommensurabile ma dalla vena creativa, in questo romanzo, totalmente esaurita.
Murakami come al solito ha scritto un libro in maniera stupefacente, ma si è reso conto di quello che ha scritto?
Indicazioni utili
Stridente
Deludente considerate le premesse, e il blasone dell’autrice, ma intrinsecamente affascinante solo come possono esserlo le storie vere di una persona che ha condotto una vita straordinaria.
Non fraintendetemi però: la delusione e il fascino non vanno a braccetto, scambiandosi reciprocamente con tempi ben studiati la luce del palcoscenico, al contrario sono nettamente (quasi stoicamente) separate in parti ben precise e l'una stenta notevolmente a lasciare il passo all'altro. Il libro infatti è nettamente suddiviso in due parti: la prima romanzo che lascia ben poco all’originalità e all’abilità letteraria della Lessing, la seconda dolorosa cronaca biografica della vita dei suoi genitori in un tempo tartassato da vicissitudini storiche di primaria importanza e tuttavia morbosamente dilettevole per tutta quella serie di particolari aspetti culturali, e di consuetudine sociale, oggi giorno storicamente non più riproponibili.
Se la prima parte dunque è un romanzetto di poche pagine la cui banalità sembra l’adeguato contorno all’affrettata stesura dello scritto, un semi didascalico esercizio letterario in cui i fatti vengono elencati senza un preciso ordine cronologico e da sovrapposti punti di vista che non fanno altro che creare un senso di confusione e distacco nel lettore, la seconda parte, per nostra fortuna, risulta essere l’esatto opposto: una precisa e attenta cronaca ricca di sfiziosi particolari che catapultano il lettore in un mondo antico, direttamente più violento, scomodo e precario, ma senza dubbio più accattivante e avventuroso. Un mondo affascinante dipinto nei toni forti e concreti dei fatti realmente accaduti, fatti che solo chi li ha vissuti in prima persona sa rappresentare così vividi e scevri di quella poco autentica romantica nostalgia che in certa letteratura sembra pervadere ogni sorta di ricordo (rendendolo del tutto artificioso).
Dunque Alfred ed Emily non è un unico romanzo ma di fatto sono due libri, due storie differenti, scritte in stile differente; tuttavia se questa diversità è per la maggioranza dei fruitori il punto di forza del libro per quel che mi riguarda è il suo punto debole, l’ingranaggio poco oliato di una macchina altrimenti perfetta, con questa “faglia tettonica letteraria” infatti sembra quasi che Doris Lessing voglia dirci, “si d’accordo devo scrivere un romanzo per obblighi contrattuali, però questa volta non mi va poiché preferisco narrare della mia realtà che per anagrafe è nettamente superiore ad ogni sorta di fantasia.” Il risultato non è un nuovo stile letterario commistione di due generi differenti (come alcuni hanno provato a dire), non è un nuovo modo di concepire il romanzo: sono semplicemente due scritti in uno, stridenti tra loro come possono esserlo la realtà e la finzione, il vero e il falso.
Alfred ed Emily dunque non è nient’altro che la somma di due differenti testi, ma, come in ogni calcolo, in cui se non si sta più che attenti ad eseguire correttamente l’addizione il risultato finale rischia di essere irrimediabilmente errato, anche qui, terminata la lettura tutto ciò che rimane è il gusto amaro dell’occasione perduta (o sprecata che dir si voglia): sì, avrebbe potuto essere un affascinante autobiografia; sì, avrebbe potuto divenire una testimonianza storica di notevole importanza; sì, avrebbe potuto essere un’ennesima opera da premio nobel; sì, avrebbe potuto…
Indicazioni utili
Rinnovatore
Quinta avventura in ordine cronologico dell'alter ego cussleriano Dirk Pitt. Un romanzo costruito attorno ad una trama piuttosto semplice ed elementare, un avventura che sconfina nel giallo senza tuttavia particolari colpi di scena. La narrazione fin troppo discorsiva e uno stile senza ricercati fronzoli (come gran parte della narrativa dell'Autore) fanno di questo libro un capitolo piuttosto interlocutorio e innocuo della lunga carriera di Cussler.
Attenzione però a non incorrere in fraintendimenti: rispetto ai suoi precedenti lavori quest'ultimo è un notevole passo avanti verso quelle vette di intrattenimento di massa che raggiungerà con i romanzi scritti verso la fine degli anni ottanta e l'inizio del novanta. Tralasciando infatti Vortice (il suo primissimo lavoro), Virus è molto più complesso ed elaborato di Enigma, e decisamente più completo di Iceberg e senza dubbio molto più romanzo di Recuperate il Titanic. Lo stile di scrittura qui infatti si affina sempre più e così la profondità della trama che, per quanto semplice, è ben articolata e senza alcun dubbio ben concepita.
Virus, o Vixen 03, dunque è un libro che, seppur semplice e per certi aspetti troppo lineare, rimane comunque interessante per tutta una serie di particolari degni di nota, tra cui la "comparsa" per la prima volta nella letteratura dell’ autore della bella Loren Smith, che poi diventerà una costante tra i personaggi principali dell'autore; e soprattutto per quella ombrosa atmosfera silvestre in cui ha inizio la vicenda, un atmosfera che poi avremmo rivisto altrettanto ben caratterizzata soltanto in certi romanzi successivi del collega Stephen King.
Dunque se per certi aspetti Clive Cussler con l'uscita qualche anno prima di Raise the Titanic poteva essere definito "un precursore", in questo nuovo (per l'epoca) libro non è da meno e se non può esattamente essere elogiato ancora per la sua vena innovativa, poiché comunque è evidente che in certi tratti si rifà (filtrandolo notevolmente) ad un filone noir anni cinquanta/sessanta e horror/pulp anni settanta, gli va almeno tributato il merito di essere un "rinnovatore".
Per concludere è interessante notare come anche in questo libro la storia principale si svolga attorno ad un tema, quello virale, che negli anni successivi sarebbe diventato a dir poco di grande consumo per ogni forma di intrattenimento, da quello letterario a quello cinematografico, da quello televisivo-mediatico-allarmistico fino e perfino a quello artistico.
In sostanza questo libro può piacere come non piacere, può essere definito in tutti i modi possibili: banale, innovativo, piatto, profondo, lungo, breve, canonico, new age... in fin dei conti è a discrezione del gusto personale del lettore, oggettivamente però è assolutamente impossibile definirlo come un opera figlia della sua epoca, infatti Virus, riletto oggi come trent'anni fa, ha ancora qualcosa da dire e questo, con certa narrativa moderna da supermercato, è indiscutibilmente un pregio.
Indicazioni utili
Profondo ma...
Allucinato viaggio di denuncia nei (e dei) disturbi della mente umana quali diretta conseguenza dell'emarginazione sociale. La psicosi, la schizofrenia e perfino l'autismo nel libro di Dick vengono trattati alla stregua di un naturale decorso della separazione dell'individuo dalla normalità istituzionale. E' la società stessa del futuro, in cui vivono i protagonisti malati, che compie questo processo distintivo tra ciò che aprioristicamente viene definito normale e ciò che viene schedato come anormale; un processo, questo, crudele e discriminante ma indispensabile per garantire la funzionalità e con essa la sopravvivenza di quell'organismo collettivo e quasi vitale che si riunisce sotto la sigla dell'ONU. Onu o società globale alla ricerca essa stessa di un identità solida e al contempo di una via di fuga dove emarginare gli "anormali" così da contemplarli da debita distanza per non sentire il peso e la forza della loro autenticità. Contemplarli distaccatamente e in questo modo racchiuderli e ri-catalogarli nuovamente dentro le fila di un tessuto che comprende sì la diversità, ma esclusivamente come malattia epidemica da debellare.
Questa è la premessa, poi l'autore si addentra nei disturbi del singolo e pian piano ci fa conoscere la loro realtà e finalmente si compie la svolta: ma saranno loro gli anormali o è il resto della società? Di sicuro gli individui nella società sembrano più solidi, con valori più definiti, puri se si vuole… ma saranno ancora così umani nella loro pura perfezione? Dunque ben vengano gli psicotici, gli autistici e i malati poiché nella loro debolezza forse è la vera natura dell'uomo, nella loro allucinazione l'autentica realtà.
E' il singolo contro il complessivo e Marte non rappresenta la soluzione a questa dicotomia, anzi ne è l'estremizzazione: in condizioni estreme spesso si è portati all'estremo e così, lì, accade con pericolose spedizioni di conquista, il mercato nero per beni alimentari, le lobby spregiudicate per accaparrarsi la fornitura dei servizi di prima necessità, le istituzioni robotizzate insegnanti e disumanizzanti, le dittature sindacali ecc. ecc.
In una simile società l’individuo ha paura del contatto umano, si auto emargina nella propria solitudine facendosi addirittura scudo con le figure degli psicologi che Dick immagina come veri e propri sciacalli che, invece di guarire i disturbi dei malati, trovano molto più semplice e remunerativo farsi carico delle loro incombenze sostituendoli fisicamente ad ogni occasione.
È questo quello a cui andiamo incontro? È questo misero destino da auto-ghettizzati che ci riserva il futuro se non cambiamo il nostro modo di vivere? Il futuro della società umana è l’auto distruzione? Sono queste le domande che infondo si pone Philip K. Dick.
C’è una qualche soluzione per evitare tutto ciò? Per prevenire questo problema?
Sì, e la risposta è un bambino autistico, un essere debole, antiteticamente contrapposto all’ingombrante solidità di tutti gli altri. Un bambino piccolo che, solo, ha la precognizione, la visione del futuro, o forse nella sua immacolata ingenuità la conoscenza e l’esperienza per capire le conseguenze della corruzione di quel mondo. Come ogni moderno profeta di sventura però quel bambino non viene ascoltato, anzi viene classificato come malato, matto, indesiderato e per questo emarginato. Fino all’ultimo, fino a quando qualcuno comprende il suo potere, ma ancora una volta quel qualcuno non sfrutta la sua verità per salvare Marte, ma per fare i propri interessi riallineandosi perfettamente a quelli che sono i principi sociali, tanto che alla fine il bambino profeta compie l’atto estremo: si auto emargina volontariamente da tutto ciò che lo circonda ritrovando una nuova identità in un gruppo di individui separati, primitivi, per questo estranei a quella irrefrenabile corsa verso l’autodistruzione e per questo umanamente autentici.
E gli altri? Quelli che assistono a tutto ciò? Non possono farci nulla: pur facendone parte è un processo molto più grande di loro, pur avendo la consapevolezza di quel che gli riserva il futuro non hanno via di scampo e non ci tengono ad averla, continuano a vivere normalmente, trovandosi molto più a loro agio nel loro preconfezionato loculo globale.
Letto in questo modo poco importa dove sia temporalmente e geograficamente ambientato il romanzo. Nel futuro su Marte, ma per la linearità della trama poteva anche essere l’ ‘800 nel Far West, anzi per certi aspetti si capisce che l’autore ha risentito del filone narrativo – cinematografico in voga all’epoca: la conquista delle nuove terre, la società violenta, fino all’immancabile duello finale a colpi di rivoltella. In fondo è naturale che sia così: il Far West per la società dell’ '800 rappresentava una terra di conquista, l’ultima frontiera; per la società moderna l’ultima frontiera è lo spazio, Marte. Ma come si diceva poco importa, poiché tutto in realtà è una metafora di quelle che sono le preoccupazioni dell’uomo, di quelli che sono i problemi verso cui, secondo l’autore, stiamo andando incontro di nostra spontanea (e stupida) volontà.
Dunque un Philip K. Dick come sempre illuminato e quanto mai “piacevolmente” pessimistico e catastrofista?
No, inutile girarci attorno, questo romanzo per quanto affascinante è inferiore agli altri e il problema sta nello stile di Dick, nel suo metodo di scrittura, che qui più del solito è troppo asciutto, troppo conciso e piatto. Se per certe opere la concisione quasi schematica può essere un pregio (vedasi per esempio le recensioni… ehm!), quando si parla di romanzi è quasi sempre un difetto: il lettore non riesce a farsi prendere dalla trama, rimane freddo e distaccato e la storia stessa perde la sua potenza.
Ma e i contenuti, le metafore, la visione del mondo crepuscolare e disincantata?
Ci sono tutti, sono intuibili e piacevoli, ma ancora una volta, come la rotella allentata di un ingranaggio altrimenti perfetto rischia di compromettere l’intero macchinario, lo stile troppo distaccato dell’autore fa rimettere in discussione tutto quanto e fa riflettere sul fatto che quando si legge su questo piano un libro (o meglio quando lo si vuole leggere per forza su questo piano) al momento di commentarlo c’è sempre il rischio di mettere in bocca all’autore parole che in realtà non sono le sue, di interpretare e quindi riportare pensieri che magari non avevano minimamente sfiorato colui che ha scritto l’opera, e in questo modo ingigantirne i pregi e minimizzarne i difetti, cercare infine la profondità la dove in realtà non c’è ne più ne meno che un banale gioco di specchi.
Ma allora la società corrotta, il futuro segnato dagli sbagli dei contemporanei, il male dell’individuo come causa del malessere sociale e viceversa?
Vero, d’accordo, c’è tutto questo e anche altro, ma l’irreparabile distacco che si crea nel lettore per colpa della narrazione troppo affrettata è più potente, più forte, e per quanto la logica (o è il sentimento?) ci ricordi che stiamo parlando di una delle più fervide menti degli ultimi cinquant’anni, il dubbio di trovarsi al cospetto di una ben collaudata accozzaglia di fatti legati da uno stiracchiato nesso sociale, qui purtroppo rimane.
Peccato, veramente peccato.
Sorprendentemente introspettivo
L'originalità, la bellezza, i sentimenti, l'ironia e la suspense, sono tutti termini già utilizzati innumerevoli volte da lettori e fan per descrivere la saga del piccolo mago occhialuto e dal canto mio non ho nulla da ridire, per quanto abbia letto solo gli ultimi due libri si capisce subito dallo stile dell’autrice, dalle sue curiose trovate che questa è senza dubbio una bella ed avvincente favola a cui, se conosciuta alla giusta età, è impossibile non rimanerne avvinti, vuoi per quel meccanismo di immedesimazione nel protagonista, sì mago ma dai connotati e problemi assolutamente umani, vuoi per quel bisogno recondito nell’animo di ogni adolescente di fuggire dalla sua apparentemente brutta realtà. E quale luogo migliore per fuggire se non quello incantato di un mondo dove tutto è possibile? Quale luogo se non uno dove, pur esistendo grosse e terribili ingiustizie, alla fine il bene, la lealtà e l’amore sembrano sempre trionfare?
Dunque niente da eccepire, una bella saga e una bella favola, tuttavia quest’ultimo libro, almeno rispetto al precedente è qualcosa di più di una semplice favola: è vero che in quest'ultimo romanzo a differenza degli antecedenti il tema della confortante realtà parallela rappresentata dal mondo costruito attorno al castello di Hogwarts viene soppiantato dal più collaudato, e forse più banale, tema della fuga dei protagonisti, fatti passare ingiustamente per fuorilegge e come tali braccati da maghi cattivi, tuttavia ciò che potrebbe sembrare un cliché narrativo è altresì una acuta metafora (anzi proprio quella metafora sopra accennata) della crescita e della maturazione dei ragazzi, degli adolescenti che diventando adulti, proprio come i loro simili reali, devono affrontare problemi via via più difficili durante un cammino costellato dall'incertezza, dall’ingiustizia e talvolta dal rimpianto. E come giusto che sia in questo romanzo conclusivo i toni si fanno adeguatamente cupi, più che negli altri capitoli, e più angosciati, peccato solo che l'immancabile, banale, scontro finale tra le stereotipate forze del "bene" e del "male" non sia all'altezza delle aspettative e conduca ad un epilogo leggermente in tono minore.
Ma non è tanto sul canonico finale (per certa narrativa più è banale e più sembra diventare indispensabile) che mi preme concentrare l'attenzione, ma sulle parti subito prima, quando il protagonista comprende alla fine quale è il suo destino e con determinato, ma ragionato cipiglio accetta la sua ineluttabile condizione: egli infatti forse dovrà morire, forse dovrà sacrificarsi, ne sarà in grado? Queste pagine sono scritte con una tale sofferta (e sorprendente) lucidità emotiva e con un tale vivido angosciante realismo che è difficile anche per un adulto non far scattare nel suo cervello quel meccanismo di totale immedesimazione che gli fa sembrare di vivere le vicenda in prima persona: ma io al posto di Harry Potter cosa avrei fatto? Io come avrei reagito, come mi sarei comportato? E così via.
Forse l’autrice finalmente stanca di focalizzarsi solo sulla narrativa per ragazzi ha voluto intercalare alla storia delle pagine di seria, sentita, se non addirittura profonda e personale introspezione, forse con questo suo excursus (anche se di excursus vero e proprio non si tratta poiché si inserisce perfettamente nella trama) ha voluto dimostrare di essere pronta per una altro più complesso (ma non necessariamente più elevato) genere di scrittura, ma queste poche pagine sono assolutamente degne di nota e non soltanto nell’ambito in cui si colloca la saga del maghetto, ma nell’ ambito letterario mondiale, elevando questo libro, di per sé forse più scontato e banale del precedente, a curiosa voce fuori dal coro del moderno filone del post realismo e sicuramente a pietra miliare, e indiscusso termine di paragone, della letteratura fantasy.
Indicazioni utili
Precursore
"Raise the Titanic!", come recitava il titolo nella versione originale, è il quarto libro scritto da Cussler, il terzo in ordine di pubblicazione (Pacific Vortex, il primo, venne pubblicato solo in seguito a mo di curioso antefatto alla vita di Dirk Pitt per i più appassionati). Oggi come oggi non è considerato tra i best seller dell'autore, tant'è vero che prima della ristampa Longanesi non era di facilissima reperibilità nei negozi di libri.
E’ altresì, questo, però un romanzo che nel corso degli anni si è scavato una piccola nicchia nella vasta letteratura navale, rimanendo in penombra rispetto a titoli più famosi, ma sempre saldamente ancorato nel suo enviroment fatto di storici fan dello scrittore, quasi fosse un piccolo relitto sommerso all’ombra dell’enorme Titanic, giusto per rimanere in tema. Quando tuttavia uscì all'epoca fu accolto con grande clamore e celebrato con il riguardo che si concede solo ai testi letterari più importanti. Ne fu tratto addirittura un film, terribile (come lo stesso Cussler più volte ha affermato), che contribuì a consacrare "il Nostro" in quella schiera di pochi eletti, o fortunati che dir si voglia, che fanno soldi a palate scrivendo.
Col senno di poi forse tutta quella notorietà era un filo eccessiva: il libro di per se è buono, intrigante la trama, incalzante il ritmo, simpatico lo stratagemma con cui si pianifica di far riaffiorare in superficie "il gigante del mare", da cui il titolo, e ha un’ architettura globale accattivante, ma anche se lo stile dell'autore qui incomincia a consolidarsi e a rendersi più sicuro, talvolta persino arditamente istrionico, si rimane sempre entro i limiti della categoria in cui si colloca questo genere di narrativa: narrazione piatta, storia incisiva ma canonica, personaggi appena accennati e colpi di scena a non finire, insomma un libro decente ma che non ha niente di più e niente di meno rispetto ad altri scritti dell'epoca fatti su misura per un pubblico di massa.
Dunque perché tanto clamore? Perché tutto quel parlare del libro?
Probabilmente il motivo va ricercato nella tempistica o per meglio dire nel tempismo: la fine degli anni settanta erano gli anni in cui si ricominciava a parlare concretamente del ritrovamento della nave affondata nel 1912, erano gli anni in cui finalmente si disponeva della tecnologia adeguata per un eventuale recupero, i mass media ogni tanto riportavano notizie sul possibile ritrovamento del transatlantico, e bene o male era un qualcosa di cui tutti erano a conoscenza e tutti se ne interessavano… dunque perché non scriverci su un bel romanzo?
L’autore cavalcando quella corrente con un tempismo perfetto si inserì con una storia ad hoc che narrava di un gruppo di persone che, attraverso molte vicissitudini tentava di recuperare proprio quella nave, proprio quel transatlantico che tutti da bambini nella loro piccola vasca da bagno sognavano di poter localizzare e salvare dalle grinfie dell’oceano. Nel 1976 uscì per la prima volta Raise the Titanic! La cosa giusta al momento giusto. Una bella favola alla portata di ogni lettore che riuscì a soddisfare la curiosità e l'interesse di tutti coloro che avrebbero voluto far chiarezza su ciò che accadde quella notte del 14 aprile del 1912. Il gioco era fatto: Cussler sarebbe diventato uno scrittore da 100 milioni di copie vendute, avrebbe fondato realmente la Numa e avrebbe incominciato a collezionare costosissime automobili d’epoca al pari del suo alter ego letterario.
Oggi tendiamo a dimenticarci di questo libro, a confinarlo al, “sì simpatico ma è la solita americanata”, vero, ma per molti fu una fonte d'ispirazione (il ritrovamento del relitto risale a quasi dieci anni dopo la pubblicazione del romanzo e così anche il primo vano tentativo di recupero.), il realizzarsi almeno su carta di un sogno altrimenti proibito, e per l'autore una vera e propria benedizione.
Non ho le competenze nautiche ne le conoscenze di fisica e archeologia marina necessarie per poter fare un valido raffronto scientifico, tuttavia trovo piuttosto appagante e soddisfacente che il modo con cui l'autore pensava di poter recuperare la nave nel '76 appaia esattamente lo stesso con cui nel 1996, vent'anni dopo, abbiano recuperato parte dello scafo della nave. Naturalmente non sarà stata tutta farina del sacco di Cussler, anche lui all'epoca avrà attinto da degli studi oceanografici fatti da esperti scienziati, tuttavia se il mondo non si è stupito di come siano riusciti a far riemergere parte della nave, poiché tutti lo sapevano già da vent'anni, lo si deve all'autore di Recuperate il Titanic! Se non un innovatore, in questo libro, almeno un precursore.
Indicazioni utili
Tutto già visto, però...
Quando si deve commentare un romanzo ascrivibile ad una tipologia di letteratura di carattere commerciale l'aspetto principale da tenere in considerazione è senza dubbio la trama: è inutile cercare il virtuosismo linguistico, l'approfondimento psicologico o qualche altra caratteristica innovativa: tutto gira intorno alla trama. La trama di questo libro stenta a decollare. Per quanto nel titolo si parli di pirati (in quello originale di "Red Seas") prima di leggere di un pirata o anche solo di un "mare rosso" occorre aspettare più di 300 pagine, su 700! Questa lunga attesa non può far altro che creare noia, distaccamento e pigrizia; sensazioni che il lettore ineluttabilmente porta con se appropinquandosi alla seconda e più vivace parte del libro. La seconda parte "funziona" meglio: è più stringata, ha più ritmo, profondità, ironia, sentimento, ed è senza dubbio più scorrevole. Sfortunatamente sa tutto di già visto: sin dal titolo, come è fin troppo ovvio, si capisce che l'autore furbacchione cavalcherà l'onda del successo di questo genere di narrativa riportato in auge dalla recente trilogia cinematografica disneyana. E sfortunatamente sa tutto di già sentito: leggendo dell' "orchidea velenosa" (la nave dei pirati, per intenderci) e del suo comandante come non pensare infatti a Salgari o Stevenson, precursori ben più autorevoli del giovane autore di questo romanzo? Anche la collocazione geografica dell'avventura è discutibile: l'argomento piratesco apporta già un considerevole elemento fantastico, era dunque così necessario creare un improbabile e poco fantasioso nuovo mondo dove far svolgere la vicenda? Per concludere questo è un romanzo commerciale più banale che innovativo, più improbabile che avvincente. Tuttavia sarà per il finale romantico (in senso letterario), sarà per il ben oliato meccanismo "buddy - buddy" tra i due protagonisti: quello grosso, fortissimo e introverso e quello magro, biondo, furbetto e agilissimo (vi ricordano qualcuno?) ma non mi sento di criticare interamente l'opera di Scott, anzi attenderò speranzoso l'immancabile seguito.
Indicazioni utili
Esaustivo
Dotta ed elegante disquisizione su un argomento di grande attualità: "il terrorismo". I fatti vengono riportati dall'autore così come li ha raccolti (a prova di ciò leggasi la dettagliatissima appendice a fine volume), le tematiche presentate sono scevre da fuorvianti interpretazioni o fin troppo facili e banali luoghi comuni. Ogni episodio, ogni evento, ogni testimonianza sono trattati con assoluta imparzialità, all'autore infatti non interessa tanto esprimere giudizi quanto tracciare un unico filo conduttore dalle origini della famiglia Bin Laden fino ai recenti atti terroristici tristemente noti al mondo. Nel perseguire questo intento Steve Coll con straordinaria abilità scava fino alle origini del nome Bin Laden producendo un affascinante ed esaustivo resoconto della storia moderna del Medio Oriente, svelando retroscena e macchinazioni politiche, indagando sui costumi di popolazioni sempre in equilibrio tra fervore religioso e ascesa economica, tra tradizionalismo sociale e impetuose innovazioni urbanistiche, facendo capire al lettore come questo mondo per alcune cellule terroristiche sia un terreno fertile da cui trarre linfa vitale. Tutto il saggio è permeato dalla fredda logica consequenzialità degli eventi e la professionalità del giornalista/scrittore è senza dubbio un autorevole apporto all'autenticità del libro. L'unico appunto che può essere rivolto al saggio è la mancanza di mappe e cartine delle zone dove si svolgono i fatti riportati: la mancanza di un preciso riferimento topografico produce talvolta nel lettore un senso di smarrimento che mai però si trasforma in tedio. In conclusione è una lettura impegnativa che non può essere affrontata con superficialità, del resto non è quel genere di letteratura ricreativa da leggere per riposare la mente; è caso mai un testo di geopolitica socio-economica che contribuisce ad arricchire il proprio patrimonio culturale all'insegna di una crescita personale e di una apertura mentale nei confronti di un mondo strettamente intersecato con quello occidentale.
NOTA: all'epoca dell'uscita del libro certi recenti ed importanti fatti non erano ancora accaduti (uno su tutti: Bin Laden era ancora vivo) tuttavia questo libro non è ormai da considerarsi superato o non più aggiornato poichè lo sforzo dell'autore non è volto tanto a riportare i recenti accadimenti mondiali, quanto a raccontare e analizzare la storia e le cause che hanno generato i sopracitati accadimenti. Dunque pur omettendo per forza di cose alcuni rilevanti episodi l'opera di Coll è da considerarsi ancora di grande attualità.
Indicazioni utili
Sufficientemente simpatico ma niente di più
Una raccolta di racconti che ha la forza della tradizione popolare… e poco altro.
D’accordo rappresenteranno nel loro insieme la nostalgica rivisitazione di uno stile di vita ormai perduto nel tempo, conterranno anche la viva forza del sentimento di un popolo, del credo di una società e della sua cultura, saranno ispirate ai miti e le leggende di un paese (la Provenza, se non si fosse capito dal titolo), ma di fatto non c’è nulla di veramente significativo.
Alcune di queste storielle sono interessanti, altre divertenti, alcune dissacranti, altre consacranti, talvolta eccessivamente patriottiche, talvolta eccessivamente retoriche, qualche altra volta burlesche e parodistiche, ma nessuna veramente rilevante se non per il solo fatto che, trattandosi appunto di racconti popolari, aneddoti da osteria e storielle da bar, riescono nel loro insieme a creare un' atmosfera schietta, grezza, sincera, che dona al lettore quel concreto, genuino buon umore da locanda che ormai si va sempre più a perdere, specialmente nelle grandi città, specialmente dove per ordinare da bere occorre una giacca, una cravatta e una carta di credito.E’ questo l’unico aspetto positivo del libro, di per loro le storie non sembrano infatti essere ne particolarmente varie ne particolarmente originali e la ridondanza dei temi attorno ai quali ruotano alla lunga diventa eccessiva.
Insomma niente più che un gradevole pamphlet di quella che un tempo era la vita quotidiana in Provenza, semplice, autentico, stilisticamente diretto, ma pur sempre un pamphlet.
Indicazioni utili
Il miglior romanzo di Philp K. Dick
Phili K. Dick con Illusione di Potere ci consegna un' opera irreprensibile in ogni suo aspetto. Equilibrato, ragionato, ben architettato, ma anche avvincente, sorprendentemente profondo e introspettivo, questo libro può essere considerato tra i lavori più riusciti dell'autore al pari dei suoi più celebri scritti, quelli che per intenderci sono diventati anche trasposizioni cinematografiche.
L'atmosfera che si respira in "illusione" é quella tipica del futurismo letterario, cara all' autore e ai suoi fedeli lettori, a cavallo tra ciò che é accaduto sulla terra nel recente passato e quello che potrebbe accadere, ipoteticamente, nella società evoluta (ma per certi aspetti involuta) di un lontano futuro, una realtà estremizzata ai margini dell'irrealtà, creata con deduzioni forzate che traggono dalla storia dell' umanità, dall'evoluzione cerebrale degli esseri viventi e che, esaminandone l'andamento, producono delle previsioni all'eccesso.
Non e' semplice fantascienza anni 50 - 60 quella di Dick, é un anticipazione scientifico - sociale ponderata dal sapere dell'epoca, una sorta di esercizio divinatorio della ragione: "date queste premesse non c'è nulla che mi dissuada dall'idea che accadrà questa cosa, date le nostre attuali conoscenze non c'è niente che non mi permetta di pensare che tra due, venti, duecento anni avremo acquisito questo grado di conoscenza," questo sembra essere il filo conduttore del pensiero di Dick, e c'e' una bella differenza rispetto al resto della letteratura di genere a lui contemporanea. Bradbury immaginava la vita su marte, i viaggi interplanetari e le peripezie della scienza spaziale, Asimov illustrava i prodigi del progresso, delle intelligenze artificiali più evolute persino di quelle umane, Dick invece racconta dei problemi dell'uomo alle prese con questi, coi viaggi nello spazio, con la vita su altri pianeti, con il rapporto con altre forme d'intelligenza. E se quello dei suoi colleghi era un libero sfogo, seppur ragionato, della fantasia, quello di Dick invece è uno studio intellettuale, seppur visionario e provocatorio, che ha sempre un punto di partenza, un soggetto e un punto d’arrivo, una sorta di termine ultimo adiacente al principio tramite il soggetto agente: l'essere umano. D'accordo, tra duecento anni vivremo su marte, ci saranno i robot e gli alieni tenteranno d'invadere la terra, ma l'uomo come vivrà? Come affronterà questi problemi? E quelli quotidiani? Quelli di ogni giorno? Di che natura saranno? In che modo li risolveranno? Questa e' la domanda di partenza di Dick, la risposta, ammesso che questa ci sia, e' la fine del ragionamento, e' il luogo dove prende forma la sua previsione, ciò che c' è in mezzo, tra l'inizio e la fine, e' il libro, lo strumento con cui si esplica la sua teoria, lo stratagemma con cui ci fa ragionare sui nostri costumi sociali di moltitudine cosciente, di esseri viventi del pianeta terra e di singoli individui, di separate unità pensanti facenti parte di un sistema globale e inclusivo definito “genere umano”
Dunque c' è una certa differenza rispetto alla letteratura fantascientifica classica; da quella trae il ritmo, lo stile e quell'ingenuo ed affascinante luogo comune che l'immaginario collettivo dell'epoca ci vuole, noi genere umano, alle prese con minacce di altri mondi, di esseri che trascendono il concetto generale di natura; da quella fantascienza prende spunto, ma rispetto a quella poi si sviluppa e si evolve alla ricerca di una nuova definizione, di vita, di percezioni cognitive, di emozione.
Attenzione non è che siamo di fronte ad un saggio filosofico od umanistico, quella di Philip K. Dick è sì la stessa realtà futuristica, probabile ma non verificata, tipica degli anni 50 - 60, ma è l’approccio a questa che è differente rispetto ai suoi colleghi: per Dick la realtà è sempre una questione personale, soggetta a multiple interpretazioni, tante quante sono le persone che la vivono, e mai netta, precisa, definita. (Vedasi per esempio in Illusione di potere le diverse conoscenze e capacità che sfoggiano i vari “io” multi dimensionali, o le possibili risoluzioni della questione storico-politica del mondo asservito o integrato agli alieni, una percezione diversa a seconda della specie che l’analizza.)
E’ come se l’autore elaborasse una realtà, e in questo romanzo è forse più chiaro che in altri, e poi si divertisse a cancellarne alcune parti, sfuocarne delle altre, deformane delle altre ancora, poiché nessuno vede le cose allo stesso modo degli altri, e l’esperienza percettiva di un oggetto tra due persone per quanto simile non potrai mai essere identica, poiché sempre mediata dalle peculiarità fisiche, genetiche, geografiche e persino culturali dei soggetti osservanti. E questo vale per soggetti della stessa specie figuriamoci tra soggetti di specie differenti, con differenti facoltà intellettive, figuriamoci, come nel caso dell’ “Illusione”, tra soggetti appartenenti a mondi diversi. Un tavolo di legno non verniciato è marrone, per un'altra persona idem, ma sarà lo stesso punto di marrone o sarà leggermente più chiaro, o magari più scuro? E per un essere vivente con non vede i colori come gli uomini? Per un Reeg o un Lilistariano, come sarà? E chi ha ragione? Ovvio, la fantascienza di Dick per una questione di estrazione sociale e storica per forza ha aspetti simili al resto di quella prodotta nella sua epoca ma da questa si distanzia, mettendo al centro della narrazione non tanto il singolo, strabiliante evento, tipico di questo filone, ma la comprensione che si ha di esso, mettendo al centro l’essere, umano, alieno, cibernetico che dir si voglia.
Quello dell’autore è l’assunto filosofico aprioristico, che nulla è certo, e dunque non c’è mai un punto di vista totalmente corretto, non c’è mai un’opinione inconfutabile, non c’è mai una specie vivente più meritevole di un altra. E in questo romanzo si vede bene, infatti qui non solo ci fa capire che non esiste una razza superiore, ne nel passato, ne nel presente e neppure nel futuro, ma non ha neppure senso parlare di razza, poiché il concetto stesso non sussiste in quanto di invenzione umana e dunque privo di valore per qualunque essere che non lo sia. Certo questa idea relativistica si può ascrivere a qualunque definizione ed allora nulla ha più un significato, nulla ha più senso, ed allora si sfiora il nichilismo assoluto, inteso come oggetto del reale che si annichilisce nella realtà stessa poiché privo di una propria sostanza oggettiva scevra dalla percettibilità, ma, proprio qui sta la forza del romanzo, del suo messaggio: posto questo assunto, che non c’è un unico punto di vista, non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo lasciarci invadere dal nichilismo della sostanza, al contrario dobbiamo trovare una nuova definizione per le cose, la vita, la realtà, una nuova definizione per l’essere, non più umano ma vivente, e ancora non più vivente, ma semplicemente, cosciente. Di fronte alla mancanza di certezze dobbiamo sforzarci di crearne di nuove, di trovare definizioni che contemplino ogni casistica possibile e che alla luce di una neo acquisita consapevolezza permettano di integrarci, noi esseri ancora umani secondo i nostri canoni, alle nuove specie, da queste trarre dell'insegnamenti, e così, assieme a loro, alle aliene, alle robotiche, compiere il successivo step evolutivo, garantendo ad ogni membro di questo nuovo sistema sociale il diritto di vivere e di sopravvivere, malgrado i problemi a cui andremo incontro, malgrado i difetti che riscontreremo gli uni negli altri.
Questo e' il tema fondamentale intorno al quale si sviluppa Illusione di Potere e in generale la maggior parte degli scritti Dickiani.
Una volta addentratosi in questa analisi, mediata dall’evolversi della trama e delle sue crepuscolari e suadenti atmosfere, (sto ora generalizzando il discorso rifacendomi all’architettura narrativa di tutte le opere dello scrittore) l'autore si trova di fronte a un bivio: il genere umano riuscirà a creare questa utopica società perfettamente integrata e polimorfica oppure non riuscendo a liberarsi dai propri vizi, dalle proprie debolezze, dalle proprie dipendenze, rovinerà tutto, magari proprio sul più bello? E a seconda della strada che vuole far prendere al proprio scritto, a seconda dei concetti sui cui vuole porre l’accento, noi lettori, ci possiamo trovare di fronte ad opere improntate al pessimismo come La Svastica sul Sole o Un' Oscuro Scutare, opere dove si risolve tutto in un' Orwelliana utopia negativa, oppure ad opere improntate all'ottimismo come per esempio quest'ultima, Illusione di Potere, in cui tutto sembra destinato ad andare a ramengo, ma alla fine la fiducia nel genere umano prevale e la società multi specie, poiché definirla multi etnica sarebbe restrittivo, si risolleva, liberandosi dal fardello delle sue ottuse colpe. E’ da notare che nella bibliografia dickiana quest’ultima è una soluzione più unica che rara, che si può apprezzare qui, in Illusione di Potere, e in ben pochi altri scritti.
Spesso questo romanzo viene criticato e non ottiene la stessa considerazione delle altre opere, ma è un errore poiché rappresenta forse l'unico vero inno alla gioia nell’universo letterario dello scrittore. Vero, c' è " la guerra dei mondi", il crimine, la violenza, la droga e gli intrighi di corte, l'illusione di potere appunto, ma alla fine l'uomo ce la fa, l'umanità sopravvive (e il mio non è uno spoiler poiché lo si legge, quasi fin da subito in una delle preveggenze pluridimensionali del protagonista) e pur nella disgrazia in cui versa il mondo, pur nella rovina, l'uomo di “Illusione” è più forte, pur nella sconfitta è un vincente.
E’ un monito quello dell’ Illusione, una lezione che il suo autore ha imparato a proprie spese e ora ci impartisce dall' alto della sua esperienza: non importa se l’uomo è alle prese con problemi difficili, più grandi di lui, apparentemente impossibili, non importa, deve sempre continuare a cercarne la soluzione e non deve mai auto commiserarsi, poiché la vita non si esplica in quella utopia del bene dove tutti vanno d'amore e d'accordo, non si esplica nel compensatorio e ingannevole paradiso terrestre delle religioni antiche e moderne, ma nella strenua lotta quotidiana, nell' abilità di adattamento del singolo, e per estensione del genero umano, alle nuove situazioni, nella sua capacità di sopravvivere ogni giorno sia che si trovi alle prese con un problema sentimentale, sia che si trovi alle prese con un vizio autodistruttivo, sia che per eccesso si trovi alle prese con un invasione planetaria.
Alla luce di ciò risultano particolarmente suggestive le considerazioni che il dr. Sweetscent, il protagonista del romanzo, fa sui "cani pigri", le singole unità di intelligenza artificiale difettose che sarebbero destinate alla distruzione ma che un suo collega mezzo svitato mette in libertà, poiché anch'esse, secondo lui, hanno diritto a vivere.
Queste unità sono probabilmente al margine del concetto stesso di vita, il più delle volte versano in condizioni pessime, sono piccole, semi senzienti e la loro unica capacità è quella di rotolare costantemente, eppure sono estremamente attaccate alla loro vita, per quanto misera possa sembrare, ne sono talmente attaccate da riuscire, in caso di pericolo, a rimanere per giorni interi nascoste, immobili, quando la loro unica funzione si risolve nel movimento.
La domanda che si pone il protagonista, e con lui ovviamente anche Dick, è: "ma chi glielo fa fare?" Vivono una vita misera, se di vita si può parlare, perché dunque se ne hanno la possibilità non la fanno finita e basta? Ma invece non lo fanno, loro, i cani pigri, non lo fanno ed anzi lottano allo strenuo per sopravvivere, perché?
La risposta gli arriva presto: perché altrimenti sarebbero esseri viventi indegni di quel nome, perché anche per loro, al pari di tutti, protagonista, autore e lettori compresi, la vita non è il risultato delle azioni che compiono, ma la forza a priori che li spinge a compiere quelle medesime azioni, l'istinto di sopravvivenza, la voglia di lottare.
“Troppo facile arrendersi, allora cosa hai vissuto a fare fino ad ora?” Sembrano dire al dr. Sweetscent, quelle piccole sfere, e lui riflette: loro lottano pazzamente, perché così e' la loro vita, e allo stesso modo io devo fare altrettanto perché così e' la mia vita, e allo stesso modo l'umanità intera deve fare altrettanto perché la lotta per la sopravvivenza è l'unica prerogativa dell'essere vivi, è l'unica cosa che ci contraddistingue dai morti e dagli oggetti inanimati. Dunque in ogni ambito della vita non conta tanto se si vince o si perde, ma se si combatte o ci si arrende, poiché se si combatte almeno una possibilità, la speranza di riuscire, rimane, mentre se ci si arrende, si è già perso, praticamente si è già morti.
E' quasi una considerazione mistica quella con cui ci lascia Dick in Illusione di Potere: non esiste una sola realtà ma tante quante gli esseri viventi, ed ognuna avrà sempre la sua buona quantità di illusioni, di dispiaceri, di lotte e di rinunce, e non c’è niente da fare, non importa se sei ricco e potente o povero e debole, se sei un umano o un essere peroidale molliccio e fluttuante di un’altra dimensione, la vita è così prendere o lasciare, ma se lasci vali meno di un cane pigro marrone, vali meno di una rotella.
Una considerazione mistica e ancora una volta frutto unicamente del suo particolare approccio relativistico alla fantascienza e alla vita in generale.
Si è detto che questo romanzo Philip K. Dick non lo citasse molto volentieri, per i suoi aspetti autobiografici relativi alla depressione e all'uso di sostanze stupefacenti, anche se la critica adora trovare delle similitudini tra lo scritto e la vita di colui che scrive; si è detto che proprio per questa sua attitudine negativa lui preferisse altri suoi romanzi, più cupi, disincantati, pessimistici.
Illusione di Potere non è immune dal pessimismo, non è orfano di quelle atmosfere buie e romanticamente surreali che l'autore ci ha fatto conoscere ed apprezzare in altri suoi lavori, ma qui a differenza che in altri testi, sono elaborate mentalmente: sono descritte, sviluppate, ragionate e superate.
Il dr. Sweetscent, il protagonista del romanzo, è l’emblema del malato che non si arrende mai, che continua a lottare e alla fine guarisce con le sue forze, che debella il suo istinto autodistruttivo.
Se fosse vero che Illusione di Potere conteneva aspetti autobiografici, non sarebbe stata un'opera di cui vergognarsi ma al contrario una di cui andare fieri, poiché sarebbe stata la testimonianza dei problemi vissuti dall'autore e poi risolti, sarebbe stata la dimostrazione che lui, al pari del dr. Sweetscent e dei cani pigri, malgrado le sue vicissitudini, malgrado i suoi vizi e colpe, non aveva smesso mai di lottare, che anche lui, come i personaggi di questo libro, alla fine era attaccato alla vita.
Ma si sa i critici, e il sottoscritto non fa eccezione, spesso vedono solo quello che vogliono vedere.
Ciò non di meno resta il fatto che Illusione di Potere resta una delle poche opere ottimiste dell'autore, che pur traendo da delle collaudate situazioni ottenebranti, angoscianti, a dir poco kafkiane, riesce a sviluppare una storia in cui traspare l'amore dell'essere umano nei confronti della vita, sia questa misera e artificiale, sia questa aliena e multi temporale. L’io pluridimensionale del romanzo ne è la prova, una propria versione di se stessi per ogni futuro possibile, per ogni futuro visitabile grazie ad una particolare droga, e tutte queste versioni hanno una cosa in comune tra loro, vogliono continuare a vivere e lottano costantemente per riuscirci. La JJ-180, la droga sintetica sviluppata dagli umani e poi utilizzata proprio contro di loro, la rappresentazione del punto più basso che può raggiungere l’essere Dickiano nel suo processo di autodeterminazione, il tanto citato anello di congiunzione tra finzione letteraria e realtà biografica, ne è la conferma definitiva.
A differenza di quel che si dice, la dipendenza dalla JJ-180 non è considerata una cosa negativa, o meglio è sì vissuta dai protagonisti come estremo negativo, ma anche come spunto da cui partire per risolvere i propri problemi, come sprone per dare una svolta alla propria vita, un punto di partenza per dare un nuovo significato alla propria esistenza, come a dire che la virtù può nascere solo dalle proprie debolezze e la forza di un' uomo, la sua fibra, il suo valore, non si stabiliscono quando va tutto bene, ma quando questi è stanco e provato, quando è ai limiti del sopportabile, quando è gettato di fronte alla scelta estrema se continuare a lottare oppure arrendersi e lasciarsi distruggere assieme al resto dell’umanità.
Questo dunque è il messaggio reale del libro, questa è la conclusione del ragionamento che porta Philip K. Dick a scrivere l’ “Illusione”, e non il bisogno di confessare i suoi istinti autolesionistici.
L’illusione di potere, che gli conferisce la droga nel romanzo, sussiste ancora, poiché la multidimensionalità prodottane con l'uso è soltanto un mero sotterfugio (l’alter ego della dimensione parallela, può essere sì più forte, saggio, intelligente e informato rispetto a quello dell’attuale dimensione, ma da un ipotetico scambio di ruoli non ci guadagna nessuno poiché pur trattandosi di copie identiche in realtà sono sempre individui differenti), dunque il sotterfugio dell’illusione persiste nel romanzo, ma il protagonista non tenta di adottarla per sfuggire alla sua realtà presente, non tenta di adottarla per desistere e abbandonarsi alle allucinazioni, ma anzi per trarne il maggior vantaggio possibile, per tentare di riordinare proprio il suo presente, la sua realtà e la sua vita.
Mai arrendersi, bisogna sempre lottare, questo è il significato dell’ Illusione, un'opera, che può essere definita futuristica, visionaria, crepuscolare, ma sicuramente anche eroica ed ottimista. Un opera, per concludere, in cui nulla è lasciato al caso, in cui persino lo stile, che in altri lavori dell’autore può essere considerato il suo punto debole, in quanto troppo commerciale, qui risulta assolutamente perfetto poiché con la sua semplicità non distrae dall’evolversi della storia, poiché con la sua schiettezza riesce a sublimare la forza delle immagini di una trama avvincente imprimendole nella coscienza del lettore, rendendo assoluta la vicenda di un singolo in costante lotta per la sopravvivenza, al pari del resto dell’umanità.
Questo dunque è Illusione di Potere, un romanzo di cui andare fieri. Un romanzo perfetto.
Indicazioni utili
Ma il significato?
Troppo serio per essere considerato comico, troppo comico per essere preso sul serio.
Leggendo questo brevissimo saggio è inevitabile porsi delle domande: quale era l'intento dell'autore, cosa voleva dire con queste due brevi arringhe? Ma davvero bisognava comprendere le formule matematiche che descrivevano la stupidità umana? Davvero l'autore riteneva di poter ascrivere a qualche formula ogni comportamento irrazionale umano e davvero pensava che elaborandolo con le suddette formule, attraverso le leggi della matematica, si poteva semplificare ogni sfumatura della mentalità umana con quattro o cinque fenotipi base? Che necessità c'era di quantificare la demenzialità in un doppio saggio che più che allegro è perplimente?
Un libro di questo tipo se non è arricchito da numerosi aneddoti e buffi esempi, a corredo esplicativo della parte teorica, è amorfo e straniante.
Invece di essere "allegro ma non troppo" il saggio, privo di sfumature comiche, diventa un delirio di pura teoria. Un delirio che si basa sulla soggettività e l'unilateralità di interpretazione con cui l'autore si arroga il dovere di farci comprendere la società umana.
In sostanza anche se l'autore di per sé è un abile scrittore dallo stile letterario scorrevole e talvolta accattivante, il libro risulta, malgrado l'originalità di certi contenuti, oltremodo tedioso per la sua eccessiva schematicità e per il forzato intellettualismo di cui è permeato dalla prima all'ultima pagina.
Indicazioni utili
di passaggio
Avventura tra i ghiacci per un Dirk Pitt orfano dell' amico Al Giordino. Cussler, al suo secondo romanzo (terzo considerando Vortice) si concentra sulla figura di Dirk Pitt tralasciando tutto ciò che lo circonda: il suo ambiente alla Numa, i suoi amici, il suo consueto modo di agire. E' un Dirk Pitt ancora giovane le sue più grandi avventure sono ancora la da venire e l'autore sembra ancora indeciso quale strada far prendere al proprio protagonista: quella del lupo solitario o quella del compagnone, pedina indispensabile dell'organizzazione Numa e instancabile rubacuori. La mancanza di Giordino poi è un inevitabile blocco agli ingranaggi dei dialoghi: si perdono infatti i duetti alla buddy – buddy tipici della futura linea narrativa di Cussler (vedasi i successivi romanzi ma anche il filone "Austin - Zavala") Sarà dunque per l'indecisione dell'autore, sarà per la scarsa originalità della trama, sarà per l'enorme vuoto che lascia la temporanea assenza di Giordino, ma questa avventura sembra proprio essere di secondo piano rispetto alle altre. L'unica cosa degna di nota in questo libro è l'abilità dell'autore nel descrivere la glaciale ambientazione in cui si svolge gran parte del romanzo. Il freddo pervade ogni cosa e infonde un'apparente calma statica al dipanarsi della trama. Un libro di passaggio
Indicazioni utili
Solo un affascinante fumettone
Un libro coraggioso che non ha timore di portare all'attenzione dei lettori un tema, all'epoca dell'uscita del libro, originale e desueto: quello degli dei. E' anche apprezzabile il tentativo dell'autore di trasfondere elementi della mitologia classica (nordica) in una novella moderna, mettendo alla prova le divinità coi problemi di tutti i giorni. Tuttavia se il motivo di fondo è apprezzabile, il risultato finale non è altrettanto accattivante. Il background fumettistico di Gaiman risalta troppo in alcuni passaggi e in alcune figure eccessivamente caricaturizzate e stereotipate. Certe altre espressioni o trovate per "portare avanti il discorso" risultano invece essere addirittura troppo ingenue e inadatte al tessuto narrativo di quella che vorrebbe essere una gothic novel, ma che involontariamente a tratti si trasforma in una dark comedy. I personaggi inoltre mancano di quella profondità che invece ci si aspetterebbe di trovare in esseri umani, e non, alle prese con temi così aulici. I rimandi alla mitologia, con i riti e le manie tipiche del pantheon greco sono mal spiegati e invece di creare quel senso di mistero e quell'atmosfera romanticamente gotica, recentemente tornata in voga, fanno degli dei un gruppo di impenitenti vecchietti new age che, per quanto dotati di elevatissima intelligenza, più per inedia che per inadeguatezza, non riescono a stare al passo coi tempi.
A tratti l'ironia dell'autore e del protagonista sono le cose più affascinanti dell'intera vicenda. E' interessante anche il tema della moglie defunta, peccato che come per il resto dei personaggi non sia ben sviluppato e approfondito. L'ambientazione della vicenda, la provincia americana per quanto ben caratterizzata è più adatta a un noir che a una guerra di dei e lo stesso si può dire del protagonista.
In sostanza se si lascia che l'originalità dell'idea abbia la meglio sulla stentata realizzazione del romanzo si può definire American Gods un buon libro che intrattiene e diverte, ma che non verrà ricordato negli anni a venire come è stato invece per i classici inventori di questo genere.
Indicazioni utili
Un archetipo nel suo genere
Il più fulgido, splendente e forse famoso esempio di narrativa commerciale. Tutti coloro che si definiscono lettori comunque dovrebbero leggero a prescindere, per amor di completezza, poiché questo romanzo si erge nel bene e nel male a portavoce di un intero filone letterario distintivo di un epoca (la nostra). Per chi è un habitué di questo genere infatti è un must, certo i più critici e più dediti a letture impegnate, leggendo i Pilastri, potrebbero storcere il naso sottolineando l’eccessiva faciloneria di certi passaggi, la mancanza di profondità dei personaggi o lo stile dell’autore a tratti talmente impersonale da far sembrare le mille e più pagine del romanzo il frutto di un prodigioso macchinario che pensa, crea e scrive al posto dell’essere umano, tuttavia non bisogna mai dimenticare il settore letterario in cui va collocata l’opera, un settore in cui si guarda più ai fatti che alle cause, più ai contenuti che alle modalità con le quali vengono narrati, un settore le cui linee di confine sono talmente poco delineate da annoverare tra le sue file opere di sicuro intrattenimento ed indicibili porcherie; ed in questo settore, come già detto, i Pilastri della Terra è uno dei migliori esempi e Ken Follett una delle voci più autorevoli.
Comunque non c’è da preoccuparsi: la stragrande maggioranza (e io sono tra loro) in questo caso troverà il testo affascinante, divertente, scorrevole e perfino assuefacente.
Gli unici difetti che possono venire ascritti alla narrazione sono riscontrabili in alcuni "momenti di debolezza" dell'autore nei quali descrive la società medievale, la mentalità, le credenze religiose e i costumi dell'epoca con uno stile permeato di una celata ironia leggermente sopra le righe. E' quasi fisicamente doloroso invece il salto temporale di diversi anni che caratterizza l'ultima parte del romanzo; parte, quest'ultima, eccessivamente breve e sbrigativa per consentire al lettore di riabituarsi alla mutata condizione, sociale, mentale, fisica e monetaria dei protagonisti. Detto questo il libro rimane comunque un capolavoro del suo genere tanto che l'elevato numero di pagine in cui si dipana la vicenda, che per molti potrebbe costituire un freno alla volontà di leggero, non pesa assolutamente e ci si ritrova alla fine malinconicamente dispiaciuti per la sorprendente brevità del romanzo.
Ken Follett pur non avendo sempre azzeccato i suoi romanzi, dimostra in questo di essere decisamente all'altezza della sua fama. In conclusione è un libro adatto e consigliabile a tutti o perlomeno a chiunque prima di andare a dormire desideri staccarsi dalla quotidianità in maniera semplice, curiosa, a tratti intelligente, e sicuramente riposante, per almeno un paio di mesi.
Indicazioni utili
Nulla da segnalare
Un noir moderno senza particolari colpi di scena e con una trama piuttosto lineare.
Il romanzo vorrebbe rifarsi alla grande tradizione dei classici di questo genere, senza però quella nostalgica e anticheggiante patina da vero noir al lettore sembra costantemente di perdere qualcosa e alla fine ne viene fuori un lavoro poco levigato dove lo stile tende a stridere con gli ambienti, i personaggi e senza dubbio il calendario. L'atmosfera in cui si svolge la storia, prima in Irlanda e poi negli States, anche se è ben rappresentata ed è forse l'unica cosa degna di nota in tutto il romanzo, risulta a tratti fin troppo sterotipata contribuendo a dare l'impressione che il libro sia un troppo affettato tentativo dell'autore di accostarsi ad un filone che probabilmente non è nelle sue corde.
Indicazioni utili
Sbrigativo
Un libro affascinate nella prima parte e inconcludente nella seconda. Ottime le premesse, travolgente l'inizio, rutilante il succedersi di eventi che coinvolgono i protagonisti. Nella prima metà del libro c'è di tutto: dalla fantascienza all'horror, dall'azione all'avventura on the road, tutto permeato da un rivolo di tensione che aumenta di dimensione e sfocia in un fiume di paura e adrenalina nei momenti di azione. Poi il lettore arriva alla seconda metà del libro....e tutto diventa piatto, banale, inconcludente, inspiegato e forse anche inspiegabile, degno di un horror movie che più di serie B forse è di C se non D. E' come se Stephen King, carico di aspettative per questo romanzo, fosse giunto disilluso e annoiato all'epilogo, tanto che nei capitoli d'azione finali, quando tutta la narrazione dovrebbe confluire nella sublimazione delle paure e delle passioni dei protagonisti, si riesce a trattenere a stento uno sbadiglio e si svolta pagina per forza d'inerzia, giungendo ad un finale che ti lascia li a farti domande destinate a non trovar risposta.
E lo stile narrativo riflette l'evolversi della vicenda, incalzante nella prima parte proprio come ci si aspetta da questo genere di narrativa, diventa man mano annoiato e sbrigativo. E' chiaro che l'autore doveva terminare il libro (forse per motivi contrattuali) e terminarlo velocemente. In sostanza non è un brutto libro considerato il settore di largo consumo in cui si colloca, una volta finito però si ha la sensazione di un'occasione sprecata. Peccato.
Indicazioni utili
SImpatico
Un libro, nel suo piccolo, meraviglioso. Woody Allen infatti in questo libro (raccolta di storielle create dalla sua immaginazione), riesce a caratterizzare perfettamente quegli ambienti metropolitani, quelle vicende quotidiane, e quei personaggi nevrotici, che chiunque apprezzi il suo lavoro ha imparato ad amare. Il tutto in oltre è farcito da uno squisito humor surreale mai sopra le righe.
Se dal punto di vista tematico il libro può sembrare leggermente ripetitivo dal punto di vista stilistico è ineccepibile, sembra infatti di vivere le stesse scene che Allen racconta, (e non è un luogo comune questo, sembra per davvero!) e fin dalla prima pagina il lettore si trova catapultato in quella tipica atmosfera burlesca e raffinata che solo lui riesce a creare.
Non è letteratura impegnata, certo, e non deve esserlo, tuttavia Allen, raccontandoci queste storielle riesce comunque a farci riflettere sui temi più profondi della vita e a farlo inoltre con il sorriso sulle labbra e un buon pezzo di dixieland jazz nelle orecchie. Peccato solo che il libro sia così corto.
Indicazioni utili
Risultato ottenuto?
Un libro difficile. Difficile per chi lo scrive: per il figlio, costante e talvolta inopportuno (leggasi il capitolo "interludio") testimone del progressivo spegnersi del padre; per il padre che ogni giorno sente appunto che la sua morte è più vicina e ciò nonostante trova il coraggio di realizzare una interessante ed affascinante cronaca della propria vita e dei fatti storici avvenuti in quel periodo; e un libro difficile infine anche per chi lo legge: se non si ha una minima conoscenza di filosofia orientale e della storia della seconda metà del novecento molte considerazioni o intuizioni dell' autore risulteranno piuttosto ostiche. Certo viene spontaneo chiedersi perché qualcuno che non è interessato ad almeno uno degli argomenti sopracitati si metta a leggere questo libro (anche se le motivazioni possono essere tante: la fama dell’autore, il consiglio di un amico, o magari proprio la voglia di incominciare ad addentrarsi in questi argomenti), tuttavia anche il lettore addentro in questioni storico filosofiche, pur rimanendo appagato per quel che riguarda la sezione relativa all’aneddotica storico-biografica, noterà nascere in sé un conflitto sempre più acceso, vivo ed insopportabile, allorché si soffermerà a ragionare sulla parte filosofica. E questo conflitto interiore è in crescendo costante con il libro poiché la sua metà logica, quella del lettore (ammesso che di metà si voglia parlare), gli farà comprendere, se non addirittura approvare, la gioia e la curiosità con cui l'autore si appresta a dipartire da questo mondo, ma l’altra metà, quella governata dai sentimenti, lo farà soffrire per l'ineluttabile destino di un uomo che ha vissuto tanto e in maniera completa e che ormai è inesorabilmente condannato dalla malattia.
Non dovrebbe essere il contrario?
Se uno ha compreso l’ultimo messaggio di Terzani, se è vero quel che afferma, non dovrebbe sentire col cuore che ha ragione lui e con la logica della mente vedere invece che, al di là dei discorsi e della filosofia, lo scrittore è soltanto entrato nella fase dell'accettazione della morte?
In definitiva in questo libro uno dei principali intenti dell'autore è quello di farci intuire e vivere con gioia il giornaliero appropinquarsi della morte, del resto anche il titolo ce lo suggerisce, ma questo intento alla fine viene meno ed il suo messaggio è talmente poco convincente che (scusate la divagazione personale) ricordo che quando scrissi questa recensione mi sentii addirittura in colpa per aver criticato l'ultima opera di un uomo buono e gentile che ormai non era più… ma, ancora una volta, questo istintivo sentimento non è forse l'esatto opposto di quello che voleva ottenere Terzani, che capissimo cioè cos’è in realtà la morte (e dunque la vita), che imparassimo a non averne paura, a non soffrirne? “Paura della morte. Perché? Perché si sa di dover abbandonare tutto quello che conosciamo… Ma se ti ci avvicini prima, se impari a rinunciare…”
Probabilmente non è colpa sua, se il figlio dell'autore infatti avesse evitato di intercalare ai discorsi del padre le osservazioni sulla sua condizione fisica in progressivo peggioramento e se avesse invece diluito la narrazione in pensieri, ragionamenti, riflessioni e rivelazioni fino a far si che si perdesse la traccia dei tristi fatti nella cristallina purezza della mente del grande giornalista, forse, ispirati unicamente dalle sue parole, avremmo inteso meglio il suo messaggio e giungere alla conclusione del libro non sarebbe stato così doloroso. Ma così invece non è e purtroppo il risultato finale è quello di un libro solo parzialmente riuscito.
Indicazioni utili
solo il titolo...
Sta tutto nel titolo: "Nemesi", intesa sia nell'accezione comune del termine come il nemico o per meglio dire tutto ciò che si contrappone per natura all'individuo e ai suoi intenti, sia più propriamente in senso etimologico come quella sorta di legge di natura che rimedia alla giustizia con l'ingiustizia tendendo ad un indispensabile equilibrio totale e sia infine nella connotazione originale, come la divinità greca incarnazione e personificazione della volontà comminatoria di giustizie ed ingiustizie.
Per prima si incontra quella "comune" intesa qui come la Polio. Il campione di essere umano, protagonista del romanzo, Mr. Cantor rappresenta l'individualità dell'uomo. L'obbiettivo dell'uomo (salvo strane eccezioni) è vivere, tendere alla vita e scansare la morte, la malattia di conseguenza, specie se mortale, è per definizione la naturale nemesi dell'uomo infatti essa è in contrasto con l'obbiettivo ultimo di tutti coloro che la contraggono, sopravvivere, dunque è la loro nemesi. Non è sufficiente però, se la Nemesi del titolo non evolvesse, se l'essenza stessa della malattia non rappresentasse qualcosa di più, definirla “nemesi” sarebbe inappropriato, se rimanesse confinata soltanto nella concezione medica sarebbe abbastanza parlare di "antagonista sociale", di "antitesi dell'uomo." Ovvero di semplice nemico. La nemesi del titolo invece no, in sé ha le potenzialità per aspirare a qualcosa di più, di più profondo e universale, la malattia per sua stessa natura evolve in quella forma etimologicamente più appropriata di legge di natura, di dispensatrice di equilibrio attraverso l'ingiustizia. Roth dunque attraverso Mr.Cantor, Bucky, si trova a riflettere, e in questo modo a fronteggiare, su un nuovo dualismo che non è più quello ingenuamente concreto del bene contro il male, ma delle cause genitrici di questi due poli opposti.
Se esiste questa sorta di legge naturale a cosa è dovuta e per tanto come agisce? E’ il frutto di un invincibile casualità a cui l’uomo col suo intelletto può solo porvi rimedio o è la diretta conseguenza di scelte precise, di decisioni oggettivamente specifiche prese dai singoli individui e che sommate tra di loro formano un ineluttabile quadro variopinto definito come destino? Le domande che ne scaturiscono sono la logica conseguenza al dilemma posto in questi termini: nel caso sia vero il principio di casualità ha ancora senso prendere delle decisioni, sforzarsi a priori per evitare un evento, nella fattispecie contenere l’epidemia di Polio? O è più utile concentrare le energie sul limitare i danni dopo che l’evento ha colpito? Ma ancora, ha senso prendere delle decisioni “post eventuali” se poi tanto il cieco caso ci infila di nuovo lo zampino stravolgendo (o magari assecondando) ogni tentativo umano? Dunque in generale ha ancora senso scegliere quando è tutto nelle mani del casualità?
Nel caso invece sia vera la seconda interpretazione, il principio che ogni scelta è causata, e a sua volta la causa di un'altra scelta, e così via in un eterno girotondo deterministico, come può Bucky Cantor, l’uomo, compiere la scelta giusta, come può da solo nel suo piccolo riuscire a considerare tutte le varianti, le possibilità, le opportunità, i pro e i contro, le connessioni, le conseguenze e prendere la decisione giusta, per se stesso e per tutti gli altri? Se il suo destino è legato a quello di chi ha intorno e per estensione a quello dell’intera umanità, appunto per quel gioco di causa – effetto globali, come può essere certo che un suo sì non corrisponda al no di un altro, che il suo positivo non sia il negativo di un altro, che il bene per lui non sia il male per gli altri e viceversa?
E’ il principio di casualità contro il determinismo, di caso contro causa e in mezzo a questa lotta c’è l’uomo.
Bucky Cantor non è solo la rappresentazione dell’uomo, è la esemplificazione dell’eroismo dell’essere umano, è la condensazione delle virtù che nel loro piccolo ogni uomo si attribuisce. Egli per sua stessa natura non vuole tendere al bene personale ma a quello universale, non a quello soggettivo ma a quello oggettivo. E’ l’eroe che combatte contro la sua nemesi e quella di tutti gli individui. Ma in un mondo così non possono esistere gli eroi: nel primo caso sono inutili poiché compiere delle scelte non ha importanza, nel secondo caso sono irrimediabilmente destinati a perdere per l’enorme complessità delle implicazioni di ogni singola scelta. Mr. Cantor che si confronta con la sua nemesi dunque non rappresenta più l’eroe, ma la distruzione dell’eroe, la distruzione dell’essere umano.
Ancora una volta la nemesi ha la meglio e ancora una volta non è sufficiente, nelle ceneri della battaglia il sopravvissuto, l’eroe sconfitto, non si arrende: sa che non ha vinto e non potrà mai vincere, ma almeno vuole capirne il perché. “D’accordo”, sembra dire, “ho perso, ma perché ho perso? Che la nemesi sia il caso o il determinato destino, che cosa l’ha creata?”
Qui si compie il passo successivo, l’evoluzione finale del titolo che liberatosi delle spoglie terrene assurge sublimando a entità divina, alla dea greca dispensatrice di bene e male. L’uomo non comprende le ragioni del suo fallimento, è incapace di comprenderle come è incapace di vincere e dunque si rifà al suo passato, alla sua educazione, a quello che gli è stato insegnato, a quello in cui ha sempre creduto e a cui si è sempre appoggiato per trovare conforto: il divino. Nel caso di Mr. Cantor esattamente Dio. Lui è un credente, gli hanno insegnato ha confidare in Dio, a pregarlo nel momento del bisogno, eppure Mr.Cantor ha perso, l’umanità ha perso, com’è possibile?
Bucky Cantor realizzato il suo destino sembra quasi alzare gli occhi al cielo e gridare: “padre, perché mi hai abbandonato?”
La risposta non tarda a venire, forse Bucky è sconfitto ma come in un sadico gioco del persecutore gli è riservata ancora la possibilità di scegliere, e così lui ragiona: non sono stato abbandonato, Dio è creatore di tutto, se è vero che esiste dunque ha creato questa epidemia, ha creato la Polio e la Nemesi stessa. E’ lui il dispensatore di giustizia, poiché lui ha creato la giustizia, è lui dispensatore di ingiustizie poiché è lui il creatore di ingiustizia. E la Nemesi di colpo assurge, in un gioco degli opposti essa stessa diventa Dio e Dio la Nemesi, e come in un riflesso di uno specchio magico in cui si inverte il principio della trinità cristiana, noi siamo testimoni dell’atto finale della nemesi, anzi ormai Nemesi con la N maiuscola, che prende posto accanto al Padre e diventa il mezzo di Dio, come prima lo era lo Spirito Santo, il mezzo che si scatena sul Figlio tradito, che è rappresentato da Mr.Cantor, e in cima a questa assurda piramide scorgiamo un Dio umanizzato (come quello dei greci appunto) che sorride sadico, ormai egli stesso dispensatore più di male che di bene.
Davvero è questo il destino dell’uomo, davvero la Nemesi vincerà sempre?
Forse, ma chi siamo noi per saperlo? In fondo al tunnel si intravede una luce, una speranza: non tutti quelli colpiti dalla polio sono destinati alla sofferenza eterna, non tutti gli afflitti sono degli sconfitti. Forse più che rimuginare sulle cause del fallimento degli obiettivi dell’ uomo contro il destino, dovremmo trovarne sempre di nuovi, nuovi spunti, fini, ideali a cui tendere e con essi dovremmo ravvivare costantemente la speranza. Forse nel cieco mare della casualità e nel profondo oceano della causalità il vincere sta proprio nel non darsi per vinti e barcamenandosi tra un insuccesso e l’altro trovare di che sorridere. Forse chi comprende questo ha già vinto, in barba alla polio, al caso, alla nemesi e a Dio stesso. Probabilmente sì, ma non Mr.Cantor lui è il figlio tradito, lui è l’eroe distrutto, egli se sopravvive è destinato solo ad una grigia vita di sopportazione.
Philip Roth con questo romanzo ci consegna una visione irrimediabilmente pessimistica della vita, contro la quale si possono scagliare folle di inguaribili ottimisti e ben pensanti filosofi della domenica. E’ naturale, quando la vicenda viene posta in termini così aulici si può sempre dire tutto e il contrario di tutto e ancora non essere soddisfatti. Si Roth ha ragione, no Roth ha torto, ma un fatto a prescindere dal suo modo di ragionare rimane inequivocabile: Philip Roth sa pensare e soprattutto sa scrivere, e scrivere bene! Il testo non sempre è scorrevole, la narrazione non sempre è fluida, delle volte è indispensabile rileggere dei passaggi, ma ha un tale impatto, una tale forza sensoriale (perché limitarsi a quella visiva sarebbe riduttivo) che quasi sembra poter definire tra le righe del romanzo “l’entità libro.”: un oggetto esemplare, somma degli sforzi cerebrali dell’autore, della sua cultura, della sua intelligenza, della sua penna e della sua realtà. Uno scrittore così è da tempo che non spuntava, all’incirca dal 1899, anno della nascita di Hemingway. Se per alcuni questo paragone è banale, o addirittura forzato, è a ben vedere in realtà assolutamente lecito poiché se i dettagli (come i mondi e i tempi) sono discordanti ad accomunarli ci pensa lo stile, la stessa viva e cruda forza nel descrivere il mondo, la stessa brama di concretezza, la stessa sete di reale e probabilmente la stessa intelligenza.
Ed infine le solite scuse: mi rendo conto di essermi concesso eccessivamente ai vaneggiamenti filosofici e di essermi altrettanto eccessivamente dilungato nelle possibili interpretazioni mistico/religiose pontificando su argomenti che il più delle volte non condivido senza essere sicuro di averli compresi. Tuttavia un centinaio di righe per interpretare un titolo così pregno di significati mi paiono addirittura poche…
- il titolo? - vi chiederete.
- già solo il titolo, poichè questa non è una recensione a “Nemesi” il romanzo, ma a “Nemesi” il titolo.
- E quella al romanzo allora?
- Ah per quella occorrerebbe un' enciclopedia!
Scherzi a parte è vero non tutto quello che ho detto è condivisibile, come non tutto quello che Roth ha scritto è condivisibile, ma quando per recensire un libro di circa 170 pagine mi rendo conto che me ne occorrerebbe uno altrettanto lungo, non posso che ammettere di trovarmi di fronte ad un vero e proprio capolavoro (e di non possedere per nulla il dono della concisione, ma questo è un altro discorso...)
Indicazioni utili
solo l'ultima parte
Libro particolare, non eccezionale. Non è infatti un romanzo con un unico protagonista e una trama ben definita, ma un miscuglio di episodi bene o male tutti collegati tra loro, purtroppo più male che bene. Le finte review scentifiche sono piuttosto stucchevoli e anche il mal celato tentativo di far passare alcuni eventi e scoperte come reali quando in realtà sono chiaramente frutto dell' immaginazione dell'autore non è da meno. Alla fine viene fuori una via di mezzo tra un romanzo di fantascienza e un finto saggio scientifico. Il problema però è che quella del romanzo è fantascienza di 30 anni fa, quella del saggio e scienza che ha ben poco a che vedere con la realtà e lo stratagemma di farlo sembrare un saggio di divulgazione scientifica, e dunque conferirgli una sorta di indimostrata veridicità, è in realtà un' arma a doppio taglio poichè il lettore il cui campo lavorativo non è la ricerca, sicuramente rimane affascinato dagli ambienti descritti nel libro (per quanto troppo stereotipati) ma rischia anche di farsi una cattiva, se non pessima, idea del mondo scientifico e della gente che vi lavora.
L'unica parte degna di nota sono le conclusioni finali, conclusioni non direttamente collegate al romanzo ma riguardanti temi reali e problemi legislativi americani legati alla ricerca medica e genetica. Conclusioni però che a uno del settore possono anche interessare ma ad uno che non si intende di queste cose non fanno altro che aggiungere altri trenta minuti di noia alla fine del romanzo.
Detto questo va comunque riconosciuta l'abilità dello scrittore che, pur non trattando nulla di particolarmente interessante e nuovo, riesce a conquistare il lettore grazie all'esposizione semplice e chiara di alcuni argomenti solitamente piuttosto ostici da comprendere ai "non addetti ai lavori", ma anche qui sto parlando solo dell'ultima parte.
Indicazioni utili
Operazione commerciale
E'un romanzo definito "inedito", in realtà puzza lontano un miglio di abile mossa commerciale: il libro, come ampiamente spiegato nella fin troppo articolata premessa del figlio di Tolkien, narra gli eventi accaduti nella prima era (quella del Signore degli Anelli mi sembra di capire sia la terza, per intenderci), ma non è esattamente un antefatto ai più noti libri del medesimo autore bensì il racconto di uno dei tanti episodi di quell'epoca, nella fattispecie la vita di Turin, figlio di Hurin (anche il titolo dunque è fuorviante poichè si parla di "figli di Hurin" quando in realtà il 90% del racconto è incentrato esclusivamente solo su Turin.), un episodio che si dice fosse già noto ai seguaci di questo genere, e dunque che non apporta nulla di nuovo se non qualche ulteriore badilata di dettagli e nomi bislacchi.
Dettagli e nomi, già: siccome infatti la storia di Turin in sè è piuttosto breve per conferire maggior spessore, e appeal, il volume è stato letteralmente farcito (mi sembra di ricordare dagli editori in accordo coi curatori, in accordo con gli eredi) di lunghe e intricate appendici derivanti da separati carteggi dell'autore, il cui obbiettivo originale senza dubbio era quello di chiarire e svelare i retroscena della vicenda ma in realtà, messi assieme così alla bell'è meglio, come spesso accade quando le cose sfuggono di mano, non fanno altro che confondere le idee. Due sole sono le appendici utili: l'elenco dei nomi che compaiono nel libro (circa 250 nomi diversi in circa 230 pagine di narrazione... ma stiamo scherzando?!) e la bellissima ed esaustiva nota di Quirino Principe alla fine del libro, che dimostra, con uno stile di scrittura chiaro e pulito, come si sarebbero potute raccontare le vicende narrate nel testo in una paginetta e mezza, senza usare tutti quei nomi impronunciabili e il più delle volte incomprensibili.
Lo stile narrativo di Tolkien in fine qui risente particolarmente del suo background di storico della letteratura inglese, si ha infatti la persistente sensazione di leggere più che un romanzo un manuale di storia, e l'intera vicenda raccontata ne esce irrimediabilmente rovinata e priva di fascino. Una mezza delusione.
Indicazioni utili
Probabilmente il primo noir della storia e molto a
Recensendo il Lupo della Steppa è impossibile non analizzarne la trama nelle sue singole, distinte, parti (salvo limitarsi al "si mi è piaciuto" o "no non mi è piaciuto") poichè i contenuti di questo libro, la loro comprensione, trascendono il mero giudizio critico e si rivolgono all' "universale" che è in ognuno di noi. Dunque quella che segue è, più che una recensione, un' interpretazione dell'opera di Hesse, un metodo di lettura, e come tale non è scevro da i necessari rimandi (anticipazioni) alla trama. Quindi, pur trovandoci di fronte a uno di quei testi il cui mero contenuto della storia non è tanto importante quanto il suo significato, sconsiglio la lettura di questa "recensione" a chiunque volesse affrontare il grande romanzo intonso e non influenzato da pareri altrui. Premetto infine che la maggior parte delle cose che dirò ai più parranno un' ovvietà, non ho alcuna presunzione infatti di poter aggiungere qualcosa che non sia stato già detto da innumerevoli letterati e critici di professione, tuttalpiù spero di fornire un minimo aiuto a chiunque riscontrasse difficoltà a raccapezzarsi con il contenuto di questa magnifica opera e con il messaggio di Hesse.
IL Lupo della Steppa è un romanzo che si sviluppa su diversi piani narrativi nettamente delineati da altrettanti diversi stili di scrittura sempre e comunque adeguati al ritmo della narrazione. E’ esclusivamente grazie al ritmo infatti che il testo non appare slegato, che il confine tra un ambiente e l’altro, che il passaggio da uno stile all’altro, non appaiono eccessivi e discordanti. Questi ambienti, queste sfere di competenza, o piani narrativi che dir si voglia, sono oggettivamente slegati e riordinati uno dentro l’altro quasi l’autore avesse voluto scrivere quattro o più libri distinti, tuttavia questo netto distacco non stona anzi a suo modo dona al testo una sorta di peculiare appeal, una sensazione di ordine, di lucidità mentale. Onde evitare fraintendimenti è bene precisare che Hesse non dispone i sopracitati piani soltanto in maniera concentrica l’uno dentro all’altro ma li illustra anche in ordine cronologico facilitando così il compito al lettore, permettendo a chiunque di seguire la trama del libro e il filo logico dei suoi ragionamenti.
Sul (o nel) primo piano narrativo l'autore ci introduce in una casa medio-borghese che rispecchia la società del tempo, in questa parte molto breve, manieristica e volutamente banale Hesse strizza l'occhio, e forse fa una pernacchia, alla narrativa a lui contemporanea.
Sul (o nel) secondo piano narrativo, con il consueto stratagemma del "carteggio ritrovato”, ci si addentra finalmente nella vita di Harry Haller il vero protagonista del romanzo i cui pensieri così alieni a quelli del suo tempo lo fanno sentire come un emarginato al di fuori della società in cui vive.
Per stile, dal mio punto di vista, questa è la parte migliore del libro, i toni e le atmosfere richiamano o probabilmente inventano il genere noir (confesso che qua l’uso dell’avverbio nasce da una mia mancanza culturale).
Sul (o nel) terzo piano narrativo, grazie ad un altro "carteggio", questa volta trovato dallo stesso Haller, l’autore si concede alla disquisizione filosofica e spirituale a lui cara abbracciando un insieme di pensieri e pensatori che vanno dai classici greci ai guru orientali. Questa è la parte più concettuale dell’opera e anche la più ostica da comprendere e condividere. In queste pagine si abbandona il ritmo del romanzo e, come un libro nel libro, ci si inoltra in un saggio filosofico - metafisico, talvolta fin troppo cerebrale ma pur sempre a tema con il resto della vicenda.
Se questa è la parte meno scorrevole del Lupo della Steppa è altresì una parte essenziale poiché rappresenta il meccanismo che fa scattare la molla interiore del protagonista, che lo spinge a compiere quell’ulteriore passo oltre il quale non si può più tornare indietro, oltre il quale c’è la salvezza o la morte. In questa parte Haller trova sé stesso, rivive la sua vicenda, ritrova i suoi problemi e, gran novità, intravede uno spiraglio, una soluzione, una via di fuga a quella vita che tanto odia.
La quarta parte è invece la corsa sempre più rapida e sempre più folle del protagonista verso quella tanto agognata soluzione ai suoi problemi, corsa in bilico sul precipizio della pazzia che culmina in una festa, comune e selvaggia, che per certi aspetti richiama il circo quale metafora dell’eccesso, dell’assurdo e appunto della pazzia.
Questa è l’ultima vicenda del protagonista, dopo questa, dopo aver varcato la soglia della follia, rimane solo un ultimo viaggio allucinato in un corridoio dalle molteplici porte, metafora della vita e delle proprie scelte, metafora del pensiero e dei singoli ragionamenti, della conoscenza e della coscienza, della logica e dell’istinto. Haller, l’uomo ormai disposto a qualunque cosa, viene messo di fronte a se stesso e la sua singola natura, il suo io, si spezza in una serie di molteplici forme, tante quante sono le porte che gli si parano di fronte, in ognuna di queste egli trova una versione di se stesso, una versione che ha compiuto una singola determinata scelta seguendo istinto o ragione. Ogni porta un nuovo Haller finché lui stesso non comprende più se quel che ha davanti sia finzione o realtà, finché lui stesso non si annulla colpendo a morte il suo redentore (o redentrice data la sua duplice natura androgina) colpendolo/a a morte per poi ripensarci e salvarlo/a, per poi svegliarsi e rinascere, trovare un nuovo sé, una nuova ragione di vita…o forse no.
Questa è la parte più intensa del romanzo, quella più vissuta, quella in cui il libro sembra veramente nascere, vivere e consolidare se stesso come opera narrativa vera e propria. In questa parte Hermann Hesse, traendo spunto dalle precedenti, si concentra maggiormente sulle problematiche dell'uomo al di fuori del suo tempo, che istintivamente si sente inadeguato in una società (quella tedesca tra le due Guerre) che non condivide i suoi valori, i suoi bisogni e in fondo la sua natura. Da qui la conseguente formazione dei "due io" faustiani, quello sociale, dei comportamenti dabbene, dell’etichetta a cui il protagonista vorrebbe abbandonarsi e quello naturale, selvaggio, ribelle, quello del lupo della steppa, animale metafora della natura sanguigna dell’uomo, animale che è sempre in agguato, digrignante, pronto a saltare sulla preda, ovvero il protagonista stesso e coloro i quali interagiscono con lui. Ed è questa anche la parte in cui il dualismo della coscienza si propaga evolvendosi con un ritmo sempre più incalzante fino al finale metafisico e allucinato fino a quell'immancabile duello conclusivo che vedrà per forza di cose prevalere una natura sull'altra decretando la totale autodistruzione o la redenzione del protagonista...o forse no.
La quinta parte… la deve scrivere il lettore, Haller sarà morto? Sarà vivo? E se vivo sarà un animale sociale o un lupo della steppa, sarà un autentico individuo o una contraddittoria moltitudine?
E’ nel dubbio della quarta parte, nell’assenza di una quinta che sta la genialità dell'autore: Hesse lasciandoci un finale aperto permette al lettore ogni possibile tipo di interpretazione, o ancor meglio: l'interpretazione che più ci appartiene poiché, è inutile negarlo, almeno una volta, anche solo per un istante, per un singolo episodio o vicissitudine chiunque abbia letto il libro si è immedesimato nel protagonista, ha sentito propri i di lui dolori e ha empaticamente vissuto le medesime vicende.
Questa è la forza del libro, scritto in un tempo ormai così lontano dal nostro che per problematiche, costumi, modi e convenzioni parrebbe assolutamente inattuale ma che in realtà è estremamente attuale e sempre lo sarà, poiché sussurra all'io profondo i temi universali.
Questa è la forza di un libro che, forse ancor più di altri suoi celebri lavori, consacra l'autore a quella ristretta cerchia di uomini a lui cara che nel testo chiama "gli Immortali."
Indicazioni utili
Scadente
Vorrebbe essere un thriller di carattere tecnologico, in realtà è un libro piatto come pochi altri: le tematiche informatico - scientifiche non sono mai trattate con la necessaria dovizia di particolari, le efferate gesta dello stereotipato serial killer sono sempre "all'acqua di rose" e, malgrado il malcelato intento di P.J. Tracy di renderle il più possibile violente, crude e brutali, non si può fare a meno di sorridere tanto della loro ingenuità quanto dell’ indiscriminato abuso che ne fa l’autore per tentare di colpire l’immaginario di coloro che, ormai pentiti, hanno acquistato il romanzo. Persino il colpo di scena finale che potrebbe risollevare le sorti di tutta la vicenda, è blando e inefficace (i personaggi del libro sono quelli, un assassino terzo estraneo non regge se si vuole far stare in piedi la trama) e man mano che si sfoglia il libro ci si accorge di fare il "toto colpevole" che immancabilmente si vince azzeccando in anticipo di due capitoli chi è il cattivone di turno.
E se viene a mancare persino la trama cosa rimane a questi romanzi?
Certo non i personaggi che qui non sono mai ben sviluppati, vedasi per esempio la figura della "sexy grassona", creata per stemperare il quadro globale della vicenda (cosa per altro non necessaria), che, più che umoristica, è patetica e nei capitoli dove compare infonde al lettore un’ implacabile senso di depressione; oppure vedasi la protagonista che con quella sorta di sindrome da rifugiato è più adatta ad un romanzo rosa che a un tecno - thriller.
Una trama che "sa di già letto" confezionata in un involucro scadente, insomma, con le adeguate implementazioni e migliorie, senza dubbio un ottimo script per una fiction estiva.
Indicazioni utili
Normale
Primo libro pubblicato da Cussler, getta le basi per le successive (migliori) avventure di Dirk Pitt. Interessante la scelta di introdurre all'inizio del libro il personaggio di Pitt con una sorta di scheda monografica a lui dedicata evitando così lunghe descrizioni del personaggio una volta cominciata la narrazione della storia. La scheda ha inoltre il pregio di far intuire al lettore neofita che non sarà l'unico romanzo in cui compare il suddetto personaggio ma sarà anzi il filo conduttore di un intera saga, tuttavia toglie un po' il fascino di scoprire man mano chi sia Dirk Pitt e conferisce al libro un fondo di amarognolo dilettantismo che non comparirà più nei successivi romanzi dello stesso autore.
La storia è semplice e lineare, si svolge senza particolari colpi di scena seguendo il classico schema della narrativa poco impegnata (e impegnativa): un "terribile" nemico, costantemente votato al male compie "tremende" ingiustizie contro dei personaggi deboli e indifesi, compare il luminosissimo eroe (sempre votato al bene) che con l'amico fidato, estroverso e scanzonato (stereotipo dell'amico, compagno di avventure che da adolescenti tutti noi avremmo voluto avere), si adopera per togliere di impiccio le vittime inermi e già che c'è anche "la bella di turno".
Alla trama di questi romanzi non manca mai nulla, ci sono tutti gli elementi necessari, non uno di più, non uno di meno ed è divertente fino all'ultima riga, ma la sua completezza è quasi sempre ottenuta a scapito della profondità narrativa. Lo stile di Cussler comunque è l’ideale per questo genere di letteratura: incalzante, avvincente, discorsivo e descrittivo quanto basta, e, se conosciuto alla giusta età (da bambino), di enorme appeal.
In sostanza Enigma come molti altri è uno di quei libri fatti in modo che quando si inizia a leggere non si smette più fino alla fine, portato a termine il facile compito però non rimane nulla al lettore, se non la curiosità di vedere in che avventura andrà a cacciarsi l'eroe nel romanzo successivo. Contenuti non particolarmente originali in un appropriata confezione, strano non ne abbiano tratto un film, ma questa considerazione vale per ogni altro libro dell’autore, sia nel bene che nel male.
Indicazioni utili
V. come...
V. Chi è V.? Che cos’è? Quale entità superumana, collettiva, trascendente l’individualismo sociale del singolo essere umano rappresenta agli occhi dell’autore? E a quelli del lettore? Non me lo chiedo tanto per amore di dialettica, per tentare, scopiazzando le altre innumerevoli recensioni, di darmi un tono da saccente intellettualoide forbito nel parlare tanto quanto nel ragionare (purtroppo o per fortuna sono ben lungi dall’essere così), quanto perché sono fermamente convinto che la comprensione della prima opera di Pynchon, e dunque anche la sua valutazione, debbano per forza di cose passare per la comprensione del significato dell’opera e il medesimo significato a sua volta può essere intuito soltanto avendo una chiara visione di quelli che sono gli elementi principali dello scritto. In questo caso l’elemento portante, non tanto il protagonista, poiché questo o questi sono due o tre uomini, tutt’al più una banda (quella dei morbosi) o un modo di vivere rappresentativo di un epoca storica (quello dei giovani ribelli del dopo guerra che portano il peso di qualcosa che non hanno vissuto e lo rielaborano sfogandone la violenza implicita con atti ingiustificati e Hollywoodianamente iconici), dunque l’elemento portante, il filo conduttore attorno a cui ruota la vicenda è questa fantomatica, tentacolare ed enciclopedica presenza che è conosciuta come V.
Dunque è lecito riproporre l’interrogativo che migliaia di lettori, critici e letterati, si sono posti nell’arco degli ultimi cinquant’anni, da quando è stata pubblicata codesta opera: chi è V.? O per meglio dire, che cos’è?
Be V. è senza alcun dubbio il titolo del libro, questo l’ho capito e anche abbastanza in fretta a dirla tutta. Dopo qualche pagina comunque viene il dubbio che V. sia anche qualcos’altro: il modo in cui terminano i titoli di tutti i capitoli, qui ammetto di averci messo un po’ di più, ma intorno a pagina cento sono sicuro di esserci arrivato. Il problema vero è che arrivati appunto a pagina cento si ha la certezza che V. rappresenti qualcos’altro ancora, ma se chiara è la certezza sicuramente non si può dire altrettanto del significato di suddetta certezza.
L’interrogativo quindi rimane: chi è V.? Dov’è? E cosa vuole? Proseguendo la lettura la questione non si semplifica anzi, tempo di arrivare a pagina duecento e Pynchon ci presenta V. come tre o quattro donne diverse tra cui una possibile madre di uno dei protagonisti, o almeno l’amante del padre, ce la presenta come due o tre città differenti sparse qua e la per il globo, tra le quali anche l’inventata città di Veissù che forse non è poi così inventata, ma semplicemente uno pseudonimo di un luogo vero, il nome in codice di forse addirittura una nazione in cui si svolge un complotto, che prende parte a un complotto, che complotta lei stessa, la nazione, contro… non si capisce bene cosa, e per qualche motivo non se ne deve parlare e coloro che ne parlano gli succede Dio solo sa cosa, perché appunto non se ne deve parlare e non si deve sapere. Ma nessun timore, tempo un'altra decina di pagine e V. ritorna a essere l’amante del padre di uno dei protagonisti misteriosamente scomparso (il padre) durante un altro complotto, solo che questa volta il padre è un desaparecido di una città che appunto, forse, probabilmente, iniziava per “v” oppure il complotto è avvenuto proprio in una città dalla medesima iniziale, ad opera di cittadini ribelli del Venezuela, che guarda caso è uno stato che incomincia anche lui per “v.”
Ma ancora niente paura perché poi torna sempre il solito protagonista che cerca disperatamente quella donna di nome V. senza neanche sapere lui perché, solo perché sente che deve, solo perché intuisce, neanche lui sa come, che è legata alla sua storia, alla sua vita o a quella di suo padre e quale luogo migliore per cercarla se non a Malta, a La Valletta, che giusto per rimanere in tema, se qualcuno non ci fosse ancora arrivato, è una città che incomincia per V.? (Anche se a onor del vero inizierebbe con la L, ma non divaghiamo eccessivamente!)
Dunque cosa significa V.? Il, o la, V. del titolo? Forse io ne ho colto un altro significato, V. potrebbe essere anche interpretato come il numero romano cinque, V appunto, come cinque sono gli uomini crocifissi sul pettinino che si passano di mano eredi e discendenti, amanti di amori non corrisposti e progenie di amori che dunque forse erano corrisposti, ma solo per brevi istanti, solo per brevi situazioni, solo in luoghi, in città che rigorosamente iniziano tutte per “v”. Ma a ben pensarci forse il mio non è neppure un nuovo significato alla lettera V., forse non è neppure un significato, forse non è neppure tanto mio: qualcuno sicuramente avrà già interpretato il romanzo in questo modo, avrà sicuramente suggerito questa chiave di lettura, avrà sicuramente bene inteso il volere di Pynchon volto a…a che? A Cosa? E la domanda di nuovo è destinata a rimanere senza risposta perché, di nuovo, (e so che mi sto ripetendo, ma talvolta si ha la medesima sensazione leggendo il libro), perché di nuovo, arriva l’amico di quello che cerca V., e non è una comparsa di poche pagine, ma un altro vero e proprio protagonista, la cui storia si seguirà fino alla fine, che è legato, intrecciato anche lui a V. da…mah forse dal fatto che lui e quello che la cerca si sono ripassati la stessa donna un paio di volte.
E il quesito rimane insoluto ed anzi si tinge di tinte ancora più gialle, e dal chi è V.?, di prima si trasforma in “e mo cosa c’entra V.?” E la domanda è pertinente perché se il lettore aveva resistito in maniera stoica fino a questo punto ora irrimediabilmente sconfitto si perde nelle arzigogolate circonvoluzioni della storia, delle storie e di tutte le lori possibili interpretazioni.
Ma il ragionamento a livello subliminale continua e continuando a leggere, in sottofondo, a livello limbico continuiamo a trovare, tentare, creare e poi cestinare interpretazioni differenti con il rischio di partire per la tangente. Tipo si potrebbe leggere l’ormai ossessiva lettera come l’estremizzazione del concetto che non conta tanto la reale natura di una cosa quanto l’apparenza, o per meglio dire il significato che ognuno di noi attribuisce a quella cosa. Oppure si può leggere come la sintesi definitiva del concetto di femminilità, be questa è facile, è lo slogan scritto pure sul retro della copertina. Oppure potrebbe essere interpretata come la v di vittoria, la vittoria definitiva dell’oggetto sul creatore, dell’inanimato sull’animato, se ne parla anche durante il romanzo, è un’interessante riflessione/divagazione di uno dei protagonisti e dunque dell’autore stesso: vero siamo noi che creiamo gli oggetti, ma loro poi regolano il corso della nostra vita a seconda di come li sfruttiamo, a seconda dell’uso che ne facciamo, a seconda se li usiamo, li abbiamo, li capiamo, oppure no. In fondo è un po’ anche la solita vecchia diatriba che si sente ripetere in certi ambienti più o meno estremisti: una pistola, un’arma, è pericolosa? O meglio è qualcosa di sbagliato, cattivo, brutto? No, ci si sente rispondere da una parte, perché è un oggetto senza una volontà propria dunque non può avere queste qualità che sono prerogativa di un essere senziente, l’arma, e così gli altri oggetti, di per sé non hanno qualità positive o negative, dipende dall’uso che ne facciamo.
“E che uso ne vuoi fare di una pistola, ci spalmi la marmellata sul panino a colazione?”, ci sentiamo rispondere dall’altra parte, “d’accordo che non è cattiva, non vai in giro a redarguire un canne mozze perché s’è comportato male, però se non venisse neanche prodotto, e così tutte le altre armi, non andrebbero in mano a chi ne vuole fare un uso cattivo.” Resta poi da stabilire cosa sia l’uso cattivo, se l’uso buono relativo ad un oggetto è esclusivamente asservito alla sua funzione originaria allora ogni sparo di pistola è un buon uso, e ogni colpo che non centra il bersaglio è un cattivo uso, ma si sa bene che non è così e quindi si ritorna all’opinione dei pacifisti, che ogni uso è un uso cattivo, ricominciando un loop senza possibilità di risoluzione.
E come dicevo si parte per la tangente.
Tornando al libro comunque, e se V. significasse proprio questo, se fosse nient’altro che la semplificazione (si va be…) di questo concetto di dualismo uomo – materia, animato – inanimato. Se ne fa cenno nel romanzo, a questa dualità, chi è migliore? Qual è l’entità superiore? Chi regola chi? L’uomo regola la forma dell’oggetto, il suo utilizzo, o al contrario, l’oggetto, la sua forma, il suo utilizzo, regolano la vita dell’uomo? Non è un balzo sconsiderato questo, non è un’ipotesi astrusa, il viaggio di una mente sotto acido; basti pensare agli eccessi di oggi giorno, al bambino asiatico che vende i propri organi per avere un I-phone o alle scene di violenza davanti ai megastore americani all’inizio della stagione dei saldi e tutto per un televisore, una borsetta o Dio sa cosa. Assurdo, illogico, impensabile, ma purtroppo è realtà e in questo caso, chi regola chi e cosa regola cosa? L’uomo o la macchina?
Nel libro addirittura si arriva alla sublimazione del concetto, alla trasformazione totale, e questa è una delle pagine più belle: l’uomo che deluso, disilluso, ormai sociopatico vive la sua vita da spettatore esterno senza più avvertire emozioni, in preda solo al desiderio di stordirsi, di bere, di non pensare e proprio durante una di queste fasi, sotto forma di allucinazione, incontra l’oggetto inanimato che ha preso vita, il manichino da crash test che pensa, respira e vive una vita, dolorosa sì, ma per questo piena, completa, molto più intensa del suo custode, del reietto che vive ai margini della società per sua scelta. E la sublimazione si compie, l’oggetto diventa un meta-uomo che mantiene entrambe le sue nature ed assume una connotazione positiva, e l’uomo diventa meta-automa che mantiene anche lui entrambe le sue nature ma assume una degradante connotazione negativa. E dunque ecco un altro significato di V. , un significato autolesionistico, poiché alla luce di questa scoperta, della dualità di ogni vita in equilibrio tra uomo e oggetto, non conta più cosa sia la “v” ma conta cosa include, e cosa esclude, cosa contiene in se, le due nature: la donna simbolo di vita e la città degli uomini resi automi dall’obbiettivo, dimentichi o mai consapevoli dell’obbiettivo stesso, (proprio come gli oggetti di cui si servono), la città degli uomini senza volto, simbolo di distaccamento emotivo, di morte.
Forse la V. è la v di vita, quella dei protagonisti, quella dei ribelli, quella di quelli che sembrano ancora vivere, la banda dei morbosi, ma che portati all’eccesso per loro stessa natura poi tendono inconsapevolmente molto più alla morte, e dunque all’assenza di vita, o vitalità, di quanto addirittura riescano a rendersene conto.
Forse è la v di vita, e il punto dopo di essa significa che prima o poi finisce, significa tutto ciò che c’è attorno, gli oggetti inanimati, la storia dei nostri avi e del mondo, imprescindibilmente legate l’una all’altro come sono appunto la V e il punto. Potrebbe essere, infondo è un’altra interpretazione, abbastanza plausibile per giunta, giustificata da quanto si legge nel racconto, ma alla fine il dubbio rimane, la domanda iniziale sembra ancora non avere una risposta: alla fine, in sostanza che cos’è V.?
Provo a darne un’ulteriore interpretazione, l’ultima lo prometto: e se V. fosse solo un pretesto?
Se la V. del titolo non foss’altro che un abile stratagemma per tentare di legare, dare un significato, ad un’opera che ritrae in maniera disordinata, confusa, caotica la vita di un quattro o cinque persone. Se fosse solo un trucco per tenere l’attenzione del lettore ancorata ad un libro che annovera sì pagine di grandissima letteratura (leggasi l’incipit e il sopracitato passaggio con l’omino del crash test) ma che le affossa anche ingarbugliandole in una intricata serie di racconti, opinioni, punti di vista e salti geografico temporali tali da far perdere l’orientamento persino ad un Tom Tom?
Forse alla fine si svela chi è V. e che cos’è, o chi è stata e cosa è stata, ma il casino è tale e il disorientamento del lettore è così universale che anche quando lo si scopre non importa più nulla; Pynchon alla fine ci spiega chi è, ma sommersi dal mare di informazioni precedenti, quasi non gli si vuole credere. Possibile che sia tutto qui? No ci sta ingannando, in realtà V. è qualcos’altro è qualcosa di più.
Dunque alla fine chi è V.? Boh! Io non l’ho capito, letti e riletti diversi passaggi, capitoli, parti, non ci sono arrivato, forse è colpa mia, del resto si sa che non brillo per intelligenza, forse è colpa del momento, ero distratto, forse della troppo semplice spiegazione finale, ma se devo trovare per forza qualcuno a cui dare la colpa preferisco attribuirne la responsabilità a… V. stessa. Mi è molto più comodo pensarla così, tanto neanche lei, o lui, se esistesse ci capirebbe qualcosa, saprebbe chi è, cos’è e soprattutto dov’è.
E’ vero quel che dice DeLillo di Pynchon, che raggiunge vette letterarie inarrivabili ai più, o qualcosa del genere, è vero le raggiunge, il problema è che poi non si mantiene su queste vette, o per meglio dire, poiché pretendere una cosa del genere sarebbe troppo anche per Dante e Manzoni, il problema è che queste vette strabilianti, stupende, evocative, lucenti ecc. ecc. nascono sprofondante in gole di caos letterario (altrettanto irraggiungibili ai più) e dunque, per quanto le suddette vette siano superlative e splendenti, all’occhio del lettore che sta affogando nel mare dell’incomprensione, appaiono niente più che come delle piccole ancore di salvezza indispensabili per rifiatare tra un ondata di disorientamento e l’altra, indispensabili per raggiungere arrancando, un po’ in apnea, un po’ ad occhi chiusi, un po’ coi crampi la fine del libro.
Un romanzo enciclopedico, sì anche questa volta l’ultima di copertina ci ha azzeccato, ma proprio come un enciclopedia, che nessuno dotato di buon senso potrebbe mettersi a leggere dalla a alla z sperando di trovarci un filo logico, anche questo romanzo non ha un filo conduttore e tantomeno un significato.
Certo la poliedricità di punti di vista, di argomentazioni, la globalità narrativa dell’autore che non si limita alla singola vicenda ma che al contrario racchiude in un unico insieme diverse storie, opinioni, aneddoti ed epoche, potrebbe essere considerato da alcuni come un pregio più che come un difetto: l’insieme delle vite, delle storie, dei casi umani. l’insieme realtà. Ecco che per quest’ultima categoria di lettori mi sorge spontaneo un nuovo significato di V.: V. come il “vel” della teoria degli insiemi, quello di “out” e “vel”. Per tutti gli altri, se non vi ricordate cosa significa, terminata la lettura di V. andatevi a rileggere il libro di matematica della prima superiore…magari lo trovate anche più interessante.
Dicevo forse la poliedricità di V. se per alcuni non aiuta a chiarire il significato della storia e tanto meno la storia, per altri, i più masochisti, potrebbe essere invece considerato un pregio piuttosto che un difetto.
Ogni parere merita rispetto a prescindere da chi lo formuli a prescindere dalla fazione per cui vogliamo parteggiare. Parlando sempre di numeri, però, rileggendo ora la mi recensione, noto che la parola che ho usato di più dopo V. (e ci mancherebbe, ormai me la sogno pure di notte) è “forse.” Anzi a dire il vero vanno di pari passo, ad ogni V. qualche riga più in la troverete sempre un “forse.” Sarà un caso, sarà una coincidenza o sarà colpa di V.? Indovinate di quale fazione faccio parte io?...
Va bene, l’ammetto, mi sono lasciato prendere un po’ la mano, non è il caso di essere così sarcastici, è vero che molti punti sono incomprensibili e generano un senso di disorientamento globale, ma alcuni passaggi invece, i sopracitati e qualcun altro ancora, quei pochi, sono veramente degni di nota, anzi di più, proprio come dice DeLillo sono vette letterarie irraggiungibili, peccato siano solo così poche, e qui non lo dico cono sarcasmo. Peccato.
Vero in fondo si tratta solo della prima opera dell’autore, non si può pretendere più di tanto, eppure è così famosa, così rinomata, così consacrata nell’echelon dei grandi romanzi del novecento; era lecito aspettarsi qualcosa di più, qualcosa di almeno relativamente comprensibile o sensato. Peccato.
Le premesse c’erano, l’incipit è stupendo e alcuni passaggi (ma l'ho già detto e ridetto migliaia di volte)ma il resto… peccato.
Forse sono io che sono troppo presuntuoso e non avendolo capito, giudico male il libro, forse sono io che mi aspettavo troppo, ma le attese quando lo acquistai erano grandi, di nuovo, è vero che sapevo si trattava di un opera prima, che non potevo pretendere più di tanto e non era lecito aspirare al romanzo perfetto, ma almeno almeno a qualcosa di vagamente leggibile?
Peccato!
Indicazioni utili
disincantato
Un' indagine avvincente per una storia affascinante, estrema, reale.
La ricerca di se stessi al di fuori di se, prima nella famiglia, poi nello studio e nel lavoro e infine nell' illusorio selvaggio delle terre estreme. Illusorio non tanto per l'effettiva collocazione geografica dell' ultimo viaggio del protagonista quanto per la sua falsa consapevolezza di aver trovato una vita migliore e una più profonda realtà in un luogo che metaforicamente rappresenta la fuga dalla realtà.
Più che un viaggio reale normalmente questo è un viaggio figurato, un viaggio di ribellione che prima o poi tutti i giovani devono affrontare, tuttavia il protagonista, forse più inappagato dei suoi coetanei, più emarginato di loro, lo fa diventare reale e ne paga le conseguenze. Conseguenze drammatiche e forse evitabili, ma analizzando bene le circostanze probabilmente ineluttabili.
E' il dramma del singolo, del suo romantico male di vivere, che si stempera e si diluisce nell'immensità della natura, nella glaciale irremovibilità delle reali contingenze di fronte alle quali i sentimenti contrastanti e lo streben della perenne (ma il più delle volte solo adolescenziale) incomprensione non valgano nulla, ciò che conta nelle terre estreme infatti è soltanto la vita e la morte: se riesci a sopravvivere bene, se no tutto continua, con o senza di te.
Questa potrebbe essere una chiave di lettura della storia, ma dal momento che l’autore (giustamente) non ce ne fornisce una in particolare il dramma dell’ incomprensione potrebbe essere anche interpretato più prosaicamente come un triste fatto di cronaca che ha voluto che un mezzo ingenuotto, e disadattato, facesse un’ultima bravata prima di ritirarsi ad una vita più savia e matura e nel mentre compisse il passo più lungo della gamba. Più cinica, più disincantata, vero, ma non per questo meno realistica.
L’autore come si è detto non fornisce una singola e certa chiave di lettura, ma, come è logico fare in questi casi, si attiene ai fatti e attraverso questi, attraverso le voci di coloro che intervista, le riporta tutte. Ed è questo il punto di forza del libro rispetto al film, il film è troppo romantico, troppo incantato e dalla parte del ragazzo, qui invece no, qui si è di fronte ad un indagine di stampo giornalistico, che se per certi aspetti può apparire persino eccessivamente irriverente e cruda, a differenza della pellicola, può vantare un’incontaminata lucidità ed un perfetto equilibrio.
Non sempre infatti per risolvere i problemi sono utili sensibilità e buoni sentimenti, talvolta, proprio come nelle terre estreme, è più utile la fredda logica e il pragmatismo.
Stilisticamente il saggio (perché di saggio infatti si tratta) tuttavia risente fin troppo del background giornalistico dell'autore e la narrazione talvolta è eccessivamente dettagliata e slegata, come tanti articoli di giornale, ma quando di tanto in tanto la professionalità di Krakauer, in una sorta di contrappasso deontologico, viene sopraffatta dell'intensità della vicenda, allora l’autore da il suo meglio ma, ancora una volta, non tanto perché è empaticamente vicino alle sventure del povero Alex (così voleva essere chiamato), quanto perché anche lui, come tutti, è umanamente partecipe della cieca e brutale casualità dei fatti che hanno portato questa storia al suo inevitabile tragico epilogo; come a dire: in fondo stiamo tutti giocando con la vita ma le regole non le stabiliamo noi.
Indicazioni utili
Delusione
Ci sono certi autori che per sentirsi realizzati devono scrivere di avventure mirabolanti, imprese epiche e gesta eroiche. Poi ce ne sono altri come Fred Vargas che scrivono la quotidianità, i piccoli e grandi problemi della vita di ogni giorno, il disincantato realismo dell'uomo medio e il tutto lo fanno in maniera semplice, pulita e lineare. Qui il protagonista, il commissario Adamsberg, un uomo come tanti che per modi di fare e carattere sembra più avere dell'anti - eroe che dell' eroe, è alle prese con un caso fatto su misura per lui, concreto, realistico, la cui risoluzione non comporterà certo particolari colpi di scena, non cambierà certo la vita dei Parigini e tanto meno la sua, e lui è l’uomo giusto per questo caso poiché è il prodotto della normalità che combatte l’eccezione dentro d’essa. L’uomo giusto, dunque, per il caso giusto, nel romanzo giusto e tutto sembra filare liscio fino in fondo, normale, senza alti ne bassi, e così del resto deve essere poiché se un romanzo di questo genere trascende anche solo per un istante la realtà, fa perdere di credibilità all'intera vicenda, se offusca la centralità degli attori attorno ai quali si svolge la trama perde di sostanza. Qui comunque non accade, anzi, tra un dialogo e l’altro, tra un’ indagine e l’altra, si riesce a intuire addirittura una certa profondità psicologica nei personaggi, una profondità assolutamente degna di nota in questo genere di narrativa, tanto che si potrebbe persino dire che non è tanto la vicenda in sé, il mistero dei cerchi azzurri a cui rimanda il titolo, l’elemento essenziale della trama, quanto le vite dei protagonisti e di tutti coloro che bene o male sono coinvolti nell’indagine.
Si potrebbe credere quindi che per certi aspetti si sia di fronte ad un romanzo inaspettatamente controcorrente, anticonformista pur nella sua normalità, e poiché, come in ogni forma d’arte così anche nella letteratura, le novità sono inizialmente bene accette in quanto tali (onde produrre quella continua evoluzione del gusto e dei costumi tipici della storia dell’uomo) questa sorta di appena accennata introspezione si potrebbe anche credere che sia quanto mai degna di lode… peccato solo che poi nel finale la vicenda ritorni in primo piano assoggettando l'uomo medio del testo alla sua piatta banalità, e l’etichetta narrativa affibbiata dalla critica all’autrice venga rispolverata (per mancanza di coraggio da parte di quest’ultima) forzando il reinserimento dell’ opera dentro le canoniche fila del poliziesco. E questo è un autogoal per la scrittrice francese poiché se un romanzo “interdimensionale” dava adito alla liceità di un finale aperto, un giallo al contrario deve essere rigoroso sotto tutti i punti di vista, a cominciare dalla soluzione del caso, dalla spiegazione del movente che ha spinto il colpevole a compiere tal crimine e a comportarsi in tal modo invece che in tal’altro, e questa spiegazione deve essere per giunta totalmente plausibile, altrimenti tutto il lavoro perde di senso. L’autrice ne “L’uomo dei cerchi azzurri” non ci riesce a trovare questa spiegazione, forse non è capace, ed costretta a far terminare l'indagine in maniera cosi grottesca, improbabile e demenziale che sembra stia prendendo in giro non solo i lettori, ma anche se stessa, non solo chiunque abbia seguito con coinvolgimento l’intera vicenda, ma anche il lettore occasionale che scorgendo un finale così poco credibile stenta a comprendere il significato logico dell’intero romanzo. Peccato, ore buttate.
Indicazioni utili
Immortale
Il sottosuolo: l'emblema della psiche umana con cui l'uomo stesso deve venire a patti quotidianamente per trovare un nesso logico alla realtà e che contemporaneamente anelerebbe a ripudiare per vivere autenticamente nel reale ed essere egli stesso più reale. Le memorie (o ricordi che dir si voglia): il lascito della vita vissuta filtrato dal sottosuolo e riportato ad una nuova più obbiettiva, più lungimirante e forse per questo più nichilisticamente rassegnata luce di consapevolezza.
Le memorie (o ricordi) dal sottosuolo: un imperituro mirabile esempio di edotto esercizio di stile e di vita, poiché per addentrarsi in tal modo nei meandri della coscienza umana non solo bisogna saper scrivere, ma occorre anche saper vivere, conoscere la vita, la sua logica illogicità e la sua contraddittoria paradossalità.
Solitamente non mi ritengo all'altezza di commentare i grandi classici della storia della letteratura tuttavia per questo, vostro malgrado, farò un eccezione poiché raramente mi sono trovato più in accordo e contemporaneamente in disaccordo con un libro, raramente mi sono trovato più simpaticamente coinvolto ed al medesimo tempo empaticamente sconvolto da una lettura, fosse questa di narrativa fosse questa di saggistica. Ed è proprio in bilico tra questi due generi che si collocano "le Memorie," in bilico e in contrasto, poichè parte sono romanzo aneddotico e parte disquisizione formale, parte premessa ai fatti e parte giustificazione, ma quale l'una e quale l'altra? E' inutile domandarselo giacché in realtà sono un perfetto tutt'uno che si fonde la dove proprio c'è discrepanza, si unisce la dove maturano i germi della diversità, ovvero nell'uomo, l'uomo di Dostoevskij, al tempo stesso romantico e anti-romantico, coraggioso e vigliacco, antieroe capace delle più vili bassezze e tuttavia archetipo dell’eroe esemplificatore della condizione umana. E alla maniera del suo personaggio anche il libro è un unicum contrastante: indissolubilmente legato alla sua epoca e ciò nonostante assolutamente attuale, così ironicamente tragico da creare uno straniamento per déjà vu, e sorprendere il lettore con una vicenda già molte volte vissuta, e così ostentatamente imponderabile ed inconsueto da risultare assurdamente lapalissiano. Un libro unico insomma, universale, e appunto immortale.
Indicazioni utili
Autosufficiente
E' un libro autosufficiente: come certi organismi che non hanno bisogno di aiuti esterni per vivere, questo libro si auto alimenta grazie alla fama che gli astuti editori e gli scaltri pubblicitari hanno creato inizialmente. E' bastato usare infatti termini come "caso editoriale" e "nuovo genere letterario" per avvolgere il romanzo dello svedese con la nomea di capolavoro; i lettori, compreso il sottoscritto, hanno fatto poi il resto: più lo si acquista più scala le classifiche e più scala le classifiche più lo si acquista.
Di per se è un discreto libro a cavallo tra il genere giallo e il noir e la fredda e statica ambientazione del paesino svedese dove si svolge gran parte della storia è anche ben riuscita, ma se per gli editori furbacchioni si è di fronte a un testo che ridefinisce i canoni del romanzo moderno, agli occhi dell'attento lettore non può passare inosservato come anche questo scritto non sia scevro di tutti quegli aspetti negativi tipici del suo genere, a cominciare dalla protagonista femminile: giovane disadattata così incapace di relazionarsi con la società da rasentare l'autismo ma che all'abbisogna si trasforma in abilissima hacker, implacabile lottatrice e trasformista esperta in camuffamenti con una personalità, tra l'altro, così salda e forte da elaborare e superare da sola in un paio di giorni uno stupro in piena regola! Tutto troppo facile, troppo lineare, troppo banale .
E anche la trama a ben vedere lascia un po' a desiderare: "Uomini che odiano le donne" in realtà sono due romanzi in uno, con due svolgimenti distinti, due epiloghi diversi e un collegamento un po' raccogliticcio. La prima storia, tratta della vicenda personale del protagonista e serve soltanto da sfondo per la seconda e più importante, la vicenda della famiglia su cui deve indagare il suddetto protagonista. Ma se la storia principale per quanto scontata è piuttosto intrigante, quella secondaria sembra creata ad hoc dall'autore per rimpolpare un romanzo che altrimenti conterebbe si e no 300 pagine.E una volta risoltasi la principale si finisce di leggerlo per inerzia soffocando a stento gli sbadigli.
Nuovo genere letterario? Ma non scherziamo!
In due parole: un libro artificiosamente sopravvalutato.
Indicazioni utili
Promettente o promessa mancata?
Un libro sottovalutato. Se nella prima parte infatti, l'introduzione o antefatto che dir si voglia, è fin troppo banale e nell'ultima, il gran finale, è materiale per il rifacimento Bolliwoodiano della saga di Jason Bourne, il libro, nella parte centrale lenta, misurata e cionondimeno ricca di spunti è a dir poco sorprendente. Non tanto per l'indagine in se, non tanto per l'originale ma mal spiegato elemento parascientifico su cui sta in equilibrio (precario) l'intera trama, quanto per l'atmosfera che crea. Un atmosfera autunnale, fredda, misteriosa contrapposta a quella calda, protettiva e un po' malinconica che crea attorno a se il protagonista del romanzo. Un contrasto all'apparenza stridente ma in realtà perfettamente calzante e rappresentativo di un particolare fenotipo umano che si circonda del calore dei propri affetti per poter continuare a camminare nella freddezza del vivere quotidiano. E' questo dunque un libro che, seppur fin troppo canonicamente suddiviso in tre parti, riesce inaspettatamente a creare nel lettore quella sensazione di immedesimazione riflessa tipica della weltanschauung della "narrativa romantica". Attenzione non stiamo parlando di un capolavoro della letteratura moderna: è pur sempre un romanzo con molti aspetti negativi, vedasi per esempio il sopraccitato originale ma mal spiegato elemento parascientifico che rimanda all'ultimo stanco Michael Crichton o certi personaggi talmente stereotipati da risultare burleschi o, ancora, certi "effetti speciali" del finale a dir poco fumettistici, ciononostante in quella “accogliente” parte centrale, con quella particolarissima e calda atmosfera, l'autore riesce (speriamo volontariamente) ad elevare il romanzo a termine di paragone per la moderna narrativa disimpegnata.
Un romanzo che lasciava ben sperare per il futuro ma la strategia di regalare il volume a chi ne avesse commentato la banale prima parte non ha reso giustizia ne al romanzo ne all'autore.
Indicazioni utili
"Reperto storico"
Vortice è il primo libro scritto da Cussler e quasi a voler giustificare la presunta pochezza narrativa della trama è lui stesso a confessarcelo a mo di preambolo. In realtà il libro è meno peggio di quello che verrebbe da pensare; fermo restando infatti che si rimane pur sempre nell'ambito della narrativa commerciale (con tutti i suoi pregi e difetti), Pacific Vortex di per sé non ha nulla di sbagliato: una trama avvincente, qualche colpo di scena ben architettato e una caratterizzazione dei personaggi che, per quanto stereotipata, regge fino all'epilogo.
Certo forse, più che in altri romanzi dello stesso autore, il protagonista della vicenda qui si rifà goffamente al carattere del James Bond dei film prima maniera (i film non i libri), tanto che a volte viene quasi naturale associare il volto del giovane Sean Connery al principale interprete della vicenda, ma ciò nonostante la costruzione del personaggio Dirk Pitt rimane adeguata alla trama e per quanto più in là nella bibliografia dell’autore il suo carattere verrà maggiormente approfondito, qui si gettano le basi per delinearne l’aspetto e la personalità. Non da meno poi è il fatto che in questo romanzo, e solo in questo, si venga a conoscenza di alcuni, fatti e figure molto importanti nello sviluppo della vita del protagonista, fatti e figure che, privi di questa sorta di premessa, nei romanzi successivi risulteranno incompleti e un po' sfuocati, vedasi ad esempio un particolare anatomico di Al Giordino che non ricomparirà più nei libri successivi o certi momenti in cui il sempre fin troppo brillante protagonista della vicenda appare misterioso, nostalgico e, non sia mai!, triste (l’eccessiva drammatizzazione e l’introspezione non sono mai nelle corde di questo genere d’autori ma non si può avere tutto dalla vita).
In definitiva quindi Vortice, o per meglio dire Pacific Vortex (questo infatti è il titolo originale che concepì l’autore vent’anni prima di pubblicare la sua opera) è un buon romanzo, e, nonostante qualche eccessivo luogo comune, nonostante qualche imperfezione, narra di un’ avventura originale e di sicuro intrattenimento; soprattutto considerate certe recenti opere del medesimo autore! All'epoca della prima stesura Cussler infatti era un giovane scrittore alla prime armi, era ammissibile qualche errore, ora invece è un navigato scrittore e di errori non ne compie più ma l’unica opera di cui può vantare l'esclusiva paternità, oltre al banale “The Chase” (ormai già sottrattogli per l’immancabile seguito), è una favoletta per bambini che non è neanche stata tradotta in italiano!
Giovane e inesperto…magari scrivesse ancora così!
Indicazioni utili
Prevedibile
Tutto come previsto, anzi peggio: se Ken Follett è uno dei pochi autori popolari che coi suoi libri può aspirare a trascendere la classificazione commerciale con "un luogo chiamato liberta" sicuramente vi si re immerge fino alla cintola. Un plot banale condito da personaggi e dialoghi altrettanto banali. Neppure il piano temporale, l'ambientazione storica tanto cara all'autore e così ben caratterizzata in altri suoi lavori, servono infatti a risollevare le sorti di un romanzo che sembra ideato più per necessità editoriali che per effettiva ispirazione. A poco servono anche gli approfondimenti sui costumi sociali dell'epoca gettati qua e la, stile rivista, giusto per dimostrare di aver fatto i compiti: troppo superficiali, comuni e ancora una volta banali.
Certo, se affermassi che sono 400 pagine da buttare peccherei di faciloneria, a tratti la narrazione scorrevole diletta e intrattiene, ma anche la più piatta e becera fiction Rai qua e la può avere spunti interessanti. Da Ken Follett è lecito aspettarsi qualcosa di più.
...E' lecito?
Se questa fosse stata una delle prime opere dell'autore si poteva anche capire, ma "I Pilastri" erano già usciti nel '95.
Per fortuna la bibliografia dell'autore ci insegna che dopo questa usciranno storie migliori, meglio architettate, più profonde e significanti, storie che gli permetteranno di risollevarsi e in punta di piedi, con strenui sforzi ai polpacci, farlo tendere a quell'echelon di autori che aspirano a qualcosa di più che essere in vetrina coi loro testi nelle cartolerie lungo mare assieme a tre materassini e un paio di ombrelloni.
Basta dare un’occhiata alle sue opere recenti per capire che sarebbero arrivati tempi migliori; letto questo libro, superato lo scoglio, resta comunque difficile scrollarsi di dosso il demone che vuole recludere Follett nel recinto degli autori venduti ad acquirenti con le ciabatte insabbiate, gli occhiali da sole e un' abbronzatura da weekend.
Indicazioni utili
classico ma originale
Ci sono autori che descrivono la quotidianità per tentare di racchiuderla in un sistema di pensiero che gli consenta di individuare delle costanti, uno schema comune, e in tal modo comprenderla più facilmente. Ci sono autori che indagano la realtà osservandola minuziosamente in ogni suo più piccolo dettaglio, scomponendola in minuscoli particolari fino a perderne talvolta il significato d’insieme, ma il loro fine è pur sempre il medesimo, è pur sempre quello dei primi: afferrarne il significato. Ci sono infine scrittori che scrivono immersi nella realtà, non mossi da impulsi analitici ma piuttosto trasportati dalle infinite correnti della vita, alla deriva nelle sensazioni di ogni giorno, accettando il mondo per quello che è, combattendo solo le battaglie alla portata del singolo, infischiandosene di ideali assoluti e assoggettando la concreta oggettività dei fatti al proprio modo di vedere le cose, al proprio modo di viverle, alla singola persona. Alla prima categoria appartengono scrittori del calibro di Philip Roth, alla seconda altri del calibro di DeLillo. Alla terza appartiene sicuramente Murakami. Non sta a me giudicare quale sia il metodo migliore, il più efficace per parlare del reale, poiché come ogni altra cosa va a proprio gusto. Una cosa però è assolutamente indiscutibile: al pari dei primi due, pur traendo da presupposti diversi e giungendo a conclusioni per certi aspetti simili, per altre differenti, l’autore di Norwegian Wood è uno dei più abili scrittori dell’era moderna. Oserei dire del novecento (giacché lo sto giudicando solo per questa opera che è stata scritta a metà anni ottanta) ma questo comporterebbe metterlo sullo stesso piano di alcuni mostri sacri del realismo letterario quali Hemingway, Steinbeck ecc. ecc. ed un simile raffronto rischierebbe di far torto sia a Murakami che agli altri due testé citati. Tengo a sottolineare nuovamente che sto giudicando l’autore esclusivamente per Norwegian Wood poiché sono consapevole che considerando tutta la sua bibliografia definirlo realista sarebbe alquanto azzardato: basta leggere la sua opera successiva (l’uccello che girava le viti del mondo) per capire che le sue tematiche trascendono l’oggettivo e si inoltrano, talvolta persino con autocompiacimento, nel surreale, accostandosi talmente alla pura sensazione da tralasciare la lucida coerenza degli accadimenti; basta pensare al suo ultimo successo 1Q84 (talmente di moda che è impossibile non citarlo parlando dell’autore) per individuare nell’onirismo piuttosto che nel reale la tematica principale della sua produzione letteraria. Eppure in Norwegian Wood no: forse ancora troppo giovane, forse non ancora pronto a compiere il balzo che l’avrebbe trasportato nel regno della sensazione pura, con questo suo romanzo Murakami ci consegna un opera concreta e semplice, magari banale, ma sicuramente equilibrata e a suo modo perfetta.
Certo la storia in se non ha nulla di nuovo: due o tre ragazzi che si innamorano, si lasciano ma non si lasciano, ci ripensano ecc. ecc., del resto si tratta di un romanzo sentimentale, è così che dev’essere. Di per se dunque la vicenda è antica, forse scontata, ma è proprio grazie a questa ovvietà implicita che il libro si eleva sopra la magmatica uniformità della narrativa di genere ed è proprio grazie a questo suo aspetto che l’autore s’affaccia nell’olimpo dei grandi del novecento. Se uno scrittore grazie al suo stile riesce traendo dalla banale quotidianità della vita di gente comune a produrre un’ opera che trascende la mera vicenda e si eleva a paradigma del duello interiore tra le intime pulsioni contrastanti dell’io profondo, riscoprendo persino quelle “doppie idee”, tanto care a Dostoevskij, facendo del sentire e del vedere del singolo il modo di vivere il reale, se uno scrittore riesce in questo, nonostante le “umili” premesse, be allora si può essere sicuri che si è di fronte ad un grande del suo tempo e che la sua opera rimarrà per sempre nella storia della letteratura per la sua cristallina perfetta semplicità, per la sua struttura equilibrata che concede tanto al capire quanto al sentire, per l’immacolata bellezza del sentimento che si alterna così autenticamente alla viva istintività della passione e in fine per tutte queste cose assieme, poiché non bisogna scordarsi che un quadro per capirlo va osservato sia da lontano che da vicino, sia nei particolari che nel insieme, sia con gli occhi di Roth che con quelli di DeLillo e se poi, anche per un solo libro si riesce ad essere entrambi, se l’autore riesce, anche solo per un capitolo, ad accostarsi ad entrambi…be non occorre aggiungere altro.
Norwegian Wood è un’opera totale, che non si pone obbiettivi grandiosi, ma soltanto quello semplice ed umile di descrivere la realtà come la vede l’autore, e facendo ciò, realizza forse l’impresa più importante di tutte: quella di farci capire la vita, quella di farcela apprezzare.
Ma, ancora una volta, sto parlando di questo libro, solo di Norwegian Wood, non degli altri.
Indicazioni utili
L' enciclopedia dei difetti della società
L’individuo lasciato a se stesso. Underworld di DeLillo narra della perdita di identità sociale dell’americano medio, e per estensione di chi suole definirsi occidentale, alla fine della guerra fredda, quando viene a mancare cioè quella che agli occhi della società democratica - capitalista è l’incarnazione di ogni male: il blocco sovietico, il comunismo.
In qualsiasi dicotomia, bene – male, vero – falso, giusto – sbagliato, se viene a mancare uno dei due termini, dei due estremi, anche l’altro perde di significato. L’U.R.S.S. crolla, il muro di Berlino viene abbattuto, l’America non si sente più in dovere di ergersi a paladina del bene e così gli stessi americani non si sentono più tanti piccoli eroi votati fin dalla nascita a combattere il male, per eredità nazionale ed elezione divina. Ora sono soli, singole unità dentro un oceano di possibilità, non più legati da quella comunione di intenti implicita dell’ essere occidentali, del risultare alla anagrafe come Mr. Smith o Mr. Johnson.
Nel libro si narra la trasformazione del singolo come riflesso della trasformazione collettiva e questa trasformazione per alcuni aspetti rappresenta una perdita di valori, per altri è l’acquisizione di nuovi: ci si lascia alle spalle la patria, il nazionalismo, il comune senso del dovere e si acquista l’individualità, il personale senso di giustizia, la soggettiva misura di ciò che è corretto e di ciò che non lo è. O almeno così dovrebbe essere se tutto andasse per il verso giusto, se gli esseri umani fossero animali razionali, logici, ma così non è e DeLillo lo sa bene: con l’inesorabile sfilacciarsi della grande coperta del nazionalismo, che nascondeva ogni problema alla luce di un obbiettivo comune tanto aulico quanto fittizio, tutti i vizi e le virtù proprie dei normali, banali, esseri umani emergono, sbocciano, risaltano.
La nascita dell’uomo medio e la scoperta delle sue origini, Underworld è la storia recente della America vissuta attraverso le vicende dei singoli americani,ognuno divisio dalle proprie pareti domestiche, ognuno portavoce del proprio pensiero e giudizio.
Il nemico malvagio dunque si è disgregato, e i paladini della giustizia, l’esercito del bene, rischiano di fare la stessa fine, ma se le singole componenti di un ingranaggio si guastano l’intero meccanismo si guasta.
La società occidentale si guasta? Questo non è accettabile, vorrebbe dire la fine della civiltà, dunque come fare per tenerla unita di fronte alla nuova crisi? Lo stato, la nazione, con la sua potenza, nella sua globalità, può fronteggiare solo problemi su vasta scala contrapponendo “bene” al “male”, violenza alla violenza, ma se il problema non può essere risolto in questi termini, se è molto più sottile, invisibile, interno? Come si può operare per risolverlo? Non certo con un’altra guerra, e allora cosa?
Underworld è la concezione che ha DeLillo degli ultimi cinquant’anni di storia americana ed è una concezione nostalgica e ironicamente pessimistica: l’uomo che finalmente è lasciato a se stesso ha una crisi d’identità. E per via di questa non riesce più ad aggregarsi ai suoi pari poiché non ne condivide i valori, poiché in primis non accetta i propri di valori, non li riconosce più come tali.
Che fare? Nei momenti di crisi di solito si fa affidamento a delle entità superiori, ai simboli, a quegli oggetti che rappresentano l’idealizzazione di ogni cosa in cui si crede. Per i cristiani è Dio, per i mussulmani è Allah e per gli americani disillusi è il baseball: lo sport tipicamente nazionale, l’unico valore rimasto a una società in disfacimento per mancanza di stimoli (così la vede l’autore): la guerra fredda è finita, lo spauracchio sovietico anche, cosa rimane per sentirsi tutti uniti? Per la difesa di quale valore ora si può combattere, morire? Il baseball. Ma lo sport, se da una parte unisce una nazione, dall’altra la divide profondamente. Nell’insieme baseball, ma così è per ogni sport, si creano tanti sottoinsiemi, tanti quanti sono le squadre della lega. Se poi si tratta di arraffare un cimelio dal valore economico, storico e affettivo inestimabile, i sottoinsiemi si suddividono ancora di più: in tante parti quante sono le persone interessate, quante sono le persone allo stadio, quante hanno sentito alla radio del fuori campo. E si è di nuovo soli.
L’uomo mosso da un intento puramente egoistico dimentica nuovamente, cosa vuol dire far parte della patria, della stessa nazione, della stessa città, della stessa squadra e lotta con il suo vicino, lo insegue, lo picchia, lo deruba. Questo è l’eterno dilemma dello sport che unisce e disgrega, che abbatte le mura domestiche per accomunare ma anche per dissociare, per stringere la mano al proprio vicino e al contempo graffiargliela, mordergliela e strappargli il simbolo la cui proprietà acquisita ri-eleva il possessore a status di eroe, di paladino del bene.
Homo homini lupus, l’individuo lasciato a se stesso che vuole comunque essere superiore agli altri, a scapito degli altri. Underworld è la storia del disfacimento subliminale, limbico, sotterraneo (da qui forse il titolo) della società americana alla luce dei fatti degli anni novanta, della perdita di identità per via della perdita di una nemesi, il tutto narrato attraverso “gli occhi” di coloro che hanno, vogliono, ricercano o sono casualmente venuti in contatto con la pallina da baseball, con quella pallina di quel fuoricampo, di quella partita in quel giorno che simbolicamente potrebbe sancire l’inizio della guerra fredda. Un oggetto specifico, di una specifica partita, di uno specifico momento storico, che dunque trascende il suo banale significato di oggetto ludico e, trasformato in icona, diventa il simbolo della nostalgia, il simbolo del ricordo di quando si era tutti uniti e si sapeva cosa si faceva, di quando si era una nazione, di quando una pallina scagliata sugli gli spalti rappresentava l’identità di un popolo.
Un tempo un saggio disse che le religioni (e con esse i loro simboli) hanno ammazzato molti più uomini di quanti ne abbiano salvati. Se ciò è vero lo stesso vale sicuramente anche per i simboli laici: il denaro, la falce e il martello, la svastica, una pallina da baseball etc. etc. Forse è così, ma se non ci fosse più niente per cui lottare, neppure una palla, un guantone o una scarpetta chiodata, cosa rimarrebbe all’uomo? Al pari della palla, così per tutte le altre icone religiose e non, forse siamo noi che creiamo i simboli, che gli diamo valore, per nutrire quella sete di violenza intrinseca nell’uomo, per sfogare quel bisogno di lottare per quello in cui crediamo, forse è la natura stessa dell’uomo che ci porta a trovare per forza un nemico, anche quando questo non c’è, anche quando questo è solo il compagno di bevute durante la partita.
Homo homini lupus.
Forse è proprio l’uomo il simbolo e non sopportando di riconoscersi come l’estremizzazione di ogni suo vizio, anzi come l’estremo stesso, ha bisogno di esternare i propri sentimenti investendo un oggetto inanimato di valori che di per sua stessa natura l’oggetto non ha, sia questa una banconota, una falce, un crocifisso o una pallina da baseball; poiché se non lo facesse non gli rimarrebbe nulla, non gli rimarrebbe più nulla in cui credere, per cui lottare…non gli rimarrebbe più neppure se stesso.
Homo homini lupus. L’individuo solo e alla ricerca di se stesso per continuare a illudersi, Underworld è la presa di coscienza dell’uomo che non riesce a ritrovarsi negli oggetti, nel valore che attribuisce a questi. E’ la disillusione ed è lo sguardo nostalgico al tempo perduto, a quando non si avevano dubbi ma solo certezze, magari sbagliate, false, ingiuste, ma pur sempre certezze.
Ora invece ci sono i computer (gli anni novanta rappresentano l’inizio del boom informatico) e tutto sembra più facile, a portata di mano, di mouse, tutto è collegato, iper-collegato, le possibilità di accedere alle informazioni sono praticamente illimitate e l’occhio critico con cui si osserva la storia diventa più oggettivo, equilibrato…e se con questa visione totale, universale, divina, si scoprisse che quello in cui si era creduto per una vita intera era sbagliato? Se si scoprisse che ci si era ingannati, che quei pochi valori rimasti, che coincidono spesso con l’intima morale di ogni essere umano, non sono nient’altro che un inganno, un’ utopia, cosa ci rimarrebbe se non la nebbia del dubbio? Negli anni cinquanta, sembra dirci DeLillo, l’uomo sapeva cosa voleva, magari era un’illusione, magari era un inganno, ma almeno era una certezza, ora invece ci sono i computer e la visione è molto più ampia; attenzione però perché se è troppo ampia si perdono i dettagli, si perdono i particolari, i singoli elementi costitutivi, gli uomini e la loro storia, la propria storia, la propria vicenda personale e non si riesce a definire più cosa è reale e cosa non lo è fino a che persino ogni singola parola, persino la parola, l’ultima, quella con cui si chiude il libro, la più bella, rimane il dubbio che in realtà non esista, che in realtà, al pari della pallina da baseball, sia nient’altro che un simbolo, un’ utopia.
Potrei come faccio di solito aggiungere qualcosa sullo stile dell’autore, che alterna accattivanti note noir ad altre impregnate di un tale eccessivo lirismo da riuscire a sublimare ed eternare l’immondizia di una discarica a cielo aperto (non è una metafora, lo fa realmente), potrei anche aggiungere qualcosa sul forte, e al tempo stesso solo presunto, simbolismo dell’opera, talvolta così perfetto da far rivivere la sensazione di un’epoca, il sapore di una decade, talvolta così pretenzioso che ci si può aspettare da un momento all’altro la descrizione di un cesso che trascende la storia moderna per la sua marmorea lucentezza (stavolta è una metafora), e potrei poi tornare di nuovo a parlare dello stile, talvolta così ispirato e totale da riassumere in una singola frase tutto il significato del libro e altre volte così prolisso e fine a se stesso da non riuscire a spiegare il significato della suddetta frase neanche in novecento pagine. Potrei, ma sarebbe come osservare un quadro analizzando ogni singola pennellata, ogni millimetro di colore: un lavoro inutile, fuorviante, un lavoro persino anacronistico se si vuole dar adito alla mia interpretazione del messaggio di DeLillo, poiché trascurerebbe il significato d’insieme dell’opera, il suo impatto globale, le necessità dell’uomo moderno. Dunque proprio alla luce di quest’interpretazione, in cui i dettagli si svalorizzano cadendo in secondo piano rispetto al risultato finale del libro, alla luce della capacità dell’autore di aver concepito una simile opera, ed esser riuscito a realizzarla in maniera unita, legata e soprattutto sensata, alla luce di tutto ciò, non mi addentrerò oltre nell’analisi dello stile e dei significati e mi limiterò a dire che non c’è miglior modo di classificare Underworld se non quello di definirlo il caposaldo della letteratura contemporanea.
…sempre partendo dal presupposto che la mia interpretazione del messaggio di DeLillo sia valida.
Indicazioni utili
Va capito.
Guardi l'Nfl e magari hai militato in qualche squadra di football americano italiana? Inizi a sfogliare la prima pagina e... "boom!" , sei costretto a leggerlo tutto d' un fiato e non importa dove sei o cosa stavi facendo: devi continuare fino in fondo (in due giorni volendo lo si finisce). Lo troverai avvincente, divertente, romantico e un po' nostalgico. Sei un profano dello sport che pensa che il football americano sia il calcio giocato in America? Un lettore che non sa che differenza ci sia tra un 1st. and 10 o un 3rd. and 2? Hai due possibilità: o guardi prima una partita con qualcuno che ti spieghi le regole (quelle di base sono semplicissime e potresti scoprire uno sport meraviglioso) oppure tenti di leggere un romanzo non capendo nulla e probabilmente annoiandoti parecchio.
Tornando al libro, la trama, è vero!, in sè non è nulla di che e la storia è piuttosto banale, ma ciò che è bello è il contorno: la carriera non proprio brillante del protagonista, tipica da 3° Qb, l'arrivo in "terra straniera", le differenze culturali e i problemi che ha l'americano ad integrarsi (sia nella squadra che nella vita quotidiana), il football in Italia con i piccoli stadi e i "piccoli atleti", il loro spirito di sacrificio così simile a quello dei professionisti e il loro spirito di squadra, talvolta addirittura superiore a quello dei professioniti, e ancora tutte le piccole cose che conferiscono quel fascino particolare al american football italiano. Forse è vero, per quanto sia ambientato in Italia, Il Professionista non è un libro fatto per lettori italiani: l'autore eccede a volte nelle informazioni di tipo geografico - turistiche per non parlare di quelle culinarie. Per certi versi sembra quasi che a corto di idee Grisham abbia tentato di pompare il volume del libro farcendolo di notizie tratte da qualche guida turistica per visitatori americani, d'altro canto però nel leggere i passaggi sopra menzionati (specialmente quelli culinari) non si può rimanere impassibili a quel lieve moto di patriottismo circa quelle cose, quelle nostre peculiarità, che talvolta ci rendono orgogliosi di essere italiani e che sicuramente ci rendono famosi in tutto il mondo.
Un consiglio per non rischiare d'incorrere in lapalissiani e fastidiosi errori di traduzione, specie durante le partite, leggetelo in inglese.
Indicazioni utili
Innocuo
Un libro dal titolo accattivante, ma che già a pagina due disattente le aspettative dei lettori autoctoni (il "lago" del titolo è il Lago di Como) per l'aspecificità geografica del testo. L'autore ambienta la sua storia in un non meglio precisato paesino durante gli anni cinquanta pensando che questo sia sufficiente a catapultare il lettore in quella realtà bucolica da vecchia cartolina che il "poliedricamente complesso" cittadino d'oggi sembra aver scordato. Se l'intento iniziale è affascinante il risultato finale però non è altrettanto suadente: l'eccessivo gigioneggiamento di Guin che antepone sistematicamente l'articolo davanti ai nomi propri, come se bastasse questo a trasformare i protagonisti in simpatiche figure dialettali d'epoca, e la stereotipizzazione di certi ruoli: vedasi per esempio il vecchio parroco con la sua perpetua, il comandante dei carabinieri meridionale, l'irriducibile pettegola o addirittura il frate buono, conferiscono all'opera una patina di dilettantismo. E' giusto però riconoscere che il titolo dell'opera è assolutamente calzante e rappresentativo, questo libro infatti, per come si svolge la vicenda, è una commistione di diversi generi letterari: ha un incipit da romanzo giallo, poi si tinge di noir seguendo l'evoluzione della coscienza del protagonista, quindi ineluttabilmente sbiadisce in un rosa pallido con lo sbocciare dell'amore tra i protagonisti. Nella parte Noir, Guin, è meravigliosamente ispirato e riesce a cogliere le spigolose contraddizioni dell'animo umano, quando però sconfina negli altri due stili è piuttosto superficiale e monotono: se il reato non ha particolari sfumature è banale, se il denso adolescenziale sentimentalismo per qualche pagina è giustificabile alla lunga risulta tediosamente incoerente alla pregressa narrazione e tutto il romanzo perde di ritmo. L'autore merita comunque un plauso per essere riuscito a introdurre nel testo dei tratti di introspezione psicologica così difficili da trovare oggi giorno in un romanzo moderno e commerciale.
Indicazioni utili
Patrimonio dell' umanità
Come si può commentare una delle opere più famose di uno dei più abili scrittori di ogni epoca? Come si può sperare di aggiungere qualcosa in più alle migliaia di parole che sono già state spese per rendere onore a Byron, genio immortale del romanticismo? Come si può anche solo immaginare di riuscire a fare una disamina di un’opera, un poema, come il Manfred quando centinaia di persone, scrittori, critici, pensatori, filosofi, drammaturghi, l’hanno già compiuta? Voci autorevoli del panorama letterario attuale e non. Semplice: non è possibile. Basta leggere il saggio di Bertrand Russell alla fine di questa edizione, per rendersi conto che qualunque sforzo sarebbe inutile. No, non c’è niente da fare Byron è un grande del suo tempo, è un patrimonio della letteratura mondiale ed è una fulgida testimonianza di un epoca, di una corrente artistica, di una società. E’ l’emblema del romanticismo, e non c’è davvero alcuna possibile argomentazione da addurre per tentare di criticarlo, sminuirlo e ridimensionarlo. Se non lo si capisce, se non lo si trova appagante ad ogni livello intellettuale, è un problema del lettore, non certo dell’artista.
Lo stesso vale per gli elogi: non c’è termine, la cui forza sia paragonabile a quella delle sue parole, non c’è singola frase che possa descrivere il suo stile, non c’è un solo verso che possa simulare l’oscura brillantezza della sua scintilla creativa.
No, di Byron, del Manfred, non si può veramente dire nulla, possiamo solo contemplarne l’arte come si può fare per le opere dei più grandi artisti, possiamo solo bearci, noi umili lettori, del suono delle sue parole come si può fare solo per le melodie dei più grandi compositori, possiamo solo inorgoglirci, noi uomini, di appartenere al suo stesso genere, il genere umano, come solo si può fare per le gesta di coloro che, grazie ad un intelletto, una sensibilità, una forza, una conoscenza e una coscienza purissime, hanno ridefinito e ricreato il concetto di umanità. Un umanità più ricca, consapevole ed evoluta.
Indicazioni utili
Eccessivamente disincantato
Un intervista lunga più di trent'anni creata ad hoc ad esclusivo uso e consumo degli Alleniani, o dei cinefili più incalliti. Considerare quest'opera come una semplice biografia su uno dei registi e autori più acclamati della storia moderna del cinema sarebbe però un errore, grazie infatti all'abilità di Eric Lax, non nuovo a questo genere di lavori, il libro ci regala un vero e proprio spaccato della vita quotidiana del regista/attore, un assaggio della sua reale personalità e un affascinante evoluzione del suo cinema dagli albori, quando stentava ad affermarsi agli occhi della critica, fino ai suoi più recenti successi. Purtroppo il risultato finale non è così accattivante come la confezione inizialmente lascerebbe pensare: se per buona parte è Woody Allen, e l'interesse che suscita il suo personaggio, a tenere in piedi l’opera, è sempre Woody Allen ad affossarla irrimediabilmente. Scordiamoci leggendo il libro di trovare la verve da slapstick e la vis comica della macchietta interpretata nei suoi film, schivo e timido per natura infatti, come lo stesso Lax premette inizialmente a mo di attenuante, il regista non entra mai fino alle ultime pagine sul piano personale, limitandosi a dare una cronaca colorata (per altro godibilissima) dei giorni trascorsi a creare film. Sarebbe stato più interessante un excursus sul pensiero del film maker e sulla filosofia che sottende ai suoi film, invece lungo tutte le 600 e più pagine del libro si fa sempre riferimento, alle suo opere senza considerare che il consumo principale di un film si ottiene nel momento che lo si guarda con il proprio occhio critico. Il dialogo incentrato sulla filmografia di Allen diventa dunque a tratti ridondante e procede fino alla fine tautologicamente piatto risollevandosi solo nelle ultime pagine quando Woody lancia due meravigliose battute (riportate anche in copertina e quindi rovinate!) che lo reinseriscono in quel suo tipico personaggio che lui per tutta la durata del libro sostiene non abbia nulla a che vedere con il suo vero io, peccato.
Indicazioni utili
La sceneggiatura di un film a basso budget
Un incipit tarantiniano e un prologo a specchi riflessi che più che sorprendere stufa e infastidisce fanno da margine e contorno a una storia troppo bislacca e strampalata per essere appena vagamente credibile. Una storia che anche se all’inizio è accattivante presto perde la sua verve cedendo il passo ad una escalation d’azione degna di un Mission Impossible di quarta categoria con gli effetti speciali di un Matrix a basso budget.
I paralleli cinematografici non sono casuali, questo testo sembra davvero la sceneggiatura di un film, una sceneggiatura che scopiazza senza ritegno da diverse pellicole cult talmente famose e note da essere ormai entrate nell’immaginario collettivo persino di coloro che non hanno mai messo piede in una sala di proiezione; e conferma di ciò si trova anche in quelli che non sono gli aspetti più prettamente scenografici del romanzo, come l’introspezione psicologica dei protagonisti, qui relegata al rimorso Darth Vaderiano di una sorella “cattiva” nei confronti del fratello più piccolo, o come la presunta analisi sociale, che la critica vorrebbe trovare ad ogni costo nel lavoro di Ruff, ma che qui in realtà fa perno esclusivamente sulle manie paranoiche e complottistiche, ormai si spera fuori moda, di certi ambienti creduloni della società americana di inizio millennio. Assurdo, ridondante, eccessivo e tutto a scapito dello stile narrativo, a scapito di uno stile a cavallo tra il farsesco e il pulp che probabilmente rappresenta l’unico aspetto positivo dell’opera.
Si dice che l’autore sia il degno erede di Pynchon e Philip K. Dick, se così è, se Matt Ruff davvero è destinato a diventare l’erede dei due grandi scrittori, be allora ne deve fare ancora di strada: ci sono accenni, rimandi, omaggi alle sue fonti di ispirazione, sì ci sono, ma è tutto molto confuso, disordinato o al contrario, lampante, ovvio e dunque banale.
Forse Ruff, in questo romanzo, in realtà più Dickiano che Pynchoniano, può ricordare qua e la il genio incompreso della fantascienza, ma certo non per inventiva, o per acuità di sguardo nei confronti della società, tutt’al più per certe fumose associazioni mentali, e per i già citati “omaggi fin troppo evidenti” che l’autore rende ai suoi modelli ispiratori, vedasi per esempio Buster Friendly, il più semplice di tutti: il poliziotto che arresta la protagonista che porta lo stesso nome del anchor man di “Ma gli androidi sognano pecore elettriche.”
Banali e fumose le prime, squilibrati e ridondanti i secondi, e il passo tra l’arguto, un po’ nostalgico, apprezzamento e la scopiazzatura diventa via via più breve: se l’omaggio è uno va bene, quando sono due o tre si incomincia a storcere il naso, quando sono tanti si chiama mancanza di inventiva.
Leggendo Bad Monkeys pare davvero di trovarsi di fronte a delle rivisitazioni di celebri scritti o produzioni cinematografiche, rivisitazioni di storie e pellicole che hanno reso celebre il noir, la fantascienza e l’action drama negli ultimi trent’anni, ma se all’inizio sono simpatiche, dopo qualche pagina diventano noiose e superflue. Vero, le rivisitazioni qui hanno un enviroment differente, delle circostanze diverse, qui sono create attorno ad una realtà urbana più allucinata e meno fantascientifica di quella da cui spesso attingono, ma proprio per questo anche meno concreta e senza dubbio meno incisiva.
A lasciarsi influenzare da illazioni che sorgono spontanee, a voler leggere tra le righe di un testo che promette profondità ma cela dietro stranianti prospettive tridimensionali nient’altro che piattume, si potrebbe evocare una sorta di assuefazione di Ruff a una certa tipologia di storie, film e scenografie, dalle quali poi non riesce a prescindere, dalla cui impressione non riesce a liberarsi se non sfogandola con frasi altrettanto impregnate di quella assurda realtà parallela. Ma se su pellicola le immagini crepuscolarmente fantascientifiche di un Matrix hanno un grande impatto visivo su chiunque sia disposto ad accettare un mondo alternativo, o una concezione della vita a scatole cinesi, sulla carta stampata le medesime immagini, non supportate da un elaborato intreccio narrativo, non hanno la stessa efficacia.
Se l’autore voleva creare un libro assurdo, cervellotico, onirico, alla Pynchon, doveva avere coraggio e andare fino in fondo, se voleva creare un noir reale e crudo doveva fare altrettanto, tentando invece, come fa lui, di mantenersi in bilico tra i due stili, ottiene soltanto un’ opaca rilettura di una realtà impossibile, quanto incredibile, quanto poco affascinante.
Certo l’ironia di fondo aiuta, ed è innegabile che, vuoi per l’oggettiva brevità del romanzo, vuoi per la, speriamo, ricercata leggerezza della prosa, la lettura sia molto scorrevole e il libro si legga in quattro e quattr’otto, ma da qui a definire l’autore come l’erede del post realismo americano, il figlio della grande scuola di romanzieri made in usa, come qualcuno sostiene,… be ce ne corre
Indicazioni utili
Prima opera?
Un po’ stupidino, un po’ sempliciotto, alle volte eccessivamente manieristico, altre decisamente troppo affettato, nel Segno della Pecora risente di tutti i dubbi, le incertezze e i problemi delle prime opere, (in realtà Murakami ne aveva già scritte altre due ma questa è quella che gli valse la notorietà e i premi come autore emergente) e, per quanto nel testo vi siano inconfutabili indizi della sua abilità narrativa, è evidente che lo stile è ancora grezzo e le opere migliori sono ancora la da venire.
Nella narrazione traspaiono, si intuiscono, già tutti i temi cari all’autore: il surrealismo, l’onirismo, il mondo della percezione e delle sensazioni, l’autocritica, il viaggio nella coscienza dei personaggi, e si respirano già anche le suadenti atmosfere da fantasy urbano, da noir fiabesco (le ultime qui addirittura più accentuate, più affascinanti forse, che in altri lavori successivi) tuttavia sono confinate alla loro stessa esistenza, quasi fini a se stesse e non complementari alla trama, scritte e descritte, cioè, non tanto per aiutare il lettore a creare un quadro di insieme un substrato, psicologico sui cui far evolvere il racconto, ma soltanto perché… è così che si fa, perché fa effetto, perché è così che fanno gli scrittori veri.
E’ questo il fondamentale problema di “Nel segno della pecora”, che si percepisce fin troppo chiaramente che Murakami, qui ancora giovane, anela a diventare uno scrittore vero e per essere riconosciuto come tale è pronto ad andare per la sua strada senza guardare in faccia nessuno anche a costo però di peccare di eccessivo manierismo: l’ironia costruita sul bisogno di ribadirsi anticonvenzionale diventa pesante, lo stesso la riflessione personale che sfiora la pedanteria, lo stesso le ambientazioni che nelle loro descrizioni (per carità, efficacissime) non riescono comunque a sottrarsi alla romantica banalità dei luoghi comuni.
Si potrebbe anche chiudere un occhio di fronte a questi piccoli difetti, focalizzandosi sull’ottimo stile di Murakami semplice e pulito, seppur come già detto ancor grezzo, ma è impossibile lasciar correre sulla faciloneria con cui sembra introdurre argomenti profondi e la fretta con cui sembra poi abbandonarli; l’autore infatti durante la narrazione presenta innumerevoli spunti di riflessione ma in quattro e quattr’otto poi li sommerge nascondendoli in zone oscure del subconscio dei protagonisti, relegandoli agli inspiegabili misteri della mente umana, o ancor peggio ai misteri del mondo. Troppo facile, troppo scontato!
E vien da pensare che questi accenni disseminati ad arte qua e la nel libro non siano rimandi alla filosofia dell’autore, e vien da pensare che non siano fini suggerimenti che ci inducono ad aprire la mente al cospetto di una realtà sensoriale, transitoria e impalpabile, ma semplicemente dei temi comuni scarsamente approfonditi, scarsamente compresi, e per questo trattati con dozzinale superficialità.
Nel Segno della Pecora, chiariamoci, non è un brutto libro, ma è una sorta di prima opera e come tale pur contenendo in se i semi, anzi i germogli, di quelle che saranno le grandi opere dell’autore da queste si discosta notevolmente per eccessiva fatuità, ingenuità, e talvolta, come s’è visto, fretta.
Un libretto leggero, che si lascia leggere, e anche volentieri ad onor del vero, ma niente di più che una prima opera, proprio niente di più.
Indicazioni utili
Perfetto
Pulito, conciso, profondo, intenso, autentico, forte, delicato, vivo. Il vecchio e il mare è il caposaldo della letteratura moderna, è il romanzo dal quale i lettori di ogni età, più che da ogni altro, dovrebbero attingere quotidianamente; è l’esempio da seguire per tutti i novelli scrittori ed è infine un inossidabile termine di paragone per tutti coloro i quali, compreso il sottoscritto, si prendono la libertà di recensire i lavori letterari altrui.
Non aggiungo altro poiché centinaia di colti ed eruditi critici letterari ne hanno già parlato e dibattuto a profusione nel corso degli anni e poiché a differenza loro (senza ovviamente anche solo ipotizzare di potermi mettere sul loro stesso piano!) sono fermamente convinto che ogni ulteriore istante “sprecato” a recensirlo è in realtà un istante perduto in cui si poteva rileggerlo e scoprirne così un nuovo dettaglio, un nuovo particolare, o semplicemente una nuova sensazione.
Il racconto perfetto.
Indicazioni utili
| 110 risultati - visualizzati 51 - 100 | 1 2 3 |