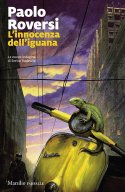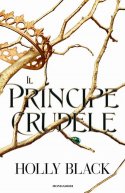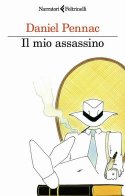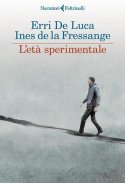Opinione scritta da Renzo Montagnoli
| 1070 risultati - visualizzati 51 - 100 | « 1 2 3 4 5 6 ... 7 22 » |
Che cosa è stata la Resistenza
Nella sua introduzione Sebastiano Vassalli scrive fra l’altro: “L'Agnese va a morire è una delle opere letterarie più limpide e convincenti che siano uscite dall'esperienza storica e umana della Resistenza. Un documento prezioso per far capire che cosa è stata la Resistenza [...]”. Sono d’accordo, tanto più che in copertina, se pur a caratteri ridotti, c’è una frase che ritengo determinante per comprendere la portata di questo libro: “Per non dimenticare che cosa è stata la Resistenza”. Sì, perché al di là della purtroppo ricorrente retorica con cui ai giorni nostri viene commemorato questo vasto movimento di popolo i giovani non sanno che cosa sia stata la Resistenza e, francamente occorre ammetterlo, questa lacuna è spesso presente non solo nella precedente generazione, peraltro nata nell’immediato dopo guerra, ma anche chi per età anagrafica è stato testimone della stessa. E così libri come “La messa dell’uomo disarmato” di Luisito Bianchi e questo L’Agnese va a morire di Renata Viganò, rappresentano due scrigni preziosi il cui contenuto è da assaporare con lentezza, quasi centellinandolo, ma alla fine le idee saranno più chiare e sarà possibile comprendere veramente ciò che è stata e ciò che ha rappresentato la Resistenza. Agnese, un’umile lavandaia, che lavora anche per il marito Palita, impossibilitato a sostenere il lavoro dei campi in quanto di salute cagionevole, è un essere umano, anche poco istruito, ma che è in grado di comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male, per puro istinto. Indifferente alla guerra, all’occupazione tedesca, quando i nazisti le strapperanno il marito, comunista, per avviarlo al lager (morirà nel corso del viaggio) si trasforma e adesso che sa da che parte sta il bene e da che parte sta il male inizierà a sconvolgere la sua esistenza nella consapevolezza di essere nel giusto. Non è un’idea politica che la guida, è molto di più, è la ribellione della sua coscienza che le impone di dedicarsi anima e corpo alla lotta partigiana, che la porta a considerare quei ragazzi che così tanto rischiano come i figli che non ha mai avuto; il suo istinto, al riguardo, è come quello del contadino che sa quando è l’ora di procedere all’aratura o di seminare. Massiccia, con il cuore affaticato, Agnese è uno di quei personaggi che incontrati per strada paiono insignificanti, ma che conosciuti bene si rivelano straordinari, gente che non esita a sacrificarsi per qualcosa che sentono molto al di sopra di loro. La sua morte non ha nulla di eroico (di lei rimane solo un mucchio di stracci neri sulla neve), non si è immolata in un’azione disperata, non ci saranno medaglie alla memoria, eppure quella morte vale più di una battaglia vinta, perché in quella conclusione a cui eravamo preparati c’è tutto lo spirito di sacrificio di una donna che ha anteposto la libertà alla sua vita.
L’Agnese va a morire è semplicemente un romanzo stupendo che resta nel cuore.
Indicazioni utili
Per l’amore si può vivere
Ultimo romanzo della trilogia dedicata alla prima guerra mondiale (il primo, Niente di nuovo sul fronte occidentale, è un capolavoro assoluto e si svolge al fronte, il secondo, La via del ritorno, è una grande opera che parla del ritorno a casa dei reduci e del loro difficile reinserimento), Tre camerati si svolge in un’epoca già lontana dagli anni del conflitto, all’incirca alla fine degli anni ‘20, un periodo turbolento e di grande crisi per la Germania, in cui cominciano a prendere sempre più piede i nazisti. L’inflazione è spaventosa, la disoccupazione cresce quasi in modo esponenziale, e poi ci sono i disordini quotidiani, alimentati soprattutto dai seguaci di un ometto dall’apparenza insignificante, un reduce pure lui, pittore fallito, che di nome fa Adolf Hitler. In questo contesto tre amici, scampati alla guerra sul fronte occidentale, riescono a campare con la gestione di un’autofficina; a prima vista sembra un trio felice, di compagni bevitori e pronti agli scherzi, ma sotto sotto si scopre che indossano una maschera di cinismo, per cercare di nascondere, nell’impossibilità di cancellarli, i segni lasciati dalla terribile esperienza in guerra. Si chiamano Otto, Goffredo e Roberto, Roby per gli amici, e quest’ultimo finisce con il diventare il protagonista principale. Solo, senza un’idea del futuro, conosce casualmente una ragazza e il suo mondo di grigiore e di cinismo si rischiara di una nuova luce. Quell’amore ricambiato infonde in Roby fiducia nella vita, gli prospetta quel futuro che nemmeno si sarebbe sognato, ma se l’amore è qualcosa per cui si può vivere, tanto più lancinante è perdere la persona amata. E’ forse dei tre il romanzo più disperato, perché non c’è di peggio che trovare un’ancora di salvezza, uno sbocco concreto alla propria esistenza, e poi vedere sfumare tutto. Per quanto bello, lo strazio che percorre non poche pagine dell’opera finisce con il provocare l’accostamento con i giorni di trincea di Niente di nuovo sul fronte occidentale, con l’anormalità di tante morti di giovani che ancora non si erano affacciati alla vita, e la normalità invece di un decesso per cause naturali. Non dico che Remarque abbia pigiato sull’acceleratore per portare a una forte commozione, ma senz’altro la sua partecipazione al romanzo mi pare qui assai più presente che in altri casi. Bello è bello, non ci piove, ma, sempre secondo me, non raggiunge l’elevata valutazione dei primi due della trilogia. Forse i tempi diversi, l’omologazione ormai definitiva dell’orrore del grande conflitto hanno inciso sulla creatività dell’autore, del resto ormai proteso a rappresentare, in un secondo ciclo di opere, l’immane tragedia del periodo nazista, con la nuova guerra mondiale e le atrocità dell’olocausto.
Indicazioni utili
Creatività al massimo
Ambientato nella seconda metà del XV secolo La baronessa dell’Olivento è ancora una volta l’occasione per dare libero sfogo all’innata corposa creatività dell’autore. Un romanzo d’avventure si potrebbe definire, ma anche un’opera che strizza l’occhio all’epico Orlando furioso, visti i toni ariosteschi e le situazioni profuse in questo suo lavoro da Raffaele Nigro. I due protagonisti sono essi stessi emblemi di un’epoca e di una certa letteratura che vede negli estremi i soggetti adatti a rappresentare una trama, spesso aggrovigliata, ai limiti quasi del parossismo; abbiamo così la storia dei due fratelli Brentano, Stanislao e Vlaika, governatori del castello di Lagopesole edificato da Federico II di Svevia; Stanislao è un cavaliere più desideroso della pace che della guerra, e sua sorella Vlaika è una disabile, che vive in una cesta, perché è nata priva degli arti, inferma di corpo quindi, ma non di mente. In breve ci troviamo di fronte a una saga familiare, ambientata in Schiavonia, in Albania, in Campania, in Basilicata e in Puglia, le zone percorse dai nostri protagonisti in un crescendo di battaglie, di amori, di conflitti non solo politici, ma anche intellettuali, con gli scontri fra cristiani e turchi, le ribellioni dei baroni del Regno di Napoli, le dispute, non sempre pacate, fra platonici e aristotelici, ma soprattutto fra scienziati ed ecclesiastici, con l’Inquisizione che non si limita a guardare. Insomma, Nigro ha messo tanta carne al fuoco, ha scritturato tanti personaggi storici come Scanderbeg, Murad Han, il principe Caracciolo, Ferrante e Alfonso d’Aragona, in un intreccio spumeggiante che se da un lato affascina il lettore, dall’altro lo porta a un certo disorientamento perché tanta è la commistione fra realtà e fantasia che alla fine diventa difficile capire ciò che è storia e ciò che è inventiva. In questo senso La baronessa dell’Olivento mi pare meno riuscito di Santa Maria delle Battaglie, dove è presente un maggiore equilibrio strutturale e c’è più linearità nella narrazione; senza voler andare a cercare a tutti i costi il pelo nell’uovo direi che ciò che nuoce a questo romanzo è proprio l’eccesso di creatività, come se l’autore, immedesimatosi nei panni di Ludovico Ariosto, avesse voluto creare, relativamente a un’epoca successiva, un dramma antico scritto con gli occhi rivolti ai nostri tempi, un’opera senza tempo quindi, ma credo che, se questa era la sua intenzione, non abbia raggiunto lo scopo.
Da leggere, comunque.
Indicazioni utili
La verità negata
Che in epoca fascista sia stata stesa una pesante coltre sulle nostre operazioni coloniali in Etiopia e in particolare sull’uso, non sporadico, che si fece dei gas asfissianti e urticanti è comprensibile, anche se ovviamente non giustificabile; che poi nel dopo guerra, quindi in periodo repubblicano, ci sia stato un netto ostracismo per quanto concerne appunto la questione del nostro ricorso a queste armi, messe al bando nella Convenzione di Ginevra, peraltro da noi sottoscritta, appare del tutto illogico; approfondendo l’argomento, si viene fin da quasi subito a scoprire che questa atroce verità cozzerebbe con l’immagine, che ci siamo attribuiti, di italiani sempre brava gente e della vulgata secondo la quale in occasione delle guerre coloniali adottammo in ogni circostanza un comportamento umano, perfino quasi amichevole. E’ vero che in alcuni teatri di guerra ci comportammo in modo civile e onorevole, ma è altrettanto vero che in altri fummo dei massacratori, né più né meno dei famigerati tedeschi. In questo contesto trova quindi una spiegazione il comportamento tenuto a livello governativo e militare nei confronti dello storico Angelo Del Boca, che pur in possesso di scarse e scarne notizie che parlavano dell’uso da parte nostra dei gas chiedeva invano con insistenza e a gran voce che fosse possibile accedere ad archivi altrimenti riservati. Nonostante l’evidente ostracismo, le minacce, la chiusura netta, poco a poco si alzò questo pesante velo di omertà e così non solo trovò conferma il nostro metodico utilizzo di iprite e di fosgene, oltre che di arsina, ma anche la preponderanza di tali mezzi di distruzione in una guerra che, almeno sulla carta, avremmo dovuto vincere nel giro massimo di un mese. Questo saggio storico, a cui hanno contribuito, oltre ad Angelo Del Boca, Giorgio Rochat, Ferdinando Pedriali e Roberto Gentili, è frutto di un articolato e complesso lavoro svolto negli archivi militari, ricerche che, pur nella loro incompletezza, hanno evidenziato una precisa volontà di Mussolini di arrivare alla vittoria con qualsiasi mezzo, ivi compresi i gas, di cui, in più di un telegramma, di volta in volta autorizzò l’uso a Badoglio quando questi, motu proprio, già li aveva impiegati in battaglia. Sebbene il ricorso a tali armi fosse coperto da segreto, la loro diffusione, soprattutto nel bombardamento aereo, era tale che non pochi dovevano esserne a conoscenza; fra chi ignorava c’è anche il famoso storico e giornalista Indro Montanelli che avviò una querelle pesantissima nei confronti di Angelo Del Boca, un conflitto durato anni, fino a quando il giornalista toscano si convinse e decise di smettere, riconoscendo la validità delle asserzioni sull’impiego dei gas e adducendo la scusa che quando lui era là al fronte non ne aveva mai avuto sentore.
Le pagine di questo saggio, a volte poco avvincenti nella cruda elencazione delle azioni condotte con queste armi, del loro quantitativo impiegato, distinte per tipologia, è in grado però di offrire un quadro d’insieme tale da poter smentire più d’uno che, messo alle strette, ne ammettesse un uso esclusivamente sporadico (e infatti ci fu chi ebbe questa infelice idea).
Si tratta di ben altro, quindi, della semplice contestazione della diversità del nostro colonialismo, intriso di tolleranza, di umanità, e che è servito a rimuovere il senso di colpa; praticammo invece scientemente una guerra di sterminio nei confronti di esseri umani che il regime, e non pochi italiani, consideravano inferiori, bestie o anche peggio.
Il saggio è pertanto da leggere, perché solo avendo una esatta e completa conoscenza del nostro passato possiamo sperare di costruire un futuro migliore.
Indicazioni utili
Prima che la memoria si cancelli
Come assai opportunamente l’autore precisa in una sua introduzione all’opera la stessa è stata concepita come un esercizio per le vacanze trascorse nell’estate del 1916 nella casetta sul Monte Amiata. L’età, che inevitabilmente trasforma e storpia anche la memoria, con l’aggiunta della sopravvenuta cecità, fanno sì che questi ricordi messi giù come racconto costituiscano per Camilleri soprattutto un punto fermo e cioè abbiano lo scopo di evitare le assai probabili future dimenticanze. Al lettore queste prose possono far pensare, giustamente, a una sorta di autobiografia non consequenziale, cioè a un insieme di episodi che possono far sapere qualcosa di più sul trascorso dell’autore. Preciso subito che non si racconta di eventi eclatanti, anzi, tranne pochi casi, di tratta di fatti che sconcertano nella loro banalità e che possono essere riferiti anche a vite di altre persone. Chi si aspettasse un Camilleri segreto, una figura dal passato epico, è meglio che si metta l’animo in pace, perché Camilleri è un comune mortale. Ciò non toglie che, nella sua non certo corta vita che ha attraversato un periodo storico memorabile per l’Italia, ci siano stati episodi che, almeno a puro titolo di curiosità, possono interessare, quali, per esempio, la storia quasi kafkiana delle ceneri di Pirandello, o la vicenda dell’ingegnere che in periodo bellico si diletta a costruire aquiloni con i quali intende bombardare Malta, per non dimenticare poi l’incontro con i briganti della banda del famigerato Salvatore Giuliano, oppure la fallita intervista a Luciano Liggio. L’episodio migliore, però, almeno secondo me, è il colloquio con Eduardo De Filippo sulla sua isola nel golfo di Napoli. Meno interessanti e, a parer mio, addirittura noiose sono le prose ove si racconta di incontri con artisti del mondo delle lettere e dello spettacolo. Forse per l’autore hanno un’importanza tutta particolare che invece non riesce a cogliere chi vive fuori da quel mondo. Nel complesso, benché fra alti e bassi, la lettura è abbastanza interessante, ma non rivela nulla di più di Camilleri di quanto già conosciamo.
Indicazioni utili
Deus lo volt
L’autore si è premurato di stilare una Nota per il lettore che, anziché essere riportata inizio dell’opera, si trova inspiegabilmente alla fine della stessa, un’allocazione che impedisce a chi si accinge a iniziare la lettura di comprendere di cosa si parlerà. Per brevità ne riporto uno stralcio.”La chiave di questo libro sta in un documento. Non si tratta della solita invenzione letteraria, il manoscritto dell’anonimo cui si sono in tempi diversi riferiti Chrétien de Troyes, Alessandro Manzoni e Umberto Eco. No. Qui il documento è autentico, e conservato nell’Archivio di Stato di Firenze. Parla di un viaggio alla fine dell’XI secolo – la prima crociata? - compiuto verso la Terrasanta dal conte Guido, antenato di quella gran dinastia dei Guidi di Casentino che avrebbe offerto, due secoli dopo, generosa ospitalità a Dante. Conosciamo anche il nome di un accompagnatore del conte alla crociata: Rimondino di Donnuccio. Solo un nome, nient’altro”. Ora, un narratore che avesse per le mani una simile opportunità finirebbe inevitabilmente per dare spazio alla migliore e più ampia fantasia, dando vita a un romanzo epico, magari avvincente, anche se poco credibile, impregnato di tutti gli stereotipi propri delle guerre in nome della religione. Cardini, però, è innanzitutto uno storico che insegna all’Università di Firenze, abituato a cercare di avvicinarsi il più possibile alla verità, lasciando poco spazio all’inventiva e allora ha pensato di utilizzare lo spunto del manoscritto in una chiave del tutto diversa, volta a erudirci sulla storia in modo piacevole, e così anziché scrivere un saggio storico, oppure un romanzo storico, ha di fatto confezionato un riuscitissimo romanzo fedele alla storia. Le lotte nel papato, con la contemporanea presenza di due pontefici, le torme di pellegrini che anelano di recarsi a Gerusalemme, irretiti dalle predicazioni di Pietro l’Eremita (quello famoso per il suo motto Deus lo volt, cioè Dio lo vuole), i signori, con i loro armati, mossi, tranne pochi casi, più dal desidero di conquista che da un autentico spirito religioso, il lungo viaggio da Clermont Ferrand, attraverso l’Italia, l’imbarco a Bari e a Brindisi, dopo la sosta a Roma, l’incontro con l’imperatore bizantino Alessio I Comneno, il passaggio in Anatolia, le mille battaglie per andare avanti, i sotterfugi, i tradimenti,le violenze e il sangue profuso si snodano nelle numerose pagine del libro, dandoci una miriade di notizie, relative anche a come si viveva in una certa epoca e in determinati luoghi, insomma per farla breve L’avventura di un povero crociato è una miniera di informazioni che si assimilano facilmente avvinti dagli eventi che si susseguono.
La figura dell’accompagnatore del conte Guido, cioè Rimondino di Donnuccio, è una presenza non ingombrante, ma essenziale all’opera. E’ con abilità che l’autore ci tratteggia questo giovane suddito, circondandolo anche di un alone di mistero a tutto beneficio della narrazione. Con Rimondino il romanzo inizia e con lui finisce; è un personaggio a suo modo semplice e complesso, un testimone imparziale di un grande evento quale fu quella prima crociata. Sappiamo anche che era luparo, cioè di professione cacciatore di lupi, e illibato fino a Bari, ove, prima di imbarcarsi, ebbe una prima esperienza sessuale; di poche parole, osservava e registrava, imparava ascoltando e vedendo; invecchiò precocemente per gli stenti e i tormenti delle battaglie, un uomo alla fine consapevole di aver vissuto l’avventura più grande della sua vita, quella che di per se stessa sintetizza un’esistenza, tanto che dopo tutto apparirà diverso, grigio e senza stimoli. Le ultime pagine sono dedicate a lui e sono di sublime bellezza.
Da leggere? Certamente, perché si tratta di un’opera stupenda.
Indicazioni utili
Una donna emancipata
Dopo alcune letture poco interessanti, o addirittura insoddisfacenti, ho deciso in questo ultimo scorcio di estate di andare sul sicuro, cioè di affidarmi a un’opera di un autore di comprovata capacità, e allora, per non voler andare troppo indietro nel tempo, per non affidarmi a un classico, ho pensato bene che un narratore come Fulvio Tomizza facesse al caso mio. La scelta non è stata facile, perché della sua produzione ho letto quasi tutto e mi resta ben poco per completare la conoscenza di uno scrittore di indubbie elevate qualità. Fra quel poco ho puntato su L’ereditiera veneziana, che Tomizza ha ricavato da un raro libro di Gianrinaldo Carli (economista, poligrafo, istriano di ampia cultura) imperniato sull’affascinante moglie Paolina, morta assai giovane, a soli venticinque anni. L’epoca è il XVIII secolo, l’ambientazione è nella città di Venezia, ben lontana dall’Istria così cara all’autore, ma pur sempre nel Veneto e per di più con il fatto che il marito è originario degli stessi luoghi dell’autore. Dico subito che le aspettative in parte sono andate deluse, restando comunque un’opera meritevole di essere letta. Questo approccio di Tomizza con un’epoca e un luogo che sono lontani dalle trame e ambientazioni dei suoi romanzi, per di più partendo dal libro di un altro autore, lo lasciano indeciso fra lo scrivere una biografia e un romanzo, tanto che finisce con il mescolare i due generi, senza però arrivare ad apprezzabili risultati. Aggiungo che non è improbabile che nell’autore istriano sia sorta una specie di finalità sociologica, visto che in una Venezia settecentesca, tollerante, ma anche perbenista, conservatrice, ma non chiusa a nuove idee, il fatto che la giovane donna con intelligenza e perseveranza riesca a costruire il destino della sua famiglia è un chiaro richiamo alla parità dei sessi, all’epoca probabilmente al massimo ipotizzabile in qualche mente particolarmente aperta. Paolina, donna energica, pratica, non mascolina, anzi molto femminile, sembra quasi una figura di fantasia, ma sappiamo che era proprio così; semmai ciò che si può imputare a Tomizza è di non essere riuscito a trasmetterci con imparzialità le sue caratteristiche, mentre invece ne risulta soggiogato e quindi si avvertono tutte le sue trepidazioni, forse anche qualche eccesso, che finiscono con idealizzare il personaggio, una mitizzazione che pesa un po’ su un’opera che non è certo fra le migliori di Tomizza, ma che è tutt’altro che disprezzabile. Del resto, questo alternarsi di rigore e partecipazione è frutto dell’incertezza dell’autore che, come ho sopra riportato, appare titubante nel decidere se dare all’opera una chiara impronta storico-biografica, oppure quelle caratteristiche proprie della narrativa.
Non è forse il libro che mi aspettavo di leggere, ma comunque è pur sempre un’opera intrigante, che induce anche a riflessioni di non poco conto e di ciò deve essere dato pertanto ampio merito a Tomizza.
Indicazioni utili
Una vita da migranti irregolari
Negli anni che di poco precedono lo scoppio della seconda guerra mondiale una variegata umanità è alla disperata ricerca di un luogo in cui sostare, liberi e senza timori; respinti da ogni paese, vivono quasi sulle frontiere gli ebrei tedeschi e gli oppositori del regime nazista, di volta in volta espulsi da Cecoslovacchia, Austria, Svizzera e Francia e sempre pronti a ripassare i confini degli stati, impauriti, impoveriti e privi di speranza, in una sorta di girone infernale. E’ di questi che parla Ama il prossimo tuo e in particolare di Kern, mezzo ariano e mezzo ebreo, di Ruth, solo ebrea, e di Steiner, un antinazista. Cacciati senza documenti dalla Germania non fanno altro che passare da Stato a Stato alla vana ricerca di un visto di soggiorno e di un permesso di lavoro; sopravvivono con il poco che hanno, si adattano ai lavori più umili e ognuno ha lasciato qualcosa in Germania, un familiare, un amico, il ricordo di tempi migliori. Kern e Ruth sono molto giovani e diventano amanti, un tenero e dolce amore che riesce a far apparire l’esistenza meno grama, Steiner, che è più anziano e che ha dovuto lasciare in patria l’amata moglie, uomo navigato e d’esperienza diventa il padre putativo di loro due. Le vicende della vita ogni tanto li allontanano, li separano, ma poi finiranno sempre con il ricongiungersi, come una famiglia i cui componenti, fuori casa per motivi di lavoro, si ritrovano la sera. Sono momenti di autentica gioia quando si rivedono e sempre Steiner stende le sue ali protettrici su quei due ragazzi, su quei compagni di sventura che ha entusiasticamente adottato. Dentro e fuori dalle prigioni dei vari stati i periodi di detenzione sono l’occasione per conoscere altri sventurati come loro, ognuno con una sua storia ben definita; sarà tuttavia a Parigi, in una Parigi fervente di lavoro per l’Esposizione Universale che finiranno tutti quasi per darsi appuntamento e sarà così l’occasione per fare conoscenza di altri personaggi, come Moriz Rosenthal, per tutti Papà Moritz, anziano e malato, il simbolo dell’ebreo errante. Si vive alla giornata, qualche volta c’è anche un po’ di allegria, ma più spesso regna la malinconia, per quell’impossibilità di essere cittadini normali, per la condizione di essere migranti eternamente. A volte, però, può capitare che il cielo scenda sulla terra e che avvenga un autentico miracolo e così accade; infatti Kern e Ruth, grazie anche alla disponibilità di Steiner, potranno finalmente andare dove nessuno più li caccerà, una nota di speranza in un romanzo che ancora una volta testimonia le grandi qualità di scrittore di Erich Maria Remarque.
Indicazioni utili
Quattro mediocri racconti
La produzione letteraria di Simenon è, a dir poco colossale, visto che fra romanzi e racconti si parla di circa 500 opere. Con una simile mole di lavori è quindi piuttosto ovvio, prima ancora che probabile, che non tutti siano riusciti bene, che in alcuni non si possano trovare le tradizionale grandi qualità del loro autore. Aggiungo inoltre che Adelphi, impegnata nella pubblicazione dell’intera produzione di Simenon sta cominciando a raschiare il fondo del barile e così può capitare che vengano stampate opere minori che, in taluni casi, francamente non sembrano riuscite. E’ questo il caso di Il fiuto del dottor Jean e altri racconti, quattro prose abbastanza lunghe scritte nel 1938 con i quali l’ideatore del celebre commissario Maigret cerca di dare vita a un nuovo personaggio, ma il tentativo secondo me è fallito, perché questo giovane medico di campagna, che si improvvisa investigatore, arrivando a risolvere casi con il solo intuito, è di modesto spessore, nel senso che non ha carisma, né è in grado di suscitare molte simpatie, tanto più che Simenon ha cercato di usare un tono leggero, quasi frivolo e un po’ scherzoso, caratteristiche che non essendo proprie dell’autore non riesce a trasferire in modo soddisfacente al suo personaggio. Mancano soprattutto quello stile incisivo che tutti riconoscono al narratore belga, quella straordinaria capacità di sondare l’animo umano e di proporre al lettore ambientazioni e atmosfere capaci da sole di avvincere; inoltre, le trame sono un po’ scialbe e le soluzioni piuttosto illogiche.
Non mi sono piaciuti questi quattro racconti che sembrano scritti da un altro Simenon, non quello che ci ha abituato a opere di elevato livello.
Indicazioni utili
L’ultima battaglia di Eustachius von Felben
Iniziata con La Croce perduta, seguita da La battaglia sul lago ghiacciato, la trilogia del cavaliere dell’Ordine Teutonico Eustachius von Felben si conclude con La setta dei mantelli neri. E’ una saga avvincente, ambientata nel XIII secolo, in cui rifulge la figura di questo monaco guerriero alle prese dapprima con i mongoli, poi con i russi di Alexander Nevsky e ora con la rivolta dei già assoggettati e convertiti al cristianesimo Galindi, con l’aggiunta di una terribile setta, quella dei Mantelli neri, che ha la sua base in un’isola di uno dei laghi Masuri, dove uno sciamano compie rituali arcaici e sacrifici umani. Per riassoggettare i Galindi occorre eliminare questa entità del male, impresa ardua, difficilissima, ma se l’incarico di una missione quasi impossibile viene affidato a Eustachius von Felben si può essere certi che i risultati non potranno che essere positivi. Fra battaglie all’ultimo sangue, fughe nella foresta, marce negli acquitrini dei laghi Masuri si sviluppa questa nuova storia che completa e segna l’epilogo appunto della trilogia, perché Eustachius riuscirà nell’impresa, pur restando gravemente ferito, al punto da formulare un voto nel caso di sua sopravvivenza e cioè basta sangue e battaglie, ma l’inderogabile necessità di trascorrere gli ultimi anni di un’esistenza bellicosa nel silenzio e nella preghiera. E dato che che il nostro eroe si salverà, appare ovvio che non ci saranno altri romanzi con lui protagonista. Ce ne duole, perché il personaggio è riuscito, desta simpatia e rispetto, è in grado di esercitare un ascendente non solo sui confratelli, ma anche sul lettore, pagina dopo pagina sempre più avvinto dal protagonista e dalla storia narrata. Guido Cervo ha indubbiamente una grande inventiva, ma non gli difettano altre doti, perché riesce a ricreare perfettamente ambiente e atmosfera e, attento anche ai particolari, affianca a Eustachius figure perfettamente delineate che suscitano immediate simpatie, oppure un vivo sdegno, a seconda che si tratti di amici e alleati, oppure di nemici. Se al romanzo non si può chiedere troppo, perché in presenza di una storia avvincente non c’è molto spazio per contenuti rilevanti, senza che però vi sia banalità e anzi troviamo una generica, ma ferma condanna della guerra, è altrettanto vero che le ore scorrono veloci, come la lettura, senza che ci sia un momento di affaticamento, e che alla fine ci si senta appagati, consapevoli di aver trascorso piacevolmente un po’ del nostro tempo.
Indicazioni utili
Avvincente e di grande qualità
Fa caldo, quel caldo umido opprimente della pianura padana quando mi accingo a iniziare a leggere questo romanzo e subito, già dalle prime pagine, mi trovo in un caldo analogo, asfissiante come può essere quello di un Ferragosto a Milano, quando il cemento dei palazzi e l’asfalto delle strade amplifica la sensazione di mancanza d’aria, quando i miasmi delle fognature si riversano sui marciapiedi, risalgono i muri e penetrano nelle indifese finestre spalancate. Corre l’anno 1972 e nel deposito bagagli della stazione Centrale aleggia un crescente tanfo di putrefazione, tanto che l’impiegato va alla disperata ricerca di quello che ipotizza essere un topo da chiavica morto, ma quella puzza nauseante proviene da una valigia che, una volta aperta, rivela un cadavere a pezzi. Chi sarà mai la vittima, chi sarà l’assassino? Il caso viene affidato al giovane vice ispettore Cavallo, con poca esperienza, ma tanta buona volontà e soprattutto un gran desiderio di giustizia. Nonostante tutto resterà un delitto insoluto fino a quando, una trentina di anni dopo, il vice ispettore, diventato nel frattempo commissario, un uomo disilluso dalla vita, coglie nella vice ispettrice Valeria Salemi, da poco arrivata, quella determinazione e quella volontà di sapere che lo avevano animato quando lui era alle prime armi. Con il suo aiuto verrà a capo di quell’omicidio irrisolto, il cui colpevole non finirà dietro le sbarre perché morirà per un attacco cardiaco. Si conclude così uno dei più bei gialli che mi sia capitato di leggere e se giungere alla soluzione ha costituito per me una vera e propria attrazione pur tuttavia ha comportato anche un certo dispiacere, perché quando un libro è scritto bene, quando è ricco di contenuti e riesce a far immedesimare il lettore in qualcuno dei suoi protagonisti non può essere che un’opera di notevole pregio. Arrivati all’ultima pagina e chiudere il libro se da un lato è motivo di soddisfazione per la certezza di aver letto qualcosa di valore, dall’altro è causa di un certo dispiacere, perché allontanarsi da una certa atmosfera, non essere più accanto a protagonisti come Cavallo, ci rende inevitabilmente esangui, come se fossimo privati di colpo di uno dei non certo molti piaceri della nostra vita. Per quanto concerne la trama che si sviluppa in un arco di tempo che addirittura va dagli ultimi anni di guerra all’inizio del secolo corrente non intendo aggiungere altro, sia perché fitta come è di eventi correrei il rischio di disorientare il lettore, sia soprattutto perché non intendo togliere il piacere della scoperta. Fra l’altro questo è uno dei rari libri in cui è difficile trovare un difetto, tanti sono i pregi, a cominciare dallo stile, dall’impostazione della struttura, alla capacità di ricreare con poche misurate parole ambiente e atmosfera, nonché l’indubbia abilità nel sondare l’animo umano, nello scavare nei personaggi, rivoltandoli come un guanto. Il nome del padre, pertanto, non è solo un romanzo riuscito, ma è in grado di andare oltre la tipicità del genere, in perfetto equilibrio fra suspense e indagine intimistica, tanto da poterlo considerare, almeno da parte mia, un vero e proprio capolavoro.
Indicazioni utili
C’è Lucas, ma non Maigret
Pare incredibile, ma in questo romanzo c’è un’indagine del Quai des Orfèvres che non è condotta da Maigret, ma dai suoi ben noti aiutanti, Lucas in primis. Probabilmente Simenon ha voluto concedere un indispensabile periodo di riposo al suo ben noto commissario e si è inventato questo giallo che, prima ancora di stupire per l’assenza di colui che ha costituito un’autentica fortuna per il suo creatore, si presenta come un frizzante gioco a incastri con un personaggio del tutto particolare e, a suo modo, simpatico. Sì, perché quel vagabondo sempre in movimento trascinando una gamba e che è conosciuto con il nomignolo di “Sorcio” è un individuo che, per quanto respinto ai limiti della società, ha una personalità che non può che renderlo interessante. Gli altri protagonisti del corpo di polizia ci sono ben noti, dall’ora commissario Lucas a quel testone di Lorgnon e quindi la novità è rappresentata appunto dal Sorcio che nel suo peregrinare e mendicare si imbatte in un portafoglio ben fornito, con una somma tale da costituire una garanzia per un’agiata vecchiaia. L’averlo rinvenuto sembrerebbe quindi una fortuna se non ci fosse un piccolo particolare e cioè che accanto a quell’oggetto così prezioso c’era un cadavere, anzi un morto ammazzato. Il Sorcio non si perde d’animo e mette in atto un piano assai articolato in base al quale quella somma che ora porta alla polizia, senza ovviamente far menzione del cadavere, da lì a un anno ritornerebbe nelle sue mani. Inizia così una storia ricca di colpi di scienza, di ipotesi che nascono nella mente del lettore e che vengono puntualmente disattese, una vicenda che sale agli ultimi piani dell’alta finanza per scendere anche ai bassifondi della città, in un susseguirsi di sorprese che riescono a mantenere alta la tensione, almeno fino alla soluzione finale, non campata in aria, ma, secondo me, non all’altezza dell’intrigo impostato. Comunque il divertimento è assicurato e quindi la lettura è senz’altro consigliata.
Indicazioni utili
La disfatta dei Teutoni
Secondo romanzo della trilogia dedicata al cavaliere dell’Ordine Teutonico Eustachius Karl Ludvig von Felben, La battaglia sul lago ghiacciato vede questa volta lo scontro non fra religioni diverse, ma fra cristiani cattolici e cristiani ortodossi. Il movente religioso, vale a dire la guerra agli scismatici russi per riportali nell’alveo della Chiesa di Roma è solo l’aspetto ufficiale, perché in realtà si tratta dei soliti giochi di potere e più in particolare di quell’ulteriore espansione a Est che ha sempre animato l’Ordine Teutonico. Stranamente, il protagonista, vale a dire Eustachius, entra in scena a narrazione già avanzata, con il compito di scorta a un diplomatico dell’Ordine nell’intento di stilare la pace con il capo dei Russi, vale a dire con il celebre Aleksandr Jaroslavich Nevskij, principe della Repubblica di Novgorod e da molti di noi ben conosciuto grazie allo stupendo film Aleksandr Nevskij del regista sovietico Ejzenstejn, noto anche per la grandiosa colonna sonora di Sergej Prokof’ev. La pellicola è fra l’altro caratterizzata da una spettacolare battaglia su un lago ghiacciato, nelle cui acque, al rompersi del ghiaccio stesso, finiranno diversi cavalieri teutonici.
Cervo, come al solito ben documentato e fedele fin dove possibile alla realtà storica, intrattiene il lettore con un’opera in cui grande risalto hanno, oltre alle scene di battaglia, anche il panorama invernale, le atmosfere rarefatte, i dubbi che cominciano ad affiorare nel monaco soldato Eustachius, un insieme di aspetti che caratterizzano positivamente il romanzo che ha il suo indubbio punto di forza nella descrizione della battaglia sul lago ghiacciato. Pur essendo un’opera di svago tuttavia certe riflessioni di carattere religioso, taluni dubbi che sorgono nei protagonisti ne fanno anche un romanzo che si propone di porre in evidenza quanto sia ancor più dissennata una guerra per motivi religiosi e come appaia illogico che in nome della cristianità si possano uccidere altri esseri umani. Se il primo della trilogia (La croce perduta) mi aveva avvinto, questo, oltre ad attrarmi, mi ha convinto sulle qualità indubbie dell’autore, che del resto avevo già sperimentato in altre due sue opere di ambientazione storica assai più recente (I ponti della Delizia e Bandiere rosse, aquile nere).
Il mio consiglio, pertanto, è di leggerlo, più che certo che possa risultare di ampio gradimento.
Indicazioni utili
Polveri bagnate per Andrea Vitali
In questo romanzo c’è il Maresciallo dei Reali Carabinieri Maccadò, il che dovrebbe essere una garanzia per un’opera di una certa piacevolezza, ma purtroppo non è così. E pensare che Vitali era partito bene, con il nostro maresciallo in attesa del primo figlio di cui desidera conoscere in anticipo il sesso e allora è tutta una serie di segnali che vengono riportati per arrivare allo scopo, tutti ovviamente privi di fondamento scientifico. Maschio sarà e nella circostanza dei giorni immediatamente successivi alla nascita Maccadò prende un periodo di ferie e la sua quasi latitanza, nonostante la presenza del brigadiere Mannu e dell’appuntato Misfatti, che sono sempre state due garanzie, finisce con l’ammosciare la narrazione, che l’autore cerca di ravvivare con una serie di lettere anonime che intendono denigrare, in termini boccaceschi, Don Sisto Secchia, il coadiutore del prevosto. Inoltre, sempre con il fine di dare fiato a un lavoro che comincia a perdere colpi, Vitali fa accentuare i contrasti fra Mannu e Misfatti, ma commette l’errore di incardinare il romanzo sugli stessi e francamente questa inimicizia finisce con il diventare noiosa, affossando del tutto quanto invece si era proposto di far riemergere. In questo modo l’opera si trascina stancamente, fra uno sbadiglio e l’altro, fino alla fine che, come d’obbligo, vede tutti felici e contenti, compreso il lettore che finalmente si è tolto dallo stomaco un mattone. E’ un peccato, ma quando si scrive tanto, con l’intenzione di far volume e non sostanza, queste cose possono accadere.
Si può leggere Quattro sberle benedette, ma è veramente una gran fatica.
Indicazioni utili
- sì
- no
Così in pace come in guerra
Nel 1931, due anni dopo la pubblicazione di Niente di nuovo sul fronte occidentale, appare in libreria La via del ritorno, il secondo romanzo della trilogia sulla Grande Guerra con cui Erich Maria Remarque si propose di evidenziare l’insensatezza della guerra. Se nel primo, che resta giustamente il più famoso, il teatro sono le trincee sconvolte e insanguinate del fronte occidentale, in questo, dopo un primo piccolo capitolo dedicato agli ultimi giorni del conflitto, si parla invece del dopo, cioè di quanto avviene a ciò che resta di una compagnia (trentadue uomini su un totale originario di cinquecento) nei giorni successivi a quello dell’armistizio, al periodo di pace che li attende. Ma sarà vera pace? Sarà possibile praticare subito una netta cesura fra le ore di tormento del fronte e quelle anonime del proprio paese? Purtroppo questi giovani sono segnati indelebilmente dall’atroce esperienza che ha sconvolto la loro gioventù e avrebbero bisogno di trovare persone comprensive, riconoscenti per quanto da loro fatto, disposte ad aiutarli, e invece percorrono le strade di un paese distrutto, affamato, in preda a un’anarchia perniciosa, con la gente che nel migliore dei casi si palesa indifferente, quando invece per lo più è tesa a incolpare questi soldatini per tutte le nefaste conseguenze della sconfitta. E la loro verde età non è motivo per una possibile rinascita, perché le tragiche esperienze li hanno invecchiati, la guerra è entrata in loro come un male subdolo dal quale è assai difficile liberarsi e inevitabilmente, abituati ad anni di cameratismo di trincea, finiscono con l’essere incapaci di ritornare alla situazione ante guerra, rifugiandosi nel conforto - cercato, ma impossibile da trovare - dell’uno con l’altro. La vita così sembrerà sempre di più senza senso, brancoleranno nel buio incapaci di abituarsi a una realtà che li respinge, così che chi è sopravvissuto alla guerra non sopravviverà alla pace. Piano piano i rapporti camerateschi si sfaldano e restano gli uomini, con le loro paure e le loro tragedie personali; c’è chi con difficoltà riuscirà a emergere dalla melma, ma c’è anche chi non vedrà soluzioni, se non quella di lasciare anzi tempo una vita diventata insopportabile. Remarque, più che in Niente di nuovo sul fronte occidentale, si cimenta in una complessa e approfondita analisi psicologica, denotando un talento non comune, e porta agli occhi del lettore una tragedia non dissimile da quella della guerra vera e propria. Per certi aspetti quest’opera è addirittura migliore della precedente perché l’autore, incidendo con precisione l’animo umano, ci pone di fronte alla chiara insensatezza di ogni conflitto, in cui il perdente è sempre colui che vi partecipa direttamente, mentre nulla hanno da temere i politici superbi, i finanzieri avidi e i generali impazienti di arrivare al successo che sono sempre alla base di ogni guerra, che la cercano, che la provocano, che la pongono in atto. Insomma, ci sono uomini e uomini, uomini già sfruttati in tempo di pace e bestie, tali sempre e che nella guerra trovano la loro più ampia e agognata realizzazione.
“Capisci? Nella parola patriottismo hanno pigiato tutte le loro frasi, la loro ambizione, la loro avidità di potenza, il loro romanticismo bugiardo, la loro stupidità, il loro affarismo e ce l’anno poi presentato come un ideale radioso. E noi abbiamo creduto che fosse la fanfara trionfale di un’esistenza nuova, forte, possente.”.
Le pagine di Remarque sono malinconiche, sono quelle di un uomo che ha compreso quanto sia ineluttabile opporsi alla violenza e come la carne da cannone sia sempre tale, in guerra, ma anche in pace.
La via del ritorno è semplicemente un capolavoro.
Indicazioni utili
Non solo thriller
Arrivati all’ultima pagina si è portati inevitabilmente a classificare Il tenente del diavolo come un thriller di ambiente militare, un thriller psicologico di notevole interesse, anche se non credo che il principale piano di lettura sia rappresentato dai disperati sforzi del capitano Kunze, magistrato militare, per incastrare il tenente Dorfrichter, sospettato di aver avvelenato con il cianuro un collega, il capitano Mader, nonché di aver tentato di porre in atto la stessa fine per altri nove ufficiali dello stato maggiore austriaco. Maria Fagyas, figlia di un tenente ungherese deceduto nel corso della prima guerra mondiale, è molto abile nell’addentrarsi in un ambiente tutto sommato chiuso alle donne e in cui predomina una morale maschilista, congiunta sovente ad aspirazioni bellicose, a conflitti sognati e facilmente vinti (ma solo sulla carta). La vicenda di questo ufficiale non promosso al rango di capitano, ma soprattutto non assurto alla carica di componente dello stato maggiore, nonostante le sue eccelse capacità, è veramente riuscita, con un continuo gioco fra il gatto (Kunze) e il topo (Dorfrichter), ma con un non raro scambio di ruoli, perché il presunto reo è dotato di una forte personalità, di un’intelligenza ragguardevole ed è in grado di tenere testa a chi conduce le indagini, rifiutandosi inizialmente di confessare, il che lo porterebbe direttamente al capestro. Peraltro, pur ammettendo che l’accusato sia in grado di esercitare un certo ascendente con il suo fascino su Kunze, che in gioventù non è stato immune da esperienze omosessuali, resta il fatto che l’azione dell’inquisitore è mossa unicamente dal desiderio di pervenire alla verità, verità che nonostante il dissennato sostegno di casta verrà fuori, portando tuttavia, in una sorta di compromesso, a una condanna pesante, ma senza che sia una sentenza di morte. Il conflitto esistente fra accusato e accusatore va ben oltre lo schema dialettico della tenzone fra imputato e magistrato, ma evidenzia un insanabile contraddizione di base che vede da un lato Dorfrichter convinto assertore della guerra che vorrebbe fosse condotta con metodi moderni e il pacifismo, spinto all’antimilitarismo, di Kunze, non tanto un’eterna lotta fra male e bene, quanto invece un concetto di essere umano radicalmente diverso alla radice. Può forse apparire simpatico il personaggio dell’accusato e in fondo detestabile quello del capitano, ma non si deve dimenticare che il primo è nato per fare la guerra, il secondo per perseguire chi delinque, una bella differenza fra chi giustifica in ogni caso l’omicidio per cause di guerra e chi invece cerca, sempre e solo, di pervenire a comprendere ciò che realmente sia accaduto e chi sia il colpevole.
Il tenente del diavolo scorre liscio, le pagine si leggono velocemente, la tensione non viene mai meno in un’opera che non è solo mero motivo di svago, ma che invita a riflettere sul significato delle parole guerra e pace, su un senso del dovere che nel caso del capitano va oltre ogni lusinga o minaccia dei potenti.
Peraltro la Fagyas è riuscita a descrivere bene l’atmosfera di fine Belle epoque, in un impero asburgico che sta implodendo non solo sotto la spinta dei popoli che chiedono maggiori autonomie, ma anche perché la decadenza si manifesta in tutte le sue caratteristiche, con una società di pubbliche virtù e di vizi privati, in cui puttanieri e puttane trascinano una squallida esistenza fatta di corna assiduamente reiterate.
Questo romanzo, che trae spunto da un fatto accaduto veramente, merita indubbiamente di essere letto.
Indicazioni utili
L’anno del riscatto
Nei giorni caotici della nostra ritirata di Caporetto erano ben pochi quelli disposti a scommettere su una rivincita dell’esercito italiano: troppi i nostri militari caduti prigionieri, notevoli le perdite negli armamenti, in particolare nelle artiglierie, consistenti, per non chiamarle cospicue, le quantità dei generi alimentari cadute in mano al nemico. Soprattutto, i timori maggiori venivano dal profondo stato di sconcerto e di sconforto delle nostre truppe. Arretrarono fino al Piave, la linea di estrema difesa, ma sarebbero riusciti i nostri militi a fermare il nemico incalzante? Contrariamente a tante paure, a una quasi rassegnazione all’inevitabile, avvenne il miracolo. Quei soldati, fino a pochi giorni prima demotivati, stanchi, affranti, strinsero i denti e si batterono come leoni, inchiodando gli austriaci sulla sponda sinistra. Più che da un desiderio di riscatto erano mossi dalla certezza che senza uno sforzo immane il nostro paese, e così le loro case, i loro familiari, le loro attività sarebbero cadute in mano al nemico. A ciò aggiungasi che un previdente intuito del generale Cadorna, sorto dopo l’arresto nel 1916 della famosa Strafexpedition, aveva portato a fortificare quel bastione naturale che era il Monte Grappa, con la costruzione anche di una strada lunga una trentina di chilometri, sebbene larga solo tre metri. In quei primi giorni del novembre 2017 e fino a tutto il dicembre dello stesso anno lì si decisero le sorti della guerra, che nel 1918 fu ancora sanguinosa, soprattutto nella famosa battaglia del solstizio, l’ultimo disperato tentativo degli austriaci di sfondare le nostre linee e di dare una svolta al conflitto. Non ci riuscirono, li respingemmo e quindi la vittoria arrise a noi. Seguirono giorni di preparazione alla nostra stoccata definitiva che avvenne con la celebre battaglia di Vittorio Veneto, decisiva per le sorti della guerra. Antonio Badolato e Armando Rati hanno voluto parlarci di questo 1918 in un bellissimo saggio storico intitolato appunto 1918: la fine della Grande Guerra. Giorno per giorno ci fanno rivivere le grandi battaglie, i piccoli scontri che ci portarono dall’inferno al paradiso, con una scrittura lineare e notevolmente avvincente. L’opera è divisa in otto capitoli, ognuno dei quali stilati dall’uno o dall’altro storico (per l’esattezza tre da Armando Rati e cinque da Antonio Badolato), e affronta tanti temi, alcuni dei quali spesso trascurati da altri saggisti, come nel caso del sesto capitolo in cui Antonio Badolato ci parla dell’attività di spionaggio, del movimento di resistenza nelle province invase e delle difficili condizioni di vita della popolazione civile. Ma se l’anno chiave è il 1918 il libro va oltre perché nell’ottavo capitolo redatto da Armando Rati si parla dell’esercito italiano dall’armistizio alla pace, con riferimento a ben tre anni, cioè fino al 1920, relazionando dettagliatamente sulla smobilitazione, sul ritorno dei prigionieri, sull’occupazione dell’Alto Adige e sulle nostre operazioni militari all’estero, fino alla conclusione dell’avventura fiumana. Si tratta quindi di un’opera di estremo interesse e di grande valore, con il supporto di una bibliografia di storici di comprovata capacità e serietà. Appare evidente, quindi, che la lettura è senz’altro consigliata.
Indicazioni utili
Una storia di mutande
La presenza del Maresciallo dei Reali Carabinieri Maccadò è una garanzia, nel senso che improntare la narrazione a una sia pur tenue venatura gialla fa sì che il romanzo possieda un fil rouge intorno al quale animare diversi personaggi, ma soprattutto il bonario investigatore. Nella storia di Le belle Cece non ci sono morti ammazzati, né rapine, bensì il furto di mutandine da donna. Già l’indumento può lasciar presagire uno sviluppo erotico, una vicenda di amorazzi carnali che non era rara in Piero Chiara, ma che invece latita nel quasi pudico Andrea Vitali, e se poi si inventa un personaggio come il sottocapo di manipolo Stelio Cerevelli, detto Dolcineo, un po’ effeminato e probabilmente omosessuale, e per non sbagliare gli si affianca un nero africano tale Buluc, tuttofare (forse anche quello...) del predetto Dolcineo, va da sé che quella sfumatura di giallo iniziale si colora di rosa. Gli ingredienti del pastone non sono finiti, perché ci sono anche le belle Cece, quelle del titolo, madre e figlia, due belle donne piuttosto vogliose, e se non bastasse c’è il marito della seconda, un ispettore di produzione del cotonificio, che è l’emblema della classica carogna, altezzoso, cattivo, e perfettamente cornuto, nonché il locale segretario del fascio, uomo che si crede d’azione e invece è un minchione. Carne al fuoco quindi ce n’è in abbondanza, ma quando è tanta si deve stare particolarmente attenti alla cottura, e il tal senso Vitali si impegna con encomiabile dedizione, non riuscendo tuttavia a evitare che qualcosa cuocia troppo e rischi di bruciare, nel senso che fino quasi al termine fila tutto liscio, ma poi si verifica l’intoppo, proprio quando Maccadò convoca in caserma tutti i protagonisti, un po’ come è abituato a fare Poirot. Quello è il momento della verità, è l’ora in cui deve essere fatta chiarezza, ma a dispetto dello scopo il Maresciallo s’improvvisa prestigiatore ed estrae dal cilindro la soluzione, non senza aver fatto un po’ di confusione. Posso dire che forse Vitali si è lasciato prendere la mano, ha dato troppa corda al suo investigatore e a un certo punto questi, libero dal vincolo del narratore, si è dovuto inventare una soluzione che, guarda caso, ha risvolti boccaceschi, un menage a trois, mamma, figlia e Buluc, ancor più tuttofare del solito. In ogni caso è il Vitali che ben conosciamo e, nonostante i limiti, quell’innesto rosa, con tanto di allusioni, è riuscito bene, ha dato tono e forza a un romanzo che si legge con piacere.
Indicazioni utili
Inutile verbosità
Devo ammettere che tanto mi attendevo da questo libro, in considerazione anche del fatto che l’autrice, con un altro romanzo, si è aggiudicata il premio Strega 2018; tanto mi attendevo, forse troppo, e quindi la delusione è stata cocente. Eppure il tema in argomento è interessante, quel ritorno al passato agli epici scontri di Montecassino, che videro impegnate, fra gli alleati, molte nazionalità, dagli inglesi e gli americani, ai polacchi, ai magrebini, perfino ai maori e molte altre ancora, con un rientro al presente, a una ordinarietà che stride con la tragedia di quel 1944 del fronte italiano. Sono tanti gli episodi, tanti i personaggi, tante e troppe le parole, con digressioni non di rado fuori luogo e che mi hanno sconcertato Si tratta di un’opera per certi aspetti squilibrata, con parti che avrebbe meritato maggiore attenzione, un più attento approfondimento e altre invece in cui l’autrice si avvita in riflessioni di poco conto. E poi ho riscontrato, nella scrittura, quella pedanteria e grevità che è propria di non pochi autori dell’est, elementi che di certo non portano acqua al mulino dell’opera e anzi finiscono lentamente con affondarla. L’’impegno c’è, non lo nego, ma ahimè i risultati sono modesti, anche perché probabilmente chi scrive non ha ben chiaro ciò che intende trasmettere, oppure è perfettamente cosciente della sostanza del suo messaggio, ma è incapace di renderlo compiutamente intellegibile al lettore. E’ un peccato, e aggiungo che la pochezza dell’opera non mi invoglia certo a consigliarne la lettura, perché sull’argomento della guerra, dei nostri rapporti con quel trascorso drammatico che rivive nei ricordi di chi vi ha partecipato c’è molto di meglio in letteratura e ben più meritevole di attenzione.
Sarà forse brava la Janeczek, ma francamente a me non è piaciuta, almeno in questo romanzo. Mi riprometto, comunque, di leggere qualche altro di suo, con la speranza di poter capovolgere il mio attuale giudizio.
Indicazioni utili
Lungo il Grande Fiume
Gabriele Oselini è un poeta che non mi è sconosciuto, tanto che l’ho anche intervistato il 12 febbraio 2012 in relazione alla sua silloge Piove da me recensita positivamente. Questo autore, che abita in provincia di Mantova, in un paese rivierasco del Po, come del resto anche il sottoscritto, trova la sua fonte di ispirazione nella natura, in quel paesaggio piatto, i cui unici rilievi sono dati dagli argini, fra i quali scorre il più grande fiume italiano. Qualcuno potrà obiettare che il tema della natura è assai diffuso, quasi inflazionato, ma è altrettanto vero che il particolare rapportarsi di ognuno di noi con la stessa fa sì che venga vista in un modo del tutto autonomo e personale, e questo vale anche per Gabriele Oselini. Se poi c’è chi manifesta il timore di una serie di quadri idilliaci, nella scia di una magica e irripetibile Arcadia dico subito che non è il caso, perché la natura di Osellini è indubbiamente poetica, ma reale, cioè non ha nulla di mitico o comunque conforme a canoni arcaici. Ed è per questo che saper cogliere in un mondo, in cui tutto cambia, lo spirito primigenio è un’occasione per riscoprire, in un’altra luce, se stessi. E’ talmente importante che il corso naturale non venga sovvertito che l’autore giunge a ipotizzare, in caso contrario, una caduta in un baratro senza fondo come in Abisso (l’usignolo / non canta / sulla magnolia / i balconi / sono spogli / dei gerani in fiore / profondo / abisso / del nostro tempo).
Dato che noi inevitabilmente cambiamo con il trascorrere del tempo l’unica certezza, forse ancora per poco, è che la natura segue sempre il suo corso, così che l’estate, che dopo ferragosto in pratica finisce, è l’occasione per pescare nell’antro della memoria i ricordi da bambino; altre volte invece la natura è evocativa del ciclo della vita che nell’ultimo temporale si chiude per un vecchio porcospino. Non poteva altresì mancare un riferimento al grande fiume, alle sue piene che incuriosiscono, pur incutendo tanto timore (improvvisa corre / in golena / l’acqua gonfia / del fiume in piena / grigia / increspata / affamata di terra /nel tempo negata / e lepri / e corvi / e ramarri impauriti / si confondono / con bici curiose / bimbi / cani felici / e guardiani della notte / sui fratelli argini / custodi delle nostre radici). In queste poesie ci sono il sole estivo che dardeggia e incendia la pianura, l’incedere lento dell’autunno nebbioso che annuncia il gelo e a volte la neve dell’inverno che qui in queste terre pare più riposare che dominare e infine l’annuncio della primavera, il verde nei campi, l’aria nuova che inebria e rivitalizza l’amore con la bella stagione che arriva al galoppo, insomma c’è lo spirito di questa pianura e delle sue genti, tutte raccolte intorno a questo grande e maestoso fiume. Leggere questa silloge sarà un po’ come ripensare al proprio passato e al proprio presente per chi, come me, è di questi luoghi; per gli altri, invece sarà l’occasione per apprezzare posti che occhi disattenti potrebbero definire monotoni e piatti, ma non è così, perché la natura è una continua scoperta, basta saperla osservare, come ha fatto appunto Gabriele Oselini.
Indicazioni utili
Un’innocente puttanella
Leggo, riguardo a quest’opera, che si è aggiudicata il premio Strega edizione 1993 e immediatamente penso che probabilmente gli altri romanzi in concorso dovevano essere assai modesti, perché Ninfa plebea non è quello che comunemente, a proposito di grandi libri, viene definito un capolavoro, anzi ritengo personalmente che si tratti un qualcosa che si elevi assai di poco sulla mediocrità. Posso capire che l’autore abbia voluto descrivere un certo tipo di vita presente in passato nel nostro paese, soprattutto in meridione, ma nella vicenda di Miluzza che si dona con spontanea innocenza ravviso degli eccessi che rasentano, più che l’erotismo, l’oscenità, con quell’insistere sulle caratteristiche degli organi sessuali maschili e femminili con una costanza quasi maniacale. Se la descrizione della mitica città di Fofi è la parte migliore del romanzo, la vicenda in se stessa pare quasi una sceneggiata napoletana, con questa adolescente che coltiva le sue pulsioni sessuali con spensieratezza, in un’esistenza segnata dalle morti della madre a seguito di un amplesso quasi feroce, del padre che, in un vespaio di maschi libidinosi è un pesce fuor d’acqua e forse un impotente, del nonno dal passato di grande amatore e a seguire con il contorno della seconda guerra mondiale grazie alla quale troverà il vero amore che la porterà all’altare. Miluzza, che senza farsi troppi problemi s’accompagna anche con donne, che si dona a chiunque come se fosse la cosa più naturale di questo mondo, che piano piano, quando di lei si incapriccerà un ricco e anziano imprenditore, viene considerata dalla gente una disprezzabile puttana, è in effetti una creatura incapace di comprendere il significato della parola trasgressione, è quel si potrebbe dire, insomma, un’innocente puttanella. Se la trama è debole, mi sarei atteso almeno una ragazza battagliera, e non remissiva, ma quel che stona più che altro è purtroppo un continuo ricorso a descrizioni di atti sessuali che francamente costituiscono un’esagerazione e che fanno di un romanzo che, altrimenti strutturato avrebbe costituito un pregevole affresco di un’epoca e di una certa mentalità, un irritante tentativo di rappresentare una ninfomane, tipo la Lolita di Nabokov, in salsa nostrana, ma senza la comicità e l’ironia della commedia all’italiana, bensì in un un continuo ravvivarsi di una libidine che sfocia talora nella pornografia.
Da non far leggere ai minori, lasciando ai maggiorenni la possibilità di decidere, ma con l’avvertenza che Ninfa plebea da romanzo che vorrebbe essere sull’amore è invece senza amore.
Indicazioni utili
Le prose del cantore del Sud
Vincenzo D’Alessio è nato a Solofra in provincia di Avellino, un paese, non una grande città, e come tale è in grado di parlare di una piccola realtà più a misura d’uomo, dove ancora i rapporti e le conoscenze hanno il sapore delle relazioni non impersonali di un’antica comunità. Ma Vincenzo è anche uomo del Sud, che osserva, che cerca di capire e che lancia il suo, se pur sommesso, grido di dolore per una condizione sociale che da anni cerca inutilmente il suo riscatto. Non a caso ha scritto una silloge poetica come La valigia del meridionale e altri viaggi, nonché la successiva Dopo l’inverno, raccolte indubbiamente tipiche di un poeta stanziale, ma anche veri e propri atti di accusa a un sistema che condanna il meridione a un perenne immobilismo. D’Alessio, però, non è solo poeta, ma è anche capace di misurarsi positivamente con la narrativa, come dimostra questa raccolta intitolata Racconti di Provincia. Si tratta di storie di epoche diverse, che l’autore ha opportunamente suddiviso in due parti, di cui la prima ha chiamato Scritti su carta di Amalfi. Al riguardo è apprezzabile l’escamotage adottato per parlarci di fatti di moltissimi anni fa, presumibilmente del XVIII secolo, inventando il reperimento di alcuni articoli scritti da un anonimo cronista dell’epoca sulla pregiata e ormai quasi introvabile carta di Amalfi. Sono storie sapientemente strutturate con un linguaggio arcaico tanto che il lettore si convince che possano essere vere. Di epoca più recente e anche quasi attuale sono le prose della seconda parte intitolata Nei paesi del sud; cambia lo stile, cambia il periodo, ma sempre rimane un atto di accusa per quanto nei secoli ha dovuto patire la povera gente, una dolorosa rivelazione di un cristiano che cerca per i suoi conterranei la possibilità di un Paradiso anche in terra, integrando così perfettamente le già succitate sillogi. In ogni caso da questi racconti emerge il Sud che un osservatore non superficiale ben conosce, fatto di tribolazione quotidiana, ma con latente o anche esplicita voglia di riscatto, di ingiustizie che fanno piegare il capo, ma non spezzano la schiena, di un mondo che, nonostante tutto, si affanna non solo per non restare troppo indietro, ma per portarsi alla pari con la parte dell’Italia più avanzata, di un sogno per un mondo più giusto e più equo che non muore mai, perché il Meridione è così, un insieme di superstizioni e di genialità, di miseria e di nobiltà.
Da leggere, pertanto.
Indicazioni utili
Le cure efficaci del Maresciallo Maccadò
Come in tutti i romanzi di Vitali ci troviamo a Bellano, sul lago di Como, l’epoca è quella ventennio, l’anno quello della proclamazione dell’Impero; la vita è quella solita del paese con un podestà che ha una moglie che è una povera demente e ritroviamo anche il Maresciallo Maccadò, tutto intento a programmare la messa in cantiere di altri figli per arrivare al numero prefissato dallo stesso, vale a dire sei. L’atmosfera è quella un po’ sonnacchiosa di una piccola realtà, con qualche improvviso sprazzo pirotecnico legato a ricorrenze importanti o a eventi clamorosi. Purtroppo, in questa quiete generale, c’è chi provvede a combinare dei guai, degli scherzi piuttosto pesanti, insomma le tipiche scemenze di una banda di imbecilli ormai oltre il periodo della pubertà, dei vitelloni, senza arte né parte che i genitori non riescono a ricondurre sulla retta via. Per fortuna, però, c’è il nostro Maccadò che si curerà di loro, riuscendo a raddrizzarli con metodi validi, anche se non proprio ortodossi.
Un po’ commedia degli equivoci, un po’ una spruzzatina di giallo, l’aggiunta di qualche particolare o fatto boccacesco, il tutto ben amalgamato porta a un’opera che risulterà facilmente gradita al lettore, anche perché l’autore infila, nella vicenda principale, delle altre storie che indirettamente si ricollegano e che hanno il pregio, a volte, di mostrare alcuni spaccati di quella che è la vita di un piccolo paese, quale è appunto Bellano. Non manca anche una leggera vena ironica, presente addirittura anche in occasione di dipartite, insomma se le pagine (448) sono tante, è altrettanto vero che la lettura scorre via veloce e che si arriva alla fine in un “amen”. E’ inutile pretendere di più, è illogico cercare messaggi di alto livello, ma se si vuol trascorrere piacevolmente un po’ di tempo questo libro è l’ideale e perciò è del tutto naturale consigliarlo.
E le olive del titolo, comprese peraltro? Non sono proprio il frutto dell’ulivo, ma...ma la decenza mi impedisce di dire cosa siano; basta leggere il libro e lo saprete.
Indicazioni utili
Un altro gioiellino
Dopo il forse insperato successo di Un matrimonio mantovano, nel 1981 esce quello che potrebbe apparire un seguito, ma non lo è, vale a dire Un adulterio mantovano. Non è un seguito, perché i personaggi sono diversi e anche l’ambientazione non è la stessa, non è Gazzuolo, piccolo borgo di campagna, ma la città, vale a dire Mantova, una Mantova colta, raffinata, vista nell’epoca del precedente romanzo, cioè nel 1912. La trama è completamente diversa, non ci sono strategie e tattiche per convolare a nozze, anzi qui c’è una coppia già unita nel vincolo del matrimonio, lui Ernesto, ingegnere, un po’ sparagnino come tutti i mantovani e in aggiunta fervente cattolico, lei nobile, la bella e irrequieta Francesca, all’apparenza solo soddisfatta della sua vita. Ma, pur nelle convenzioni di un’epoca, l’eterno femminino che la porta a soddisfare il suo ego facendo di tutto per strappare complimenti sulla sua persona è un diavoletto dietro l’angolo, come un diavoletto è il conte Vezio, fulminato dallo sguardo ammaliante e dalle forme seducenti di Francesca. Insomma, per farla breve, il tradimento viene quasi del tutto naturale e si instaura un rapporto a tre, lei con l’amante, un uomo che incarna gli stilemi della bella epoque, un D’Annunzio meno estroso, ma tutto portato all’autoesaltazione, all’adorazione del proprio “io” , e lei con il marito Ernesto, tutto l’opposto dell’altro, pragmatico, simbolo della nascente nuova borghesia. In questa strana relazione mi pare di aver capito che gli unici capaci veramente di amare sono Ernesto e Vezio, mentre Francesca è nulla più di una civetta, una che in dialetto mantovano definiremmo “na ligera”, una donna che ritrae più piacere dal sentirsi desiderata che dall’essere amata veramente. Il menage non ha una breve durata e se i contatti si interrompono è solo per colpa della guerra, perché i due uomini vanno a combattere. Quindi, non ci sarà dato di sapere se essi torneranno, se tutto andrà avanti come prima, ma Nuvoletti, pur lasciando un finale aperto ha l’abilità di mostrarci per chi dei due uomini parteggia e lo fa con due lettere, una di Vezio che, di spirito dannunziano, è colma di retorica sulla bellezza della guerra, dimostrando così che sotto le spoglie dell’uomo di vita c’è un immaturo, e l’altra di Ernesto, di tono completamente opposto, Ernesto che sa della tresca, ma tace, perché nonostante tutto è innamorato della sua Francesca. Il primo aspira a essere un superuomo e invece è quasi un guitto, il secondo, semplice, silenzioso, consapevole della tragedia del conflitto, è un piccolo eroe.
Di caratteristiche completamente diverse da Un matrimonio mantovano, Un adulterio mantovano rivela uno scrittore capace - e di questo non si è mai dubitato -, ma soprattutto un attento analista della psicologia umana, sia maschile che femminile, in grado di ricavare da una vicenda tutto sommato quasi banale un’opera di pregevolissima fattura, un altro avvincente gioiellino.
Indicazioni utili
Amore in parole
Per quanto l’umanità sia percorsa da ondate di odio il mondo non è ancora distrutto e si può continuare a sperare poiché a trionfare è l’amore, in tutte le sue variegate forme, che va da quello per l‘altro sesso (ma anche per lo stesso sesso) a quell’affetto che ci lega ai familiari più stretti, in primis la madre, poi a seguire il padre, i fratelli e le sorelle. Trattasi di un sentimento del tutto naturale di cui prima o poi l’individuo cerca di trovare una spiegazione logica, ricerca che spesso si rivela vana. E quello che non si riesce a dire a voce, un po’ per incompletezza, un po’ per ritrosia, per quel senso di vergogna che tutti proviamo nell’aprire agli altri la nostra sfera intima, lo si partecipa con una lettera, a volte anche non spedita. Questo libro è una raccolta di queste lettere d’amore, alcune di autori famosi, le altre più spesso di meno noti, ma ugualmente valide.
Ora sarebbe d’obbligo che io parlassi di queste lettere, ma sono tante, sono troppe e allora dovrei fare una difficile cernita per esaminarne solo alcune, ma la cosa non è possibile, perché per quanto diverse sono tutte ugualmente belle e farne una scelta diventerebbe francamente un’impresa improba. Mi limiterò pertanto solo a dei brevi cenni, principiando in questa sede che, a puro e solo titolo di notizia, ce n’è anche una scritta da me. I destinatari sono i più disparati, come la nonna di un testo onirico, un pianista a cui tributa il suo affetto un musicista, il padre in uno struggente ricordo della figlia, la madre nei malinconici, ma non tristi versi del figlio, la gioventù che appare lontana e irripetibile nel sentito rimpianto di una donna, il teatro, peraltro greco (quello di Taormina), da parte di un attore, un uomo nelle accorate parole di una sirena, le due figlie nella delicata prosa del padre. E poi ancora altre indirizzate a figli, a mogli, ad amanti e perfino alla poesia. E’ bello vedere persone diverse esprimere il loro amore: uomini, donne, poeti, insegnanti, scrittori, musicisti, perfino un vescovo e questo dà l’idea della grande, grandissima forza dell’amore che, se si riuscisse a convogliare in un unico binario, in un unico afflato, consentirebbe un mondo senz’altro migliore dell’attuale.
Questo è decisamente un bel libro e presenta anche altri aspetti di pregio, visto che ogni tanto una pagina riporta un disegno di Maria Leone, un’artista con uno stile del tutto personale che può ricordare un certo classicismo, con immagini tuttavia a linee decise che proiettano più avanti nel tempo, insomma una moderna reinterpretazione dell’Arcàdia di antica memoria; si tratta di figure, evocatrici di personaggi femminili, che hanno anche il pregio di interrompere la lettura di quel tanto da consentire riflessioni. Non è finita, però, in quanto il curatore Aurelio Caliri, oltre a riportare lo spartito musicale ispirato da qualche lettera ivi contenuta, offre un saggio delle sue qualità musicali come autore ed esecutore di alcuni dei brani sul tema dell’amore in un CD allegato che invito ad ascoltare, magari mentre si leggono le lettere del libro. E’ anche questa un’esperienza, senz’altro positiva, un invito a reperire il volume e il CD (venduti congiuntamente), convinto che la soddisfazione sia assicurata.
Indicazioni utili
Una spugna
Che sulle nostre montagne (non solo lì, ma soprattutto lì) si bevano alcolici in quantità non certo modeste penso sia cosa nota e che fra questi amanti di Bacco ci sia stato anche Mauro Corona non fa meraviglia; ciò che stupisce invece è che l’autore ertano si sia dedicato al vino e alla grappa in quantità ragguardevoli, che abbia bevuto smodatamente e che, ubriaco, abbia compiuto atti di cui oggi, più sobrio, ha memoria con vergogna. Ciò che ha scritto potrebbe meglio definirsi le confessioni di un grande bevitore e, francamente, il lettore, a volte un po’ infastidito da una narrazione che non di rado è ripetitiva, si accorge a poco a poco che un po’ di quelle quantità industriali di vino sembrano uscire dalle pagine, traboccando, per andare a infilarsi nella sua bocca a togliergli una sete che non prova. Personalmente e in tutta sincerità a leggere continuamente di bevute colossali ho corso il rischio di ubriacarmi e spesso ho cercato di leggere in velocità per superare certi periodi che in pratica non dicevano nulla di nuovo, alla ricerca invece di fatti, connessi all’ubriachezza, di cui Corona sembra avere una prodigiosa memoria, assai strana per un ebbro, tanto da pensare che in buona parte siano frutto solo di invenzione. Purtroppo siamo lontanissimi dalla qualità di opere come Storia di Neve, Il canto delle manere, L’ombra del bastone, I fantasmi di pietra e Il volo della martora, tanto da sembrare che questi libri e Aspro e dolce non siano stati scritti dalla stessa mano. E’ da un po’ di tempo però che la vena di Corona sembra essere esaurita e di questo non posso che provare dispiacere, perché conservo sempre dentro di me le emozioni dei suoi libri migliori, di un mondo reale in cui è riuscito a innestare una vena di fantasia che arriva a sfiorare il mito; l’unico vero elemento positivo di Aspro e dolce è dato dal forte monito ai giovani affinché non percorrano la stessa strada di stravizi, perché bere si può, ma sempre e solo con moderazione. Il libro si può leggere, ma non c’è da avere particolari aspettative, presentandosi talora e per non poche pagine decisamente noioso.
Indicazioni utili
- sì
- no
Il feuilleton di Simenon
Nel 1936 Simenon era già un autore affermato, grazie ai gialli con Maigret e agli indovinati noir e non piaceva solo al lettore medio, ma anche a letterati assai famosi come André Gide. Confortato da questi elementi positivi e indubbiamente consapevole delle sue capacità deve aver pensato che fra tanti successi ne mancava uno relativo a un romanzo di maggior spessore, quale poteva essere costituito dalle vicende di una potente famiglia avviata a un inarrestabile declino. E a passare dall’idea alla realizzazione non ci mise molto, solo i mesi di luglio e agosto del 1936; nacque così Il testamento Donadieu, un romanzo corposo, considerate le sue 393 pagine.
Strano clan, quello dei Donadieu, che vivono fra La Rochelle e Parigi, che conducono una vita ritirata, ma che tutti assieme, come in processione, vanno a messa alla domenica per un rito anziché per una fede; è un’esistenza senza un acuto, monotona, anzi grigia, prigionieri della loro stessa potenza. Un giorno però accade un fatto straordinario: il capostipite, l’armatore Oscar Donadieu scompare, senza lasciare traccia, nemmeno un rigo. E’ l’inizio della fine, perché nonostante la proverbiale meticolosa efficienza e la non scalfibile sicurezza quello che si potrebbe definire l’ordine Donadieu mostra dapprima una crepetta che però in breve si allarga e si dirama fra La Rochelle e Parigi fino ad arrivare al crollo di questa grande famiglia, trascinando nel baratro anche l’arrivista Philippe, inseritosi di soppiatto fra gli apparentemente rigidi legami del clan. Costui, figlio del proprietario di un cinema ridottosi quasi in miseria per operazioni finanziarie sbagliate, circuisce Martine, la figlia dello scomparso Oscar Donadieu, il cui cadavere verrà poi ritrovato nel limo del porto senza che possiamo sapere se si sia trattato di incidente, di suicidio o di omicidio; il suo intento non è nobile, né quello di un vero innamorato, in quanto ha un unico scopo, vale a dire impadronirsi delle fortune dei Donadieu, che ritiene colpevoli delle disgrazie finanziarie del padre. Non vado oltre per quanto concerne la trama di questo lungo romanzo, limitandomi a far presente che la passione dell’autore per il giallo e per il noir qui sembra assente, se pur tuttavia i morti ammazzati non mancano e tutti legati, direttamente o indirettamente, a questa famiglia. Il finale, poi, non potrebbe essere più pirotecnico e a onor del vero mi sembra che in tale circostanza Simenon abbia usato più di una forzatura, travalicando il limite dell’equilibrio per piombare in una specie di tragedia greca. Il romanzo non è certamente un capolavoro, ma ha il sapore di certi drammoni propri dei feuilleton e in effetti è giusto ricordare che Il testamento Donadieu uscì agli inizi a puntate su Les feullets bleus, senza dimenticare che era stato commissionato dal quotidiano Le Petit parisien. A mio parere è uno di quei libri, denso di intrecci, di tresche e di atmosfere grevi, adatti a un lettore che, amante delle tinte forti, desidera un prodotto che gli consenta di trascorrere diverse ore immerso nella realtà fittizia di un mondo in cui amore e morte non solo convivono, ma vanno felicemente a nozze. Per concludere si tratta di un’opera di non grande pregio, la tappa di un percorso che però avrebbe portato George Simenon a scrivere romanzi di notevole valore, quali, e solo a titolo di esempio, La finestra dei Rouet, I fantasmi del cappellaio e L’angioletto.
Indicazioni utili
Una vera e propria tigre
Figlia naturale del depravato Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, e di Lucrezia Landriani, moglie di un uomo di corte, Caterina Sforza (Milano, 1463 – Firenze, 28 maggio 1509) si fece notare fin da giovane per il suo carattere ribelle e per la sua passione per le armi (quest’ultima verrà poi trasmessa al figlio Ludovico di Giovanni de’ Medici, più conosciuto con il nome di Giovanni dalle Bande Nere). Divenne signora di Imola e contessa di Forlì, dapprima con il marito Girolamo Riario, nipote di Papa Sisto IV, e, dopo l’uccisione di questi in una congiura cittadina, in qualità di reggente del figlio primogenito Ottaviano. Fu proprio nella veste di reggente che di distinse in modo particolare, comandando a tutti gli effetti e dimostrando una fermezza eccezionale. Dopo un secondo matrimonio con il giovane Giacomo Feo, che finì pure lui vittima di una congiura, Caterina sposò l’ambasciatore della Repubblica di Firenze Giovanni de’ Medici, detto il Popolano, membro di una ramo collaterale della nota famiglia fiorentina. Anche il terzo marito, tuttavia, morì, questa volta però per malattia. Divenuta così nuovamente vedova si trovò al centro delle azioni volute da Alessandro VI, il famoso Borgia, per la conquista dell’Italia; in particolare dovette fronteggiare l’alleato esercito francese calato in Italia e che già aveva sottomesso Milano, poi ripresa dagli Sforza grazie agli Austriaci. Lo scontro vero e proprio però avvenne con il figlio del Papa, il Valentino, che, posta sotto assedio e infine occupata Imola, rivolse la sua attenzione a Forlì, dove Caterina, asserragliata nella fortezza di Ravaldino, tenne a lungo testa agli aggressori, fino alla capitolazione e la prigionia a Roma fino al 30 giugno 1501, quando, liberata dai francesi di passaggio per la conquista del Regno di Napoli, si ritirò a Firenze nelle proprietà del marito Giovanni e lì si spense il 28 maggio 1509. Personaggio indubbiamente interessante, battagliero, in un’epoca densa di avvenimenti come quella del pontificato di Alessandro VI, assunse al ruolo di eroina non solo agli occhi del popolo che le diede il soprannome di Tygre, ma anche di suoi illustri contemporanei, fra i quali il Machiavelli. E proprio Caterina Sforza è la protagonista del bel romanzo storico La bastarda degli Sforza, scritto con felice estro da Carla Maria Russo. La narratrice, che si è avvalsa di ampie e meticolose ricerche storiche, è stata brava nel riproporci un mondo in cui l’essere donna significava normalmente essere schiava dell’uomo, e non importava che si trattasse di una popolana e di una nobile. In particolare il libro riesce a trasmettere l’immagine di un personaggio che, dietro la finezza dei lineamenti e la dolcezza dello sguardo come appare nel suo presunto ritratto “La dama dei gelsomini” di Lorenzo di Credi, cela un carattere indomito, forte e deciso ad affermarsi, un’autentica Signora a tutti gli effetti di uno Stato, anche se piccolo, come infatti ebbe a dimostrare. Ho l’obbligo però di muovere un appunto, perché la narrazione si interrompe improvvisamente quando Caterina riesce a riparare nella fortezza di Ravaldino, lasciando i figli e i familiari alla mercé del Valentino. E’ vero che in una breve nota Carla Maria Russo si impegna solennemente a scrivere il seguito della storia, ma ho avuto netta l’impressione di una porta che mi fosse stata sbattuta in faccia. Posso comprendere le esigenze dell’editore, ma resta il fatto che questo comportamento è censurabile e che influisce non poco sul giudizio complessivo dell’opera.
Da leggere, comunque.
Indicazioni utili
Finale in giallo
Secondo me i romanzi migliori di Andrea Vitali sono quelli meno lunghi, di duecento pagine o poco di più; tuttavia non mancano le eccezioni e a tal proposito si deve riconoscere all’autore una capacità non comune nel portare avanti una trama piuttosto esile, come è quella di Premiata Ditta Sorelle Ficcadenti, con tutta una serie di accorgimenti che vanno dai nomi azzeccati dei protagonisti (Giovenca, Zemia, Geremia, Stampina, Novenio) all’invenzione di nuove storie, collegate alla principale, nel momento in cui questa comincia a dare segni di stanchezza. Del resto due personaggi, per certi versi agli antipodi, come la bella e prosperosa Giovenca Ficcadenti e Zemia, la sua sorellastra più brutta della morte, poteva crearli sono uno come Vitali, teso a privilegiare i contrasti netti in modo che una vicenda nel complesso banale potesse diventare una sicura attrazione per il lettore. A un certo punto, però, si deve essere chiesto come pervenire alla fine della storia e allora, in un momento di grazia, ha pensato bene di innestare in una trama non eclatante un risvolto giallo e questo è stata la mossa che ha dato ampio respiro all’opera e che ha consentito di arrivare al termine in un crescendo quasi rossiniano. Vitali ha avuto un intuito felicissimo, con il quale ha riscattato una prosa altrimenti tutto sommato scialba, ma che poi ha incatenato il lettore per circa un centinaio di pagine, desideroso di conoscere una soluzione da subito nota, ma che vedeva coinvolto un personaggio che fino ad allora aveva riscosso unanimi simpatie. Diavolo di uno scrittore che, come un mago, ha tirato fuori dal cappello un’opera dall’andamento lento per tre quarti e decisamente veloce per il resto. E infatti, quando cominciavo a stancarmi, sono stato colto improvvisamente da un raptus di conoscenza che mi ha fatto ingoiare quel centinaio di pagine in un battibaleno.
Da leggere, magari in spiaggia sotto l’ombrellone, oppure in camera da letto prima che colga il sonno, e comunque in ogni caso senz’altro da leggere.
Indicazioni utili
Le Alpi in guerra e in pace
Quest’anno ricorre il centenario della fine della Grande Guerra, l’ultima guerra di indipendenza, secondo la tesi di alcuni storici che tuttavia considero semplicistica e volta a sviare l’attenzione da quello che a tutti gli effetti fu un conflitto di aggressione a una nazione ex alleata. Il nostro fronte, all’incirca dal massiccio dell’Ortles fino a poco più a nord della foce del Tagliamento, correva per lo più in montagna, a tratti su rilievi molto alti, altre volte su alture un po’ meno svettanti verso il cielo e se è vero che la maggior parte dei soldati di ambo le parti fu impegnata sul basso e tormentato Carso, resta però il fatto che più di armata ebbe a combattere sui monti, spesso a quote elevate.
Di questi scontri su scenari spesso di sconvolgente bellezza ci parla Alpi di guerra, Alpi di pace, un riuscito libro di Stefano Ardito che presenta una particolare caratteristica che non potrà che riuscire gradita ai lettori. Infatti, i vari capitoli in cui si compone l’opera parlano di tratti di particolare interesse del fronte e descrivono ciò che avvenne, le battaglie che si combatterono, per poi, ogni volta, tornare ai giorni nostri sui luoghi della contesa, fornendo preziose indicazioni per mettere i piedi laddove un centinaio di anni fa italiani e austriaci si combatterono, spesso ferocemente. Se a volte queste località sono difficilmente accessibili a chi non ha pratica di alpinismo a livelli elevati, come nel caso del Corno di Cavento nel Gruppo Adamello-Presanella, altre invece sono raggiungibili anche da anziani e bambini, come Monte Piana, vicino alle Tre cime di Lavaredo. Per chi è appassionato di montagna come me è stato un vero piacere leggere le descrizioni dei posti, dei percorsi, delle viste panoramiche che si possono avere da alcune cime, ma se la montagna è il palcoscenico, gli attori di quella tragedia umana che è la guerra sono presenti sempre in queste pagine, a volte visi anonimi, altre personaggi che loro malgrado sono diventati noti; mi è piaciuto constatare che Ardito guarda questi protagonisti con occhi di pietà, siano essi alpini, siano Kaiserjager, il che non esclude che sappia vedere con realismo e che, libero da qualsiasi tendenza retorica, una volta per tutte dica delle verità che nei libri scolastici non sono presenti, vale a dire la totale incapacità e indifferenza per la vita umana dei nostri comandi superiori che immolarono tante vite inutilmente, così come evidenzia giustamente che a fronte di uno sparuto gruppo di irredenti trentini la stragrande maggioranza degli abitanti del Sud Tirolo di lingua italiana era fedele al suo imperatore e all’Austria.
Alpi di guerra, Alpi di pace è un libro che merita senz’altro di essere letto.
Indicazioni utili
I maneggi per arrivare all’altare
C’è qualcuno che ha voluto vedere dei richiami manzoniani in quest’opera che si può tranquillamente definire un romanzo storico, ma mi sembra francamente eccessivo e, soprattutto, non corretto, giacché del lavoro del grande Manzoni non ha assolutamente nulla, nemmeno, magari anche solo in parte, la trama. Un matrimonio mantovano è invece una testimonianza storica di quella che è stata la civiltà contadina, con i suoi riti e le sue superstizioni, emblemi probabilmente indispensabili in un mondo legato alla terra a tal punto da esserne parte, soggetto ai capricci del tempo e all’oneroso lavoro proprio del contadino.
La vicenda è quella relativa al matrimonio di Felicita, figlia di un coltivatore della terra che è riuscito a elevarsi al rango di padrone. Ma, prima dello sposalizio, c’è tutto un periodo di tempo necessario per la ricerca del futuro sposo e, una volta trovato, per riuscire ad accalappiarlo.
I maneggi, gli artifici, le piccole trappole poste in essere sono la parte migliore di un libro che si fa anche apprezzare per la capacità dell’autore di descrivere un piccolo borgo e i suoi abitanti. Il paese, sito nel mantovano, si chiama Gazzuolo, dove appunto Nuvoletti è nato e dove il padre, ingegnere, nonché conte, aveva diversi fondi agricoli. I nuovi Renzo e Lucia come potremmo definire, sono figli del popolo, per quanto diventati abbienti in forza del duro lavoro dei genitori, e sugli stessi è imbastita l’intera struttura, con il corollario di una serie di personaggi che si possono trovare solo nelle piccole realtà. Dunque, in questa Italia del 1912, epoca della storia, l’autore, ovviamente conte pure lui come il padre, preferisce rendere protagonisti due individui che si potrebbero definire della nuova borghesia, non omettendo però la peculiarità dei nobili e quindi inserendo nella vicenda le figure di una vecchia marchesa vedova e di un conte avanti con gli anni, smaliziato per i trascorsi giovanili, ma paternamente benevolo. E se da un lato l’attribuzione di una certa benevolenza alle figure degli aristocratici rientra in un comprensibile desiderio dell’autore di farli apparire diversi, protettivi, autorevolmente presenti, dall’altro sembra volerci dire che si tratta delle ultime figure di una classe sociale in decadenza e che il turbine della seconda guerra mondiale avrebbe spazzato via.
La mano dell’autore è leggera, la lingua italiana è utilizzata come si deve, la trama è avvincente e la lettura, sempre gradevole, corre veloce, pur necessitando di qualche sosta per opportune riflessioni, per un tentativo di paragone fra un mondo così lontano e il nostro, fra un’epoca in cui il tempo pareva scorrere lento e la nostra in cui le lancette girano troppo velocemente. Quello era un mondo in cui i contatti fra giovani degli opposti sessi dovevano seguire un rigido cerimoniale, fatto agli inizi di occhiate, di pudici e brevissimi sorrisi, per arrivare con gradualità al fatidico giorno del matrimonio, dopo il quale tutto era concesso.
Un matrimonio mantovano, la cui lettura all’inizio incuriosisce, ma che poi, procedendo sempre più celermente, appassiona è quello che si potrebbe definire un autentico gioiellino.
Indicazioni utili
Collaborare, o non collaborare?
Arrigo Petacco affronta un tema che non è molto noto ed è senz’altro meno conosciuto di quello che, relativamente ai nostri soldati imprigionati dopo l’8 settembre 1943 nei lager tedeschi, vide offerta loro la possibilità di abbandonare le dure condizioni di vita per arruolarsi nel neonato esercito della Repubblica Sociale Italiana, offerta che fu accolta da un numero assai limitato di prigionieri. Lo storico spezzino qui invece si interessa della condizione dei nostri militari catturati dalle truppe angloamericane con riferimento a una particolare data, l’8 settembre 1943, cioè quella dell’armistizio, data in cui erano presenti nei campi di concentramento alleati sparsi un po’ ovunque fra Africa, Asia, Australia, Europa e America, circa 600.000 soldati italiani. Preciso che la distinzione fra il prima e il dopo ha più un carattere giuridico che un effettivo aspetto pratico, perché ben poco cambiò con la cessazione delle nostre ostilità nei confronti degli anglo-americani, mentre qualcosa di più significativo avvenne con la nostra successiva dichiarazione di guerra alla Germania. Di questo argomento già sapevo parecchio in quanto mio padre fu catturato nel gennaio del 1941 in Libia durante la vittoriosa avanzata inglese e la nostra ignominiosa rotta; portato ad Alessandria d’Egitto, dopo una lunga marcia nel deserto, fu imbarcato con destinazione Durban in Sud Africa dove rimase fino alla primavera del 1946, allorché rientrò in Italia. Già quasi da subito fu offerto agli italiani di collaborare, che non voleva dire combattere accanto agli inglesi, ma di essere utilizzati per tutti quei lavori di carattere non militare previsti dalla Convenzione di Ginevra. Chi accettava doveva firmare una dichiarazione e diventava un collaboratore, con modesti vantaggi, tuttavia non trascurabili per un prigioniero, quali una minor restrizione. Chi non era di questo parere veniva messo in un lager riservato ai fascisti, in cui il trattamento non era disumano, salvo qualche tentativo un po’ troppo violento per far cambiare idea. Dopo l’8 settembre 1943 e ancor più successivamente alla dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania, la figura del collaboratore assumeva una luce particolare, tanto che la qualifica diventava di cobelligerante, non comunque di combattente alleato, ma in ogni caso con un trattamento migliore e con una certa, per quanto non completa, libertà. Gli altri continuavano a restare nei lager dei non collaborazionisti, per quanto il loro numero continuasse a diminuire per le defezioni. Questi ultimi erano tutti ferventi fascisti? In buona parte sì, ma c’era anche chi aveva un senso rigido dell’onore e che riteneva sconveniente l’idea di dare una mano all’ex nemico. Petacco parla soprattutto di chi scelse di non collaborare, cercando di comprenderne le ragioni, tema senz’altro interessante, ma, se devo essere sincero, affrontato dallo storico spezzino in modo un po’ superficiale, senza mai affondare il bisturi per portare alla luce motivazioni anche recondite, ma basandosi prevalentemente sull’etichetta di fervente fascista. Il saggio diventa così un po’ noioso, anche se a tratti presenta delle impennate di interesse con delle notizie poco conosciute ai più, se non agli addetti ai lavori, come per esempio il lavorio intrapreso dagli inglesi, quando ancora non l’avevano preso prigioniero, per far diventare Amedeo Duca d’Aosta la guida dell’Italia libera, così come era De Gaulle per i francesi, tentativo non riuscito e poi definitivamente abbandonato con la sopravvenuta morte in prigionia dell’eroe dell’Amba Alagi. Inoltre, già si sapeva, ma qui viene riconfermato il pessimo trattamento dei nostri militari nei lager francesi, forse ancora infuriati per la famosa pugnalata alla schiena inferta ai transalpini da Mussolini. A parte qualche altra notizia e la descrizione delle nostre operazioni militari in Africa il saggio di Petacco non riserva altre sorprese, o motivi d’interesse, e si trascina, un po’ stancamente, fino alla fine. Non che non meriti di essere letto, ma mi sembra che l’autore, in altre occasioni meticoloso, qui sia stato un po’ superficiale, mancando di effettuare quegli approfondimenti indispensabili per la natura del tema trattato.
Indicazioni utili
Più forte di un legame di sangue
Che cosa abbia spinto Romain Gary a scrivere La vita davanti a sé (e non solo questa, ma altri tre romanzi) con lo pseudonimo di Emile Ajar non è ben chiaro, tanto più che di questa attribuzione effettiva siamo venuti a conoscenza solo dopo il suicidio dello scrittore. Infatti, in forza della pubblicazione postuma di Vita e morte di Emile Ajar, si venne a sapere che quell’Emile Ajar vincitore cinque anni prima del prestigioso Premio Goncourt con La vita davanti a sé altri non era se non Romain Gary. A onor del vero, se pur la psiche di Gary fosse particolarmente complessa, non è improbabile che la scelta di un altro nome da dare come paternità della sua produzione fosse anche dovuta al fatto che, in parte a ragione, si riteneva perseguitato dalla critica letteraria, che dopo l’attribuzione del Premio Goncourt 1956 con Le radici del cielo lo incolpava di non essere stato capace di ripetersi con libri di eguale valore. Per ironia della sorte anche La vita davanti a sé ottenne, come ho già scritto, il prestigioso premio Goncourt e la cosa più strabiliante è che riviste di critica letteraria che avevano bersagliato Gary si dimostrarono entusiaste per Ajar. A parziale giustificazione di questo comportamento incongruente devo dire che per stile e argomenti il romanzo in questione sembra effettivamente scritto da un autore diverso, anche se alcuni aspetti tipici di Gary, come per esempio una certa vena poetica, ogni tanto affiorano, nonostante un linguaggio meno ricercato e più crudo.
Ciò premesso, è arrivato il momento di una disamina di quest’opera che, a onor del vero, alla sua uscita ha suscitato opinioni contrastanti e anch’io, benché mi sia piaciuta, ho comunque formulato delle riserve perché in bocca a un bambino certe frasi e certe riflessioni a volte sembrano artificiose, trattandosi di discorsi propri di uomini maturi. Però devo ammettere che il piccolo Momò ha una sua naturale simpatia, una tenerezza nella sua fanciullesca innocenza che coinvolge emotivamente. Periferie squallide dove vivono emarginati gli immigrati, le famose banlieues sono lo scenario, il palcoscenico su cui si svolge una vicenda tutto sommato semplice ma che è un grande romanzo d’amore, non dell’amore fra un uomo e una donna, ma del forte legame affettivo fra il bambino e la donna ebrea a cui è stato affidato, a dimostrazione che non esistono solo i vincoli di sangue e che nel bene e nel male l’esistenza può essere anche motivo di gioia, purché si abbia il desiderio di vivere, concetto molto bello, ma strano in un uomo che poi si suiciderà.
Non era facile da scrivere, era anzi difficile proprio per l’ambientazione, per i personaggi, rappresentanti di un mondo di reietti in cui abbondano protettori, drogati, prostitute, e far uscire da quel letamaio un giglio come Momò per dimostrare che in qualsiasi circostanza la vita comunque vale pena di essere vissuta deve avere quasi provocato nell’autore un’ossessiva ricerca del suo originario e ormai trascorso spirito infantile.
La vita davanti a sé non è un capolavoro come Educazione europea, benché toccato dalla grazia, incline però un po’ troppo, nonostante la rudezza dell’esposizione, a un sentimentalismo neppure tanto velato; è però quel che si dice un romanzo eccellente, dalla gradevole lettura e che lascia un’intensa commozione, facendo nascere un istintivo desiderio di protezione, la voglia di stendere una mano per carezzare il viso piangente di Momò.
Indicazioni utili
L’affabulatore
Sono tentato di aprire e, contemporaneamente, chiudere il discorso a proposito di questo Almeno il cappello scrivendo semplicemente che si tratta del solito Andrea Vitali, cioè che presenta le caratteristiche di tutti i suoi numerosi romanzi, non pochi e forse anche troppi, che hanno una trama che si svolge prevalentemente a Bellano, sul lago di Como, con tanti personaggi tipici di una piccola realtà sempre meno evidente in una società impersonale come la nostra. Sono tentato anche per pigrizia perché in fin dei conti le opere di questo autore lasciano ben poca traccia nell’animo del lettore, ma sono un ottimo mezzo per trascorrere piacevolmente alcune ore. Però, se mi astenessi dal comprendere il perché del successo di Vitali, di questa smania che prende chi legge a passare da un suo romanzo all’altro benché consapevole del modesto spessore letterario, non tributerei all’autore il giusto risalto che dovrebbe avere. Questa sua innata capacità di tessere una tela principale, non evanescente, anzi fitta, in cui confluiscono altre storie, semplici, ma non banali, con personaggi caratterizzati da una ben precisa personalità non è cosa che si possa incontrare facilmente, così come l’indubbio talento di narrare in modo convincente, per non dire affascinante, storie inventate e in fondo poco dotate di credibilità, sono tutti elementi per un giudizio che non deve essere superficiale. Certo in Almeno il cappello questo ragionier Geminazzi, in preda al sacro furore della musica, che fra mille difficoltà vuole trasformare una semplice fanfara in una banda di paese, sembrerebbe di primo acchito un protagonista un po’ sciapo, se Vitali non avesse l’abilità di porgli accanto delle spalle ancor più interessanti e interpreti di storie proprie. E’ forse questo il segreto del narratore comasco, cioè percorrere un sentiero principale, con brevi e rapide variazioni di percorso, che procedono quasi in parallelo, per poi confluire in un’unica strada a conclusione di un lavoro che forse non è convincente, ma è capace di attrarre in modo continuativo.
Credo che Vitali più che essere definito un romanziere possa essere soprattutto considerato un affabulatore, peraltro un abile affabulatore, qualità che fra alti e bassi, ma con un livello complessivamente più che discreto caratterizza tutta la sua produzione, anche questo Almeno il cappello, capace di strappare qualche risata, ma anche di commuovere, insomma un libro senz’altro da leggere.
Indicazioni utili
Un’insperabile ironia
Si è spesso detto che Andrea Vitali per certi aspetti è il successore di quel grande narratore che è stato Piero Chiara; personalmente non sono d’accordo, perché troppa è la differenza di classe artistica fra l’uno e l’altro, e non basta certo la medesima ambientazione di piccolo paese della provincia per colmarla. Tuttavia, almeno in questo Il segreto di Ortelia, il romanziere di Bellano si avvicina a quello di Luino, in una prova dall’esito felice e in cui si narra di una sorta di piccola “Dynasty”. La vicenda di Amleto Serva, giovane garzone senza arte né parte di un commerciante di bestiame che grazie a un matrimonio intraprende una carriera senz’altro rilevante è di per sé motivo d’interesse, ma se a ciò aggiungiamo il carattere sanguigno del soggetto, la voglia smodata di prestazioni sessuali che la moglie, purtroppo, per un difetto fisico non può soddisfare si comprende come la creatività questa volta abbia messo in campo più di un argomento a favore di un’opera attraente. E’ necessario anche precisare che l’unica volta che Amleto è riuscito a congiungersi con la moglie Cirene, nonostante i dolori indicibili della stessa, c’è stato il concepimento di una figlia, Ortelia appunto. L’ambizione dell’uomo, succeduto nel negozio di macelleria del suocero, lo porta a raggiungere traguardi sempre più alti, ma gli rende anche la vita quasi intollerabile al punto che, su consiglio del medico di famiglia, decide di entrare a far parte di una congrega di crapuloni e puttanieri, altro argomento di potenziale interesse. E in effetti, vuoi per il dipanarsi senza intoppi della vicenda, vuoi per un’insperata ironia che accompagna la narrazione, Il segreto di Ortelia è uno di quei libri che paiono ispirati a una delle opere di Piero Chiara, e non solo per le caratteristiche della trama. In queste pagine Vitali ha forse profuso il meglio di stesso, in un particolare momento di grazia, con una pacatezza, e senza mai un eccesso, che sono assai probabilmente le grandi qualità del romanzo. Inoltre, a differenza di altre sue opere, non è lunga, direi anzi che è breve, così che tutta la storia è un riuscito concentrato che non potrà che risultare gradito al lettore.
Indicazioni utili
Un’atmosfera surreale
Villa Carafa, a Bari, ospita il museo delle cere a cui si recano in visita Andrea, all’ultimo anno di liceo, perennemente indeciso nella sua relazione con la fidanzata, e il nonno, un vecchio professore deluso dal fallimento del Socialismo. Quella che. almeno in origine, doveva essere una giornata di pura curiosità si trasformerà in un qualcosa di impensabile, in un viaggio che cambierà per sempre le loro esistenze.
Infatti, in una sorta di allucinazione, le statue di cera prenderanno vita, chiedendo del dopo, cioè di quanto avvenuto dopo la loro scomparsa, e narrando la propria storia. Così faranno il poeta Nazim Hikmet, il guerriero longobardo Erchemperto, il monaco Cassiodoro, il regista, attore e scrittore Carmelo Bene, il brigante Giuseppe Schiavone, Federico II Hohenstaufen di Svevia, suo figlio Manfredi, ultimo sovrano del regno di Svevia, Gottfred il falconiere, ingaggiato da papa Onorio III per spiare re Federico II, Pierpaolo Pasolini, un Leonardo Sciascia dallo sguardo malinconico, e ci sarebbe spazio per molti altri, ma nel caldo afoso della città, con una temperatura interna al museo già elevata per un guasto all’impianto di condizionamento, scoppia un improvviso e vasto incendio. Non vado oltre, per via di un finale del tutto a sorpresa e bellissimo, che chiude nel modo migliore e diciamo unicamente possibile un racconto dall’atmosfera altamente surreale. Come in altre sue opere risalta la notevole fantasia dell’autore, a cui non manca certamente il dono della creatività, ma per quanto la lettura si presenti piacevole e di sicuro interesse il continuo avvicendarsi di personaggi, l’alternarsi di passato e presente richiede sovente un’attenzione particolare al fine di evitare possibili confusioni. E’ l’unico appunto che mi sento di fare a un’opera che comunque mi è piaciuta e che riconferma le eccellenti qualità di Raffaele Nigro, qualità che mi riprometto di verificare con ulteriori letture, con l’auspicio di trovarle sempre più che gradevoli.
Indicazioni utili
Montagne insanguinate
Prima guerra mondiale, la Grande Guerra: il fronte italo-austriaco va grosso modo dallo Stelvio all’Adriatico, un po’ prima di Trieste. Di questa linea irregolare ben 640 chilometri sono in montagna, corrono su ghiacciai, su creste, su cenge, su altipiani, su brevi tratti di pianura. Ci sono rilievi notevoli, che si avvicinano ai 4.000 metri e ci sono le più belle montagne del mondo, le Dolomiti. Gli scenari sono incantevoli, ma anche mozzafiato, con guglie che si inerpicano verso il cielo e altissime colonne di giaccio. In questo ambiente, estremo, surreale, ma anche di sublime bellezza combatterono per tre anni e tre terribili inverni i nostri Alpini da una parte, i Kaiserjager dall’altra, nemici, ma accomunati dal fatto di essere appassionati di questo mondo, tanto bello e incantato, ma anche capace di essere crudele con i suoi rigidissimi inverni, con le valanghe che seppelliscono interi reparti, provocando morti in larga misura, quasi e forse di più di quelli degli scontri veri e propri che, per la natura del terreno, non videro mai impegnate grandi masse di combattenti come invece accadeva a est sul Carso. Di questi eroi ci parla Enrico Camanni; sulla base di diari e di testimonianze, riferisce di episodi che hanno visto protagonisti sia dell’una che dell’altra parte, senza mai enfasi, ma soprattutto riesce a non cadere mai nella retorica, pregio non indifferente, data la materia trattata. L’autore non toglie nulla all’aureola dei protagonisti, ma è chiaramente un pacifista, come traspare chiaramente non poche volte. Fra gli Alpini e i Kaiserjager Camanni non sceglie nessuno, ma parlando di alcuni di loro sceglie la pace, in una narrazione che anche per gli scenari magistralmente descritti si rileva estremamente affascinante, riuscendo a cogliere, accanto all’orrore di un conflitto, la sublime emozione della natura. Non tutti sono personaggi come Damiano Chiesa e Cesare Battisti, o come Sepp Innerkofler, ma sono protagonisti di storie, vere, che restano indimenticabili, e non solo per le azioni belliche vere e proprie, ma per le capacità alpinistiche che dimostrarono nell’adempimento del loro dovere, arrivando al punto di inaugurare nuove, spericolate vie. Ci si può commuovere di fronte alla vicenda dell’ufficiale mantovano Arnaldo Berni, tanto coraggioso quanto sfortunato, e il cui corpo non verrà mai ritrovato, imprigionato sotto tonnellate di ghiaccio, o a quella del sergente Sepp Innerkofler, nota guida, che si immola per difendere il suo paese, ma ciò che resta è l’immagine di uomini che, pur essendo contro, non furono mai effettivamente nemici, troppo uniti dal comune amore per quella montagna che li volle con sé per sempre. Furono a lungo vicini agli angeli e angeli stessi divennero; combattevano per pochi sassi, per speroni di roccia così scoscesi che non di rado lasciavano cadere, travolgendo chi stava sotto, gigantesche valanghe. Se nella guerra ci può anche essere un barlume di logica, lì mancava del tutto, perché si soffriva, si moriva, ci si disperava in uno dei posti più belli del mondo.
Il fuoco e il gelo è un rigoroso libro di storia, ma ha il sapore di un romanzo, di un racconto irripetibile e avvincente come pochi.
Indicazioni utili
Con la spada e con la preghiera
L’espansione mongola a occidente degli Urali iniziò nel 1236, abilmente condotta da Batu, nipote del grande Gengis Khan. Dopo aver soggiogato la Russa e l’Ucraina le orde selvagge si riversarono nel centro dell’Europa, sconfiggendo eserciti, saccheggiando e compiendo ogni genere di nefandezze.
Queste tribù di guerrieri nomadi, che i Cristiani chiamarono tartari, sembrò non avessero ostacoli e che per loro tutto fosse possibile, perfino la conquista dell’intera Europa. In questo contesto si narra la vicenda che vede protagonista Eustachius von Felben, monaco guerriero dell’ordine dei cavalieri teutonici che ritorna dalla Terrasanta con pochi compagni, scortando altresì un mercante veneziano, latore di un importante messaggio del Doge per il Gran Maestro dell’ordine in Prussia, nonché, di un dono di inestimabile valore religioso, oltre che intrinseco, rappresentato da una croce ricoperta di gemme, già di proprietà di Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino. Il viaggio, di per sé non facile in periodo di pace, diventerà quasi un incubo a causa delle continue incursioni dei cavalieri tartari che arriveranno anche a sottrarre il prezioso carico del mercante veneziano. Fra combattimenti all’ultimo sangue, battaglie che registrano le sconfitte dei cristiani, in un turbinio di eccidi, di crudeli torture e anche di sorprese, spesso gradite, la missione di von Felben arriverà a felice conclusione, con il recupero peraltro della preziosa reliquia. Guido Cervo ha fatto del romanzo storico la massima espressione del suo talento artistico, ambientando vicende in epoche diverse, ma sempre supportate da preziose ricerche storiche che danno alle opere la parvenza di veridicità, come se questo Eustachius von Felben fosse esistito veramente, e forse può esserci stato un personaggio con caratteristiche simili, visto che i cavalieri dell’Ordine Teutonico, dei veri e propri monaci guerrieri, presentavano la particolarità di una totale dedizione alla causa comune, simili ai Templari, ma per lo più di origine tedesca. E’ un romanzo in cui è preponderante la trama, ma molto curata appare sia la caratterizzazione dei personaggi, che l’atmosfera, ricreata sapientemente; se pur inferiore a mio giudizio a I ponti della Delizia e a Bandiere rosse, aquile nere, opere ambientate in epoca assai più recente, è in grado di essere apprezzato dal lettore per la continua tensione e l’indubbio coinvolgimento, che avviene fin quasi da subito. In buona sostanza, invito a leggere Il Teutone. La croce perduta, perché sono sicuro che non potrete che esserne soddisfatti.
Indicazioni utili
Bestie, e non animali
Pardini ci ha abituato, con i suoi romanzi e con i suoi racconti, a descrivere un tempo in cui uomini e natura, ma soprattutto uomini e animali erano capaci di interagire, di convivere in una posizione sostanzialmente paritaria; non è un’Arcadia di cui ci parla, ma è una realtà che attualmente, presi da interessi secondari che riteniamo invece primari, ci sfugge e non vedendola ci priviamo della facoltà di essere liberi in un mondo di liberi. E’ stato quindi con un certo stupore che, leggendo i racconti di questa raccolta intitolata Banda randagia, ho trovato argomenti ben diversi e soprattutto svolgimenti di temi che non ricordano lo stile di scrittura tipica dell’autore lucchese. Si è infatti in presenza di noir, che non di rado sfiorano l’horror, ma soprattutto c’è una violenza sotto tutti gli aspetti che mi ha invero sconcertato. Il Pardini misurato di Il postale, tanto per citare una sua opera, lascia spazio qui a una inusuale tensione emotiva che esplode in una aggressività rabbiosa, in un eccesso che probabilmente si ritrova nei delinquenti psicopatici o paranoici, quali sono quasi tutti i protagonisti dei racconti. E questo eccesso è presente pure sotto l’aspetto sessuale, in cui i rapporti non sono per niente sfumati, ma sbattuti sotto gli occhi di tutti con descrizioni che non sono proprie della scrittura erotica, ma vanno oltre, sfiorando la pornografia. Mi riferisco in tal caso a due racconti, La moglie del serpente, con rapporti saffici, e Lo chiamavano orso, intriso di passioni omosessuali. Questione di gusti, ma questi due non mi sono piaciuti, a differenza di altri due che da soli valgono la pena di acquistare questo libro. Mi riferisco a Banda randagia, che dà il titolo all’opera, e che è tutto sommato un normale noir con la figura di uno psicopatico che diventa un serial killer, uccidendo a destra e a manca, ma il crescente disagio psichico è descritto felicemente, tanto che l’attesa nel lettore di arrivare alla fine cresce di pari passo con il delirio di onnipotenza tipico di questi soggetti; ed è l’unico racconto in cui ritrovo il Pardini capace di far parlare gli animali, di dare loro una personalità quasi da homo sapiens che così tanto ho apprezzato in altri suoi lavori; è un racconto bellissimo, quasi un piccolo romanzo breve, da cui ho ritratto impressioni positive su un senso di giustizia universale che non è dell’uomo, ma della natura. L’altra prosa che ha incontrato i miei favori è Ferrovia parallela, un viaggio da incubo in un incubo, la parabola di un uomo che si accorge di non poter definire la propria esistenza, perché altri, dal volto ignoto, decidono per lui senza che possa interloquire; in questo treno che viaggia senza mai fermarsi c’è tutta la vita di ognuno di noi, c’è il nostro destino che non possiamo cambiare. Mi è piaciuto, ma in misura minore, anche Il Roero, con un altro viaggio in treno, dove un uomo che rincorre il suo psicanalista si trova in una situazione di pericolo allucinante, partecipe di un giallo breve di cui non intendo dire altro per non anticipare troppo.
Mi sono chiesto il perché di questi racconti così diversi dalla consueta produzione dell’autore e non ho trovata altra risposta se non nell’attività svolta in precedenza; forse l’essere stato guardia giurata e magari qualche esperienza legata a questa professione hanno fatto scattare la molla della creatività, anche se credo – la mia però è un’ipotesi – che Pardini, uso a parlare di rapporti fra uomini e animali, abbia inteso questa volta narrare di bestie, cioè di quel che diventa l’uomo quando delinque.
Sono dell’opinione che, per quanto Banda randagia mi sia sembrata un’opera minore nella eccellente produzione di Pardini, sia comunque meritevole di lettura per le motivazioni che ho sopra esposto, nonché per la capacità di sondare l’animo umano, scoprendo il suo lato più oscuro.
Indicazioni utili
Nulla è ciò che sembra
Quando un romanzo di Vitali, che è sostanzialmente una commedia degli equivoci, parte bene si può essere certi che l’autore riesce a condurlo con mano sicura fino all’ultima pagina. Se poi alla consueta ambientazione (il grazioso paese di Bellano) e a personaggi che sembrano delle caricature si accompagna la figura del maresciallo dei Regi Carabinieri Maccadò, dando una punta di giallo all’intera trama, si può star sicuri che il divertimento è assicurato. In A cantare fu il cane accade di tutto, con un tentativo di furto che serve però a coprire ben altre cose e che fa da fil rouge, e con la ricerca di un rampollo di una famiglia borghese che pare sia fuggito con l’ammaliante Omosupe, illusionista ed escapologa, l’effettiva grande attrazione del circo Astra, famosa per l’esibizione del suo ombelico che tanto fa eccitare i maschi del paese.
Tutto quanto è non ciò che sembra e Maccadò avrà il suo bel da fare per venire a capo delle sue indagini, coadiuvato dai suoi due carabinieri dai nomi indovinatissimi (Grafico e Virgola) e dall’appuntato Misfatti che incapperà in una disavventura da far sbellicare dalle risate.
Di più non posso dire, o meglio non riesco a dire, perché il romanzo non vive su un unico equivoco, ma su molti altri che nascono pagina dopo pagina grazie all’inesauribile vena dell’autore.
A Vitali qualche volta la torta non riesce bene, nel senso che l’opera, fragile sin dall’inizio, si ammoscia pagina dopo pagina, ma in questo caso, con A cantare fu il cane, non è così e assicuro che il libro consente di trascorrere alcune ore di sereno svago.
Indicazioni utili
Un grande piccolo borgo
Mi corre l’obbligo di effettuare una doverosa premessa relativa all’autore, da me conosciuto una decina di anni fa in occasione della pubblicazione di un mio libro con un comune editore, Il Foglio Letterario, piccola, ma solo a dimensioni, realtà imprenditoriale; in quella circostanza, oltre a conversare piacevolmente con Naspini, ho ritratto la sensazione di trovarmi di fronte a un narratore di grandi speranze, sensazione che ha trovato poi una conferma nella lettura delle sue prime opere, vale a dire I sassi, un noir che privilegia gli approfondimenti di carattere psicologico, e L’ingrato, una storia di paese che è il pretesto per una spietata denuncia della maldicenza. Soprattutto quest’ultimo presenta caratteristiche e peculiarità proprie di un artista esperto e consumato, elementi positivi che si ritrovano in genere al culmine di una lunga carriera letteraria e non certo ai suoi inizi, a inequivocabile prova che in Naspini non c’è solo talento, ma quello stato di grazia proprio dell’artista a tutto tondo. Sono seguite poi altre opere, di cui l’ultima, Il gran diavolo, è un romanzo storico incentrato sulla figura di Giovanni dalle Bande Nere, un genere che non è peculiare del narratore toscano, ma il cui risultato è stato tuttavia ampiamente soddisfacente. Ritorna ora, in un certo senso sulle orme dell’Ingrato, questo Le case del malcontento, un’opera di per sé quasi ciclopica con le sue 464 pagine (romanzi così corposi non frequenti al giorno d’oggi), ma non gli si può certo imputare di aver voluto tirare in lungo o di essere stato dispersivo, anzi ho l’impressione che si sia frenato, perché avrebbe potuto scrivere ancora di più.
Le Case è un paese, un borgo della Maremma toscana, un insieme di abitazioni e di rocce, di cave, di strade con grandi curve, insomma una piccola realtà talmente a sé stante da considerarla quasi un enclave nell’ambito di uno stato assai più esteso; eppure, riflette, nei suoi personaggi, e pur con le tipicità di un mondo provinciale, le presenze quotidiane in cui normalmente ci imbattiamo e di cui noi stessi siamo parte. E di questo agglomerato Naspini narra una storia, o meglio racconta tante piccole storie che finiscono con il fondersi in un racconto assai più grande, un racconto corale che porta il lettore da casa in casa, dal termine della guerra alla fine del secolo scorso. Peraltro l‘impostazione strutturale è di una originalità particolare, perché l’opera inizia con la pianta del borgo e ogni casa ha il suo nome e ognuno di questi nomi, congiuntamente ad altri, è uno dei narratori, così che ogni capitolo comincia con un nome che racconta, che spazia dal passato al presente; ogni nome è protagonista, racconta di sé, ma anche di sprazzi della vita di altri, che possono benissimo essere smentiti o visti in altro modo, insomma una complessa realtà in cui tutti sono dipendenti l’uno dall’altro, e ognuno è tutto e il contrario di tutto. Ciò che in realtà Naspini narra è un mondo che sta in piedi con fragili puntelli, caratterizzato da inganni e da segreti, destinato, e non potrebbe essere altrimenti, prima o poi a implodere. Mi pare evidente che se si pensa all’attuale realtà non è difficile comprendere che è tutta la nostra Società a dare vita alle case del malcontento.
Le Case è pertanto una metafora di un realtà che non vogliamo vedere, come se a nascondere la verità la menzogna potesse diventare verità, atteggiamento che inevitabilmente prima o poi finirà con il travolgerci.
Lo stile è fresco, scorrevole, la tensione è in costante crescita, pagina dopo pagina, così da risultare il romanzo piano piano avvincente, avviluppando il lettore in una rete in cui la commistione di diversi generi, anziché risultare sgradita, affascina, convince ed è un altro dei motivi di pregio del libro. A voler cercare un difetto è un po’ difficile trovarlo, anche se c’è il rischio concreto, di perdersi, di fare confusione con tanti personaggi che quasi si spintonano per mettersi in luce, ma è un peccato da poco, quello che si potrebbe definire veniale, perché in fondo che sfugga un nome, o si confonda l’uno con un altro poco importa, perché determinante è l’immagine che viene a crearsi di una piccola e chiusa realtà, coincidente però con il mondo intero di cui essa stessa è parte. Forse gridare al capolavoro può sembrare eccessivo, ma se non è tale, e al riguardo ho più di un dubbio, Le case del malcontento è almeno di un elevato livello di eccellenza.
Indicazioni utili
La guerra sull’Isonzo vista dall’altra parte
Undici grandi battaglie sull’Isonzo si conclusero con un quasi nulla di fatto, se si eccettua la presa di Gorizia, ma con gravissime perdite e, soprattutto, con pesanti strascichi sul morale delle nostre truppe, i cui effetti negativi, unitamente a gravi responsabilità dei comandanti, si sarebbero visti in occasione della dodicesima battaglia, quella nata dall’offensiva austriaco-tedesca e che si concretizzò nella disfatta di Caporetto. Fritz Weber che durante la Grande Guerra era tenente d’artiglieria sul fronte italiano, autore di altre celebri opere come Guerra sulle Alpi (1915-1917) e Tappe della disfatta, con questo volume in cui predomina l’aspetto storico sulle vicende personali parla appunto delle dodici battaglie dell’Isonzo e lo fa con quella sostanziale imparzialità presente anche negli altri suoi due libri. Certo ha un occhio di riguardi per l’esercito imperiale, di cui faceva parte, ma non lesina giudizi negativi sulla condotta delle operazioni, né si esime da apprezzamenti sul valore del nemico; in ogni caso la sua penna è guidata da un profondo senso di pietà per chi combatté disperatamente, morendo o restando gravemente ferito, lungo quel fiumiciattolo che risponde al nome di Isonzo e che negli intendimenti del nostro Stato Maggiore avrebbe dovuto rappresentare il punto di partenza per l’invasione dell’impero asburgico. Da un lato Cadorna mandava all’attacco frontale i suoi soldati, con conseguenti immani perdite, dall’altro Borojevic imponeva alle sue truppe di resistere a oltranza, contrattaccando ove fosse stato possibile. Questa tattica militare spiega pertanto l’elevato numero di caduti sugli opposti fronti, e senza che ci potesse essere una soluzione definitiva, perché se gli italiani non sfondavano, era altrettanto vero che gli austriaci, peraltro inferiori di numero, non potevano sperare in una vittoria determinante con una tattica d’arresto. Era una situazione di stallo, imposta dal terreno e dagli elementi contingenti, ma le cose avrebbero potuto essere molto diverse se, nei primi giorni di guerra, Cadorna avesse osato un po’, visto che il fronte austriaco era difeso da un velo di truppe; né mai al generale italiano venne in mente una mossa geniale come quella inventata da Conrad von Hotzendorf nella primavera del 1916 con la famosa Strafexpedition, fermata sì dall’eroismo dalle nostre truppe, ma soprattutto dal ritiro di numerosi reparti imperiali per essere avviati al fronte orientale onde contrastare una profonda offensiva russa, peraltro reclamata a gran voce dal nostro Stato Maggiore, messo alle strette dalla dirompente avanzata nemica sugli altipiani. Non dico che Cadorna avrebbe dovuto necessariamente attaccare sulla direttrice Asiago – Lavarone, ma ci fu più di un’occasione in cui un’azione ben congegnata in Valsugana avrebbe potuto portarci rapidamente a Bolzano e da lì al Brennero, minacciando di avvolgimento lo schieramento austriaco postato lungo l’Isonzo.
In Dal Monte Nero a Caporetto l’esperienza bellica di Fritz Weber ha un peso piuttosto modesto e a prevalere è invece la ricerca storica, a tutto beneficio della comprensione di certi eventi, fra i quali appunto lo sbandamento del nostro esercito in occasione della dodicesima battaglia, ed è importante sentire il suono dell’altra campana, la quale ribadisce l’incapacità dei nostri comandi a comprendere il senso di un’azione congiunta e manovrata di ampio respiro, che avrebbe potuto giustificare le grandi perdite con la conquista di vaste zone e con la minaccia non certo velata di puntare su Vienna. Quindi rispetto e onore per i nostri soldati e critiche, non infondate, per i nostri comandanti; per quanto concerne poi l’esercito austriaco c’è una partecipata commozione alla sorte di tanti militari di diversa nazionalità, ma tuttavia fedeli a un impero agonizzante ancor prima dell’inizio del conflitto; per i comandanti imperiali in genere c’è rispetto e anche stima, pure loro vittime di un regime morente. Per chi vuole conoscere un po’ di più la storia della nostra Grande Guerra Dal Monte Nero a Caporetto rappresenta un saggio utile e per niente greve, un’opera quindi che mi sento di consigliare anche perché dalla lettura di fatti che ci riguardano scritti da un ex nemico si possono solo trarre apprezzabili insegnamenti e ragionevoli metri di giudizio.
Indicazioni utili
Il miracolo delle parole
Fra i soppalchi di una libreria c’è una statua lignea del XVI secolo raffigurante la Madonna, e per la precisione Santa Maria delle Battaglie. In quella camera c’è anche un letto dove dorme, in attesa di un quasi impossibile, ma tanto bramato risveglio Federica, una ragazza vittima di un incidente stradale che l’ha ridotta in quello stato comatoso. Tutto si fa perché esca da quell’immutabile torpore: la televisione sempre accesa, l’infermiera che continua a parlarle, ma c’è anche chi comunica con lei in silenzio, in ciò pregata dalla madre dell’inferma: è quella statua che le narra dei suoi avi, una storia stupenda che ha appreso dai versi del cantastorie Colantonio Occhiostracciato. Quella camera fa parte di una villa in cui vivono, separati dalle loro passioni, i genitori di Federica, lui un filosofo, per sua natura portato a una vita quieta e riflessiva, lei una giornalista, continuamente in prima linea.
In pratica là si consumano due drammi: quello di una giovane bellissima che ormai vegeta e quello di un uomo e una donna uniti solo dall’incomunicabilità.
Per quanto diverse le cause, uguali sono gli effetti; il silenzio fra i coniugi si intuisce, pare un fatto ormai assodato e assolutamente impossibile da sanare; poca speranza c’è per il risveglio di Federica, ma nondimeno la Madonna delle Battaglie continua a parlarle, perché in ciò è stata pregata da Magdalena, la madre della ragazza. Le vicende degli avi, di quel figlio, che da scapestrato diventerà un difensore della cristianità, figlio nato da una relazione pressoché incestuosa fra zio e nipote, gli scontri inevitabili fra gli spagnoli che comandano in meridione e i francesi che vorrebbero soppiantarli con l’aiuto dei Turchi, hanno un ritmo incalzante, proprio dei romanzi d’avventura, ma non tralasciano tuttavia di soffermarsi sul senso della vita, su quella ricerca affannosa che anima e divora non pochi uomini. E in questo contesto prende corpo una tenzone fra Braccio Cacciante (questo è il nome del figlio del peccato) e il famoso pirata Khair ed-Din, il Barbarossa, dapprima per una donna, ma poi per dare un senso alle loro esistenze. La sfida continuerà, una volta morto Braccio, con suo figlio Belisario, diventato un virtuoso dei fuochi pirotecnici, ma anche in questo caso senza che uno prevalga sull’altro, perché è troppo importante avere nella vita qualcuno con cui misurarsi.
Se I fuochi del Basento mi aveva impressionato, entusiasmandomi, questo Santa Maria delle Battaglie é stata un’emozione continua e crescente, perché, al di là della vicenda narrata, non si può restare indifferenti alla creatività visionaria di Raffaele Nigro che porta perfino davanti agli occhi del lettore lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d’artificio, grazie a uno stile di rara efficacia, con una scrittura che sembra scivolare sul foglio. La capacità descrittiva è quasi incredibile, tanto che le scene si susseguono come in una pellicola cinematografica. Ci sarebbe da dire che a ogni pagina si attende il miracolo della Madonna, ma il miracolo, così come auspicato, cioè la guarigione non ci sarà, eppure possiamo parlare tuttavia di miracolo, di un qualcosa di speciale che risiede nella forza delle parole, capaci di far ricordare il passato e quindi di consentire agli uomini di essere artefici del proprio presente e del futuro.
Mi piacerebbe aggiungere qualche altra considerazione, perché il romanzo merita tanto, ma per quanto cerchi dentro di me sono sopraffatto da un’emozione intensa, da quel senso di entusiastico appagamento che mi coglie quando ho la certezza di aver letto un capolavoro.
Indicazioni utili
Meglio lasciar perdere
Ai libri di Vitali non si può chiedere molto se non di consentire di passare alcune ore in tutta tranquillità e magari piacevolmente. Quando questa semplice aspettativa viene disattesa è ovvio che la lettura diventa particolarmente faticosa, soprattutto se ci si accorge che l’autore tira in lungo con il solo scopo di riempire pagine. E’ questo il caso di La ruga del cretino, titolo invero un po’ infelice, soprattutto se si guardano gli scarsi contenuti dell’opera. E pensare che, per l’occasione, alla penna di Vitali si è unita quella del noto criminologo Massimo Picozzi, anche se in questo caso si può tranquillamente dire che l’unione non la forza. Per scrivere il romanzo il narratore comasco parte da lontano, un po’ troppo da lontano, dilungandosi in eventi di poco, per non dire di nessun interesse; che cerchi di aggiungere pagine a pagine è abbastanza evidente, ma non è la corposità che può decretare il successo di un’opera, bensì il suo contenuto e la sua trama. Considerato che il primo è sempre assente, sarebbe stato logico trovare una vicenda abbastanza appassionante, ma così non è, tanto che dopo dieci pagine ho cominciato a innervosirmi, dopo altre dieci a sbadigliare e, arrivato a pagina 32, ho spento la luce (ero a letto) e mi sono addormentato. Penso che sia superfluo che aggiunga che a quella pagina la mia lettura si è fermata e non è più ripresa; è un peccato perché, pur considerando Vitali più che un artista un buon artigiano della penna, in questo caso non è riuscito a concretizzare il solito diligente romanzo e di conseguenza il mio giudizio non può essere che negativo e tale da sconsigliarne la lettura.
Indicazioni utili
Il torpore di Simenon
Simenon, la cui scrittura è attenta ai particolari al punto di rasentare la pignoleria, ogni tanto tuttavia si prende un periodo di svago, durante il quale scrive romanzi che, se fossero di altri autori meno blasonati, si potrebbero considerare nel complesso soddisfacenti, ma, portando in calce invece quella firma così nota, si rivelano per essere delle prose invero modeste, magari con una trama interessante, ma prive di tutte quelle caratteristiche positive che così tanto hanno indotto il pubblico dei lettori ad apprezzare l’autore belga. Prendiamo questo romanzo di navigazione, che forse vuole evocare, non riuscendoci, certe atmosfere tipiche di Joseph Conrad, un noir privo di una vera e propria tensione, con parecchi rallentamenti nel ritmo, in contrasto con la dinamicità dell’ambiente (il mare del Nord in tempesta), ebbene se all’inizio riesce a presentare qualche motivo di interesse poi, piano piano, procede stancamente e così si arriva alla fine con la scoperta dell’assassino di turno che lascia alquanto basiti, perché se è vero che era il meno sospettabile, è altrettanto certo però che la soluzione si presenta tutt’altro che logica. C’è qualche pagina buona, come se occasionalmente Simenon si fosse scosso dal torpore che lo aveva pervaso, ma questo implica che appaiano ancor più stridenti quelle parti – e sono molte – in cui c’è più verbosità che sostanza.
Peccato, a fronte di tanti capolavori mano a mano che procedo nella lettura della corposa produzione letteraria dell’autore mi imbatto, ormai con una certa frequenza, in opere che, solo per rispetto nei confronti di un grande scrittore, non esito a definire minori, se non marginali.
Indicazioni utili
- sì
- no
Senza retorica, solo pietà
E’ passato ormai ben più di mezzo secolo da quei quasi 4 anni (1942 – 1945) così gravidi di eventi e di sofferenze per il nostro paese, in pratica dalla sconfitta delle truppe dell’Asse a El Alamein, all’invasione della Sicilia, alla defenestrazione di Mussolini nel corso della seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, all’armistizio dell’8 settembre 1943 con con conseguente occupazione tedesca del nostro suolo, alla nascita della Repubblica Sociale Italiana, ai lunghi mesi di una guerra civile che finì solo con la liberazione degli alleati il 25 aprile 1945. Più trascorre il tempo da un periodo storico, più si raffreddano gli animi, più il raziocinio prende il sopravvento sulla passione e quindi meno difficile, ma ancora tutt’altro che facile, è imbastire un romanzo storico ambientato in un periodo così travagliato. Guido Cervo ha voluto cimentarsi in proposito e mi sento di dire che il risultato è ampiamente positivo. Questo narratore ha capacità di profonde analisi storiche, sa sapientemente accostare personaggi realmente esistiti a frutti della sua creatività, è in grado sempre di trasmettere al lettore la sensazione che quanto scritto sia una cronaca reale, e questo grazie a uno stile non ridondante e all’abilità di descrivere i protagonisti con pochi e sicuri tratti di penna. Bandiere rosse, aquile nere si riallaccia, idealmente, a I ponti della Delizia, stupendo romanzo di Cervo sulla ritirata di Caporetto nella Grande Guerra. Infatti troviamo tre dei protagonisti di quell’opera, la maestra Ersilia che si è sposata con l’ex tenente degli arditi Ferruccio Martinelli, pure lui presente e diventato seniore della milizia fascista, nonché l’allora piccola Anna, dagli stessi adottata, ma cresciuta con idee politiche totalmente contrapposte a quelle dei genitori, fuggita da casa seguendo il sogno comunista. La famiglia Martinelli è composta anche dai figli avuti dopo il matrimonio, un’altra femmina, molto giovane e che nel romanzo è quasi una comparsa, due maschi, Alberto tenente dei bersaglieri che ritornerà dall’Africa gravemente ferito e menomato ed Eugenio, impulsivo, desideroso di battersi e che aderirà fra i primi alla X Mas. Il lungo e tormentato periodo dalla guerra darà luogo a tante vicende in cui oltre a vedere come attori principali i membri della famiglia Martinelli registrerà la partecipazione di tanti personaggi, alcuni dei quali di grande spessore, come il terrorista dei Gap Stefano Zanderighi, una figura apparentemente minore, ma a cui viene demandato il compito, non certo facile, di precipitare nella disumanizzazione per poi tentare con fatica di riemergere, di cercare una vita propria lontana da tensioni adrenaliniche e da ogni violenza.
Ci siamo sempre chiesti il perché, dopo l’8 settembre 1943, ci siano state scelte così contrastanti e che portarono alla guerra civile. Indubbiamente, in un frangente come quello dell’improvviso armistizio, non fu facile prendere una decisione, anche se fu certamente più difficile quella di prendere la via della montagna per combattere gli occupanti tedeschi e poco dopo anche i Repubblichini. Privi di organizzazione all’inizio, quasi disarmati, con pochi viveri non fu certamente una scelta a cuor leggero quella di diventare partigiani, anche perché si trattava di sconvolgere un modo di vita instillato da anni di dittatura, in un regime progressivamente inviso con il progredire di una guerra sanguinosa. Dall’altro lato, posso capire chi accampò motivi di onore, di coerenza di comportamenti, decisioni forse rispettabili, tanto più che ben si sapeva, o comunque si intuiva, che la guerra era persa. Questi dilemmi, queste lacerazioni interiori sono parte della narrazione e non potrebbe essere diversamente, perché a parte i fanatici, gli approfittatori, coloro che vedevano una possibilità per esprimere il loro animo criminale, gli altri si trovarono di fronte a una scelta assai difficile. Il romanzo non fa sconti a nessuno, né alle violenze della Guardia Nazionale Repubblicana, né a quelle dei partigiani che soprattutto a guerra finita insanguinarono il paese. Cervo però ha un pregio, racconta, non prende le parti di nessuno, ci mostra così come è stato un lungo orrore e lo fa senza enfasi, così come da cronista attento e indipendente descrive con grande abilità i bombardamenti aerei su Milano, con una prosa talmente realistica che si avverte la tensione, sembra di udire il suono della sirena d’allarme, si avverte il crescente sibilo delle bombe che cadono, si assiste impotenti alle distruzioni. Devo dire che francamente questo romanzo mi ha stupito per la capacità di comprendere e di far comprendere le opposte motivazioni, perché non c’è odio, ma solo tanta pietà per un dolore immenso che ha sconvolto l’Italia più di mezzo secolo fa.
Da ultimo, ho ritratto l’impressione che giunto all’ultima pagina sia rimasta una certa sospensione, quasi che possa essere sottesa l’ipotesi di un terzo romanzo, che credo potrebbe andare dal dopo guerra fino al termine del secolo scorso, un periodo di estremo interesse per tutti, ma soprattutto per chi come me l’ha vissuto.
Da leggere, mi sembra ovvio.
Indicazioni utili
Un grandioso affresco
Scrivere un romanzo storico riguardante l’ultimo travagliato periodo del regno borbonico, mostrando attraverso le vicende di una famiglia, i Nigro, le lotte aspre e sanguinose volte al riscatto dei cafoni, in un contesto di profonda miseria per la stragrande maggioranza della popolazione del Regno di Napoli e delle Due Sicilie, non deve essere stato facile, perché si apprezzano la minuziosa ricerca delle fonti e le descrizioni dei personaggi, pressoché tutti realmente esistiti. Grosso modo il periodo in questione va dall’imminenza della rivoluzione francese alla spedizione dei Mille, un lasso di tempo non breve, caratterizzato da turbolenze, da confusi moti popolari in cui era difficile distinguere i rivoltosi dai briganti e dove sovente le parti finivano per invertirsi, generando un caos in cui era difficile comprendere i ruoli dei protagonisti. Furono le idee liberali che accesero la miccia e che fecero pressioni affinché il Borbone concedesse almeno una costituzione e brigasse per non far morir di fame i suoi sudditi, ponendo fine a contrasti, a epidemie, a un banditismo che nasceva e si sviluppava in un tessuto di particolare miseria, in cui era più facile morire che vivere. Non si trattava quindi del Regno ricco tanto osannato dai neo borbonici, era un regime assolutista che assai probabilmente, anche senza la spedizione di Garibaldi e il soccorso dei piemontesi, avrebbe finito per dissolversi.
Raffaele Nigro narra le vicende dei suoi avi, le racconta come fosse una saga nordica, in cui tuttavia la predominante epica viene smussata da un verismo simile, anche se non uguale, a quello di Giovanni Verga. Ne nasce un’opera che affascina e stupisce, un grande affresco di un Meridione che ancor oggi è in attesa del suo riscatto, un romanzo corale con tanti protagonisti, ognuno ben inserito nel contesto, e di questi vorrei ricordarne qualcuno, perché si tratta di individui dotati di forte personalità, che si affacciano prepotenti sulla scena e che se ne vanno, mestamente, in punta di piedi.
Francesco Nigro, un povero bracciante analfabeta, ma con un naturale talento per la poesia, costretto dalle circostanze a diventare brigante, abbraccia la causa della povera gente, dei contadini, diventando generale e morendo per sostenere quell’idea di riscatto che accompagna la ribellione dei cafoni; Concetta Libera Palombo, moglie di Francesco, donna devota e fedele alle tradizioni, sarà un giunco nella tempesta, con i figli che le daranno non pochi grattacapi, tranne uno, Raffaele Arcangelo Nigro che, avviato alla vita monacale, combatterà una sua personale guerra, del tutto pacifica, per soccorrere i miseri e i deboli, forte delle sue convinzioni e toccato dalla grazia divina, da cui tuttavia riuscirà a non essere schiacciato, a non vivere dell’aureola di santo che tanti gli vogliono porre sul capo; Padre Ferdinando Paolino Tortorelli, un sacerdote che non si chiude nelle mura della chiesa, ma che è sempre in giro, a proprio agio fra i contadini, uomo saggio e studioso, uno scienziato con la tonaca; Don Tommaso Maria Bindi, un liberale, un avvocato, che sostiene la causa dei contadini, pagandone le conseguenze, un puro e disinteressato, pacifico e tuttavia coinvolto in una guerra di cui non riuscirà a vedere la fine. Ambientato tra Puglia e Lucania, in terre per lo più aride, ma in cui sono presenti due fiumi ricorrenti nella narrazione, il Basento e l’Ofanto, è un romanzo in cui cruda realtà e utopia, speranze spezzate, solitudini e rassegnazioni si alternano in una narrazione che avvince, che rende partecipi delle tragedie e delle poche effimere gioie, un quadro che la mano dell’autore ha saputo dipingere con rara abilità, tanto che, giunti alla fine, è impossibile non essere travolti dalla commozione.
Indicazioni utili
Predestinati
Non è possibile di certo affermare che Luigi Panzardi sia un’ottimista, ma d’altra parte, di questi tempi, in cui economia, politica e finanza sembrano complottare contro le misurate aspirazioni di gran parte degli individui, non è strano che in ognuno di noi prevalga un più o meno accentuato pessimismo. L’autore, in verità, in un racconto (Il mio medico) sembrerebbe lasciare spazio a una certa vena di speranza, con la vicenda grottesca, ma a lieto fine dei coniugi Saposdelli, ma a ben guardare lo scopo non è quello di narrare di una storia in sé e per sé, bensì di porre in risalto i pericoli insiti in una società ipertecnologica, in cui l’uomo e il suo intelletto sono soffocati da un razionalismo, ma sarebbe meglio dire irrazionalismo, di tipo meccanico, accompagnato non di rado da un approccio deontologico piuttosto carente.
Il fil rouge che unisce le altre sei prose è la predestinazione, cioè l’impossibilità per molti esseri umani di reagire a quelli che sono gli eventi più importanti del loro destino, è quell’inerzia, quell’abbandono al vento della vita da cui, più che lasciarsi trasportare, si viene travolti. E’ cosi che la giovane Federica di La ragazza del mercato non riuscirà mai a uscire dal mondo della malavita, alle cui regole ferree non ci si può ribellare se non a patto di pagare pesanti conseguenze, e in un mondo chiuso l’aver subito una violenza carnale (Lucia di La pecora) non solo non dà diritto di protezione, ma finirebbe, nel caso il fatto fosse risaputo, con il provocare l’emarginazione sociale della vittima.
Non è immune da questo fato, anzi è il primo a sperimentarlo dalla nascita Corrado, il down di Il custode del canile; in questo caso non c’è l’emarginazione da parte di quelli del paese, che anzi gli vogliono bene, ma c’è la perdita di un animale, una cagnetta, a cui si è affezionato in modo quasi morboso; invece per Fiore (Il gemello virtuale) la fermata in cui ogni mattina attende l’autobus per andare al lavoro diventa l’occasione per un autoritratto, impietoso, prima del salto nel buio; in un periodo di profonda crisi economica la vicenda di Dino (La recessione per Dino), appena promosso capo reparto e subito licenziato per la chiusura della fabbrica dove lavora, porta all’eterno dilemma fra lo stare al proprio paese, dove non c’è lavoro e facendo quindi la miseria, e andare invece dove c’è la richiesta, in una storia kafkiana in cui chi si lascia travolgere dal vento dell’avversità sarà ormai senza speranza.
Ho lasciato per ultimo La macchina divina, da cui il titolo all’intera opera, poiché di tratta di un racconto piuttosto lungo (65 pagine) e anche perché il dramma che coinvolge il protagonista, Silvestro, dirigente d’azienda stimatissimo e che d’improvviso perde la memoria, ha un’origine diversa dalle altre prose: non si tratta di ambiente, di recessione, ma dell’insorgenza di una malattia di carattere cerebrale, peraltro inguaribile. Panzardi è bravo nel descrivere i sintomi, le reazioni, l’angoscia che piano piano prende il sopravvento e la conclusione, per quanto logica e auspicabile, è un colpo da maestro.
So per esperienza che i racconti non sono molto appetiti dai lettori italiani, che però sbagliano, perché quando la prosa breve ha un inizio e una fine, quando i personaggi sono ben delineati e la loro analisi psicologica risulta approfondita, tutti elementi positivi riscontrabili in questa raccolta di Luigi Panzardi, meritano senz’altro di essere letti; se poi aggiungiamo lo stile non ridondante, ma nemmeno scarno, la capacità di ricreare ambientazioni del tutto plausibili, direi che ce n’è più che a sufficienza per caldeggiare quest’opera.
Indicazioni utili
Un socialista particolare
Soprattutto dopo aver letto questa interessante biografia sono più che mai convinto che certi personaggi possano nascere solo in Italia. Perché? Basta leggere la vita di Nicola Bombacci, romagnolo purosangue, amico fraterno di Mussolini, prima fervente socialista, poi fondatore del partito comunista italiano, da cui fu espulso per il suo non allineamento alle direttive della segreteria, non perseguitato durante il ventennio e che addirittura, all’indomani della liberazione di Mussolini dalla sua prigione sul Gran Sasso e successiva fondazione della Repubblica Sociale Italiana, si fiondò a Gargnano, dove dimorava il duce e si mise a sua disposizione. Credo che una vita così avventurosa e anche piena di controsensi sia pressoché unica, vita che come sappiamo si conclude il 28 aprile 1945 sul lungolago di Dongo con la morte per fucilazione, unitamente ad altri gerarchi fascisti, fra i quali Pavolini. Il libro di Petacco è ben scritto e ben documentato, finisce inoltre con il ripercorrere la storia del partito socialista italiano dagli anni antecedenti la Grande guerra fino a quello in cui si conclude la seconda guerra mondiale. Non c’è la pretesa di dire tutto e di parlare di tutto, resta però il fatto che con un personaggio come il mite Bombacci è impossibile esaurire il tema in poche pagine, perché ci troviamo di fronte a un uomo che, oltre a provocare la famosa scissione di Livorno nel partito socialista con la fondazione del partito comunista, è stato un testimone d’eccezione dei primi anni anni della Russia sovietica, frequentando a Mosca Lenin e costituendo un ponte ideale fra la rivoluzione russa e quella fascista, in ciò stimolato dalla dirigenza del Comintern e con il compiaciuto assenso di Mussolini. Oratore di indubbie capacità (i suoi comizi erano sempre un successo e lo furono anche nel breve periodo della Repubblica Sociale Italiana), un po’ narcisista, era uomo politico più teorico che pratico e ciò lo si nota anche negli articoli della Carta di Verona, le cui basi, strutture e indirizzi furono senz’altro sue e approvate da Mussolini; questo manifesto della RSI è sostanzialmente socialista, ma, se gli intenti sono ottimi, le modalità per raggiungere uno stato che vedesse paritetici capitale e lavoro nel comune interesse sono alquanto fumose e di difficile realizzazione, soprattutto in un periodo come quello, con l’Italia invasa e la guerra civile in corso. Prima di cadere sotto i colpi del plotone di esecuzione pare abbia gridato “Viva Mussolini! Viva il socialismo!” e c’è da credere che sia vero, perché l’uomo, pur non avendo dei concetti ben precisi di quello che dovrebbe essere una democrazia socialista, tuttavia intimamente apprezzava e desiderava un mondo in cui il lavoro e i lavoratori potessero trovare dignità di protagonisti non subordinati. Il suo corpo, come quelli degli altri fascisti giustiziati a Dongo e di Mussolini e della Petacci, eliminati a Giulino di Mezzegra, finì appeso a Milano a Piazzale Loreto e nel documento che attestava la fucilazione sotto il suo nome c’era scritto “Supertraditore”, perché tale era considerato dai suoi ex compagni comunisti.
Da leggere.
Indicazioni utili
Sogni di gioventù
Tipo strano questo Aurelio Caliri, e non solo perché si cimenta nella letteratura, nella musica e nel disegno, in ogni caso con risultati di eccellenza, ma soprattutto perché, nonostante non sia più giovane, affronta la vita con l’entusiasmo e l’ingenuità di un bambino. E’ un vulcano di idee e non fa in tempo a tradurne in pratica una che già si danna per un’altra maturata all’improvviso. Come ho già avuto modo di scrivere di lui, in un articolo che nelle mie intenzioni tendeva a delinearne l’aspetto psicologico, Caliri vive perennemente in un sogno che gli offre gli spunti per mettere in pratica le sue tendenze artistiche e se la musica resta la principale e il disegno una piacevole variante, la letteratura e in particolare la narrativa finiscono con il diventare una testimonianza di questa vita in sogno. E’ anche questo il caso di Pablo Storie di Sicilia, una raccolta di racconti che potremmo definire i risultati dei flussi di memoria dell’autore e che se letti e osservati con particolare attenzione rivelano nei protagonisti le caratteristiche salienti del loro ideatore. Si tratta per lo più di persone che cercano di dare un senso alla propria vita, che tentano di percorrere una strada e quando questa viene interrotta non demordono, perché sembrano dire, pur provati dalla delusione, che domani è un altro giorno e che perciò si deve ricominciare. Tuttavia, se qualcuno pensa che si tratti di confessioni, con l’inevitabile pathos intimistico, si sbaglia, perché sono storie che forse, partendo magari da una minuzia, si sviluppano sull’onda della creatività in una narrazione che ha il pregio di essere agile e leggera, e quindi mai stancante. In questi racconti non pochi sono quelli in cui si parla di una ricerca dell’amore da parte di protagonisti giovani, il che mi fa supporre che il tema, più o meno sentito da tutti, abbia avuto un peso particolare nella vita di Caliri, né una mania, né un’ossessione, ma comunque un argomento di grande rilevanza che viene trasfuso in tutte le sue implicazioni nei personaggi, che, guarda caso, spesso e volentieri maturano un sogno d’amore. Non mancano comunque altre tematiche e in proposito credo che qualcuno, speranzoso di trovare le classiche storie siciliane (indicate nel sottotitolo) di passioni, di drammi, di infruttuose ribellioni resterà deluso, perché della Sicilia abbiamo poche tracce, delineate dai paesaggi ben descritti e da rari spunti di classica atmosfera locale, in quanto l’autore non solo ha privilegiato l’aspetto intimistico degli attori, ma ci ha mostrato una Sicilia in divenire, già lontana dagli stereotipi, in buona parte fondati, degli anni ante 1968. Si assiste così a una carrellata di protagonisti, per lo più timidi e speranzosi, che in non pochi casi destano tenerezza per i loro insuccessi amorosi e per gli atteggiamenti impacciati con i quali cercano di contattare il soggetto del desiderio. Se esce un’immagine della Sicilia non è pertanto quella classica, di cui ho prima cennato, ma di un luogo che va superando ristrette mentalità per cercare di stare al passo con i tempi o comunque di rincorrere l’evoluzione dei costumi.
Alla formazione di questa immagine non poco concorrono i disegni dell’autore che rappresentano invece una Sicilia antica, un contrasto che accentua lo spirito moderno della parte narrativa, circostanza che risulta ancora più evidente per il fatto che Caliri ha riportato anche gli spartiti delle musiche create nel tentativo di far rivivere atmosfere lontane nel tempo, di quando per le strade girava il pianino a manovella; comunque, per chi, come me e penso molti altri, non è in grado di leggere la musica non c’è da avere paura, perché l’autore ha pensato anche a questo, allegando al libro il cd con la sua esecuzione personale, tranne per il brano La danza del tuono, eseguito dal figlio Federico e dal noto pianista Bruno Canino.
Sono dell’idea che Pablo Storie di Sicilia meriti di essere letto, specialmente se qualche volta sorge il desiderio di abbandonarsi al sogno, quando la vita si fa più dura o comunque quando si avverte venir meno la speranza di un cambiamento.
Indicazioni utili
| 1070 risultati - visualizzati 51 - 100 | « 1 2 3 4 5 6 ... 7 22 » |