- Warning
Dettagli Recensione
L'AMBIGUO CONFINE TRA IDEALISMO E DISIMPEGNO
“«Può tenermi fuori» dissi, «non c’entro niente. Proprio niente» ripetei. Era un mio articolo di fede. Dato che la condizione umana era quella che era, che si facessero pure la loro guerra, che si amassero, che si ammazzassero, io non volevo essere coinvolto. I miei colleghi giornalisti si facevano chiamare corrispondenti. Io preferivo la qualifica di reporter. Scrivevo quello che vedevo. Non prendevo parte all’azione, e anche un’opinione è una specie di azione.”
Se Greene non si fosse limitato a scrivere romanzi di ridotte dimensioni, con tutta probabilità egli avrebbe composto i “Fratelli Karamazov” o il “Delitto e castigo” del XX secolo. Infatti la scrittura di Greene assomiglia molto a quella di Dostojevskij: c’è in essa, perlomeno nelle sue opere serie, una fortissima tensione etica e, soprattutto, una costante volontà di mettere i suoi personaggi di fronte a situazioni e a scelte di straziante difficoltà, anche a costo di far vacillare quei principi religiosi in cui lo scrittore inglese, cattolico impegnato, credeva fermamente (basti pensare al suicidio del protagonista de “Il nocciolo della questione”). “L’americano tranquillo” non fa eccezione a questa regola (come pure ad altre, meno importanti ma non per questo meno caratteristiche, quali l’ambientazione in località lontane dall’Europa o dagli Stati Uniti, come l’Africa Occidentale de “Il nocciolo della questione” o il Centro America de “Il potere e la gloria”): la guerra in Indocina che fa da cornice storica al romanzo è infatti il laboratorio in cui Greene sperimenta e fa interagire tra loro le proprie ossessioni morali, quali il problema di Dio, il libero arbitrio, lo scontro tra ragione e sentimento, il dovere di prendere posizione nella scelta tra bene e male, la colpa e la redenzione, e così via. Non è difficile pertanto vedere nei due personaggi principali, il reporter inglese Fowler che narra in prima persona e l’americano Pyle che dà il titolo al libro, altrettante figure archetipiche, un po’ come Ivan e Alesa Karamazov (ma, se possibile, dotati di ancor maggiore ambiguità, se non altro perché qui non c’è, a differenza dei “Fratelli”, alcun eroe positivo). In essi si incarna infatti il dualismo tra disimpegno e idealismo: da una parte il cinismo, la neutralità désengagée di Fowler, il quale non sta con nessuno – né con i francesi né con i vietminh - ma che, come ogni uomo è chiamato a fare in ogni circostanza della sua vita, così nel suo intimo (la fede) come nel sociale (il rapporto con gli altri), alla fine è costretto a schierarsi; dall’altra l’innocenza strumentalizzabile di Pyle, l’ingenuità di chi si rifugia nelle teorie dei libri di scuola per non vedere da quanto sangue sono macchiati gli astratti principi che egli va propagandando (“Non ho mai conosciuto un uomo che avesse ragioni migliori per tutti i guai che combinava”). Sono due uomini che vanno tenacemente in direzioni opposte e inconciliabili, forse addirittura rappresentano due facce della stessa medaglia: fatto sta che in mezzo sta Phuong, la ragazza vietnamita, compagna prima di Fowler, poi di Pyle, infine, dopo la morte dell’americano, di nuovo di Fowler, la quale (proseguendo nel nostro azzardato esercizio metaforico) è un po’ il simbolo di un paese irriducibile agli sforzi di comprensione e di assimilazione dell’Occidente, un paese dignitoso, composto e pudico, nonostante venga continuamente conteso e violentato da un mondo straniero, guerrafondaio, imperialista, anche quando si presenta con il sorriso paternalista di colui che fa tutto quanto solamente per il suo bene.
“L’americano tranquillo” è un romanzo estremamente attuale. La guerra colonialista dei francesi narrata da Greene non può infatti non portare alla mente i tanti, troppi conflitti (dal Vietnam degli anni ‘60 fino all’Iraq del decennio scorso) con i quali l’Occidente ha preteso di ergersi a guardiano planetario della libertà, della democrazia e dei diritti umani, e ha invece tristemente lasciato dietro di sé solo dolore, rabbia e distruzione. Greene mette in guardia da chi (come Pyle) è ingenuamente convinto, magari in buona fede, che è possibile (e addirittura doveroso) esportare la democrazia con l’aiuto delle armi. E’ significativa la scena in cui Pyle, trascinato da Fowler nel luogo della strage provocata dalla Terza Forza che l’America sta segretamente sostenendo, inorridisce guardandosi le scarpe macchiate dal sangue delle incolpevoli vittime. Alla fine Fowler deciderà di tradire Pyle, consegnandolo alla resistenza vietnamita. A suo modo è costretto a prendere posizione, come già avevano preconizzato Vigot, il capo della polizia che ama citare Pascal («Anche lei è engagé, come tutti noi.»), il capitano Trouin («Non sono coinvolto.» «Lo sarete tutti un giorno… In un momento di emozione ci facciamo coinvolgere tutti, e poi non se ne esce più.») e il signor Heng («Prima o poi bisogna scegliere da che parte stare, se si vuole restare umani»). Ma la scelta di Fowler non è quella, facile, obbligata e un po’ manichea, di chi ha riconosciuto il proprio errore e si comporta di conseguenza per emendarlo (è la scelta, comune a moltissimi personaggi di film e romanzi, di chi sceglie alla fine di stare dalla parte giusta, cioè dalla parte dei buoni contro gli odiosi cattivi). Greene infatti, come si è già detto più sopra, è un maestro dell’ambiguità. Il suo stile a prima vista è il massimo della trasparenza, è secco, conciso, quasi giornalistico, non si sofferma né in descrizioni ambientali né in dettagli psicologici, ma, con le sue geniali, inaspettate e lapidarie epifanie (debitrici spesso dei meccanismi del romanzo giallo), lascia intravedere un universo pieno di dubbi, di rimorsi, di menzogne e di secondi fini non dichiarati. Fowler sa di avere condannato a morte Pyle, ciononostante cerca, contro ogni verosimiglianza logica, di convincersi che gli sgherri del signor Heng adotteranno con l’americano metodi non violenti; inoltre agli scopi ideali (impedire il ripetersi di orribili stragi come quella a cui è stato costretto ad assistere a Saigon) si intrecciano fini assai meno nobili (Pyle gli ha sottratto Phuong, la donna che era l’unica ragione della sua vita, e uccidendolo egli può sperare di riaverla con sé). Quello di Greene è un mondo dai contorni incerti, sfumati, in cui il giusto e lo sbagliato, il bene e il male, si confondono facilmente tra loro e solo un atteggiamento di cristiana compassione (quello che alla fine permette a Fowler di comprendere e far suo il dolore dell’”odioso” Granger) permette al lettore di trovare una corretta chiave di interpretazione.
Il lieto fine (l’inatteso ricevimento del telegramma con cui la ex moglie di Fowler accetta di concedere quel divorzio che gli permetterà di sposare Phuong) può, alla luce di quanto si è detto, lasciare interdetti. Ma in fondo, per chi conosce solo un poco Greene non c’è alcuna sorpresa: l’happy end è solo una ironica strizzatina d’occhio al lettore, un giochetto innocuo e beffardo che non muta il carattere fortemente problematico dell’opera. Qualche riga prima della lettura del telegramma, il quale, come le agnizioni nel teatro di Goldoni o di Molière, risolve provvidenzialmente i problemi del protagonista, Phuong torna infatti dal cinema e, commentando la trama del film appena visto e terminato con il ghigliottinamento della protagonista, afferma: “Preferisco i film che finiscono bene… Io penso che questo sia un punto debole della storia. Dovevano lasciarla fuggire. Poi potevano fare tutti e due un sacco di soldi e se ne sarebbero andati all’estero, in America… o in Inghilterra”. Più chiaro di così…
Indicazioni utili
Commenti
| 2 risultati - visualizzati 1 - 2 |
Ordina
|
| 2 risultati - visualizzati 1 - 2 |





















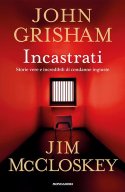


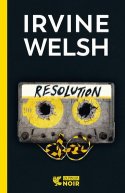



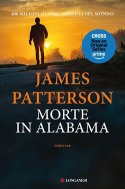
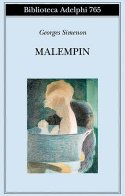
Tempo fa avevo iniziato un suo libro ma non l'ho finito. Ciò non è indicativo perché ero giovane e piuttosto immaturo. Penso quindi che sia uno scrittore da non lasciar perdere tanto facilmente.