Dettagli Recensione
Il tabù più grande
Possiamo inquietarci, spaventarci, morire di paura leggendo e vedendo le pellicole con i temi dell’orrore classico, i più comuni, il vampiro, l’uomo lupo, lo zombie, il fantasma, ma in fin dei conti tutto l’orrore che si può provare, tutti gli spaventi, le palpitazioni, i salti dalla sedia, possono tutti indistintamente ricondursi alla paura per l’orrore più grande, indefinibile, nascosto finanche a se stessi, quello di cui non si parla mai, almeno in pubblico, quasi a volerlo celare ed esorcizzare nello stesso tempo: la morte.
In “Pet Sematary” Stephen King affronta, appunto, il gran tabù, l’orrore principe di cui tutti hanno paura, lui stesso compreso: la leggenda vuole che King abbia avuto più di un ripensamento prima di dare il proprio assenso alla pubblicazione di questo suo romanzo, giudicandolo il più inquietante parto dalla sua fantasia.
In effetti, “Pet Semetary” è un romanzo inquietante, nel senso che lascia un che d’indefinito, di spiacevole, al lettore: ma è, a ben pensarci, un effetto voluto, diretta conseguenza del modo come l’argomento della morte è dibattuto.
La storia, di per sé assai semplice, e che tuttavia ben si presta alla tecnica solita dello scrittore del Maine di introdurre un elemento insolito, perturbatore in una situazione di banale e ordinaria routine, vede protagonista, ed anche questa non rappresenta alcuna novità nella produzione di King, una famiglia rappresentativa della middle class della piccola provincia americana, costituita dal dottor Louis Creed, giovane e valente medico, un dottor Kildare sui generis, pare creato apposta sullo stampo del mitico dottor Manson d’alcuni fortunati romanzi di Cronin, sua moglie, Rachel, una classica e saggia massaia, di cui è innamorato pure dopo anni di matrimonio, la figlia Ellie, una bambina dolce e delicata, il figlio più piccolo Gage, un bambino vispo e vivace, e naturalmente, il “pet”, il classico ed immancabile animale domestico di casa, un membro della famiglia a tutti gli effetti, amato e coccolato da tutti gli umani della famiglia, nella fattispecie non il più comune cagnone tenerone alla Cujo, ma il più infido gatto Church, il cui nome (chiesa) è già tutto un programma.
A questi si aggiunge il vecchio Jud Crandall, il vicino di casa che a Louis, cresciuto senza padre, appare come il genitore, la guida che non ha mai avuto.
Ma anche i genitori, anche le guide, possono sbagliare strada e sentieri, ed è questa casuale conoscenza che porterà il dottor Creed a conoscere gli effetti magici, o meglio diabolici, del locale cimitero degli animali, gravato da un’antica maledizione indiana, che restituisce alla vita gli esseri viventi riposti in quel luogo per breve tempo. Li restituisce a una parvenza di vita; non li trasforma in zombie, fa di più, li trasforma in puri e gratuiti concentrati d’indifferente malvagità, in esseri senza anima, senza sentimenti, senza discernimento, poiché il ritorno alla vita è in realtà una tragica beffa, il prezzo pagato per questa rentrée non vale lo spettacolo in scena, non ha nulla di sacro e di benigno, è agli antipodi per esempio rispetto alla cristiana resurrezione dei corpi o al risveglio ed incarnazione in una dimensione migliore, in una nuova positiva esistenza.
Quello che lascia sconcertati, che crea l’inquietudine che serpeggia sottilmente e magistralmente in tutte le pagine del romanzo, è proprio l’assurdo comportamento di Louis Creed.
Louis, lo ripetiamo, è un medico: come tutti i medici, ha dimestichezza con la morte, sa che essa è un evento, non è un “mostro”, è un accadimento, talora imprevisto, precoce, accidentale, e tuttavia inevitabile, naturale, parte intrinseca del corso delle cose. Per la morte, tutti i medici hanno rispetto; la combattono, la respingono, talora la maledicono, eppure nessun medico si sogna di dileggiarla, deriderla, sminuirne il valore, l’importanza, il mistero. Un buon medico, un qualunque medico, si limita a curare, anche parossisticamente, intensivamente, cocciutamente, ma non si accanisce inutilmente, non tenta mai, con presunzione ed arroganza, di osare l’incredibile quando sa, con umiltà ed umanità, di essere giunto ad una soglia oltre la quale non è permesso, non è di questo mondo, nemmeno è giusto ed umano provare a ritornare, e perciò il suo sforzo è vano, deleterio, finanche demoniaco.
Louis Creed pecca, e pecca per cieco egoismo: non intende rassegnarsi con umiltà, accettare i propri limiti, essere leso come tanti altri nei propri affetti, si ammanta senza neanche accorgersene di superiorità e di presunzione, e perciò nemmeno intende riconoscere alcuna valenza catartica, salvifica, consolatoria al dolore umano, anche a quello più atroce e più intimo, e forse soprattutto a quello, non ha rispetto per il mistero, il tabù per eccellenza, e ne infrange la sacralità. E riporta alla vita, alla grottesca parvenza di vita, prima il gatto, poi il figlio, e altri via via, in una sorta di diabolico, vampiresco deja vù, un delirio di folle onnipotenza di creazione e resurrezione alla Frankstein, con un finale magistralmente lasciato in sospeso, onde non sminuire la tensione, l’inquietudine che è la caratteristica unica e principe del romanzo.
Un buon romanzo quindi sul tabù, vero o presunto, della morte, al solito un buon romanzo di King; ottime le descrizioni dei luoghi e degli ambienti, le caratterizzazioni dei protagonisti, profondi ed intimi i pensieri e le considerazioni sugli eventi, scorrevole il tragico dipanarsi della storia; sarebbe stato un romanzo ancora migliore, tuttavia, solo se il dottor Louis Creed, e per lui Stephen King, avesse avuto conoscenza diretta o immediata memoria delle parole dello scrittore argentino Jorge Luis Borges: “La morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare”.
Indicazioni utili
Commenti
| 4 risultati - visualizzati 1 - 4 |
Ordina
|
| 4 risultati - visualizzati 1 - 4 |

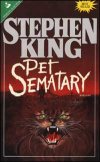













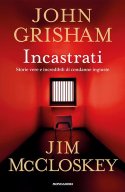





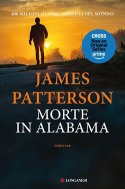
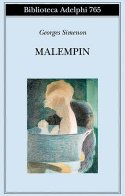








Mi tocca aggiungere anche questo!
Mi sa che al Re devo dedicare un altro mese...
Grazie Bruno!