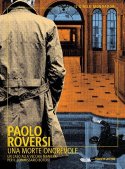Dettagli Recensione
Arcadipane: scheletri nell’armadio della politica
I lavori dell’Alta velocità nelle campagne torinesi portano alla luce alcuni resti umani: ossa ormai corrose dal tempo, sotto terra da chissà quanti anni. Appartengono a una decina di esseri umani. Il commissario Vincenzo Arcadipane è chiamato a fare un sopralluogo quando appare il primo scheletro che lui fa portare subito al laboratorio per analisi. Però, le ossa cominciano a diventare tante e subentra la questura milanese che avoca a sé le indagini e le classifica come resti del mai esaurito filone delle vittime della seconda guerra mondiale.
Però il primo scheletro ritrovato mostra, chiaramente, in un femore, i forellini lasciati dalle viti di una placca ossea; nel 1944 non si praticava la riduzione chirurgica di una fattura femorale. Arcadipane accetta di trasferire tutto ai colleghi milanesi, ma si trattiene quell’osso e un piccolo bottoncino metallico di jeans moderni, trovato lì vicino, nella fossa.
Il commissario sta attraversando una fase di depressione cosmica, rapporti difficili con moglie e figli, timore d’aver perso lucidità sul lavoro, ma non può lasciar perdere. Così incarica la ribelle, ma abilissima, Isa Mancini di fare qualche ricerca. La ragazza in meno di 24 ore scopre che i resti potrebbero appartenere a un tal Stefano Aimar, un ragazzo coinvolto negli anni settanta nel lancio di molotov contro una sede del Movimento sociale: una brutta storia in cui un impiegato del partito era morto bruciato. Alle successive indagini aveva partecipato pure il giovane Corso Bramard, che, in seguito, sarebbe diventato capo e mentore di Arcadipane. È inevitabile coinvolgerlo delle ricerche, per ricostruire quei fatti e sciogliere dubbi che all’epoca non furono mai chiariti. I tre scopriranno cose terribili, rimaste segrete sino a oggi.
Questo è il secondo romanzo poliziesco dedicato al duo Corso Bramard e Vincenzo Arcadipane, assistiti dalla aggressiva, riottosa agente Isa Mancini, quasi sempre in punizione per le sue intemperanze.
La prosa di Davide Longo è affascinante e, nel contempo, disturbante: grezza, sfrontata, incurante di ogni convenzione stilistica o eufemismo. Talora trascurata e scarsa (pure nel rispetto delle regole sintattiche), non di rado quasi scurrile, come può esserlo un linguaggio da caserma. Ma, come una ruvida raspa riesce a grattare e mettere a nudo anche il legno più duro, così quella prosa, a volte trasandata e spigolosa, a volte ridondante, pletorica o acidamente sarcastica, riesce a scoprire e mettere in luce i sentimenti dei personaggi dando loro una vita quasi reale. Sono uomini e donne che, spesso, hanno perso ogni speranza o mai l’hanno avuta, e trascinano stancamente una vita alla deriva come i resti di un relitto in alto mare nel cui sfacelo spesso è difficile distinguere i vari componenti che, ormai, galleggiano sparsi e senza meta. Tutto molto umano e toccante.
Tra i protagonisti emerge tenera, anzi patetica, la figura di Arcadipane, brillante poliziotto, degno allievo del commissario Bramard, ma ormai uomo disilluso, sperso, che non riesce a comprendere più il mondo in cui vive e fatica a tenere assieme la sua famiglia, nonostante l’ami disperatamente e sia disposto a tutto pur di rinsaldare i rapporti. Ne risulta un personaggio commovente per la sua disperata, concreta umanità. Quanto a Bramard – che nel romanzo precedente era descritto come un uomo cupo e disperato, con istinti suicidi, che aveva rinunciato a provare sentimenti per paura di soffrirne ancora – qui ci appare invece dotato di una saggezza ascetica e stoica; ormai consapevole quali limiti brutalità e violenza possano agilmente superare, accetta con mesto cinismo tutto quanto di orrendo la vita e l’indagine gli andrà rivelando.
In definitiva il romanzo si rivela un ottimo esercizio letterario in uno stile che, forse, potrà non piacere a tutti, ma che risulta decisamente interessante e coinvolgente, anche per quel suo carattere quasi sperimentale e creativo che ha di esporre i fatti.
Tutto bene, allora? Non proprio. Sono assai meno convincenti i temi sviluppati dalla trama: l’eversione e gli attentati che insanguinarono l’Italia negli anni ’70, ma soprattutto i modi in cui vengono esposti e le soluzioni che, alla fine, sembrano suggerire. Temi, modi e risposte che fanno sorgere più di una perplessità.
La storia è suddivisa in tre sezioni, con la prima e l’ultima dedicate alla risoluzione del caso che il ritrovamento della fossa comune ha aperto. La parte centrale, invece, è dedicata a un minuzioso flash-back sul ruolo avuto da Bramard giovane nelle indagini della polizia politica sull’attentato incendiario alla sede MSI di via Lampredotti che costò la vita all’unica persona che, in quel momento, vi si trovava per lavorare. Già questo passo indietro temporale determina una cesura che spezza la continuità narrativa e risulta non perfettamente consono ai toni intimamente dolenti che aveva assunto la narrazione. Ma l’aspetto più criticabile sta proprio nell’argomento scelto: inoltrarsi nel pericoloso campo minato dei cosiddetti “anni di piombo” italiani è sempre problematico. In un giallo classico ove crimini e autori degli stessi possono essere arbitrariamente decisi dall’A. ci si muove in un universo immaginario, simile al nostro, ma parallelo e solo imitativo di quello reale. Quindi è consentita qualunque invenzione e “fuga in avanti” senza rischio di turbare nulla o nessuno. Ma se si va a toccare un tema di per sé scottante e non del tutto sopito negli animi di chi, direttamente o indirettamente, l’ha vissuto e ne è stato testimone, è difficile muoversi senza causare deflagrazioni indesiderate, sollevando ipotesi, più o meno fantasiose, che portano a congetturare su oscure manovre, stragismo o complottismo di Stato, fosche macchinazioni di quelli che venivano definiti “poteri forti” e compagnia cantando. Insomma si rischia di alzare un polverone di polemiche e supposizioni, più o meno campate per aria, che se sono sicuramente sgradite a chi non le ritiene neppure lontanamente reali, risultano malviste, a mio avviso, anche a chi nutra qualche dubbio in proposito. Il romanzo poliziesco, quindi, per definizione, “di evasione”, non può tramutarsi in un pamphlet di denuncia, soprattutto non può farlo inventando una tesi che frammischia situazioni realmente accadute con i parti della fantasia, senza mostrare dove si è voluto tracciare la linea di confine; dove finisce la cronaca di quegli anni e dove inizi la fantapolitica e il racconto ucronico. Non lo si può fare accettando pedissequamente e in modo acritico una tesi (chiaramente di parte) frutto dell’assemblaggio di tutti i luoghi comuni e le cervellotiche motivazioni segrete che hanno avvelenato quegli anni tristissimi.
Purtroppo questo peccato originale deprime l’opera che, altrimenti, sarebbe stata degna di una valutazione decisamente più alta. Peccato...
____________
P.S. Mi sembra opportuno segnalare che il libro, prima edito da Feltrinelli con il titolo "Così giocano le bestie giovani", ora è stato ripubblicato da Einaudi con il titolo semplificato "Le bestie giovani".