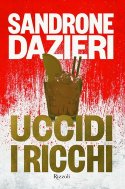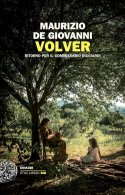Dettagli Recensione
Memento vivi
Il titolo, di proposito, rimanda al conte ed all’isola omonimi del capolavoro di Dumas padre, e indirettamente anche al famoso testo risorgimentale di Silvio Pellico sulle sue prigioni, citato espressamente nel corso del racconto.
Con quei romanzi ha non poco in comune: in questa storia Fabiano Massimi, infatti, ci parla di carceri, di prigioni, di luoghi di reclusione e dell’umanità che suo malgrado ci vive o ci ha soggiornato, a torto o a ragione; direi di più, si accenna qui neanche troppo velatamente a galere che non sono necessariamente fisiche e provviste di sbarre, e dove più spesso di quanto non si creda chi vi è rinchiuso, neanche sa di esserlo, talora vi si è imprigionato volontariamente, spesso non è nemmeno un pregiudicato, un reo confesso, o addirittura colpevole di qualche reato.
Ne consegue che questa non è perciò una storia di errori giudiziari, o una denuncia degli orrori della reclusione disumana tipo “Le ali della libertà”, o di rocambolesche fughe da Alcatraz o dal castello di If. Questo è invece un buon romanzo, affatto banale, una bella storia di riscatto e di redenzione, non solo, ma anche di riconsiderazione degli eventi dell’esistenza con uno sguardo diverso, più pacato e riflessivo. Troppo spesso i fatti della vita, anche quelli più ordinari, appaiono del tutto differenti da quanto sono in realtà, il libro suona allora come un richiamo corale, un invito a valutare meglio, ad approfondire la conoscenza di quanto accade prima di giudicare, un appello rivolto in generale a quanti, spesso troppi e troppo a sproposito, sono chiamati a ricostruire la verità e a giudicare.
Tanti troppo di mezzo, dunque, specialmente troppo in fretta:
“Non siamo qui per indovinare…siamo qui per sapere. La verità è una cosa lenta.”
Questo è un romanzo scritto con tutta evidenza da uno studioso di storia e di filosofia, da un uomo amante dei libri, della lettura, delle biblioteche, che invita alla lettura, alla cultura, alla sapienza, gli artifizi unici per qualificare al meglio la nostra esistenza.
Rinveniamo una trama abilmente intrecciata, che ne comprende al suo interno altre in relazione tra loro, in sintesi, è un bel narrare: preciso, discorsivo, fluente, avvincente proprio perché offre più chiavi di lettura. Date queste premesse, etichettare questo libro come classificabile in un solo genere narrativo, tra l’altro è edito da un campione dell’editoria dei gialli, risultato finanche vincitore di un premio ad hoc per esordienti, mi sembra comunque riduttivo.
Fabiano Massimi non ha scritto un enigma da sciogliere per il tramite dell’investigatore di turno, ha fatto molto di più, serve andare oltre le apparenze per accorgersi che, proposto con un linguaggio semplice e scorrevole, arguto e con un sottile umorismo, ci ha offerto invece con il suo elaborato più di uno spunto di riflessione sulla condizione umana.
Talora una condizione misera e miserrima, al punto che la giustizia ricorre, in mancanza di alternative, ai soli mezzi di reclusione coercitiva per il rispetto delle regole.
Da tale condizione di miseria morale, materiale, educativa e culturale che spinge al delinquere e alle condanne giudiziarie, ci si può certamente redimere e risollevare, per non reiterare i danni collaterali a sé stessi ed agli altri…se solo lo si permetta, e la costrizione, se proprio inevitabile, sia dettata dall’osservanza del dettato costituzionale del fine ultimo della pena, la rieducazione, la riabilitazione e il recupero sociale del reo. Questo spesso, e purtroppo, non avviene: perché se è vero che errare è umano, è altrettanto vero che l’umanità, o almeno gran parte di essa, tende comunque a mantenere inalterate le condizioni esteriori perché il reo venga regolarmente agevolato, se non obbligato, a perseverare nell’errore, spessissimo unica alternativa per la sussistenza al di fuori dell’istituto di reclusione.
“Quando esci di prigione nessuno ti dà da lavorare…chi si fida di uno che fino a poco fa era un ladro o peggio…Così gli ex detenuti hanno pochissime strade aperte, quasi tutte illegali…Si chiama recidiva, ed è una condanna…”
Perché non esiste rieducazione, in definitiva. Chiunque ha o ha posseduto un cane lo sa: se lo si educa con fermezza ma con pari dolcezza, senza picchiarlo o infliggergli dolore e umiliazioni, evitando di strozzarlo al guinzaglio ma permettendogli di muoversi in sicurezza, interagire socialmente, impiegarsi utilmente nel gioco come nel lavoro, gratificarlo, allora obbedisce volentieri, si attiene alle regole, è un compagno ed un amico fedele, rispettoso dei suoi simili e degli umani.
Se lo si tiene invece perennemente alla catena, impedendogli una qualsiasi vita di relazione ed aizzandolo con botte e privazioni, ne risulterà una belva, tanto più feroce ed aggressiva quanto confusa e impaurita, e recuperarlo alla normalità è un’impresa proibitiva.
Sic et simpliciter, lo stesso accade con gli esseri umani, il carcere così com’è rinchiude ma non redime, ti lega ad un palo con una catena a gioco corto, incattivisce ed imbarbarisce, non rieduca, non recupera, nemmeno fa giustizia, persevera diabolicamente per un motivo o per un altro a far sì che chi ha sbagliato una volta torni a delinquere. L’unica soluzione proposta giocoforza per svariati motivi è la reclusione coatta, e non altro, che è una barbaria che finisce per coinvolgere con la stessa depressione nel vivere tanto i reclusi che i loro carcerieri.
Ben lo comprende solo chi ha vissuto la reclusione, l’inferno in terra; e lo comprende per la stessa logica di base nelle comunità per il recupero dalle tossicodipendenze, dove i migliori operatori sono proprio ex ospiti passati efficacemente dall’altra parte della barricata.
Primo, ex carcerato che, con stenti e sacrifici si è rifatto un’esistenza prospera e felice, è uno di quelli che, come si dice, ce l’ha fatta, e una volta libero ha costruito onestamente una fortuna economica. Memore dei suoi dolorosi trascorsi in prigione, si prodiga generosamente per i compagni meno fortunati di lui, ha ideato e presiede “Il Club Montecristo”, una vera e propria associazione pro bono di ex-carcerati che di giorno lavorano onestamente, ma nel tempo libero si prestano volentieri come volontari in una sorta di misericordia, di Caritas pro ex detenuti, un mutuo soccorso per coloro che, una volta usciti dal carcere ed aver pagato il loro debito con la giustizia, decidono risolutamente di cambiare vita e filare diritto. Risolutamente, perché è il carcere è un’esperienza che ferisce a sangue, che non intendi ripetere mai più. Però poi, per quanto esci a pena scontata, la fedina penale macchiata è un deterrente che ti ostacola in qualsiasi attività, rende chiunque diffidente nei tuoi confronti, l’assioma “delinquente una volta delinquente per sempre” è inestricabilmente radicato nel profondo delle coscienze di tanti, e rende impossibile trovare un lavoro onesto e dignitosamente retribuito, e questo prioritariamente, ma non solo, in più sei letteralmente degradato da ogni dignità sociale.
“…Se hai la fedina penale sporca, anche buttare una cicca per terra ti può costare caro”.
Il Club Montecristo allora interviene, cerca e procura un lavoro a chi lo richiede, magari presso la sede ufficiosa del circolo, il Caffè Dantes, vedasi che coincidenza nel nome, supporta e assiste gli ex carcerati a condizione che siano fermamente decisi a cambiare vita.
La solidarietà è sempre particolarmente viva tra i derelitti, tra fratelli di sventura, perciò il club Montecristo li aiuta, li soccorre, li sostiene, non li lascia soli…specialmente quando li sa innocenti.
I membri del Club, tutti, da Primo all’ultimo dei suoi uomini, Azzicca, Zero Zero, Oleg, Olaf e tanti altri diffusi come una ragnatela per tutta la città uniscono tutte le loro competenze e si ribellano alle norme non scritte che certificano che chi delinque è irrecuperabile, letteralmente si ammutinano a questo pregiudizio infondato, sono gli ammutinati, coloro che si rifiutano di obbedire ai pregiudizi, dissentono da chi definisce i detenuti indegni finanche di speranza.
Marco Maletti detto Arno è quello che si dice un giovane professionista affermato.
Informatico di alta classe, un geniaccio nel suo campo, una splendida moglie, due bambini stupendi, un uomo di successo economico e professionale, quindi, ma anche realizzato negli affetti.
Questo in apparenza: in realtà Arno, seppure ne sia cosciente solo a livello subliminale, è un uomo rinchiuso, non in un penitenziario, ma in uno spazio di reclusione che si è costruito da sé.
L’uomo realizzato come si mostra è in realtà un giovane partito con ben altre ambizioni, è un lettore appassionato, e come tutti coloro che amano la lettura, è da sempre fortemente attratto dalla scrittura, e dal cimentarsi con quella, fosse pure sotto forma di scritti brevi quanto una poesia.
Le esigenze logistiche del realizzarsi nella professione e l’impegno familiare però lo hanno portato a distoglierlo dal rivolgersi alle sue passioni con la necessaria dedizione di riuscita, e sottilmente tale frustrazione si insinua nel suo rapporto con la moglie Elsie.
Un giorno Arno viene contattato dal suo amico del cuore, il classico fratello ben più di un congiunto di sangue, che non vede da un’eternità perché l’amico, Alan Luis detto Lans Iula, ha trascorso anni in carcere per un reato connesso alla sua professione di valente pittore. Reato commesso non tanto per fini di lucro ma per amore di una donna. Lars è il tipico creativo votato solo alla sua arte, e se delinque lo fa solo perché travolto dall’ arte creativa più grande che esista: l’amore.
“Ti porta dove vuole lui…e se è vero amore, obbedisci e basta, e alla fine ti ritrovi dove ti ritrovi.”
Lans contatta Arno perché necessita delle sue abilità informatiche per scoprire l’autore di un brutale omicidio ai danni di una giovane impiegata di una galleria d’arte, Viviana Ferrante, detta Vivi.
Una donna bellissima e sconcertante insieme, infatti a prima vista una pittrice di evidente talento, con una casa le cui pareti ospitano, oltre che alle sue tele molto più che pregevoli, anche i testi che potrebbe avere in casa solo una donna profondamente intrisa di cultura: libri di Paul Valery, Erri De Luca, Wittgenstein, Seneca, Marco Aurelio e, più di tutti, i versi incorniciati delle poesie di Antonia Pozzi. Viviana è descritta, da tanti che la conoscevano, sempre a tinte diverse, come se fosse una, nessuna o centomila, chi una ragazza dolcissima, timida e pensosa, chi una donna allegra, chi una persona seria e malinconica, versioni diverse e discordanti.
Nonché possiede un computer con tanto di raccolta di foto che la identificano come una attiva e disinibita escort a pagamento di siti dedicati.
Del delitto, è accusato l’ergastolano Danilo Secchi, poiché il modus operandi dell’omicidio è lo stesso con cui Secchi uccise il proprio padre, un ubriacone violento in famiglia e che insidiava la sorella minore; inoltre, le sue impronte digitali sono rinvenute sul luogo del delitto.
Danilo Secchi è innocente, ma non può provarlo, è colpevole soprattutto perchè su di lui pesano i precedenti, ed è il classico capro espiatorio ideale per inquirenti ed opinione pubblica, il necessario mostro da sbattere in prima pagina, stante anche la notorietà del papà di Vivi, Cosimo Ferrante, manco a farlo apposta direttore del carcere dove è recluso Secchi e dove a suo tempo fu internato Lars.
Interviene allora il Club Montecristo, e all’unisono tutti i protagonisti, ognuno nella propria cella, ciascuno invischiato dai propri legacci esistenziali, all’unisono agiscono come Edmondo Dantes, non si rassegnano allo stare rinchiusi, l’esperienza patita gli fa da Abate Faria, insegna e tempra.
Evadono liberandosi dagli orpelli personali, trovano un tesoro nella solidarietà che li unisce, ricostruiscono una realtà diversa, ammantata di nobiltà, ricompongono la realtà dei fatti, ristabiliscono la giustizia. Quella vera, spesso diversa da quanto immaginato, talora amara.
Chi ha ucciso Viviana Ferrante lo ha fatto quasi per caso, o forse no, perché la vita di Viviana è stata un’esistenza dura, tormentata. Quasi l’assassino desiderasse punirla per aver trascorso un’infanzia infelice, chiamando assurdamente “casa” i locali del carcere adibiti ad abitazione del direttore del penitenziario, in definitiva la giovane donna è morta perché ha smarrito il “memento vivi” inciso a mò di firma su alcuni quadri, una variazione sul tema del “memento mori”, la nota frase latina che suona a monito all’umana vanità.
Viviana Ferrante ha “dimenticato di vivere”, questa la sua prigione.
Ed il motivo della sua fine.
Termina così questo romanzo giallo, se davvero vogliamo definirlo così, ma soprattutto un bel romanzo. Un racconto che parla di arte, e rimanda a libri, ad autori, alla poesia: un sunto pubblicitario dello scibile umano come si rinverrebbe in una biblioteca.
Amante dei libri, e dell’arte, finanche bibliotecario, Fabiano Massimi lo è davvero, e dello studioso curioso e attento ne ha tutte le caratteristiche.
Ne è venuto fuori un testo preciso, curato, con i tempi giusti di tensione e aspettativa, ed un rigore da storico, da studioso, nella esposizione e ricostruzione dei fatti che poi ritroveremo nel suo romanzo successivo a questo, “L’angelo di Monaco”, il fortunato thriller storico che lo consegnerà alla meritata notorietà. Ne aspettiamo piacevolmente il sequel, in uscita a breve.