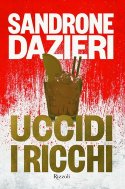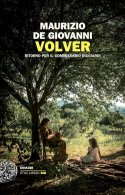Dettagli Recensione
Lacrime a Firenze
Ottobre 1966, Questura di Firenze. Il commissario Franco Bordelli è chiamato ad indagare sulla misteriosa scomparsa di un ragazzo appena adolescente di nome Giacomo Pellissari. Di lui ogni traccia si è persa un mercoledì mattina come tanti, quando, dopo essere uscito dal Collegio alle Querce, durante una pioggia torrenziale e una regolare giornata di scuola e aver invano atteso che uno dei genitori lo andassero a prendere, si era avviato da solo verso la propria abitazione. Ben presto, però, questa assenza si rivela essere ben più di una fuga volontaria o di un rapimento, il corpo del giovane viene rinvenuto privo di vita nei boschi fiorentini in avanzato stato di decomposizione. Le analisi inoltre sono chiare; ha subito molteplici violenze e da più persone prima di morire. Gli aggressori, rapitori, violentatori e assassini erano almeno in tre al momento del compimento del fatto. Da questo breve assunto ha inizio l’opera di Marco Vichi, un testo solido e ben strutturato caratterizzato da una indagine diversa da quelle tipiche del giallo a cui siamo abituati. Man mano che l’opera scorre, un’opera interamente caratterizzata da un velo di tristezza e da un retrogusto amaro e di malinconia che accompagna dall’inizio alla fine, diventa sempre più chiaro che riuscire a consegnare alla giustizia “i cattivi” sarà sempre più difficile se non impossibile, e a confermare questa certezza si aggiungerà un altro dato di affatto scontata importanza; l’alluvione del 4 Novembre 1966 che con la sua forza disarmante non solo strazierà il cuore di Firenze ma porterà via con sé anche le prove e quegli indizi chiari, precisi, concordanti e inequivocabili circa l’omicidio del Pellizzari.
Il tutto avviene attraverso quella che è una penna fluente, priva di fronzoli e ben orchestrata e attraverso un intreccio narrativo solido, impenetrabile e cadenzato per quel che riguarda la trama. Altro pregio inestimabile dell’elaborato è la realtà storica che ci viene mostrata. Sulle note de “Che colpa abbiamo noi” dei The Rokes, il cuore piange per la sorte toccata a Firenze, il cuore piange per la sorte toccata alle città vicine, il cuore piange perché già era intravedibile la sorte a cui quella società italiana sarebbe stata destinata negli anni a venire.
«Era tutto orribilmente semplice. I ricchi pensavano solo a essere sempre più ricchi, non gliene importava nulla di come fosse fatto il mondo, purché potessero rapinarlo e accumulare denaro. Non gliene importava nulla del Fascismo o della democrazia, l’unica cosa che volevano era essere lasciati in pace a fare soldi. Erano avidi, meschini, stupidi, di quella stupidità e meschinità che piace tanto ai ricchi, perché è la loro forza per diventare sempre più ricchi. Si arricchivano per merito di persone che in fondo disprezzavano, come sempre è successo in ogni luogo della terra e in ogni tempo. Erano spregevoli, ingordi, banali, ottusi, contavano i soldi leccandosi le dita, si chiudevano nelle loro ville e credevano di lasciar fuori il resto del mondo, credevano di non avere nulla a che fare con il mondo che si trascinava fuori di casa anche la morte, e quando uno di loro moriva si guardavano con occhi spaventati, sbalorditi che tanta ricchezza non fosse capace di proteggerli dalla morte. [..] Non guardavano negli occhi i loro figli e le loro figlie? Non vedevano che quelle serpi in seno non volevano più regole e scalpitavano per avere la loro fetta di potere, di comando, di soldi? Non capivano che i loro figli, educati nell’arroganza verso il mondo, erano diventati naturalmente arroganti? Non si accorgevano che i loro figli non aspettavano altro che di ereditare le loro ricchezze, le ricchezze dei padri, buttando a mare le loro regole imputridite di cui non sentivano alcun bisogno? Non si rendevano conto che i loro figli volevano abbattere la loro autorità, che non volevano padroni per diventare loro stesso padroni? Quei giovani che avevano cresciuto nel lusso, schiacciati da regole di ferro, avevano negli occhi una rabbia irridente, un disprezzo universale. Tutto ciò che volevano era buttare giù i padri dal trono e prendere il loro posto. Erano peggiori dei loro padri e delle loro madri, volevano essere ancora più ricchi e potenti dei loro genitori, e l’apparente voglia di libertà non era altro che voglia di potere e di soldi. Ma la cosa ancora più ridicola era che adesso anche gli operai, gli impiegati, le mezzemaniche, volevano essere come quei ricchi dei quali erano sempre stati servi. L’invidia aveva preso il posto dell’orgoglio. Anche loro volevano essere ricchi e potenti, volevano avere una villa e un giardino per potercisi chiudere dentro e lasciare fuori la miseria, la sofferenza, la morte, così come si lascia la spazzatura fuori dalla porta…» pp. 121-122-123
«Quelli che in guerra hanno ammazzato guardano passare la gente per la strada, le donne, gli uomini, i bambini, i ragazzi e le ragazze, i vecchi, e vedono morti che camminano, persone che stanno morendo, che stanno per essere ammazzate, calpestate, trucidate. Vedono questo e cercano di non pensarci, di non crederci, cercano di vede donne luminose, ragazzi allegri, uomini sorridenti, ma vedono solo la morte che ha generato quella luce, quell’allegria e quei sorrisi. Non possono dimenticare quello che hanno visto, per tutta la vita avranno negli occhi i morti della guerra, quelli che hanno ucciso e i loro compagni uccisi, non c’è differenza, sono un’unica montagna di morti su cui hanno camminato per arrivare dall’altra parte, e non ci sono bandiere, né amor di patria, né medaglie al valore, né discorsi ufficiali, né commemorazioni solenni, capaci di cancellare quella memoria. Uccidere in guerra è una maledizione che dura per tutta la vita, uccidere in guerra è normale, se uccidi in guerra hai fatto ciò che dovevi fare, è proprio per questo che non è possibile dimenticare.» p. 132