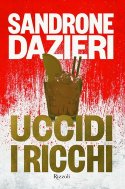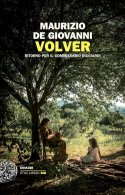Dettagli Recensione
Per t'lian lettori
Ci sono giorni in cui esci compri un libro lo leggi e ti fai un idea dell'autore, così torni in libreria decidi di prenderne un altro e la sensazione precedente viene accantonata e sostituita da una nuova visione che per anni ti tiene lontano da quell'autore.
Viene il giorno in cui il caso ti mette di fronte un nuovo libro dell'autore dimenticato e decidi, visti i commenti, di dargli un'ulteriore possibilità. Grazie all'occasione scopri una testo interessante, capace di riprodurre atmosfere, climi e situazioni dei primi del Novecento nell'ex colonia dell'Eritrea. La molteplicità delle scene, la ricercatezza del linguaggio, la dualità della lingua, la storia delle abitudini portano in una terra lontana, riuscendo a ricreare attraverso il racconto ambienti e luoghi lontani, mostrando le similitudini e le diversità (“..come da tradizione, Ogbà è il padrone di casa e dovrebbe stappare un pezzo di ingera con cui avvolgere qualche cubetto di carne da intingere nella senape o nella ricotta e imboccare l'ospite, non ci pensa neanche, sicuro che il capitano non capirebbe...”). Si formano attraverso queste peculiarità, le scene e le atmosfere, comprese quelle tipiche del giallo classico, narrazioni capaci di rendere la suspance e la difficoltà delle indagini del passato, fatte più di logica e deduzione che di scienza. I lunghi attraversamenti del deserto, le difficoltà nel reperire i reperti e i testimoni dei crimini, il telegrafo con le sue parole battute al vento colpiscono e affascinano. Immersi in questo contesto, tanti personaggi, negri e bianchi, coloni e colonizzatori, donne e uomini plasmati con dovizia di particolari per far trapelare i molteplici sentimenti della colonia, ovvio, su tutti spiccano i protagonisti.
Il capitano dei regi carabinieri Colaprico, d'istanza alla caserma di Asmara e il suo fedele aiutante, il vice, lo zaptiè Ogbagabriel Ogbà indagano sulla morte del marchese Sperandio, un sognatore Carlo Maria, coltivatore di viti per produrre chianti africano, e di tre abeshà, tutti impiccati ad “ainí berberè”, il sincomoro a pochi passi dai tucul di Afelba.
Quale relazione esiste tra le morti? Cosa unisce i tre indigeni con il “ferengi” (bianco)?
Due menti a confronto diverse, ma oneste e rette. Così il t'lian Colaprico e l'abeshà Ogba si completano a vicenda e se dei ferengi, compresi i t'lian, non c'è da fidarsi (“T'lian fetiunnì ilkà aitiaguès, non sentirti felice se l'italiano ti ha detto che ti ama. Non sentirti triste se ti ha detto che ti odia. Mai prenderli sul serio, gli italiani. Fanno sempre cose inutili.” ), Ogba, pur rispettando le gerarchie militari, non tiene allo scuro il suo capitano, illustrandogli le sue deduzioni. Passando tra le dita, la fiamma rossa dell'arma osserva e deduce, finendo per somigliare all'inquilino del 221 di Baker Street, spesso accomunato a lui anche da Colaprico, appassionato dell'investigatore appena inventato dalla penna di Doyle.
L'ombra del suicidio aleggia sulla vicende, sembrerebbe naturale quasi ovvio e le tessere del mosaico potrebbero comporre uno scenario simile. Attenzione però, Sherlock docet! “There is nothing so unnatural as the commonplace”, Ogba preferisce “Kem fulut neghèr zeybahriawí yelèn”, visto che snobba gli appellativi del capitano e non vuole fare la fine di Isaias, soprannominato Dante, un semplice “amarí t'lian”.
Così la “cosa del mosaico” porta via tempo, si scompone e si ricompone più volte, sempre più “hadeghegnà”, pericolosa, è tanta la pazienza da usare per disegnare la giusta scena, ma i due ci riescono, facendo trapelare un mondo di avventurieri, faccendieri, trafficanti di armi e di uomini, mogli legittime e illegittime che reclamano eredità, in breve una colonia già colma di loschi affari e specchio di una madrepatria altrettanto “trafficona”.
Semplice, classico da leggere.