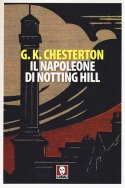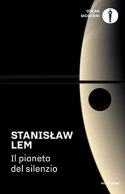Dettagli Recensione
LA BIBBIA SECONDO BARTH
“Il lettore dovrebbe aprire questo libro con un atto di fede, e chiuderlo con un atto di carità.”
Vorrei iniziare questa recensione partendo da una doverosa premessa. “Giles ragazzo-capra” è stato pubblicato in Italia, a sei anni dalla sua uscita americana, nel 1972 da Rizzoli e da allora non ha più avuto né una ristampa né una nuova edizione, al punto da risultare al giorno d’oggi praticamente introvabile. Se non si ha la fortuna di reperirlo in una biblioteca pubblica o presso qualche rivenditore di libri usati oppure (come il sottoscritto) in un sito di streaming online, il romanzo di Barth, pur inserito da diverse pubblicazioni come uno dei libri da leggere almeno una volta nella vita, è destinato al più inglorioso anonimato, come un tesoro sepolto di cui si sia colpevolmente perduta la chiave. La domanda che inevitabilmente mi viene da porre è pertanto la seguente. E’ mai possibile che in quasi cinquant’anni nessuna casa editrice si sia sentita, nell’ambito di un progetto di ampio respiro e non solo nell’ottica del profitto mordi e fuggi, di dare spazio a una proposta di nicchia ma di altissimo profilo intellettuale, in parole povere non si sia sentita di fare – seriamente – cultura? Dove sono finite la voglia di rischiare, l’orgoglio di avere in catalogo opere di qualità, il senso etico di chi non vuole accontentarsi di seguire acriticamente il gusto delle masse, dov’è finito cioè il ruolo di quell’editoria a cui abbiamo sempre guardato con ammirazione come a un baluardo contro l’imbarbarimento e l’ignoranza? E’ un vero peccato che la mia recensione abbia solo il simbolico valore di un messaggio in una bottiglia affidato alla provvidenziale benevolenza del caso, perché “Giles ragazzo-capra” meriterebbe di stare nelle librerie di un numero molto più grande di lettori.
Quasi anticipando beffardamente le possibili reazioni di critica e pubblico nei confronti del suo libro, Barth nella prefazione riporta gli eloquenti pareri di alcuni fantomatici redattori: c’è chi rifiuta categoricamente il romanzo in nome della moralità, della decenza e perfino del realismo (“non è mai esistito un ragazzo-capra!”), chi dichiara che il solo scopo dell’autore è quello di strabiliare, di essere eccentrico a scapito della realtà; chi considera il libro anti-economico, e così via. Barth dimostra fin da subito di aver le idee chiare e di potere (o volere?) fare a meno del pubblico, perché “felice di aver solo una dozzina di lettori, in quanto un tredicesimo potrebbe tradirlo”. Ma cos’è che rende “Giles ragazzo-capra” un’opera così atipica, da doverla leggere solo dopo che il suo autore si è premunito di mettere tutti sull’avviso, similmente al bugiardino di un farmaco, circa i rischi che si possono correre?
In effetti “Giles” è un romanzo che definire bizzarro e stravagante suona quasi come un eufemismo. Perfino “L’arcobaleno della gravità” di Pynchon appare come un libro convenzionale se messo a confronto con questa storia di un ragazzo allevato in un gregge di capre, il quale, solo dopo essere uscito dalla fanciullezza vissuta in una serena selvatichezza, prende coscienza di essere un uomo e, convinto di essere il Gran Tutore (ovvero il Messia) che tutti stanno attendendo, parte alla volta della civiltà con il proposito di “promuovere” l’umanità e, giunto tra i suoi simili, scopre altresì di essere il figlio di un calcolatore e di una vergine! Come se ciò non bastasse il mondo barthiano non è esattamente quello che conosciamo ma, con una ardita similitudine, appare come una gigantesca Università, divisa in Campus concorrenti, con regole, usi, tradizioni e modi di comunicare tipici dell’ambiente accademico. Non si tratta, come si potrebbe a prima vista pensare, di una allegoria (ossia l’Università utilizzata come simbolo per parlare della realtà contemporanea), bensì di una trasposizione analogica in scala – per così dire – 1:1. Come nel mondo parallelo del murakamiano “1Q84” o nell’Anti-Terra del nabokoviano “Ada o ardore”, anche qui il mondo è sostanzialmente riconoscibile, al punto che gli avvenimenti storici, i personaggi, le correnti religiose e filosofiche sono praticamente gli stessi, anche se diversamente denominati. Non si intravede, a essere sinceri, un’autentica necessità narrativa di creare un universo ex-novo (dove tutto funziona praticamente allo stesso modo), se non nella volontà da parte dell’autore di sfoggiare un virtuosismo davvero raro, quello di creare un’infinità di geniali neologismi: così Stati Uniti, Unione Sovietica e Germania diventano i collegi New Tammany, Nikolay e Sigfrido, la Guerra Fredda è la Sommossa Silenziosa, capitalismo e comunismo sono informazionalismo e unionismo, l’energia atomica è l’EAT (Amplificazione e Trasmissione Elettroencefalica, ma il termine in inglese ha anche ovvie assonanze con il verbo mangiare), Dio e il Diavolo sono il Fondatore e il Decano dei Bocciati, Gesù e Buddha sono Enos Enoch e Sakhyan, gli Ebrei sono Moisiani, perfino personaggi antichi della storia o dell’arte come Socrate o Edipo diventano Maios e il Decano Pietorto. In più tutto è declinato in termini di esami e votazioni, promozioni e bocciature, Decani e Gran Tutori, in un gustoso pastiche di stampo sottilmente parodistico.
Il mondo di “Giles” è inequivocabilmente il nostro (perfino nel Cancelliere Lucius Rexford si può riconoscere la figura di JFK), eppure assistiamo a una doppia distorsione di segno opposto. Da una parte l’universo di “Giles” presenta curiosi tratti di arretratezza: gli spostamenti, ad esempio, avvengono esclusivamente per mezzo di motociclette e di sidecar, mentre di automobili e di aerei non c’è stranamente traccia; e più in generale tutto sembra avere una consistenza di cartapesta, oggettiva e concreta come può esserlo la materia di un sogno. Dall’altra parte, per contro, il mondo prefigurato da Barth è per molti versi più avveniristico del nostro. In “Giles” infatti si immagina che a un gigantesco calcolatore, Il Wescac, sia demandata l’intera gestione pratica del Campus Occidentale, dall’approvvigionamento dell’energia elettrica alle misure di difesa militare (comprese le strategie di deterrenza per scongiurare un attacco da parte del Collegio nemico, a sua volta dotato di un analogo calcolatore, l’Eascac). Barth ipotizza che il Wescac sia stato dotato di libero arbitrio e reso capace non solo di funzionare automaticamente, senza richiedere l’intervento di alcuna persona, ma anche di provare passioni, desideri e immaginazione: un incubo che nemmeno l’Orwell più pessimistico era mai giunto a concepire. In pratica, il Wescac, programmato per programmarsi autonomamente e per distruggere tutti coloro che tentino di alterare gli scopi da lui prescelti, è diventato come una sorta di divinità, minacciosa e incontrollabile. Barth, che grazie alle pagine sul Wescac potrebbe a buon diritto essere considerato il padre della letteratura cyberpunk, esprime con una satira amara e pungente la preoccupazione per la stolida pretesa dell’uomo di padroneggiare con i suoi miseri e fallibili mezzi cose troppo più grandi di lui, che rischiano in ogni momento di sfuggire al suo controllo e condurlo alla catastrofe: una preoccupazione che negli anni ’60, in piena Guerra Fredda, era vissuta angosciosamente da milioni di persone, ma che risulta con ogni evidenzia ancora attualissima.
La paranoica distopia dell’universo barthiano trova la sua espressione a mio avviso più compiuta nelle pagine ambientate nella Fornace, governate da una parossistica follia. C’è qualcosa del Kafka di “America”, ma di un Kafka survoltato e ubriaco, in questa sorta di pantomima burattinesca, di “manicomio scatenato”, in cui schiere di operai corrono affannosamente in un perenne stato di emergenza, con carrelli che scendono alla cieca sui binari, argani che si incagliano, cavi che si spezzano e condutture che prendono fuoco, il tutto in un frastuono assordante e in un’atmosfera di massima disorganizzazione. Ci sarebbe da ridere di gusto di fronte a queste scene, se non fosse che ci troviamo all’interno della Centrale dell’energia che fa funzionare il calcolatore, e con esso l’intero Campus. Contraltare della Fornace è la Disciplinare, che rappresenta un secondo tipo di inferno, non più caotico e incontrollabile, bensì organizzato meticolosamente secondo un progetto che ricorda la suddivisione in gironi e bolge dell’Inferno dantesco. Un piano dell’edificio, ad esempio, è riservato a “quei professori che avevano usato il sabbatico come luna di miele o avevano preso parte a certe feste della facoltà in cui ci si scambiava le mogli” o “chi pur leggendo e svolgendo delle ricerche non si decideva mai né a insegnare né a pubblicare, o viceversa dedicava tanta parte del suo tempo alle pubblicazioni e all’insegnamento che non gliene restava più per leggere o per fare ricerche, e infine i professori che intimidivano gli studenti e gli studenti che scrivevano libelli contro i loro professori”. E un blocco di un altro piano è dedicato “a quegli autori di libri di testo che pubblicavano edizioni rivedute o accresciute per boicottare il mercato di libri usati, ai facitori di tesi, proliferatori di note a piè di pagina, e di ricerche inutili, e dispensatori di borse di studio privi di scrupoli”, e così via, in una divertentissima escalation di peccati accademici che mettono in risalto la bravura del Barth più parodistico, capace non tanto di usare, come farebbero i più, l’università per fare l’allegoria della realtà, ma al contrario di usare la realtà, lui che era stato per dodici anni docente alla Pennsylvania State University, per fare l’allegoria dell’università.
Ho parlato di Kafka e di Dante, ma “Giles” vanta un vero e proprio florilegio di riferimenti, soprattutto mitologici. In primo luogo la già citata nascita straordinaria del protagonista George, il ragazzo-capra, richiama ovviamente il Vangelo. Anzi, l’intero romanzo è un po’ una rivisitazione degradata delle Sacre Scritture: come Gesù George vive appartato, lontano – per così dire – dalla luce dei riflettori, la sua giovinezza, e proprio come Gesù decide di scendere tra gli uomini e rivelarsi come il Messia, affrontando le tentazioni (le scandalose feste a cui viene invitato da Stoker), compiendo i primi miracoli (le “prove” della Grata del Capro Espiatorio e del Cancelletto Girevole, grazie al “prodigioso” superamento delle quali ottiene l’ammissione ai corsi universitari, la discesa nel famigerato e letale “ventre” del Wescac, che funziona un po’ da riconoscimento soprannaturale della sua natura “grantutoria”) e venendo addirittura annunciato da un ambiguo Battista (il trasformistico Harold Bray, che per tutto il romanzo è una specie di Messia concorrente, non si sa se più lestofante o più “graduato” di George); attraverso la sua ingenua e appassionata predicazione è pian piano attorniato dai primi bizzarri discepoli e da una sorta di sensuale e fedelissima Maddalena, viene addirittura messo a morte dalla folla inferocita, “risorgendo” inopinatamente nella seconda parte del romanzo e dando vita a una nuova religione, il “gilianesimo”, con tanto di scismi e divisioni in confessioni parallele. Anche se la parabola religiosa di Barth non è apertamente irrispettosa e canzonatoria, si possono capire le resistenze che il suo libro deve avere creato alla sua uscita nel mondo cattolico, dal momento che George, privo dei freni inibitori inculcati da una normale educazione umana, non disdegna affatto il sesso, e più in generale i comportamenti anticonformistici (quando ad esempio il Rotolo del Fondatore, un corrispettivo del nostro Antico Testamento, viene inavvertitamente ridotto dal catalogatore in striscioline di carta, egli si trova, memore della sua alimentazione caprina, a mangiarne dei pezzi). L’intento di “Giles”, ancorché inevitabilmente scettico, non è comunque quello di essere una parodia alla Monty Python del Libro Sacro del Cristianesimo, tanto è vero che il finale ha delle inaspettate venature tragiche e persino nichiliste, laddove George, ormai invecchiato come il Gesù di Kazantzakis (dopo che a morire sulla Collina del Fondatore è stato il suo mentore Max Spielman, e ad “ascendere” al cielo, sparendo dalla vista degli astanti, è stato il suo antagonista Bray) riflette amaramente sulla deriva della sua dottrina, così lontana dalla purezza e dagli entusiasmi degli esordi. In linea con la sua natura di romanzo postmodernista, il proposito di “Giles ragazzo-capra” nel raccontare la prodigiosa storia di George è invece, più propriamente citazionistico. Prendendo spunto dall’imprescindibile testo di Joseph Campbell, “L’eroe dai mille volti”, Barth scrive infatti una sorta di testo programmatico che contiene tutti i “topoi” della letteratura eroistica: dalla nascita misteriosa (pensiamo, oltre a Gesù, a Mosé e a Romolo e Remo, questi ultimi tra l’altro allevati, similmente a George, da una lupa) alla relazione complicata con il padre (Edipo), dal ritiro dalla società al ritorno in essa attraverso il superamento di prove di vario genere (qui vengono in mente gli eroi di Omero, in particolare Ulisse, espressamente citato nella scena della gola di George – dove il protagonista deve opporsi alla irresistibile visione della nudità di Anastasia – o quando, per accedere alla Torre dell’Orologio in cui “nessuno” può entrare, egli adopera lo stesso stratagemma utilizzato con Polifemo). Naturalmente Barth sottopone questo materiale alle deformazioni e agli stravolgimenti tipici del postmodernismo. Il ragazzo-capra ripercorre così tutti i momenti topici dell’eroe classico-mitologico, ma si comporta più come un velleitario Don Chisciotte che come un astuto Odisseo, e nella sua predicazione ricorda piuttosto il Candido di Voltaire o l’Idiota dostojevskijano che Gesù. Infatti quando, nella sua prima fase “grantutoria”, egli insegna a separare manicheisticamente il bene dal male (il “promosso” dal “bocciato”), George provoca involontariamente, nonostante le sue migliori intenzioni, una montagna di danni, rischiando addirittura di far scoppiare la Terza Sommossa. In questo senso “Giles” si candida a romanzo chiave della letteratura postmoderna, in quanto giunge a teorizzare l’impossibilità di addivenire ad una conoscenza irrefutabile del mondo e ad un’etica condivisa. George, dopo aver constatato che Bene e Male non possono essere tenuti distinti, dapprima arriva a predicare, prendendo alla lettera il detto evangelico che “gli ultimi saranno i primi” (“i bocciati saranno promossi”), che per arrivare al Bene bisogna paradossalmente perseguire il Male, che le distinzioni tra colpa e innocenza, tra vero e falso sono infondate, per giungere infine, attraverso una serie di confuse capriole logiche, ad una sorta di relativismo filosofico vagamente orientale e molto anni ’60, in cui “tout se tient” e dove natura e cultura, istinto e razionalità vanno infine tra loro a braccetto. Nella sua seconda parte “Giles” diventa una sorta di “conte philosophique” (ovviamente molti sui generis), in cui i personaggi sillogizzano in continuazione, perdendosi in lambiccate elucubrazioni dove volta a volta a prevalere è una ferrea logica aristotelica o al contrario una capziosa manipolazione della stessa, con la conseguenza di arrivare a sostenere una cosa per affermare il suo contrario (“Sorrisi, sperando di confonderlo a forza d’inversioni d’inversioni così da poter alla fine chiarire a me stesso quelle giuste. «Quel che tu non sai, quando ti dico che la Bocciatura è Promozione, è se io voglio che tu creda che è così perché non è così o che non è così perché è così.» Anche Stoker sorrise ed aggiunse come en passant «… o che è così perché è così eh? o che non è così perché non è così…»”). L’effetto di questo helzapoppiano teatro delle idee è quello di mettere alla berlina la filosofia contemporanea, nel romanzo rappresentata soprattutto dagli “essisti” (specie di ibridi intellettuali, metà “clerici vagantes” e metà hippies ante litteram), attraverso la cui sterile dialettica sganciata dalla realtà è possibile arrivare a rendere filosoficamente legittima qualsiasi cosa.
“Giles” è postmoderno anche – e soprattutto – per l’utilizzo spregiudicato del linguaggio. Attraverso un uso sapiente del pastiche (che forse solo nell’”Ulisse” di Joyce era stato utilizzato con pari consapevolezza) Barth alterna diversi stili, spaziando dalla tragedia sofoclea (l’”Edipo re” è addirittura riscritto nella sua interezza con il titolo di “Decano Pietorto”, in un titanico sforzo di parodistico citazionismo che occupa decine di pagine) alla religione (è veramente spassoso il “Padre Nostro” declinato in versione studentesca), dalla scienza alla filosofia. Ovviamente il linguaggio è anche visto in chiave critica, laddove Barth mette in evidenza la sostanziale ambiguità della comunicazione. Ad esempio, George, dopo aver assistito di nascosto, nel suo periodo “caprino”, all’accoppiamento di due studenti, usa del tutto fuori contesto con la Signora dai Capelli di Panna le parole udite durante quel corteggiamento e, fraintendendo la risposta della donna, la aggredisce brutalmente facendola fuggire terrorizzata.
Altre caratteristiche tipiche del postmodernismo sono presenti in “Giles ragazzo-capra”, dalla incertezza sulla paternità dell’opera (chi ha scritto in fondo “Giles”: una ragazzo-capra, un uomo o un calcolatore? e il testo è originale oppure un falso storico, passato attraverso astute e interessate manipolazioni?) alla voluta noncuranza per le psicologie dei personaggi. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si può osservare che, come gli ambienti paiono di cartapesta, anche i personaggi sembrano più delle macchiette e dei cartoni animati che degli individui in carne ed ossa, ognuno estremamente caratterizzato in chiave simbolica (anche se in maniera forzatamente grottesca) e assomiglianti vagamente alle bizzarre figure incontrate dal piccolo Principe di Saint-Exupéry nel corso delle sue peregrinazioni (si pensi, a mo’ di esempio, ad Ira Hector, il Vecchio del Viale, un avaro patetico e “testugginoso” che cerca di vendere a tutti qualsiasi cosa o informazione in suo possesso, persino l’ora esatta). Alcuni dei personaggi di “Giles” sono dotati di una statura artistica che li rende davvero memorabili. Maurice Stoker è l’alter ego del ragazzo-capra, principe dell’intrigo e fomentatore di disordini, sorta di subdolo pirata alla testa di una rissosa e sguaiata banda di teppisti, eppure inopinatamente a capo sia della Centrale dell’Energia sia della Disciplinare; mefistofelico e perverso, secondo lui “il disordine è l’unico vero ordine”, e la contraddizione è l’unica armonia”; Stoker in fondo è come il diavolo dostojevskijano, “il necessario termine negativo, senza il quale (come si legge ne “I fratelli Karamazov”) “non succederebbe niente, e bisogna che succedano le cose”. Sua moglie Anastasia è invece una specie di “puttana santa”, crocerossina del sesso che si concede carnalmente a chiunque la desideri, più per altruismo e spirito di carità che per autentica ninfomania, e non a caso diventerà la più fedele discepola di George rendendolo anche padre. Max Spielman, scienziato “moisiano” e padre putativo di George (praticamente una combinazione dell’evangelico Giuseppe e di Einstein), cerca di allevarlo nella natura e lontano dalla civiltà (critico com’è nei confronti della sua deriva tecnocratica), in una riedizione del mito rousseauiano del buon selvaggio; per un inestirpabile spirito di sacrificio sceglie alla fine del romanzo di farsi impalare, in una cerimonia che ricorda la crocifissione del Cristo, per redimere le colpe ataviche del suo popolo. Stoker, Anastasia, Max e gli altri non meno indimenticabili personaggi (i coniugi Sear, dediti a depravate raffinatezze, Peter Green e Leonid, simboli delle due ideologie politiche contrapposte e destinati non a caso a finire entrambi ciechi, Eblis Eyerkopf e Gracchione, l’uno tutto cervello e l’altro tutto istinto, che si trovano ironicamente condannati a vivere simbioticamente insieme, e molti altri ancora) formano una fauna umana di straripante fantasia e di esemplare icasticità.
Non tutto, a dire il vero, è perfetto in “Giles ragazzo-capra”. Ad esempio, la seconda parte del romanzo gira un po’ a vuoto e risulta abbastanza ripetitiva, dal momento che George, dopo aver fallito le sei prove del compito che il Wescac gli aveva affidato, le ritenta per altre due volte in circostanze praticamente identiche (compresa una triplice discesa nel ventre del calcolatore), Ciò genera un inevitabile senso di ridondanza e di prolissità. Anche se strutturalmente alla fine tutto torna e il cerchio si chiude perfettamente, resta l’impressione che una bella sforbiciata alla mole del romanzo (lungo – è bene ricordarlo – quasi mille pagine) gli avrebbe probabilmente giovato. Anche taluni aspetti molto “politicamente scorretti” (anche se questo termine negli anni ’60 non esisteva ancora) rischiano al giorno d’oggi di risultare disturbanti (il personaggio di Gracchione, un nero frumentiano – ossia, nella terminologia barthiana, un africano – è talmente tutto istinto e niente cervello da apparire un odioso stereotipo; le donne del libro sono quasi tutte manipolate come oggetti sessuali), benché l’intenzione di Barth non era certo quella di scrivere un trattato antropologico né sociologico né tantomeno morale. Restano comunque indelebilmente impresse del romanzo la prodigiosa intelligenza dispiegata a piene mani, una fantasia praticamente inesauribile e, tra le righe, l’allarmante (ed estremamente attuale) disamina dei rischi che corre l’umanità affidando le proprie sorti a una tecnologia invasiva e onnicomprensiva. La satirica rappresentazione della Sommossa Silenziosa è un prezioso ed originalissimo gioiello che da solo rende imperdibile e preziosa la lettura di questa sgangherata, bislacca ma ineguagliabile teodicea.
Indicazioni utili
"L'arcobaleno della gravità" di Thomas Pynchon
Commenti
| 5 risultati - visualizzati 1 - 5 |
Ordina
|
| 5 risultati - visualizzati 1 - 5 |