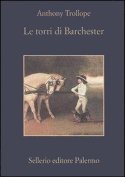Dettagli Recensione
Top 1000 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
IL TRADUTTORE PIÙ FEDELE DI SÈ STESSA
Che non si incorra nella malsana e ottusa opinione di inserire gli scrittori dentro una cerchia univoca, come se tutti fossero capaci di scrivere qualunque cosa e cimentarsi in qualunque genere. Se vogliamo parlare di impronta, alla base delle tante variabili possibili, esistono scrittori destinati alla prosa e scrittori destinati alla poesia. Sylvia Plath è una poetessa. E lo è perché per lei non c'è nulla da inventare nella scrittura, con essa cerca soltanto di essere il traduttore più fedele di se stessa, avendo il dono di trasferire l'epifania, il sacro parto della mente, su fogli destinati ad essere squarciati dal suo crudo ed emozionante realismo. Ho sempre pensato che le più belle poesie non possano prendere forma fisica, che la loro nobiltà stia nel fluttuare dalla mente al corpo, destinate ad essere intrappolate nella voce misterica di una conchiglia, ma fortunatamente mi sbaglio e qualcuno ci riesce. Sylvia Plath è un percorso, una folgorazione di femminilità tenera, tremenda e tremante. Se partiamo da tutto questo, allora credo che la poesia di Sylvia Plath, innanzitutto, sia di più quanto sliricato ci possa essere, perchè la scrittura striscia insieme a chi la partorisce come un verme che cerca il buco della terra per entrare nelle sue stesse viscere. La forma del contenuto poetico diventa solenne perché nobili sono i suoi sentimenti, ma la scrittrice è investita dal fango, è macchiata dalla sua primigenia forma di bruco ed è solo un inesorabile ciclo naturale a far diventare le sue poesie divine farfalle, non esiste nessuna menzogna, non esiste nessun artificio retorico. Questo romanzo mi ha stravolto perché mi ha fatto capire come la Plath non si sia mai sentita farfalla nella sua vita e mi commuove molto pensare quali capolavori riesca a creare il dolore di un bruco. Ho conosciuto Sylvia Plath leggendo prima i suoi "Diari" e poi le sue poesie, più o meno cinque anni fa. A quel tempo la cercai perché iniziava l'estate e io avevo bisogno di un riparo dalla presunzione del sole. Adesso l'ho ricercata perché volevo la compagnia di una donna vera, qualcuno che mi sorridesse debolmente, con il corpo sporco di una terribile umanità e che avesse capito che nella vita si parla di "vuoto" solo per dissimulare e non sentire la vertigine che apre al terremoto psichico della tenerezza.
"La campana di vetro" è una solitudine che stramazza. Ha una razionalità raggelante e, nel mio soggettivo e debole parere, credo che la scrittrice volesse cercare la verità più profonda del suo dolore. La scrittura è da intendere come archeologia, mentre il romanzo non è nient'altro che emergenza, un'esigenza carnale, non c'è sperimentalismo, nessuna prova di narratività; penso davvero sia nato soltanto dall'urgenza del caso. Se volessi prelevare un segmento, solo un piccolo pezzettino di tutto questo romanzo, cercando di ricostruire un quadro filologico che potesse poi rispondere alla totalità del testo, io farei affidamento all'entfremdung (alienazione, straniamento): tema concepito nell'800, ma protagonista indiscusso del Novecento e che in Sylvia Plath sembra quasi aver preso struttura ossea che non trova pace. Questo tema è diventato un vero e proprio catalizzatore letterario di dispersione quando gli scrittori hanno cominciato ad avere fede nell'abbandono e ad intraprendere questa nuova via di pellegrinaggio. La nausea, tra tutte, è forse la sensazione più forte che la scrittrice mi abbia trasmesso. In questo romanzo l'autrice cambia prospettiva e prova a guardare, a volte, l'interno dall'esterno, intenta a scavare spiegazioni su spiegazioni, con una ferocia animalesca e una naturalezza selvaggia di chi, con le parole, sta cercando terra.