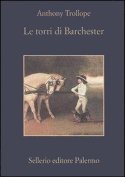Dettagli Recensione
AQUILE E COLOMBE
“Poiché sono vissuta tutti questi anni come se fossi morta, morirò, senza dubbio, come se fossi viva, e allora mi capiterà di essere come tu mi vuoi. Perciò vedi” concluse “non saprai mai a che punto mi trovo. Tranne quando me ne sarò andata, e allora saprai dove non mi trovo più.”
In un bel film uscito di recente al cinema, “Killers of the flower moon” di Martin Scorsese, il giovane e ingenuo protagonista viene spinto dallo zio, un uomo rispettato dalla comunità ma ambiguo e senza scrupoli, a sposare una ragazza della tribù indiana degli Osage (diventata enormemente ricca per via dei giacimenti di petrolio scoperti sotto la terra dell’Oklahoma in cui si era pochi decenni prima insediata) con il subdolo scopo di entrare in possesso della sua ingente eredità. Fatte le debite proporzioni tra storie e contesti quanto mai diversi tra loro (un western cinico e amorale da una parte, un romanzo intriso di torbido romanticismo dall’altra), il medesimo spunto narrativo lo si trova praticamente identico, quasi fosse un archetipo, ne “Le ali della colomba” di Henry James, dove il deuteragonista Merton Densher è indotto dalla sua astuta fidanzata a corteggiare la facoltosa ereditiera americana Milly Theale, fidando sul fatto che la esiziale malattia da cui la donna è afflitta le conceda poco tempo da vivere, e quindi che il suo patrimonio possa quanto prima e legittimamente passare alla coppia. Il paragone tra le due opere è curioso, e probabilmente anche opinabile e azzardato, ma è indubbio che il libro di James si allontani fin dalle prime pagine dagli stilemi della letteratura coeva per addentrarsi nei territori oscuri, impervi e ancora tutti da esplorare (siamo agli albori del Novecento) del modernismo. Certo, trattandosi dello scrittore newyorkese naturalizzato britannico, non mancano le atmosfere sublimi e raffinate, le conversazioni delicate da salotto, l’eleganza e il bon ton dei personaggi, gli arabeschi e i velluti damascati, eppure sotto questa impeccabile e immacolata superficie covano pulsioni molto poco nobili, a tratti anzi morbose e quasi diaboliche, degne dell’interesse di uno psicanalista non meno che di un romanziere. Non è un caso che fin dalle primissime pagine del romanzo i personaggi vengano considerati, prima ancora che persone, dei “valori” da sfruttare, degli atout da monetizzare (tale è sicuramente Kate, in virtù della predilezione manifestatale dalla zia Maud, per il padre e la sorella, così come più avanti lo sarà Milly per la corte che la accoglierà a Lancaster Gate). E’ come se James ci introducesse alle regole di un gioco di strategia complesso e imprevedibile, la cui posta è decisiva e richiede calcolo e astuzia, dissimulazione e tattica. Il “gran mondo” a cui il lettore si trova ad assistere è una specie di agone economico, in cui “era tutto un prendere e un dare, con le ruote del sistema meravigliosamente oliate” e la cui morale è cinicamente sintetizzata da lord Mark quando confessa che “qui nessuno fa nulla per nulla”. Il grande, modernissimo, motivo di interesse del romanzo è che apparentemente esso è un amabile ritratto della società aristocratica dell’era vittoriana, ma dietro le quinte, in una proliferazione di pulsioni ambigue e incontrollabili, si annida un “mostro” che – con le parole dell’autore – è in grado di produrre “un’estasi esagerata o… un orrore anche più sproporzionato”. Quando Milly Theale, con la fida amica Susan, giunge in Europa dagli Stati Uniti, “una giovinetta sottile sottile, sempre pallida, delicatamente sciupata, di una anormale e graziosa angolosità, dai capelli di un rosso troppo eccezionale perfino per essere vero, e dai vestiti troppo neri anche per un lutto”, dotata di una ricchezza e di una libertà praticamente sconfinate, si capisce subito che essa è destinata a diventare la vittima predestinata di un complotto spietato, ancorché mascherato di simpatia, di benevolenza e di premurosità. Lei è la colomba del titolo, essere fragile e innocente, ma le cui ali sono anche capaci di avvolgere e proteggere coloro che ama. Contrapposti a lei ci sono le aquile (James indulge spesso in questi paragoni ornitologici, chiamando espressamente così la zia Maud), coloro che per un motivo o un altro (Kate per riuscire a sposare Merton, giovane brillante ma privo di risorse, la zia Maud per allontanare lo stesso Merton dalla nipote, lord Mark per risollevare un blasone compromesso da troppi debiti, perfino la candida Susan per rendere il più possibile felice l’amica giunta al tramonto della sua breve esistenza) tramano alle sue spalle, trasformandola nella ignara pedina di un gioco che la sovrasta. Altrettanto strumentalizzato e passivo, letteralmente gettato tra le braccia della ragazza a dispetto di tutte le sue riserve morali, è Merton Densher, al quale viene però riservato nel finale dall’autore, in un clamoroso e inatteso colpo di scena, un gesto di nobile rinuncia, di disinteressato sacrificio, che è tanto una estrema dichiarazione d’amore quanto un atto di ribellione nei confronti di una società avida e calcolatrice.
Milly Theale è un personaggio che richiama altre famose eroine jamesiane, dalla Catherine di “Washington Square” alla Daisy Miller dell’omonimo racconto. Il suo alter ego più evidente è però l’Isabel Archer di “Ritratto di signora”. Come Isabel, Milly è giovane e intelligente, ricca e libera, in viaggio nel Vecchio Mondo dopo aver lasciato la natia America (vero e proprio “topos” della narrativa di Henry James). Vi sono però delle importanti differenze che è doveroso sottolineare. Innanzitutto, Milly non è più la sola protagonista del romanzo: al suo fianco si stagliano, con pari importanza diegetica, i personaggi di Kate Croy e, soprattutto di Merton Densher, tanto è vero che l’ereditiera americana entra in scena soltanto nel libro terzo. Inoltre Milly Theale è spesso descritta solo in modo indiretto, attraverso gli occhi di coloro che le gravitano intorno, o addirittura, in un capitolo tra i più belli del libro, per mezzo di un dipinto del Bronzino, che rivela con la nostra protagonista una misteriosa, ineffabile affinità. Per quanto riguarda la malattia, che quasi sempre James aveva riservato solo a personaggi secondari (si pensi al Ralph Touchett di “Ritratto di signora”), qui ha un ruolo fondamentale, investendo direttamente la protagonista e mettendola di fronte alla straziante contraddizione tra una voglia di vivere smisurata e una quantità di tempo a disposizione fatalmente ridotta. La stessa malattia, pur essendo costantemente in primo piano, è però trattata dallo scrittore in maniera sfuggente e sibillina. Milly, orgogliosamente, si rifiuta di prenderla in considerazione, e perfino il dottor Strett non la cita mai, invitando semplicemente la ragazza a godere quanto più possibile i piaceri della vita. Tutti i personaggi la danno per scontata nei loro discorsi e nei loro rapporti con la protagonista, ma la verità è che essa non è mai conclamata, è un argomento tabù, un minaccioso convitato di pietra relegato nei meandri più nascosti della coscienza. Paradossalmente, Milly è considerata da tutti una donna condannata, senza speranza, anche se nessuno ha mai esplicitamente pronunciato un verdetto medico, e la stessa ragazza prende coscienza della propria condizione soltanto davanti al già citato dipinto del Bronzino (che gli esperti hanno identificato nel ritratto di Lucrezia Panciatichi conservato negli Uffizi di Firenze), che tanto le assomiglia (“La donna in questione, con la sua leggera scriminatura michelangiolesca, i suoi occhi d’altri tempi, le sue labbra tumide, il suo lungo collo, i suoi famosi gioielli, i rossi sbiaditi dei suoi broccati, era un grandissimo personaggio, ma non l’accompagnava la gioia. Ed era morta, morta, morta”). Questa elusività risponde sicuramente all’intento dell’autore di non rendere melodrammatica la vicenda narrata, ma è altresì funzionale allo stile dell’autore, improntato all’ambiguità e al non detto, come si può notare anche nella lettera di Milly indirizzata a Merton, che l’uomo fa leggere a Kate ma di cui rifiuta di conoscere il contenuto, preferendo che venga bruciata nel fuoco del camino (espediente che viene ripreso da Cormac McCarthy ne “Il passeggero”, a dimostrazione della modernità psicologica del romanzo di James di oltre un secolo prima).
Lo stile di Henry James è, come sempre, di mirifica perfezione, con alcune scene di raffinatissima resa pittorica (come il ricevimento a palazzo Leporelli, che rimanda ai quadri del Veronese). L’abbagliante bellezza della scrittura jamesiana non deve però far pensare che quella de “Le ali della colomba” sia una lettura semplice e comoda, tutt’altro. Già da qualche anno, James stava collaudando un modo di scrivere più ricercato, quasi sperimentale, se paragonato ai suoi romanzi degli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento. In questo romanzo tutto ciò si esprime in una forma quanto mai matura: la trama non è infatti mai scontata, non pare affatto rigida e predeterminata (anche se la lunga e interessantissima prefazione dello scrittore fa comprendere quale complesso lavoro progettuale vi sia dietro). Ogni situazione descritta presenta sempre svariate alternative, ogni circostanza legittima costantemente diverse interpretazioni, e perfino un semplice dialogo cela in ciascuna parola un significato potenzialmente equivoco (spesso perfino un banale pronome riesce a depistare l’interlocutore, e con lui il lettore, potendosi attribuire a un personaggio piuttosto che a un altro). Tutto questo offre al testo innumerevoli potenzialità narrative, nelle quali il lettore non ha mai il salvagente di un punto di vista demiurgico e assoluto, in quanto ne sa né più né meno che i personaggi del libro che sta leggendo. Ciò gli conferisce un ruolo quanto mai attivo, anche se in alcuni momenti tale ruolo può apparire indubbiamente ingrato e scomodo da sostenere. La ricompensa a questa fatica, una volta che si sia riusciti a portare a termine questa affascinante storia romantica e sentimentale raccontata alla stregua di un vero e proprio giallo psicologico, è però una soddisfazione rara, una beatitudine ineffabile, che pochissime altre opere e pochissimi altri autori (mi vengono per primi alla mente, per limitarmi alla prima metà del Novecento, Marcel Proust, Thomas Mann e Vladimir Nabokov) sono in grado di eguagliare.