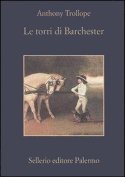Dettagli Recensione
CONFESSIONI DI UN GIUDICE-PENITENTE
“In fin dei conti, è proprio questo che sono, rifugiato in un deserto di pietre, di nebbie e d'acqua putrida, profeta vuoto per tempi meschini, Elia senza messia.”
“La caduta” è una lunga, ininterrotta conversazione che si sviluppa, per la durata di sei capitoli corrispondenti ad altrettante giornate, tra il protagonista, Jean-Baptiste Clamence, e un anonimo interlocutore incontrato in un sordido bar di Amsterdam. Siccome l'improvvisato compagno di Clamence non apre mai bocca, o se lo fa Camus lascia sempre sottintese le sue rade parole, il dialogo assomiglia tanto a un incessante monologo. La memoria letteraria non può che andare ad altre famose opere del passato, da “La tana” di Kafka a “Memorie dal sottosuolo” di Dostojevskij, accomunate a “La caduta” non solo dall'analogo procedimento stilistico (l'uso della prima persona singolare) ma anche – soprattutto la seconda – da un analogo impianto filosofico. Apparentemente le differenze tra i loro protagonisti non potrebbero essere più grandi: mentre quelli di Dostojevskij e di Kafka sono personaggi del sottosuolo (anche letteralmente, se si considera l'animale de “La tana”), frustrati, inappagati e diffidenti, Clamence si presenta fin dall'inizio come un uomo ben inserito nella società in cui vive, soddisfatto di sé, moralmente irreprensibile, dalla parte del giusto e – guarda caso – amante dei luoghi elevati (“alla metropolitana preferivo l'autobus, ai mezzanini le terrazze”). Egli è a prima vista quello che Dostojevskij definisce polemicamente un “homme de la nature et de la vérité”, la cui esistenza è improntata esclusivamente a meschini e conformistici principi come l'utile o il piacere. Ciò non gli impedisce però di lasciarsi andare ad appassionate requisitorie contro gli aspetti più ipocriti della società del tempo, come l'amicizia (“ci salvi il cielo dall'essere collocati troppo in alto dai nostri amici!”), la famiglia (“i parenti sanno la parola che ci vuole,... ma è una parola proiettile;... e mirano giusto, i traditori!”), il matrimonio (“orgia burocratizzata”, “monotono carro funebre dell'audacia e dell'inventiva” che “ha ridotto il nostro paese in pantofole”), la morale religiosa (“ci sono persone per cui la religione consiste nel perdonare tutte le offese, e le perdonano effettivamente; ma non le dimenticano mai”), ecc. L'istintiva simpatia e la disarmante sincerità di questo ex-avvocato parigino induce il lettore, nonostante la sua fastidiosa logorrea (è un po' come il troppo loquace compagno di viaggio in treno che ti impedisce con le sue chiacchiere di leggere in santa pace il tuo libro) e una sorta di malcelata ambiguità che trapela dalle sue parole, a empatizzare con lui, a condividere la sua irresistibile, vitalistica, anche se vagamente contraddittoria, volontà di “épater le bourgeois”, convinto che egli è, come il bombarolo di Fabrizio De André, “se non tutto giusto, quasi niente sbagliato”. E così le tirate polemiche contro i francesi (“mi è parso che i nostri concittadini avessero due frenesie: le idee e la fornicazione”), gli intellettuali da caffè (che si scandalizzano, contorcendosi “in preda alle convulsioni come il diavolo sotto l'acqua santa”, di fronte alle opinioni illiberali e reazionarie), ai romanzieri atei (che per partito preso professano nei loro libri idee anti-religiose, ma non riescono a evitare di adottare un moralismo altrettanto ipocrita dei pensatori cristiani, in una sorta di “satanismo virtuoso”: una frecciata dell'autore all'amico-nemico Jean-Paul Sartre?), gli uomini di fede e i ministri del culto (che “hanno installato il Signore in un tribunale, nel fondo di loro stessi, e picchiano, e giudicano, soprattutto giudicano […] col perdono sulle labbra e la sentenza nel cuore”), e perfino Dio (che non è più necessario come entità garante della morale, al punto che oggigiorno l'unica funzione della religione sarebbe quella di essere “una grande impresa di lavatura”) e la società contemporanea (dominata dalla cieca violenza del potere e dall'hobbesiano principio che “homo homini lupus”), queste tirate polemiche – dicevo – funzionano come altrettante trappole che, abilmente predisposte da Camus, catturano poco alla volta il lettore, trasformandolo a sua insaputa in un complice del protagonista, una sorta di suo “doppelganger” (“La caduta è in fondo come uno specchio in cui, guardando l'immagine riflessa, egli vi si riconoscesse e, parafrasando la famosa frase di Flaubert, fosse costretto ad ammettere: “Clamence c'est moi!”)
Quando, verso la metà del romanzo, il gioco finalmente si scopre, è ormai troppo tardi. A fare da linea di demarcazione tra la chiacchierata spensierata tra due compagni di bevute e la discesa agli inferi di un'anima ferita ed esacerbata è un episodio fatidico, il classico evento del quale si può dire che dopo di esso niente è più come prima. La notte d'autunno in cui Clamence, passeggiando lungo la Senna, sente distintamente una persona, presumibilmente una donna fugacemente incrociata pochi attimi prima, gettarsi dal ponte che ha appena attraversato e non fa nulla per salvarla o per chiamare i soccorsi, fa irruzione nella sua vita la coscienza, sotto forma di una beffarda risata che lo perseguiterà negli anni a venire, risuonando nei luoghi e nei momenti più inaspettati. La risata, oltre che la coscienza, rappresenta anche l'assurdo che fatalmente entra senza preavviso nella vita dell'uomo, mettendo a nudo la sua falsità e la sua ipocrisia. Le certezze acquisite da Clamence iniziano così a vacillare, facendo trapelare l'egoismo alla base delle sue scelte di vita (“Sono sempre stato pieno di vanità da scoppiare. Io, io, io, ecco il ritornello della mia cara vita”) e lasciando come ineliminabile scoria di una esistenza di dissolutezze e di sterile ricerca del piacere un sordo, disperante disagio. Ma l'uomo non vuole sentirsi in colpa e non ammette di essere giudicato in alcun modo (“Vorremmo nello stesso tempo non essere più colpevoli e non fare lo sforzo di purificarci. Non abbastanza cinismo e non abbastanza virtù”). L'unico modo per evitare il giudizio (“Il problema è... di evitare il giudizio. Non dico evitare il castigo. Il castigo senza giudizio è sopportabile […] No, si tratta invece di sfuggire al giudizio, di evitare d'essere sempre giudicati senza che mai venga pronunciata la sentenza”) e non essere più dalla parte del torto è quello di giudicare a propria volta gli altri. Camus modifica impercettibilmente la massima di Kafka (“La colpa è sempre fuori discussione”), trasformandola nella più confortevole formula “la colpa degli altri è sempre fuori discussione”. Ma siccome non si possono condannare gli altri senza giudicare immediatamente se stessi, bisogna fare la strada inversa: incolpare se stessi per avere il diritto di giudicare gli altri. Ecco quindi Clamence trasformarsi da avvocato in giudice-penitente. Cosa significa essere un giudice-penitente? La spiegazione risiede in tutto quanto si è letto fino ad allora, in una sorprendente e inattesa mise en abyme. La confessione di Clamence (il racconto apparentemente franco e privo di reticenze della propria vita) è il meccanismo da lui studiato per provocare l'immedesimazione degli altri (“Non mi accuso grossolanamente, a pugni sul petto. No, navigo con destrezza, moltiplico le sfumature e digressioni, insomma adatto il discorso all'ascoltatore, lo induco a rincarare la dose. Mescolo quel che mi concerne e quel che riguarda gli altri. Prendo i tratti comuni, le esperienze sofferte insieme, le debolezze che abbiamo entrambi, le buone maniere, l'uomo d'oggi insomma. […] Quando il ritratto è terminato... lo mostro, tutto sconsolato. “Ahimé, ecco chi sono.” La requisitoria è finita. Ma in quel preciso istante il ritratto che mostro ai miei contemporanei diventa uno specchio. […] Poi, inevitabilmente, passo nel discorso dall'io al noi. Quando arrivo all'”ecco che cosa siamo”, il gioco è fatto, posso dire a ciascuno la sua verità. […] Il vantaggio è chiaro... Più mi accuso e più ho il diritto di giudicare”). Con questo sistema il processo intestato a se stessi si rovescia come un guanto e coinvolge gli altri. Camus capovolge quindi il famoso grido di Ivan Karamazov citato nel suo “L'uomo in rivolta” (“Se non sono salvi tutti, a che serve la salvezza di uno solo!”) in una sorta di “Se non sono condannati tutti come si riesce a realizzare la felicità di uno solo?”. Ne “La caduta” il protagonista, come un demoniaco demiurgo, si auto-assolve dai suoi peccati, si ripulisce la coscienza, o meglio dimentica di averne una, sfugge la responsabilità di un vero pentimento e abdica alla propria libertà in cambio di un po' di smemorata tranquillità. Clamence usa il suo stratagemma come un anestetico, che non fa sentire il dolore della vita ma ottunde i sentimenti più profondi, rendendolo in fondo meno umano. La morale de “La caduta” è profondamente pessimistica: Clamence rinuncia, insieme alla sua angoscia, anche alla sua libertà e quindi, dal momento che Kierkegaard e Heidegger ci avevano insegnato che l'uomo è condannato a essere libero, rinuncia alla sua unica possibilità di una vita autentica. Come ne “La leggenda del Santo Inquisitore” di Dostojevskij, la libertà è per l'uomo un fardello insopportabile (“alla fine di ogni atto di libertà c'è una sentenza: per questo la libertà pesa troppo”), ed egli è disposto a cederla in cambio del servaggio (“L'essenziale è di non essere più liberi e di obbedire, nel pentimento, a qualcuno più furfante di noi. […] Tutti uniti, finalmente, ma in ginocchio, e a capo chino”). Se “Il mito di Sisifo” e “La peste” avevano, dopo il nichilismo de “Lo straniero”, gettato un barlume di speranza nella filosofia esistenzialista di Camus, esaltando il primo la sopportazione, l'accettazione del proprio destino, sia pure quello di rotolare un masso per l'eternità, la seconda la solidarietà umana (di stampo, oserei dire, leopardiano) come gesto di ribellione nei confronti dell'assurdo, ne “La caduta” si registra un netto passo indietro: l'uomo prende sì coscienza dell'assurdo, ma non cerca mai – sia pure in modo velleitario – di lottare contro di esso; al contrario egli si sforza di evitare il giudizio con la dimenticanza e di sfuggire alle responsabilità facendosi scorrere sopra le cose, in tal modo sprecando la sua libertà e la sua possibilità di scelta, e decretando in tal modo lo scacco della filosofia esistenzialista (le ultime parole - “Adesso è troppo tardi, e sarà sempre troppo tardi, per fortuna!” - sono fin troppo emblematiche).
“La caduta” è un libro lucido e incalzante, caratterizzato da una densità filosofica inusitata. Dalla prima all'ultima delle sue ottanta pagine, Camus non dà un attimo di tregua al lettore, incalzandolo con domande esistenziali di ineludibile urgenza, fino al delirante e quasi satanico finale. La costruzione del romanzo, scritto con uno stile di limpida e adamantina chiarezza, è eminentemente astratta e mentale: tutto è proiezione dell'io ipertrofico del protagonista, e lo stesso interlocutore potrebbe essere benissimo una sua invenzione (e del resto ciò non è così importante, dal momento che – come abbiamo visto – Clamence è come se parlasse a tutti noi, con un meccanismo analogo a quello cinematografico dello sguardo in macchina, quando cioè in un film un personaggio comunica rivolgendosi direttamente alla cinepresa). Clamence passeggia nelle viuzze del Ghetto Ebraico e lungo i canali di Amsterdam oppure naviga nello Zuiderzee alla volta dell'isola di Marken, ma l'Olanda stessa è null'altro che un luogo fantomatico, utile tutt'al più come pretesto di eleganti metafore (i canali concentrici della capitale assomigliano ai girono dell'inferno, le dune e le spiagge livide davanti al mare color lisciva fanno pensare a una terra morta e spopolata, e gli stessi olandesi, “costretti in un piccolo spazio di case ed acqua, assediati da nebbie, da terre fredde e da un mare che fuma come un bucato”, sono espressione della duplicità della natura umana, essendo come degli spettri, qui e altrove nello stesso istante). Tutto ne “La caduta” è ambiguo, segnato da aporie e contraddizioni, e il lettore deve imparare a destreggiarsi tra verità e menzogna (“E' molto difficile districare il vero dal falso in ciò che racconto... In fin dei conti che importanza ha? Le menzogne finiscono per mettere sulla strada della verità”). Alla fine di questa lettura, al tempo stesso esaltante e ostica, splendida ed estenuante, veniamo come risucchiati dall'inesauribile vortice delle sue riflessioni e finiamo per sentire sulla nostra stessa pelle il disagio del protagonista e per patire i suoi medesimi rovelli mentali, come insetti catturati nella sua mitrabile ragnatela, accomunati a lui da una ineffabile sensazione di torbida e vergognosa connivenza. “Pronunzi lei le parole che da anni non hanno smesso di risuonare nelle mie notti e che finalmente dirò per bocca sua: “Fanciulla, gettati di nuovo in acqua perchè io abbia una seconda volta la possibilità di salvare entrambi!”. Una seconda volta, eh, che imprudenza! Supponga, caro avvocato, che ci prendano in parola? Bisognerebbe decidersi”. Noi che decisione prenderemmo al suo posto? Ci butteremmo in acqua rischiando la vita per salvare un suicida o gireremmo la testa dall'altra parte, facendo finta di nulla?
Indicazioni utili
Commenti
| 13 risultati - visualizzati 1 - 10 | 1 2 |
Ordina
|
Questo libro mi attrae poco. Ho letto altro di Camus : uno scrittore che letterariamente risulta di livello, ma che tristezza!
| 13 risultati - visualizzati 1 - 10 | 1 2 |