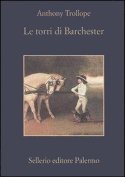Dettagli Recensione
Essere uno zero
Per tentare di fare un passo appena nel complesso intrico di significati che potrebbe celarsi nello “Jakob von Gunten”, può essere d’aiuto al lettore un principio cardine della comunicazione e cioè l’impossibilitò di non comunicare. Il cupio dissolvi che anima il protagonista, ben condensato nella volontà di essere niente più che uno zero, costruisce una coreografia letteraria che continuamente si sottrae alle sue conclusioni, come in un continuo movimento della macchina da presa che rifiuta di mettere a fuoco il problema. Sgranato, sfocato, inintelligibile, il cuore impossibile del romanzo si trova in un altrove che esiste solo nella mente del lettore, abituato a indagare significati nascosti, simboli criptici, misteriose associazione. Eppure la verità è che in questo libro i simboli non significano nulla, sono idoli inconsistenti e tutto si radica in un pragmatismo inesausto che vuole condurre il lettore a non interrogarsi, non fare troppe domande. Lo costringe anzi a quello che gli studenti dell’istituto Benjamenta, Jakob in primis, fanno ogni giorno: ripetere a memoria nozioni inutili, studiare e ristudiare gli stessi concetti, occupare la mente per tenere il pensiero a bada. Quale è l’insegnamento che viene impartito nell’istituto? Quale è il segreto che si nasconde nelle stanze interne? Il fatto è che Walser, indefesso prestigiatore, costruisce lo spettacolo e suscita le domande, ma poi non spiega il trucco perché semplicemente non c’è trucco. Al cuore dell’istituto Benjamenta, al centro dell’esperienza di Jakob, non c’è nulla. Uno zero assoluto. E su questo vuoto si spalanca il libro.
Robert Walser è considerato uno dei più grandi autori svizzeri di lingua tedesca insieme al suo connazionale Dürrenmatt. Ha scritto migliaia di pagine, costellazione di microstorie che tentano di ricostruire un disegno e che allo stesso tempo demoliscono ogni possibilità di disegno. Non credo sia un caso che Walser fosse un autore molto amato da Kafka, che amava molto lo Jakob von Gunten e che nel suo “Il castello” recuperò l’idea di uno spazio geografico chiuso, il castello-istituto, che sfugge ad ogni semplice simbolismo o facile metafora. L’istituto Benjamenta non è né la vita, né la crescita, né un subdolo grande fratello, è piuttosto uno spazio indifferenziato in cui il pensiero lotta per negare se stesso, in cui la prassi è potenza di negazione. Walser passò ventotto anni in una clinica psichiatrica, distrutto, stanco come una stufa spenta e più volte ebbe a dire che nessuno poteva davvero pretendere di conoscerlo. E allora tutta l’enigmaticità delle sue opere, i significati reconditi, le interpretazioni più svariate, il vuoto cupo che lasciano al lettore, sono forse gli estremi esiti di chi sa che non c’è nessuna verità possibile, che il fondo delle cose è uno zero assoluto. E la manciata di vuoto con cui il lettore resta in mano è la voce di chi non ha saputo essere capito.
Detto questo, il romanzo in sé procede in modo del tutto particolare, abbastanza fastidiosamente, lo stile è quasi infantile, ma molto studiato, i temi accennati e mai analizzati. Resta un senso di inconsistenza, come se di tutto non fosse rimasto niente, ancora uno zero assoluto e allora l’unico modo per capire è analizzare il negativo del libro. Eppure il negativo del libro non basta a renderlo una lettura del tutto soddisfacente.
Commenti
| 7 risultati - visualizzati 1 - 7 |
Ordina
|
Inoltre, parli di "temi accennati e mai analizzati". Secondo me, proprio il suo stile poetico 'suggerisce' e lascia aperta la porta alla profondità di lettura . 'Analizzare' è compito della saggistica, non dell'arte.
La scrittura di Walser, per me bellissima , quindi è dotata di lievità profonda.
Ovviamente, questo romanzo mi è assai piaciuto.
Ti saluto con stima e simpatia inalterate.
| 7 risultati - visualizzati 1 - 7 |