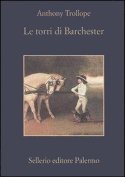Dettagli Recensione
TRE LETTURE DI UN PICCOLO CAPOLAVORO
Attenzione: Questa non è una vera e propria recensione, bensì una sorta di saggio con cui ho provato a spiegare i tanti misteri della storia, analizzando la trama, un po' come un detective, fin nei minimi dettagli. Ne consiglio pertanto la lettura solo a chi già conosce il racconto.
“Ci sono degli abissi, degli abissi!.. Non so più che cosa non vedo, che cosa non mi fa paura!”
“Nessuno finora, all’infuori di me, ne ha mai udito nulla. E’ semplicemente troppo orribile. E’ al di là di ogni immaginazione”. Con queste parole, rivolte a un piccolo gruppo di ascoltatori riuniti attorno al focolare di una vecchia casa, ovviamente di notte come nella miglior tradizione delle ghost stories, il personaggio cui James dà il nome di Douglas si accinge a raccontare la vicenda racchiusa nel manoscritto di una donna morta vent’anni addietro. La cosa che salta subito agli occhi è il gran numero di piani di narrazione stratificati nel racconto: c’è Henry James, lo scrittore, c’è l’anonimo personaggio che dice “io” e che fa parte del ristretto uditorio della storia, c’è Douglas, il narratore, e c’è la donna autrice del manoscritto, che ha vissuto in prima persona gli avvenimenti descritti. E’ difficile rimuovere l’impressione che questi differenti livelli di enunciazione siano altrettante cortine fumogene che James innalza per rendere più fitto il mistero di questo agghiacciante racconto e impenetrabile il suo autentico messaggio. Non è questo l’unico motivo che mi fa propendere per la tesi di una ambiguità consapevole e metodicamente voluta: nel “Giro di vite”, infatti, gli avvenimenti rimangono quasi sempre sospesi, non definiti, incapaci di connotarsi con gli attributi della quotidianità e di svelare fino in fondo il proprio significato. L’astrazione prevale sulla concretezza, l’illusione sulla realtà, e le stesse parole di James, nella loro ridondanza stilistica, sembrano portare non già ad una rivelazione bensì ad un ispessimento del mistero. La presenza costante di questi filtri mistificatori, se da una parte contribuisce indubbiamente ad aumentare in maniera irresistibile il fascino del racconto, dall’altra ne ingigantisce le difficoltà di lettura, rendendolo, pur nella sua brevità, un’opera ostica e impegnativa da affrontare. “Il giro di vite” è, in altre parole, uno di quei libri che richiedono, quasi obbligatoriamente, più di una lettura per poter andare al di là di una prima impressione riduttiva e insoddisfacente.
LA PRIMA LETTURA, OVVERO LA LETTURA INGENUA
L’autrice del manoscritto era stata in vita una stimata istitutrice, “piena di fascino, ricca di acume e di simpatia”, come la ricorda Douglas, che ha avuto modo di conoscerla molti anni avanti. Nel corso del prologo, Douglas racconta come, all’inizio della sua carriera di insegnante, la giovane istitutrice avesse risposto all’annuncio di un affascinante gentiluomo, il quale le aveva offerto di curare, in una piccola dimora di campagna, l’educazione dei suoi piccoli nipoti, Miles e Flora, rimasti orfani di entrambi i genitori. Nonostante la stranezza della proposta (lo zio aveva posto come condizione imprescindibile che l’istitutrice non lo avrebbe mai, per nessun motivo, dovuto disturbare), la ragazza aveva accettato, probabilmente ammaliata da quell’attraente e gentile scapolo, che le aveva presentato tutto come una specie di favore, una grazia per la quale le sarebbe stato per sempre obbligato.
E’ a questo punto, con il viaggio verso la tenuta di Bly, che si apre lo sbiadito manoscritto e la parola passa definitivamente alla governante. Ella si presenta subito in preda ad uno stato d’animo di angosciosa inquietudine, come se si rendesse conto di avere commesso un errore fatale o temesse di andare incontro a qualcosa di insicuro. L’impatto con Bly è comunque tale da dissipare ogni incertezza: lo splendido scenario della villa e del giardino, l’amabilità e la schiettezza della responsabile della casa, la signora Grose, e soprattutto l’incantevole fascino della piccola Flora trasformano in men che non si dica l’abbattimento iniziale dell’istitutrice in euforica esaltazione. La seconda sera avviene però, del tutto inatteso, il primo di una lunga serie di avvenimenti che, in capo a poche settimane, trasformeranno il soggiorno a Bly dell’istitutrice in un incubo terrificante: l’arrivo di una lettera con la quale il direttore del collegio in cui da tre mesi è ospitato Miles comunica, senza fornire alcuna spiegazione, la volontà di rimandare il bambino a casa. E’ questo un fatto che si rivelerà fondamentale nell’economia del racconto, al di là del comprensibile sconcerto che la notizia getta istantaneamente nella casa: Miles infatti si rivela un bambino tenero, delicato, affettuoso, permeato della stessa luminosa purezza che contraddistingue la sorellina. Come può una così angelica creatura essere stata espulsa ignominiosamente da scuola? Cosa può aver mai fatto di male un essere che è l’emblema stesso dell’innocenza? La prima reazione dell’istitutrice è quella di ribellarsi, indignata, alla crudele e misteriosa accusa, trovandola assurda e persino grottesca. Ma un tarlo si è intanto subdolamente insinuato nella sua mente, un dubbio che con il passare dei giorni aumenta sempre più fino a diventare un’ossessione: ella sente che qualcosa le è stato nascosto, che un enigma si cela nell’apparentemente idilliaco universo di Bly, e con l’ostinazione e l’aggressività proprie di un investigatore si mette alla ricerca di un qualsiasi indizio che possa confermarla nella propria impressione. La traccia viene scoperta nei silenzi e nei sottintesi della signora Grose, l’unica possibile interlocutrice della governante a Bly.
“Per tutto il resto di quel giorno, andai nondimeno in cerca di altre occasioni per avvicinare la mia collega, specialmente quando, verso sera, cominciai a sospettare che volesse evitarmi. La raggiunsi, ricordo, sulla scala, scendemmo insieme i gradini e giunte in fondo la trattenni, prendendola per un braccio: «Da quello che mi avete detto questa mattina, devo concludere che voi non l’avete mai visto comportarsi male».
Gettò indietro la testa; era chiaro che nel frattempo e con molta lealtà, aveva deciso l’atteggiamento da prendere. «Oh, mai visto!.. Non voglio dir questo!».
Ero turbata, di nuovo: «Allora lo avete visto…».
«Ma sì, signorina, grazie al cielo!».
Dovetti riflettere su quella risposta prima di accettarla: «Volete dire che un ragazzo che non è mai …».
«Non è un ragazzo, per me».”
Il giorno dopo, l’istitutrice torna alla carica, affrontando l’argomento della precedente governante di Bly.
“«Che tipo era la signorina che stava qui prima?».
«L’ultima istitutrice? Era anche lei giovane e carina… giovane e graziosa quasi quanto voi, signorina».
«Ah, allora spero che la giovinezza e la bellezza le siano state d’aiuto! – ricordo d’aver detto con impeto. – Sembra che ci preferisca giovani e belle!».
«Oh, è proprio così! – confermò la signora Grose. – Era quello che cercava in tutte!». Aveva appena pronunciato queste parole che volle correggersi: «Dico che questo è il suo gusto, il gusto del padrone».
Rimasi di stucco: «Ma di chi parlavate prima?».
Si sforzò di apparire disinvolta, ma arrossì: «Di chi, dunque?! Di lui».
«Del padrone?».
«E di chi altro?».”
Quando poi la conversazione scivola sulla misteriosa morte dell’istitutrice che l’ha preceduta, la signora Grose si dimostra stranamente concisa, fuggendo alla fine frettolosamente verso le sue faccende domestiche. Non deve però sembrare che questi imbarazzi e queste reticenze scalfiscano la buona fede della signora Grose: è comprensibile che, di fronte a un nuovo arrivato, ella cerchi di nascondere, magari del tutto inconsciamente, i segreti più vergognosi o compromettenti del passato. Il suo codice morale e la sua posizione le impongono infatti di adoperarsi in tutti i modi per evitare scandali o pettegolezzi, e questo atteggiamento ella adotta, senza malizia o mistificazioni, anche nei confronti dell’istitutrice.
In questo singolare frangente psicologico, nel quale tutto sommato la seduzione esercitata dai due meravigliosi piccoli allievi prevale nettamente su ogni altra considerazione, irrompe la prima apparizione. Nel tardo pomeriggio, nel corso di una delle sue consuete passeggiate nel parco, l’istitutrice vede improvvisamente di fronte a se, sulla cima della vecchia torre merlata della casa, una figura di uomo che la osserva con aria insolente e sfrontata. Il terrore provocato dalla visione, tanto più grande in quanto non le riesce di spiegarla razionalmente se non attraverso il ricorso a un’improbabile intrusione di un estraneo, induce l’istitutrice a risparmiare la signora Grose, tacendole l’accaduto. Ma quando, qualche giorno dopo, la stessa persona riappare nell’atto di guardare, dalla parte esterna della finestra, dentro la sala da pranzo, questi scrupoli scompaiono completamente e la governante, sconvolta, decide di confidarsi con l’anziana compagna. Nel lungo dialogo tra le due donne, la giovane descrive con abbondanza di particolari la figura apparsale, ricevendone in cambio la più sorprendente delle risposte.
“«Allora lo conoscete davvero?»
Esitò, ma soltanto un attimo. «Quint!» esclamò.
«Quint?».
«Peter Quint… il suo domestico personale, il suo cameriere quando lui stava qui!». (…)
«E che ne è stato di lui?».
Tardò tanto a rispondermi, che mi sentii ancor più avviluppata. «Se n’è andato anche lui» sbottò alla fine.
«Andato dove?».
Un’espressione indicibile, a questa mia domanda, le si dipinse sul viso. «Dio sa dove! E’ morto».
«Morto?» quasi gridai.
La signora Grose sembrò chiamare a raccolta tutte le sue forze, piantandosi più saldamente al suolo per esprimere l’arcano di quel fatto: «Sì. Il signor Quint è morto»”
L’angosciante scoperta che l’uomo intravisto sulla torre prima e affacciato alla finestra poi sia nientemeno che un fantasma si accompagna alla precisa sensazione che esso sia venuto per cercare il piccolo Miles. Questa impressione è antecedente al colloquio con la signora Grose, ma è indubbio che la conoscenza dei particolari della vita di Quint, sinistra figura di domestico che “si prendeva troppe libertà” con i bambini, rafforza l’istitutrice nella sua orribile convinzione. La necessità di salvaguardare i bambini dalle malefiche influenze di un corrotto abitante del regno dei morti diventa in breve lo scopo stesso della vita dell’istitutrice. In questa dimostrazione di eroismo e di spirito di sacrificio (“Io ero uno schermo… e dovevo stare davanti a loro. Quanto più avessi veduto io, tanto meno avrebbero visto loro”), la giovane riesce a provare persino brividi di autentica felicità: ella si sente investita di una santa missione, come un paladino chiamato a proteggere e a difendere le forze del Bene dall’attacco congiunto degli spiriti del Male.
E’ impressionante la capacità di James di far progredire lentamente l’orrore fino a livelli di autentico parossismo, aggiungendo sempre nuovi e inquietanti elementi allo spaventoso quadro fino a quel momento realizzato. L’ulteriore giro di vite della storia è costituito dalla spettrale apparizione della precedente governante, la signorina Jessel, sulla sponda opposta dello stagno dove l’istitutrice si è recata insieme a Flora. La cosa più mostruosa di questa inattesa apparizione non è data tanto dalla comparsa del secondo fantasma (questa volta a rivelare la sua identità non è la signora Grose, ma è la stessa istitutrice a pervenire autonomamente a questa conclusione) quanto dalla presa di coscienza che i bambini “sanno”, pur senza volerlo dare a vedere.
“Era un peccato che dovessi di nuovo farfugliare le ragioni per cui non avevo dubitato neppure per un attimo, e con mia grande delusione, che la bambina vedesse la nostra visitatrice proprio come io in quel momento vedevo la signora Grose, e che la bambina desiderasse, pur avendo una visione di quel genere, farmi credere che non vedeva nulla, ed allo stesso tempo, senza scoprirsi, cercare d’indovinare se io avessi veduto qualcosa! Era un peccato che dovessi descrivere ancora una volta le piccole, portentose astuzie con le quali aveva cercato di distogliere la mia attenzione… il percettibilissimo accrescersi della sua vivacità, il maggior fervore nel gioco, il canto, il chiacchiericcio senza senso e l’invito a ruzzare”.
I due bambini appaiono per la prima volta non più come candidi angeli ma come astutissimi demoni, in grado di dissimulare alla perfezione le proprie emozioni. Ciò che fa rabbrividire di più in questa constatazione è la percezione del pericolo che l’infanzia corre nel trovarsi esposta, senza difese, di fronte al male e alla corruzione di cui il mondo adulto è impregnato. In questo senso, Miles e Flora non sono solo i simboli astratti del conflitto tra Bene e Male, ma i rappresentanti di una condizione umana immacolata e innocente, minacciata dal contagio della perversione morale. Aver detto che i bambini del “Giro di vite” sono creature diaboliche non significa pertanto sancire la natura perversa del fanciullo, come potrebbe sembrare ad una prima frettolosa analisi, ma solo riconoscere che essi, nella fattispecie narrata, sono stati costretti ad abbassare le armi di fronte al potere della depravazione e dell’immoralità (“Non li posso né salvare né proteggere! E’ assai peggio di quanto immaginassi… sono perduti!”).
Venuta finalmente a conoscenza dalla signora Grose dei retroscena del torbido rapporto tra Peter Quint e la signorina Jessel e dei particolari (sempre molto sfumati, per la verità) del morboso legame esistito tra Quint e Miles (le lunghe ore trascorse insieme, le bugie del bambino, la sensazione che questi coprisse la relazione tra il domestico e la precettrice), l’istitutrice moltiplica le energie dedicate alla sorveglianza dei bambini. Ma quanto più aumenta l’attenzione loro riservata, tanto più ella intuisce (o crede di intuire) in ogni loro gesto e parola la traccia di qualche complotto ordito ai suoi danni. Ad onta del fatto che questi oscuri segnali, al pari delle apparizioni spettrali, si susseguono senza tregua, la vita a Bly procede in maniera apparentemente tranquilla. Improvvisamente, però, la governante riesce ad acquisire la raccapricciante certezza che i bimbi non sono solo al corrente della presenza dei fantasmi, ma si incontrano regolarmente con essi. Svegliatasi nel cuore della notte, ella si accorge che Flora è uscita dal suo letto e, rannicchiata dietro la tenda della finestra, è assorta a guardare nel giardino. Sicura che la piccola sia faccia a faccia con la stessa apparizione del lago, l’istitutrice esce senza far rumore dalla stanza e si affaccia a un’altra finestra della casa, intenzionata a smascherare quella silenziosa conversazione, ma qui scopre con sgomento che la figura sul prato non è la signorina Jessel, bensì il fratello Miles, il quale a sua volta sta immobile sul prato con lo sguardo fisso sulla cima della torre. Anziché riuscire a far loro ammettere la complice relazione coi due perversi servitori defunti, l’istitutrice è costretta a riconoscere di essere tenuta in pugno dai bambini: la storia dei fantasmi non è cosa di cui poter parlare apertamente senza correre il terribile rischio di venire accusata di instillare colpevolmente nei giovani superstizioni e paure infondate. Di fronte al falso candore di Miles, la governante è costretta a “subire” la disinvolta scusa del ragazzo, addirittura “con un formale riconoscimento da parte mia di tutte le riserve di bontà che aveva dovuto impiegare per permettersi un simile scherzo”. Le conclusioni che l’istitutrice comunica il giorno dopo alla signora Grose non ammettono repliche: la prova evidente che i bambini sono in intima complicità con le due orrende presenze è proprio il loro ostinato silenzio sulla faccenda. La loro dolcezza e bontà non sono altro che ostentazione e inganno. Miles e Flora sono in realtà impregnati di sentimenti cattivi (risuona ancora nelle orecchie della governante la ricattatoria frase di Miles: “Pensate un po’ a quello che potrei fare!”), posseduti come sono da demoni tentatori che, attirandoli negli strani luoghi in cui appaiono, forse vogliono addirittura la loro morte.
Al termine dell’estate, mentre l’istitutrice è incapace di allontanare da sè l’idea crudele che, qualsiasi cosa ella possa vedere (e da molte settimane non vede ormai più nulla), Miles e Flora vedono di più, che cioè gli intrusi siano insistentemente tra loro, percepiti dai due conniventi bambini, scoppia la “rivoluzione”. Una domenica, col suo abituale amabile candore, Miles domanda: “Per favore, mia cara, sapreste dirmi quando mai tornerò in collegio?”, lasciando intendere, dietro a questa innocente frase, di volersi svincolare dalla ferrea tutela della donna. Sconvolta dalla consapevolezza di essere in balia di Miles (e, in particolare, di avergli fatto credere di non voler affrontare la questione dei motivi della sua espulsione dal collegio, a cui si riallacciano in un modo o nell’altro tutti gli altri orrori), l’istitutrice decide di lasciare di nascosto la casa. Ma l’ennesima, e questa volta inaspettata, apparizione dell’orrenda signorina Jessel seduta al tavolo del suo studio, convince la giovane a non rinunciare alla propria missione.
Un paio di capitoli prima, l’istitutrice rivela a quale livello sia giunta ormai la sua ossessione.
“In quei momenti, se non fossi stata trattenuta dalla sola possibilità che il rimedio potesse essere peggiore del male, la mia esaltazione sarebbe liberamente esplosa. «Loro due sono qui, sono qui, piccoli disgraziati, - avrei urlato,- e non potete negarlo ora!».”
La crescente difficoltà dell’istitutrice di trattenersi emerge pericolosamente durante una lunga schermaglia psicologica con Miles, nella stanza da letto di quest’ultimo. Credendo di avvertire qualche segno di cedimento nel suo interlocutore e oscillando tra ansia di sapere e commozione, l’istitutrice va troppo oltre, lasciandosi scappare di bocca l’invocazione: “Voglio soltanto che tu mi aiuti a salvarti!”. In risposta a questo appello “proibito”, la candela si spegne, un soffio di aria gelida entra nella stanza (ma la finestra è rimasta chiusa) e il bambino lancia un urlo acutissimo di terrore, prima di ritornare perfettamente padrone delle proprie emozioni.
Il giorno dopo, mentre la governante, stregata dal fascino miracolosamente intatto di Miles, è assorta nell’ascolto del suo piccolo allievo seduto al pianoforte, Flora scompare. La donna non ha alcun dubbio: l’invito del bambino a suonare per lui era un trucco per tenerla occupata e permettere nel frattempo alla bambina di recarsi al laghetto con la signorina Jessel. Trascinandosi dietro la sempre più confusa signora Grose, l’istitutrice si precipita laggiù, in tempo per avere la conferma dei propri sospetti: Flora è in piedi, sorridente, sull’erba, come se la sua impresa fosse ormai compiuta. L’equilibrio nervoso dell’istitutrice a questa vista crolla di colpo e la coppa, che ella da molte settimane teneva colma sino all’orlo e che aveva rischiato di traboccare la sera prima con Miles, si rovescia con la violenza di un uragano alla domanda: “Dov’è, carina, la signorina Jessel?”. La smorfia di sofferenza che si dipinge sul viso di Flora, l’urlo di terrore della signora Grose e il gemito della governante si susseguono nel giro di pochi secondi e si accavallano alla comparsa, sulla sponda opposta dello stagno, del demone evocato. Lo sguardo attonito della signora Grose, rivolto al punto indicato dall’istitutrice, sembra a tutta prima la prova suprema che anche lei, finalmente, vede. Ma la situazione si capovolge in un istante: gli occhi della signora Grose sono purtroppo sigillati senza speranza e quelli di Flora non si turbano davanti alla visione, ma fissano l’istitutrice con un’espressione terribile di accusa. Il possibile trionfo si tramuta in rovina: Flora e la signora Grose sono ora dolorosamente unite contro di lei, e mentre la vecchia collega trascina via la bambina, il cui viso sembra di colpo orribilmente invecchiato, la governante si lascia andare, riversa a terra, ad una selvaggia disperazione.
La tragedia sta per consumarsi ma, prima del suo ultimo atto, si ha la sorpresa di assistere a un’inattesa manifestazione di solidarietà da parte della signora Grose. Dopo aver udito Flora pronunciare, nel delirio della febbre, orrende parole nei confronti della sua insegnante, la signora Grose si dice favorevole a portare al più presto la bambina lontano da quei malefici influssi.
“«Allora, a dispetto di quanto è accaduto ieri, voi credete…».
«A quelle cose? – La sua semplice descrizione, alla luce dell’espressione dipinta sul suo viso, non richiedeva ulteriori spiegazioni, e lei aprì il suo cuore come non aveva fatto mai – Ci credo».”
Mentre la signora Grose e Flora lasciano precipitosamente la casa, l’istitutrice cerca di salvare Miles, tentando l’ultimo assalto alla sua reticente volontà. Resasi conto che Miles è indeciso, esitante e nervoso, l’istitutrice ad un tratto capisce che il bambino si sente escluso dal suo canale privilegiato con Quint. Di fronte allo scacco di Miles, l’istitutrice prova un brivido di trionfo e prepara con cura il momento della verità, capendo di avere ormai partita vinta. Ora ella può avere il coraggio di sfidare il sinistro fantasma di Quint, che ricompare per qualche attimo alla finestra, forte della sicurezza che ormai al bambino è definitivamente preclusa qualsiasi visione. La scomparsa dello spettro è il segno del definitivo trionfo dell’istitutrice. Accecata dalla vittoria conseguita, come ubriaca di piacere, la donna imperversa sull’animo esacerbato e sconvolto del bambino, costringendolo impietosamente a rievocare i terribili momenti della sua cacciata da scuola. Ma al culmine di questa tortura, Peter Quint compare ancora: il pericolo di veder crollare la vittoria e il riaccendersi della battaglia scatenano l’irruenza dell’istitutrice.
“«Mai più, mai più!» gridai con voce stridula al mio visitatore, mentre cercavo di stringere il bambino al petto.
«Lei è qui?» domandò Miles con ansia mentre seguiva con i suoi occhi sigillati la direzione delle mie parole. Poi, mentre quello strano “lei” mi sconvolgeva, ed io lo ripetevo con un fil di voce, come un’eco, «la signorina Jessel, la signorina Jessel!» mi gridò con furia improvvisa.
Stupefatta, compresi, ad un tratto, la sua supposizione… come un seguito di quello che avevamo fatto con Flora, ma ciò mi fece soltanto desiderare di mostrargli che si trattava di meglio: «Non è la signorina Jessel! Ma è alla finestra… dritto davanti a noi. E’ là… quel vile orrore, là per l’ultima volta!».
A queste parole, dopo un momento in cui la sua testa imitò il movimento del cane deluso che ha smarrito una traccia, ebbe un moto convulso, quasi cercasse aria e luce; si voltò verso di me in preda ad una rabbia muta, disorientato, guardando invano dappertutto, senza però trovare un segno (sebbene a me la stanza sembrasse impregnata come delle esalazioni d’un veleno) di quella grande, dominatrice presenza. «E’ lui?».
Ero ormai così decisa ad ottenere la prova voluta che, per sfidarlo, mi resi di ghiaccio: «Che vuoi dire con quel “lui”?».
«Peter Quint… demonio maledetto!» - il suo viso rivolgeva ancora, a tutta la stanza, la supplica convulsa. «Dov’è?».
Ho ancora nelle orecchie la resa suprema del nome e il suo omaggio alla mia devozione. «Che cosa t’importa di lui ormai, tesoro?.. che importanza potrà più avere? Io ti ho, - gridai rivolta all’essere immondo, - mentre lui ti ha perduto per sempre!». Poi, per dimostrare che la mia opera era compiuta: «Là, là!» dissi a Miles.”
Ma Miles, gli occhi sbarrati dalla paura, non regge ulteriormente lo spavento e, con l’urlo di una creatura scagliata oltre un abisso, muore tra le braccia della governante.
Mentre il dramma sta avviandosi febbrilmente verso la conclusione, raggiungendo punte quasi insopportabili di tensione, è avvenuto un inaspettato cambiamento di prospettiva: tutt’a un tratto non siamo più così sicuri che i fantasmi di Bly siano effettivamente reali, che i bambini siano creature astute e corrotte, che l’istitutrice sia il valoroso e disinteressato paladino delle forze del Bene. L’ombra di dubbio che ci aveva sfiorato nel corso della isterica scena del lago è diventata un ingombrante e ineludibile sospetto, che mi ha spinto a spiegare la morte di Miles non già in termini soprannaturali (il piccolo cuore del bambino che non regge al fatto di essere “liberato” dal Male, in quanto ormai troppo corrotto per vivere senza di esso), ma come naturale effetto dello spavento. Per la prima volta dall’inizio del racconto, ci si accorge che tutta la storia di fantasmi si basava su una semplice ragione: che l’istitutrice racconta la storia con una convinzione tale da trascinare se stessa ed il lettore nell’orribile incubo. Non si può negare che la narrazione dell’istitutrice proceda sempre in modo chiaro e lineare, e sia sorretta da una logica ferrea e implacabile anche nei momenti in cui ella affronta i fenomeni più strani e anormali. Se a ciò si aggiunge il fatto che il lettore non ha nessun altro elemento su cui fare affidamento che la parola dell’istitutrice, è comprensibile che questi abbia potuto prendere un clamoroso abbaglio, spinto a ciò, non va dimenticato, dalla sovrumana abilità di uno scrittore che usa il sistema della “mistificazione” in maniera sopraffina. Se dunque si cessa di concepire i fantasmi di Bly come spiriti ma li si considera come proiezioni, creazioni di una mente turbata, tutto quanto detto finora finisce per non avere più valore. La prima lettura si è rivelata troppo semplicistica, in quanto ci ha fatto vedere le cose in una prospettiva manifestamente fasulla. Ci troviamo perciò costretti a prendere nuovamente in mano il libro, per tentare di rintracciare, senza ovviamente far violenza al testo, gli elementi nascosti in grado di suffragare le nuove teorie.
LA SECONDA LETTURA, OVVERO LA LETTURA INIZIATICA
La prima questione da affrontare consiste nello stabilire se la governante sia una testimone credibile oppure no, se cioè ella creda a quanto va raccontando oppure sia solo una volgare bugiarda. Il problema, a mio avviso, va risolto in questi termini: i fantasmi sono inconfutabilmente reali per l’istitutrice, la quale quindi crede, o si sforza di credere, alle esperienze soprannaturali vissute a Bly. Una risposta recisamente negativa devo dare invece alla seconda, fondamentale domanda, che solo apparentemente è simile alla prima: è l’istitutrice una testimone attendibile? Vi sono numerosi elementi, psicologici prima ancora che testuali, che depongono a favore di questo mio convincimento. Anzitutto, non bisogna dimenticare che il racconto si svolge, sia pure al di là dell’Atlantico, in piena epoca vittoriana: la giovane protagonista è figlia di un curato di campagna, è appena uscita da un vicariato dell’Hampshire e ha quindi una visione del mondo da parrocchia, con un forte senso del peccato e un rigido atteggiamento moralista. Per lei, educata in maniera presumibilmente repressiva, il soggiorno a Bly coincide con un allentamento delle proprie rigide e puritane regole di vita (“Imparai qualcosa che non avevo appreso nella mia vita modesta e limitata… Era la prima volta, in un certo senso, che mi accorgevo dello spazio e dell’aria e della libertà…”). Fin dalle prime pagine ella si rivela inoltre romantica e sognatrice, con la tendenza a ricamare sulle cose e a romanzarle (“…Bly mi sembrò un castello romantico abitato da un folletto rosa, un luogo che in qualche modo, per piacere a una mente infantile, avesse assunto forma e colori dei libri di racconti e delle fiabe. Non era forse un libro di favole quello su cui mi ero appisolata per sognare? No: era una casa grande, brutta e vecchia, ma confortevole,… in cui fantasticavo che ci fossimo smarriti come un pugno di passeggeri su un grande vascello alla deriva”). Se si aggiungono poi la tendenza a mutare d’animo in maniera alquanto repentina (un alternarsi di turbamenti, sollievi, oppressioni ed euforie caratterizzano, ad esempio, i suoi primi giorni a Bly) e una capacità di immaginazione “terribile”, come lei stessa ammette più volte nel corso del racconto, si può facilmente arrivare alla conclusione che l’istitutrice è costituzionalmente predisposta a caricare fatti, gesti e parole, anche del tutto trascurabili o secondari, di una valenza che supera di gran lunga la loro reale importanza oggettiva. Così, quando fa la conoscenza con la signora Grose, l’istitutrice nota con un pizzico di inquietudine l’evidente sollievo di costei nel vederla (“Mi ero accorta che per quasi mezz’ora la sua felicità nell’incontrarmi… era decisamente controllata perché non trasparisse troppo vistosamente”).
Nel prologo veniamo a conoscenza di un particolare che eserciterà un’influenza determinante nel prosieguo di questa rivisitazione del “Giro di vite”: l’istitutrice si era segretamente innamorata dello zio dei bambini. “Sì, era innamorata – ammette il narratore Douglas – Cioè, lo era stata. Ciò venne fuori… non poteva raccontare la storia senza che venisse fuori”. Sebbene la governante non lo ammetta mai esplicitamente, l’attrazione erotico-sentimentale esercitata su di lei dall’affascinante Master viene effettivamente rivelata in almeno due occasioni, quando confida alla signora Grose di essere stata conquistata a Londra e quando sogna di dimostrare “alla persona giusta” di essere in grado di riuscire là dove molte altre giovani avrebbero fallito. Chiaramente, con la rigida educazione puritana ricevuta in gioventù, è inevitabile che questa innocente passione venga nel subconscio connotata con un senso di peccaminosità. Si ha così una situazione che, caratterizzata da un amore inconsciamente vissuto come “impuro”, prelude a uno stato di vera e propria repressione sessuale.
A questo punto, forti di una conoscenza non più superficiale della protagonista, siamo in grado di interpretare i tragici avvenimenti del racconto in un’ottica completamente diversa. Quando a Bly giunge la lettera proveniente dal direttore del collegio, la fantasia dell’istitutrice si mette subito a lavorare. L’espulsione da scuola di Miles, i lapsus e gli imbarazzi della signora Grose, il mistero della morte della governante che l’ha preceduta, vengono caricati dalla protagonista di connotazioni esageratamente sinistre, cosicché nella sua mente si sviluppa in maniera informe l’idea che a Bly vi sia un orrendo mistero da svelare. Lo scontro tra la repressione degli istinti sessuali da una parte e le morbose inclinazioni dell’immaginazione dall’altra fa sì che il precario equilibrio psichico dell’istitutrice sia destinato a saltare alla prima occasione. L’occasione arriva nella famosa scena della prima apparizione, durante la passeggiata serale nel parco.
“Uno dei pensieri… che erano soliti accompagnarmi in quel mio vagabondare era che sarebbe stato incantevole, degno d’un romanzo affascinante, incontrare improvvisamente qualcuno. Qualcuno che mi apparisse laggiù, alla svolta del sentiero e che – fermo davanti a me – mi sorridesse con l’aria di approvarmi. Non chiedevo niente di più… chiedevo soltanto che sapesse, e il solo modo per esser certa che sapeva, sarebbe stato di leggerlo sul suo bel viso, rischiarato dalla luce di quella consapevolezza. Tutto ciò – intendo dire soprattutto quel volto – era esattamente presente al mio spirito…”.
E’ evidente che in queste fantasticherie l’istitutrice ad altri non pensi se non allo zio di Miles e Flora, oggetto di un silenzioso amore senza speranza. Il fantasma sulla torre merlata sembra quindi essere la materializzazione di una fantasia romantico-sentimentale con sottile piacere evocata. Ma a questo punto, secondo i meccanismi di una personalità contorta, scatta il complesso di colpa. Il senso di peccaminosità di un tale desiderio (con sottile ironia, James fa notare che “c’era una punta d’insolenza nella strana familiarità che dimostrava nel restare senza cappello”) non provoca il dissolvimento dell’apparizione, al contrario la fissa in una posizione antagonistica. Il lungo, reciproco e sfrontato fissarsi della governante e dell’uomo riflette il conflitto interiore tra purezza e perversione. Quest’ultima, inammissibile in una giovane coscienziosa e timorata di Dio, viene, se così si può dire, espulsa, oggettivata in una visione che, da quel momento in poi, vivrà di vita propria.
Che le apparizioni di Bly siano solamente proiezioni allucinatorie dell’istitutrice mi sembra di poter inferire anche da una sorta di insistita autoidentificazione con esse che ricorre più volte nel corso del racconto. Così, quando si verifica la seconda apparizione, l’istitutrice si ritrova affacciata alla stessa finestra attraverso la quale, poco prima, le era comparsa davanti la sinistra figura d’uomo. Ma (questo è molto strano) l’istitutrice non è in grado di precisare la durata degli avvenimenti, come se avesse perduto la nozione del tempo o se una frattura temporale (non saprei come altrimenti definirla) avesse separato i due momenti. Qualche capitolo più avanti troviamo un episodio significativamente analogo.
“Ricordo che nell’atrio, tormentata dalle difficoltà e dagli ostacoli che mi restavano da superare, mi lasciai cadere ai piedi della scala… improvvisamente sfinita, mi sedetti sul gradino più basso; poi con una violenta reazione rammentai che esattamente in quel punto, più di un mese prima, nella tenebra notturna, avevo visto lo spettro della più orribile delle donne, curva sotto il peso della sua malvagità”.
Nella scena immediatamente successiva, con uno speculare ribaltamento delle parti, l’istitutrice trova la signorina Jessel seduta al suo scrittoio, con un’espressione tale da lasciar capire che “il suo diritto di sedersi al mio tavolo valeva il mio di sedersi al suo”. Tornando ancora alla seconda apparizione, non è poi di poco conto il fatto che essa faccia venire alla mente della protagonista il seguente pensiero: “… fu come se lo avessi guardato per anni e lo conoscessi da sempre”.
Uno degli argomenti principali a favore della mia teoria è che nessuno, all’infuori dell’istitutrice, vede mai i fantasmi. Ciò che ci traeva in inganno nella prima lettura era la sicurezza che la governante mostrava, e trasmetteva in seconda battuta al lettore, nel credere che anche i bambini fossero a conoscenza delle apparizioni. In realtà, una più attenta analisi dei fatti evidenzia che non esiste alcuna prova che l’istitutrice abbia ragione. Ma di questo parlerò più avanti. L’ulteriore circostanza che la signora Grose crede fino alla fine a ciò che la giovane protagonista le racconta può essere poi spiegata mediante il ricorso a una semplice considerazione: la vecchia domestica è sì una donna dalle qualità umane eccezionali, ma è anche una sempliciotta, scarsamente istruita e, ciò che più conta, molto superstiziosa; niente di più facile, perciò, che sia stata suggestionata, fino a rimanerne plagiata, dalla sfrenata immaginazione dell’istitutrice. Ben altra capacità di resistenza ad essere piegate in termini psicanalitici offrono, invece, altre parti del racconto, prima fra tutte la scena in cui l’uomo apparso alla governante prende la fisionomia del defunto Peter Quint. Ad effettuare con sicurezza l’identificazione è, come ho già detto, la signora Grose, durante un lungo e sovreccitato scambio di battute con l’istitutrice. A prima vista, il fatto che una pura e semplice allucinazione della protagonista, risultato della sua mente turbata, venga a coincidere con una persona realmente esistita e di cui, per di più, la protagonista stessa non era nemmeno a conoscenza, sembra del tutto inspiegabile. La cosa, in realtà, non si presenta proprio in questi termini: nella prima parte, infatti, ho citato la scena, apparentemente secondaria, in cui l’istitutrice ha l’impressione che la signora Grose parli di altri che non il padrone quando le dice: “Era quello che cercava in tutte!”, correggendosi poi: “Dico che questo è il suo gusto, il gusto del padrone”. Nella memoria dell’istitutrice è probabilmente rimasta una traccia di questa originaria sensazione, inconsciamente legata a qualcosa di sordido e sinistro avente per protagonista un uomo. Dal canto suo, la signora Grose ricorda Peter Quint come una presenza inquietante, se non addirittura persecutoria. E’ logico che ella pensi involontariamente a lui quando, dopo averle confermato che non si tratta di nessuno del posto, l’istitutrice dice del misterioso uomo: “E’ un orrore”. Difatti, l’istitutrice stessa registra, qualche attimo dopo, l’apparire sul volto della compagna, di “un remoto, debole lampo di consapevolezza,… il tardivo spuntare di un’idea che io non le avevo suggerito e mi era completamente oscura”. Quando poi l’istitutrice rivela un particolare assolutamente insignificante, come quello che l’uomo non porta il cappello, è facile accorgersi che il meccanismo dell’identificazione è già scattato. Da quel momento in avanti, si può dire che la signora Grose sia psicologicamente predisposta a riconoscere in qualsiasi descrizione le venga prospettata la figura di Peter Quint. I dettagliati particolari fisici rivelati dall’istitutrice vanno quindi a posarsi sui contorni di una immagine mentalmente già delineata. Non è necessario che la descrizione sia fedele al ritratto, perché la signora Grose ha già deciso dentro di sè che quell’uomo è Peter Quint. Che i dettagli fisici siano superflui lo dimostra il fatto che gli eloquenti barlumi di consapevolezza della signora Grose non compaiono quando l’istitutrice descrive l’apparizione, ma solo dopo che ella rivela particolari non propriamente distintivi, l’ultimo dei quali (l’uomo indossa vestiti eleganti, ma non suoi), mentalmente unito a un altrettanto trascurabile ricordo (Quint aveva rubato alcuni panciotti del signore), dimostra che la signora Grose sta seguendo un suo corso di pensieri ed associazioni. La scena tra l’istitutrice e l’anziana donna assomiglia vagamente a quella in cui una chiromante, basandosi su una insignificante base di verità, ricostruisce la vita della persona che le sta di fronte, la quale, con la predisposizione a immedesimarsi in ciò che le viene detto, aiuta inconsapevolmente l’altra a svelare i propri segreti.
Quando più tardi entra in scena la seconda apparizione, l’istitutrice non ha più bisogno della signora Grose per stabilire che si tratta della signorina Jessel, perché ormai il disegno è chiarissimo nella sua mente. L’ultimo particolare di cui ella ha bisogno per perfezionare la sovrapposizione tra la coppia dei servitori defunti e le proiezioni allucinatorie dei propri complessi di colpa è sapere se Quint e la signorina Jessel erano malvagi. “Allora mi assicurate, è una cosa molto importante, che egli era assolutamente e notoriamente cattivo?”, domanda l’istitutrice nel capitolo successivo alla scena dell’identificazione. La risposta che ella riceve non lascia adito a dubbi: Peter Quint e la signorina Jessel erano “infami”. L’istitutrice non ha bisogno di altre prove; ella vede tutto “con prodigiosa chiarezza”. I due individui, che fin da quando erano in vita avevano cominciato a contaminare Miles e Flora con i loro malefici influssi, sono ritornati ora dal regno dei morti per completare quell’opera di corruzione e riprendersi le loro piccole vittime. Quale “magnifica occasione” per cercare di salvare eroicamente i due bambini dall’attacco delle forze del Male! Nei due piccoli fratelli l’istitutrice riversa evidentemente le proprie ansie di innocenza, traducendo nella lotta contro i due fantasmi il tentativo di recuperare la propria purezza perduta. L’illusione è completa e rifiuta qualsiasi spiegazione logica. Quando la signora Grose, all’istitutrice che le espone le proprie convinzioni, domanda: “Ma come lo sapete?”, ella risponde con un elusivo: “Lo so, lo so, lo so!”, che rifiuta qualsiasi controprova.
L’identificazione dei due bambini con la propria innocenza da difendere è necessariamente gravida di conseguenze. Infatti, l’istitutrice ha inconsciamente provocato la scissione delle due parti della propria personalità, quella “buona” e quella “cattiva”, proiettandole rispettivamente nei bambini e nei servitori perversi. Ma se questi ultimi sono mere allucinazioni dell’istitutrice, i bambini sono invece creature che vivono in maniera autonoma nella realtà e che, ovviamente, non hanno bisogno di essere salvate da alcunché. Come tali, essi continuano a comportarsi in maniera “naturale”, “normale”. Ma la mente irrimediabilmente paranoica della governante percepisce tali comportamenti come “inadeguati” e reagisce ad essi da una parte con un esasperato atteggiamento possessivo (al quale non mi sembra estraneo, soprattutto nei frequenti e insistiti abbracci, un rigurgito di istinti materni repressi) e dall’altra con manifestazioni molto simili alla gelosia più morbosa (la paura dell’insuccesso nella “missione” di salvare i bambini viene vista nell’ottica del tradimento). Questa situazione degenera nel sospetto prima e nella convinzione poi che i bambini sono in relazione con i diabolici fantasmi.
Le argomentazioni avanzate per supportare questa conclusione sono la prova più evidente che l’istitutrice è irretita in una inestricabile trama di allucinazioni. Nei comportamenti più normali dei bambini ella vede ora ipocrisia e dissimulazione, ora astuzia e ironica consapevolezza. Un esempio per tutti: nella scena della prima apparizione della signorina Jessel al lago, ciò che persuade definitivamente l’istitutrice che Flora ha visto tutto e voglia tenerlo nascosto non è altro, come abbiamo già visto, che “il percettibilissimo accrescersi della sua vivacità, il maggior fervore nel gioco, il canto, il chiacchiericcio senza senso e l’invito a ruzzare”, qualcosa cioè che ci meraviglieremmo di non riscontrare in una vivace bambina di otto anni. L’analisi circostanziata del comportamento dei due bambini nell’arco di tutto il racconto non può che definirli assolutamente “normali”, anche in quelle manifestazioni (la curiosità di Miles sul suo futuro scolastico, la fuga in barca di Flora) che per l’istitutrice sono i segni più evidenti di quanto essi siano ormai corrotti. E’ l’istitutrice a far sì che il loro modo di fare sembri sinistro quando invece è l’estrinsecazione di naturalissimi impulsi infantili. Dal canto loro, i bambini tentano in continuazione di adattarsi all’ottica della loro insegnante, secondandola in ogni sua fisima, anche quando non capiscono che cosa ella pretende da loro. L’istitutrice, infatti, non rivela mai i suoi sospetti e, quando lo fa, si comporta in modo così isterico da oltrepassare i limiti della loro comprensione. In questo senso deve sicuramente intendersi la scena del lago in cui l’istitutrice crede di sorprendere Flora in compagnia della signorina Jessel, ma provoca solo la comprensibile crisi di nervi della bambina.
La follia della governante, alla luce di queste considerazioni, è inoppugnabile. Ciò che nella prima lettura ci aveva indotti in errore era il fatto che la storia del “Giro di vite” ci è raccontata in prima persona da colei che di questa follia è la protagonista e che, in quanto tale, non può vederla coi propri occhi, ma solo riflessa, attraverso sentimenti come paura, perplessità e disagio, negli occhi degli altri personaggi. Ad esempio, al termine della scena, più volte richiamata, in cui l’istitutrice ripete alla finestra la spettrale apparizione di qualche minuto prima, facendo spaventare la signora Grose, ella si domanda candidamente: “Mi chiesi perché anche lei si fosse spaventata”. Nel corso del racconto si susseguono poi espressioni del tipo: “sul mio viso si stavano inseguendo prodigiose espressioni, perché le vedevo man mano riflesse sul volto della mia compagna”, “sbatté coraggiosamente le palpebre al significato delle mie parole”, “la signora Grose mi guardò sgomenta”, per non parlare degli intimi turbamenti e dei cenni di imbarazzo di Miles al cospetto della sua insegnante. Solo la semplicioneria dell’anziana signora e l’ingenuità, nient’affatto perversa, dei due bambini fanno sì che queste reazioni si manifestino esclusivamente a livello emozionale, consentendo pertanto all’istitutrice di conservare la propria credibilità fino al termine del racconto.
Un ultimo elemento che ritengo opportuno sottolineare è il seguente: dopo la famosa scena in cui Miles viene trovato in piena notte nel giardino della casa, l’istitutrice si convince di essere tenuta in pugno dei due bambini; ma la scoperta nei bambini degli “inequivocabili” segni della loro subdola scaltrezza è, guarda caso, immediatamente successiva agli ansiosi pensieri che l’istitutrice fa circa la propria delicata posizione di educatrice, esposta al rischio di possibili accuse di superstizione e di oscurantismo. Allo stesso modo, qualche pagina più avanti, l’”insubordinazione” di Miles avviene proprio mentre l’istitutrice si sta domandando come, nel caso in cui il bambino avesse preteso la sua libertà, ella avrebbe potuto tenergli testa: l’istitutrice è cioè portata psicologicamente ad interpretare ogni parola ed ogni gesto dei suoi allievi come un possibile segno di ribellione, quasi aspettandosela con affanno. Ciò che a noi, leggendo il racconto, appare a tutta prima come il progredire di un diabolico complotto, è in realtà il lento e graduale tracollo nervoso della protagonista, la quale, al termine della seconda scena del lago, si abbandona addirittura, senza neppure sapere quello che sta facendo, ad una incontrollabile crisi di isterismo.
Arriviamo così alla tragedia finale, quella che oserei definire una catastrofe annunciata. Gli istinti sessuali dell’istitutrice, per lungo tempo repressi, esplodono con inaudita violenza, e la vittima predestinata è il piccolo Miles.
“…ora sentivo di nuovo… quanto il mio equilibrio dipendesse dalla vittoria della mia ferma volontà, la volontà, cioè, di chiudere gli occhi il più possibile sul fatto che ciò che dovevo affrontare era rivoltante, contro natura. Non potevo resistere se non entrando, per così dire, in confidenza con la “natura” e tenendone conto, e considerando la mia prova mostruosa come una spinta verso una direzione insolita, ovviamente, e sgradevole, ma che dopo tutto non richiedeva, per farvi fronte serenamente, che un altro giro di vite alla comune virtù umana”.
L’istitutrice si convince che, per vincere il Male, deve mettersi sul suo stesso piano, liberandosi per “necessità” di ogni inibizione e remora morale: è una sorta di forzata legittimazione, di anticipata assoluzione dei propri impulsi “oscuri”, dei propri desideri più inconfessabili. Ora che, presa nelle spire di una irreversibile follia, si crede consacrata alla “mistica” impresa di salvare un’anima dal demonio, l’istitutrice è pronta a far violenza all’indifeso bambino. Ciò che segue è un lungo e feroce gioco al massacro, di una inaudita e parossistica crudeltà psicologica. L’istitutrice, che si immagina, insieme a Miles, "come una giovane coppia in viaggio di nozze", abbraccia il bambino con gemiti di felicità, lo bacia sulla fronte, lo stringe fortemente al suo seno. Ora lei è Quint e fa a Miles le stesse cose di cui prima rabbrividiva al pensiero che quest’ultimo le potesse fare a sua insaputa al bambino: ma ormai ella ha dato il giro di vite, e tutto è giustificato. La confessione di Miles non fa che acuire il perverso piacere del proibito, che ella assapora con intensa voluttà, fino ad ubriacarsi di un incestuoso trionfo. L’ultima apparizione di Quint è l’estremo barlume di un senso di colpa che, fin dall’inizio del racconto, l’istitutrice aveva inconsciamente cercato di estraniare, trasformandolo in un elemento conflittuale, capace, per contrasto, di far risaltare la propria personale purezza e l’indispensabilità della propria missione. Ora, nel delirio erotico-sessuale, essa si rivela come un’irresistibile attrazione verso il peccato e la depravazione, non disgiunta da un ossessivo desiderio di possesso. La lotta finale non è che il dissidio interiore tra la colpevolizzazione della purezza e la purificazione dei sensi di colpa. Col grido selvaggio rivolto all’essere immondo: “Io ti ho, mentre lui ti ha perduto per sempre!”, l’istitutrice vampirizza il bambino, lo “possiede” finalmente. Quando Miles pronuncia il nome della signorina Jessel, anziché quello di Peter Quint, ogni possibile ombra di dubbio cade: Miles non ha mai visto nulla, e se pronuncia il nome della antica governante lo fa solo perché lo ha sentito proferire dalla sorella il giorno innanzi. La sua mente sigilla, direi quasi inevitabilmente, la cupa e feroce tragedia della follia: all’orrore dell’infanzia insidiata dai fantasmi corrotti si è sostituito, non meno terrificante, l’orrore dell’infanzia esposta, senza difese, a una immaginazione malvagia.
LA TERZA LETTURA, OVVERO LA LETTURA METAFORICA
Cos’è che mi spinge a tentare una terza lettura del “Giro di vite”? Non certo, lo dico subito, l’intenzione di sconfessare quanto ho sostenuto poc’anzi; piuttosto la sensazione che altri significati, oltre a quello che è emerso nel corso del mio saggio, siano nascosti in questo piccolo libro dall’inesauribile fascino. “Il giro di vite”, nella sua ricchezza di sfumature e nella sua intenzionale ambiguità, è un po’ come un enorme spazio bianco che altro non chiede se non di essere riempito da chi ha la pazienza di soffermarvisi. E’ questa una caratteristica che contraddistingue tutti i grandi capolavori artistici. Ricordo uno stupendo, vecchio film di Ingmar Bergman, intitolato “Il volto”. Il soggetto è una storia, semplice ma non banale, di trucchi e mistificazioni, di scetticismo e ipocrisia. Interpretando i numerosi simboli del film, emerge però, inequivocabilmente, anche il conflitto emblematico tra fantasia e raziocinio, tra spirito e scienza. Ad un terzo livello, infine, esso appare come un’allegoria dell’uomo di spettacolo, esposto alla diffidenza e al sospetto dei “grandi inquisitori” dell’ordine costituito. Qualcosa del genere si riscontra, a mio avviso, anche nel “Giro di vite”. Tutto parte da una considerazione: l’elemento della corruzione si innesta nelle esistenze dei due bambini come un’entità eminentemente verbale, almeno per quanto ci è dato di sapere attraverso gli avvenimenti a disposizione della protagonista: Flora, durante la malattia, dice “cose orrende”, che superano “ogni immaginazione”; Miles è espulso dal collegio per aver “detto certe cose” a quelli che gli piacevano. Per entrambi si tratta quindi di “parole”. Ciò non ci stupisce più di tanto, perché i personaggi di Miles e Flora sembrano appartenere alla magica, eterea e disincarnata sfera dell’arte, la quale è principalmente “parola”. Non credo affatto che siano casuali i numerosi riferimenti, che James dissemina lungo tutto il racconto, alla “teatralità” della vita dei bambini.
“…si divertivano immensamente senza di me: e questo spettacolo, allestito da loro con cura particolare, mi coinvolgeva nella parte di ammiratrice appassionata”.
“Mi spuntavano davanti non soltanto mascherati da tigri o da antichi romani, ma anche da personaggi di Shakespeare, da astronomi e da navigatori”.
“Vivevamo in una nuvola di musica, di amore, di successi e di rappresentazioni teatrali tutte per noi”.
In aggiunta, lo scenario autunnale di Bly appare agli occhi dell’istitutrice “come un teatro dopo lo spettacolo… con i programmi cincischiati sparsi al suolo”. Da questi continui e, ripeto, non casuali rimandi al teatro si può dedurre che i due bambini simboleggiano la condizione dell’artista, il quale, agli occhi della società in cui vive e opera, è innocente e perfido allo stesso tempo. La malsana esposizione di Miles e Flora all’influenza dell’istitutrice è, in quest’ottica, l’esposizione dell’artista e delle sue creazioni all’influsso della critica o ai condizionamenti della censura. Non è difficile trovare nel personaggio dell’istitutrice e in quello del direttore del collegio i rappresentanti, subdolamente condiscendenti o dispoticamente intransigenti, di questa categoria. Se una valenza morale può avere questa identificazione, allora la si può ritrovare, più che in ogni altro luogo, nelle lettere che essi scrivono e che, in un modo o nell’altro, non dicono assolutamente niente. Nel piccolo universo di Bly, la signora Grose rappresenta invece il pubblico, o meglio la parte più ignorante e sprovveduta di esso. Non va dimenticato, infatti, che l’anziana donna “non sa leggere”.
Risalendo al livello di narrazione immediatamente superiore, ricordiamo che nel prologo Douglas racconta la storia a un pubblico che via via si assottiglia, si seleziona. Coloro che rimangono, dopo che le sciocche signore si sono allontanate, rappresentano la cerchia ideale di fruitori dell’opera d’arte, tra i quali si cela il lettore privilegiato, quello intelligente e sofisticato: “Continuò a guardarmi fisso. «Tu lo comprenderai facilmente, - ripeté, - tu lo comprenderai»”. Al livello ancora superiore rimane soltanto lo scrittore, Henry James. Non ci meraviglieremmo più, a questo punto, se scoprissimo che “Il giro di vite”, in fondo, di altro non parla se non di James e della sua arte, e che, attraverso le esche, le trappole e i filtri mistificatori, sparsi un po’ dovunque, l’autore si sia inteso burlare dei suoi critici e di tutti coloro che, come me, si sono appressati o si appresseranno all’esegesi del racconto. Allora è tutto inutile, potrebbe dire, saggiamente, qualcuno, sarebbe stato meglio fermarsi alla prima lettura e, almeno, non rovinare la magia e l’incanto di una storia che, letta ingenuamente, dà ancora i brividi. E se invece tentassimo una quarta lettura? Nell’affascinante e misterioso mondo di Bly potrebbe saltare fuori (perché no?) un delitto e, chi lo sa, alla fine l’assassino potrebbe essere proprio il lettore.
Indicazioni utili
Commenti
| 12 risultati - visualizzati 1 - 10 | 1 2 |
Ordina
|
E' probabile che l'autore ne abbia tratto qualche suggestione.
ridondanza stilistica ( pesantissima, non qui ma nei romanzi...eppure mi ammalia)
"Che le apparizioni di Bly siano solamente proiezioni allucinatorie dell’istitutrice mi sembra di poter inferire anche da una sorta di insistita autoidentificazione con esse che ricorre più volte nel corso del racconto." (dubbiosa in merito)
"in fondo, di altro non parla se non di James e della sua arte, e che, attraverso le esche, le trappole e i filtri mistificatori, sparsi un po’ dovunque, l’autore si sia inteso burlare dei suoi critici e di tutti coloro che, come me, si sono appressati o si appresseranno all’esegesi del racconto" ( PIENAMENTE D'ACCORDO).
Letto solo una volta: mi hai fatto venir voglia di smontarlo ma non posso distruggere le prime impressioni che si sono originate la prima volta, passatemi il paragone assurdo: è come l'iniziazione alla pratica sessuale, piacevole o meno che sia stata, quella è la prima volta. Quella con James è stata fantastica...ahahaha. SCUSATEMI TANTO. Strano vero che sia giunta proprio questa similitudine, sarà casuale o indotta?
| 12 risultati - visualizzati 1 - 10 | 1 2 |