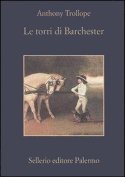Dettagli Recensione
LA COLPA DI NON AVERE COLPE
Di primo acchito tutta l’opera di Kafka sembra dare l’impressione di scarsa coesione e di frammentarietà, ma ciò, lungi dall’essere un fattore negativo, appare del tutto funzionale allo stile onirico dell’autore. Frammentario ed episodico è soprattutto “America”, il quale, permeato di sensazioni fanciullesche e puerili, si abbandona, come la novellistica infantile, a situazioni sempre nuove e diverse, senza curarsi troppo della coerenza narrativa. In quello che è considerato da molti il romanzo più positivo di Kafka, per l’incrollabile ottimismo e l’ingenuo idealismo con cui il protagonista Karl Rossmann affronta le dure prove che l’ingresso nel mondo adulto gli impone, il destino fa comunque sentire la sua implacabile e beffarda presenza. In un crescendo di inaudita crudeltà, il giovane Karl è impietosamente schiacciato dalle soverchianti forze di un mondo abietto, volgare e corrotto. Fin dalla prima pagina veniamo a sapere che Karl è stato cacciato dalla casa del padre per essere stato sedotto e violentato da una cameriera. Per questa colpa grottesca e stramba egli è condannato ad abbandonare la famiglia e la patria ed a peregrinare indifeso in un mondo estraneo ed ostile. “America” non manca di insperati colpi di scena, che sembrano volgere la vicenda a favore di Karl. In realtà, questi capovolgimenti sono del tutto precari e provvisori ed hanno il solo effetto di rendere ancora più dolorosa la sorte del giovane protagonista quando essi rivelano la loro inconsistenza. Così, nel porto di New York, Karl incontra un misterioso, ricchissimo zio, che lo accoglie teneramente e gli dimostra grande affetto, ma alla prima banale mancanza, alla prima inconscia ribellione, viene scaraventato nuovamente in mezzo alla strada. In questo frangente, ricompaiono come per incanto la valigia e l’ombrello che Karl aveva smarriti sulla nave il giorno del suo arrivo e che costituiscono il simbolo della lacerazione, dell’esilio e dello sradicamento. In maniera quasi del tutto analoga, Karl viene inaspettatamente assunto come ragazzo d’ascensore nel pletorico Albergo Occidentale, ma è licenziato, ancora una volta per ragioni al di fuori della sua volontà, dopo un crudelissimo interrogatorio in cui perde quasi del tutto la forza di reagire. Il destino non vuole solo la sconfitta di Karl, ma il suo totale annientamento morale. Se fino a questo momento il nostro eroe aveva potuto contrapporre alle avversità un comportamento fiero e dignitoso, ora non può neppure più chinare la testa, ma è obbligato a fuggire in continuazione, dal sadico portiere dell’albergo, dalla guardia, dal perfido Delamarche, in situazioni sempre più simili ad incubi notturni. La sensazione che la sua sorte non gli appartenga veramente ma venga sempre decisa altrove, fuori del luogo sicuro della sua ragione, si fa via via più opprimente e intollerabile. Con l’ingresso nel putrefacente e nauseante mondo di Brunelda, con quell’esperienza postribolare che rischia di intaccare indelebilmente la sua purezza, Karl Rossmann tocca il punto più estremo della sua parabola discendente.
Vi sono peraltro pagine in cui la filosofia di Kafka sembra giungere ad un approdo definitivamente sereno. Mi riferisco al capitolo finale, intitolato “Il Teatro naturale di Oklahoma”, che è un prodigioso esempio di arte onirica e surreale, nel quale Kafka, da gran maestro, spande a piene mani la giocosa levità delle favole e il gusto burlesco per la parodia. Esso recupera la vicenda di Karl Rossmann dopo una brusca ed improvvisa interruzione della narrazione, dietro la quale non è improbabile che si nascondessero nell’intenzione dell’autore esperienze ancora più degradanti di quelle che il nostro giovane eroe aveva dovuto sopportare in precedenza. Avevamo lasciato Karl nello squallido ed inquietante appartamento di Brunelda, lo ritroviamo ora mentre passeggia senza meta lungo le strade della città. All’angolo di una di esse, Karl legge un manifesto con questa scritta: “Oggi dalle sei di mattina a mezzanotte, all’ippodromo di Clayton, viene assunto personale per il Teatro di Oklahoma! Il grande Teatro di Oklahoma vi chiama! Vi chiama solamente oggi, per una volta sola! Chi perde questa occasione la perde per sempre! Tutti sono i benvenuti!… Noi siamo il Teatro che serve a ciascuno, ognuno al proprio posto!”. Con queste parole, che richiamano da vicino l’appello che si legge nell’evangelista Marco – “Il tempo è compiuto, e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo” – si prepara il grande prodigio, si realizza la perfetta utopia. Quel Teatro in grado di accogliere tutti gli uomini, giacché “il numero dei posti è illimitato”, è la proiezione scenografica dell’aspirazione umana a sfuggire alla precarietà dell’esistenza per inserirsi in un complesso ordinato e sereno, in cui l’individuo può finalmente annullarsi, scaricare le proprie angosce e responsabilità e partecipare della magica armonia del creato. Il Teatro è così grande che l’uomo ne ricava un senso di infinita sicurezza, come se un provvidenziale ordine superiore lo guidasse e vi infondesse una beatitudine senza limiti. Se nella babelica burocrazia de “Il processo” e de “Il Castello” l’uomo non riusciva a districarsi, nell’organizzazione del Teatro il presentarsi senza un documento di riconoscimento e sotto false generalità, come fa Karl, non è più un problema di eccessiva importanza. Questo parodistico anticipo del Regno dei Cieli è descritto da Kafka con accenti grotteschi e surreali. Davanti all’ippodromo di Clayton, si presenta agli occhi di Karl uno spettacolo fantasmagorico: in un podio lungo e basso, centinaia di donne vestite da angeli e collocate su zoccoli di altezza diversa suonano lunghe trombe d’oro. L’effetto è sicuramente bizzarro, e non è escluso che Kafka abbia voluto, da impareggiabile umorista quale nonostante tutto egli era, fare la caricatura della tradizionale iconografia religiosa, così ieratica e solenne: infatti le figure degli angeli, appollaiate su quegli enormi piedistalli, appaiono gigantesche, ma questa impressione è turbata dalle loro teste, così piccole al confronto. Inoltre il suono delle innumerevoli trombe suonate tutte insieme, anziché assomigliare a una melodia celeste, produce solo un grande frastuono. All’interno dell’ippodromo però tutto funziona a meraviglia e procede sorprendentemente sui binari del più assoluto e fiducioso ottimismo. Karl viene assunto, le sue paure e le sue inquietudini svaniscono come d’incanto e sembra quasi che un miracoloso colpo di bacchetta magica abbia fatto scendere la grazia sulla sua giovane persona.
Nonostante che nel capitolo finale di “America” siano completamente assenti i toni tragici e disperati degli altri due romanzi kafkiani e sebbene nel resto del libro le stupefacenti costruzioni burocratiche in esso presenti (si pensi al burattinesco automatismo degli uffici di New York o della portineria dell’Albergo Occidentale) siano apparentemente utilizzate per fare una satira chaplinesca della moderna civiltà dei consumi piuttosto che rappresentare il simbolo di qualcosa che trascende le possibilità di comprensione umana, non sono d’accordo con coloro che vedono in esso un sereno e fiducioso punto di arrivo dell’opera dell’autore boemo. Purtroppo l’incompiutezza di “America” mi impedisce di dare un sostegno pieno e irrefutabile alla mia tesi. Credo però che se il romanzo si fosse interrotto al momento dell’assunzione di Karl nel pletorico Albergo Occidentale di Ramses, le valutazioni non avrebbero potuto essere molto dissimili. Siccome la caratteristica di “America” è, come si è visto, quella di far seguire a favorevoli ed insperati colpi di scena delusioni cocenti e dolorose, non si vede perché ad Oklahoma Karl avrebbe dovuto essere risparmiato da una simile sorte. Se si leggono attentamente le ultime pagine di “America”, si scopre ad esempio che, dopo l’assunzione, il capo della compagnia dice a Karl: “Ad Oklahoma si esaminerà tutto ancora una volta”. E i compagni di scompartimento di Karl, così scontrosi e impertinenti, hanno tutta l’aria di essere i prossimi torturatori del nostro giovane eroe, non meno ambigui e demoniaci di Robinson e Delamarche. Esiste inoltre un significativo frammento dei diari kafkiani che sembra avallare questa tesi: “Rossmann e K., il senza colpa ed il colpevole, ambedue alla fine uccisi senza distinzione per punizione, quello senza colpa con mano più leggera, più messo da parte che trucidato”. Karl Rossmann doveva dunque essere ucciso, al pari di Josef K., e, quel che più importa, doveva essere ucciso per punizione. Ma se anche si volesse credere, come suggerisce Max Brod riportando una dichiarazione orale dello stesso Kafka, che il romanzo avrebbe dovuto avere un lieto fine (“in quel teatro quasi illimitato, il suo giovane eroe avrebbe ritrovato, come per un incanto paradisiaco, la professione, la libertà, l’appoggio, e persino la patria e i genitori”), ciò significherebbe solo che lo scrittore aveva voluto risparmiare alla giovane e innocente vita di Karl una sentenza definitiva e inappellabile di condanna, pur essendo lungi dal volergli concedere una qualche forma di ottimistica assoluzione.