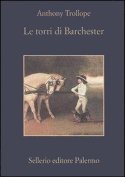Dettagli Recensione
L'INAFFERRABILITA' DEL DIVINO
Il tema del sofferto adeguamento dell’essere umano alle incomprensibili leggi divine, che già era il fulcro tematico de “Il processo”, è trattato in maniera ancora più penetrante ne “Il Castello”. Questo romanzo è una compiuta evoluzione non solo del “Processo” ma anche del breve racconto kafkiano “Durante la costruzione della muraglia cinese”. Rispetto alla “Muraglia cinese”, “Il Castello” rappresenta lo sviluppo coerente della cosmogonia in essa accennata. Laddove al centro dell’universo descritto nel racconto c’è l’Imperatore, circondato da innumerevoli stanze e cortili e palazzi, ai quali fanno seguito la capitale “piena colma della sua feccia” e lo sterminato impero cinese, ai confini del quale la purissima luce imperiale non riesce a fare arrivare neppure un fioco bagliore, al centro della struttura del mondo del romanzo c’è, arroccato sulla collina, Il Castello del Conte West-West, attorniato dalle case del villaggio, verso le quali irradia i suoi riflessi divini, e da un immenso, desolato deserto di neve. La somiglianza, come si vede, è impressionante e non certo casuale. Della vicenda di Josef K. “Il Castello” è invece, per così dire, il logico e necessario completamento. Se nel “Processo” la grande avventura “religiosa” del procuratore veniva brutalmente interrotta dalla sua morte, nel “Castello” Kafka sembra voler riannodare le fila del discorso per spostare le proprie conclusioni un poco più avanti. Per farlo, egli sceglie di sviluppare la vicenda dell’agrimensore K. su un piano eminentemente metafisico, con lo scopo di trasformare più facilmente i valori immediati della esile trama in cifre e simboli del destino.
Nel “Castello” viene affrontato in primo luogo il problema dell’inadeguatezza del razionalismo umano ad affrontare quel fenomeno tipicamente irrazionale che è la fede. Anzi, “Il Castello” può essere senza mezzi termini definito, pur tenendo conto della sua sorprendente poliedricità, un romanzo sulla fede. La fede è sviscerata da Kafka in tutte le sue possibili sfumature, con l’ausilio dei numerosi personaggi che popolano la storia, ognuno dei quali rappresenta un diverso modo di rapportarsi a Dio. La fede è per Kafka un sentimento problematico e sofferto: essa non corrisponde mai a qualcosa di reale od oggettivo, non garantisce neppure un rapporto con il suo oggetto, ma è una adesione totale e senza riserve a qualcosa di incomprensibile. Viene subito in mente, a questo proposito, il capolavoro di Søren Kierkegaard, “Timore e tremore”, al quale Kafka si è senza dubbio ispirato per rappresentare l’enigmaticità del divino, che l’uomo deve accettare anche quando ciò comporta il sacrificio delle più elementari norme etiche. Come Abramo, che in nome di un mostruoso decreto celeste accetta di immolare il figlio Isacco, così gli abitanti del villaggio si piegano a tutte le arbitrarie decisioni del Castello, sforzandosi di sentirle come necessarie e provvidenziali. Questa fede, lo si capisce subito, non è apportatrice di felicità: l’atmosfera del villaggio è infatti tetra e malinconica, e la disperazione con cui i suoi abitanti attendono che un messaggio qualsiasi giunga dal Castello o la feroce caparbietà con la quale essi si tengono avvinghiati al loro credo riflettono ad ogni istante questa sensazione.
Quando K., giunto in paese come un viaggiatore solitario, riceve dal messaggero Barnabas la prima comunicazione del funzionario Klamm, egli si trova di fronte ad un’alternativa angosciosa: accettare passivamente e acriticamente la legge del Castello, senza avere la certezza immediata di esservi un giorno ammesso, o cercare di raggiungere il Castello con le proprie forze, cioè razionalmente. K. sceglie la seconda strada, ben sapendo che la sua decisione sarà giudicata sia dal Castello sia dai membri del villaggio come un atto di aperta ribellione nei confronti di un comandamento ritenuto inviolabile. Per poter sostenere questo sforzo, che è poi una inesausta e mortificante coazione a ripetere ciò che fino ad allora si è dimostrato vano, K. è costretto a rinunciare a tutte le allettanti profferte della vita, prima fra tutte l’amore di Frieda. Nel descrivere il rapporto tra K. e Frieda, Kafka mette in scena tutti i sentimenti e le ipocrisie, le speranze e le paure, gli slanci e gli egoismi della vita di coppia. K. è un uomo come tanti, un po’ eroe e un po’ vigliacco, ama la sua donna ma capisce, senza del resto riuscire a confessarlo apertamente, che questo amore lo intralcia nel suo tentativo di stabilire un contatto con il Castello, rappresentato dal misterioso Klamm (“Se egli perseguiva queste speranze, e non poteva essere altrimenti, doveva concentrare su di esse tutte le forze, non più curarsi d’altro, né del cibo né dell’alloggio, né delle autorità del paese e neppure di Frieda”). Non solo, Kafka avanza addirittura l’ipotesi che K., nel momento in cui ha deciso di sedurre Frieda, sia stato più o meno consciamente affascinato dal fatto che ella era l’amante ufficiale di Klamm e dall’idea che fosse possibile usarla come un ostaggio da riscattare solo ad altissimo prezzo. L’acuta sensibilità femminile di Frieda intuisce un simile calcolo e, in un momento di sconforto, lo dichiara a K.: “Tu calcoli tutte le probabilità: purché tu ottenga il prezzo che vuoi, sei pronto a fare qualunque cosa; se Klamm mi vuole mi cederai a lui, se vuole che tu mi scacci mi scaccerai; ma sei anche disposto a far la commedia, se ne vedrai vantaggio fingerai di amarmi”. L’unione tra Frieda e l’agrimensore, che per il secondo è stata soprattutto una sospirata pausa nell’assillo della sua esasperante ricerca, affoga quindi tra le reciproche incomprensioni dei due: Frieda non riesce a capire l’ostinata irreligiosità di K. e K., a sua volta, non è in grado di percepire la grandezza del gesto di Frieda, che ha abbandonato volontariamente Klamm, preferendo alla luce del divino la precarietà dell’amore terreno.
Oltre a perdere Frieda, K. è costretto anche ad inimicarsi la gente del villaggio, la quale considera empio e blasfemo il suo tentativo e irriverente la spavalderia con cui egli nomina il Conte: “«Lei conosce il Conte, naturalmente?». «No» disse il maestro, e fece l’atto di andarsene. Ma K. non si diede per vinto e ripeté la domanda: «Come? Lei non conosce il Conte?». «Come potrei conoscerlo?» disse il maestro piano, e aggiunse forte, in francese: «Abbia riguardo alla presenza di bambini innocenti»”. Dal maestro al calzolaio Brunswick, dal mastro conciatore Lasemann al carrettiere Gerstacker, l’atteggiamento nei confronti di K. è costantemente improntato ad ostilità e ad insofferenza. Ma è l’ostessa Gardena, con i suoi continui e franchi rimproveri, a stigmatizzare maggiormente la sfrontata sicumera di K. Gardena, che è stata vent’anni prima l’amante di Klamm e da questi è stata poi abbandonata senza un cenno di spiegazione, simboleggia, con la sua fedele devozione al Castello, la mistica della distanza e della separazione dal mondo celeste. Ella è una figura patetica e straziante, incapace com’è di dimenticare il doloroso passato, ma di fronte all’atteggiamento miscredente di K. diventa una spietata e violenta accusatrice. La sua calorosa schiettezza di donna di mondo inquadra la situazione dell’agrimensore meglio di qualsiasi pacata analisi razionale. “Come vuoi che lui capisca – dice a Frieda – quello che per noi è tanto naturale, vale a dire che il signor Klamm non gli parlerà mai, che dico «non gli parlerà»? non gli potrà mai parlare. Ascolti, signor agrimensore. Il signor Klamm è un signore del Castello, ciò indica di per sé, lasciando stare le sue attribuzioni, una posizione molto alta. E cos’è invece lei…? Lei non è del Castello, lei non è del paese, lei non è nulla. Eppure anche lei è qualcosa, sventuratamente, è un forestiero, uno che è sempre di troppo e sempre fra i piedi, uno che vi procura un mucchio di grattacapi… Io le dico che lei è spaventosamente all’oscuro della situazione, vengono i sudori freddi a chi l’ascolta… Questa sua ignoranza non si può correggere in una volta sola, e forse non si può correggere affatto, ma molte cose andrebbero meglio se lei mi credesse almeno un poco, e tenesse sempre presente la sua insipienza".
L’accettazione del mistero, il rito religioso sono chiaramente insufficienti alla mente umana, eppure costituiscono l’unica possibile salvezza, l’unica via percorribile per accedere all’Assoluto. Si tratta chiaramente di una illusione, ma l’uomo ha assolutamente bisogno di questa illusione per vivere. Nel racconto “Una relazione per un’Accademia”, la scimmia Pietro il Rosso comprendeva, dopo essere stata catturata e rinchiusa in una gabbia, che l’unica via d’uscita non risiedeva nella fuga verso la vera libertà, che era diventata impossibile, ma nella creazione di un simulacro di libertà: “No, non volevo la libertà. Soltanto una via d’uscita: a destra, a sinistra, purché fosse; non avevo altre esigenze, anche se la via d’uscita fosse risultata un’illusione”. Così egli sceglieva di soffocare in sé la propria consapevolezza animale, decidendo di diventare un uomo, anche se questa evoluzione appariva nient’altro che una patetica rinuncia. Trattandosi di una fragile illusione, Pietro il Rosso non poteva sopportare alla luce del sole lo sguardo spiritato della scimpanzé con cui si intratteneva la notte, perché quello sguardo era la presa di coscienza della frattura tra la mitica libertà dell’inconscio e l’angusta prigionia del mondo. In maniera non dissimile, gli abitanti del villaggio rifiutano K. perché la sua smania di assoluto minaccia di far saltare il precario e illusorio equilibrio su cui si regge la loro misera vita.
Pur essendo costretto ad assistere impotente alla continua vanificazione dei suoi sforzi e all’accanito diffondersi del malanimo nei suoi confronti, K. non rinuncia a perseguire il suo obiettivo e si adopera in tutti i modi per trovare uno spiraglio, per aprirsi un piccolo varco. Egli è disposto, come si è visto più sopra, ad usare qualsiasi stratagemma gli capiti tra le mani. Avendo scoperto, ad esempio, che il piccolo Hans è figlio della “ragazza del Castello”, una malinconica figura di Madonna incontrata in una capanna di contadini nel corso del suo febbrile girovagare, K. si sforza di conquistare la sua infantile fiducia per riuscire ad avvicinare la madre. Anche questi astuti e maliziosi tentativi con cui K. cerca di penetrare tra le maglie del divino sono però pateticamente votati al fallimento: il Dio del “Castello”, come un vero e proprio deus otiosus, continua a rimanere chiuso nella sua glaciale indifferenza, assente e refrattario a qualsivoglia rivelazione. Eppure, verso la fine del romanzo, il miracolo inaspettatamente accade. Trovatosi solo nella Locanda dei Signori e sfinito dall’insonnia, K. entra per errore nella stanza di un bizzarro ed enigmatico individuo, il segretario Burgel, il quale, svegliatosi di soprassalto, lo invita a fermarsi un poco. Incorreggibile chiacchierone, Burgel inizia a parlare di cose curiose, come delle “occasioni che non concordano con la situazione generale, occasioni nelle quali una parola, uno sguardo, un cenno confidenziale possono ottenere di più che non certi sforzi estenuanti prolungati per tutta la vita”, oppure delle udienze notturne, così invise ai segretari ma altrettanto inevitabili per ragioni di regolamento. In questi dibattimenti notturni, i segretari rivelano una insospettata debolezza: essi perdono la loro facoltà di giudizio, diventano inclini a considerare le cose da un punto di vista più privato e, cadendo completamente in balia delle parti, sono portati ad arrogarsi compiti ben superiori ai loro uffici e ad esaudire le richieste più inaudite. La barriera tra gli uomini e gli dei, che sembrava così sconsolatamente insormontabile, di notte si incrina e vacilla. La Legge si indebolisce, le distanze e le separazioni cadono, Dio ci viene compassionevolmente incontro. Per questi motivi, i segretari cercano di evitare gli interrogatori notturni o di prendere contro di essi delle precauzioni. Ma esiste per gli imputati la possibilità, anche se “nota solamente per sentito dire e mai confermata dai fatti”, di sfruttare la debolezza notturna dei segretari, sorprendendoli nel sonno. Vinto da una irresistibile stanchezza, K. però si assopisce e non ascolta più il soliloquio di Burgel, il quale continua a spiegare che, quando quell’occasione unica si realizza, la parte in causa ritiene ingenuamente di essere entrata nella stanza sbagliata e si lascia sfuggire il momento magico in grado di fargli padroneggiare gli eventi: “Stanca, delusa, inconsiderata e insensibile per sfinitezza e disinganno ritiene di essere penetrata, per chi sa quali motivi indifferenti e casuali, in una stanza che non è quella dove voleva recarsi, sta lì ignara, e i suoi pensieri, se ne ha, s’aggirano intorno al suo errore o alla sua stanchezza. E non si potrebbe lasciarla così? Non lo si può. Con la loquacità di chi è felice, si è sforzati a spiegarle tutto, a descriverle con minuzia e senza nulla tralasciare tutto quel che è avvenuto e per quali ragioni, come l’occasione offerta sia straordinariamente grande e stupenda, come la parte si sia in essa imbattuta con quella spensieratezza che le è propria, ma come ormai, se vuole, essa possa dominare gli eventi, signor agrimensore, e perciò non abbia altro da fare che manifestare i suoi voti, di cui è già pronto, anzi le vola intorno, l’adempimento”. Immerso nel sonno, K. non capisce che Burgel gli sta annunciando la salvezza, che è proprio lui l’agile e sottile pesciolino sgusciato tra le fitte maglie della rete del Castello. Egli non solo non è in grado di sfruttare l’occasione tanto attesa, ma non ha neppure la possibilità di sapere di averla avuta tra le mani: il Cielo lo ha addormentato, facendolo cadere proprio quando potrebbe vincere. Pur ammettendo per la prima volta esplicitamente l’esistenza di una possibilità di realizzare una autentica unione mistica con Dio, Kafka raggiunge in queste pagine una delle sue conclusioni più pessimiste. La situazione dell’agrimensore è identica a quella di Josef K., incapace di decifrare il senso riposto della parabola narratagli dal cappellano, dietro alla quale si nasconde nientedimeno che la sospirata salvezza. Come Tantalo nella leggenda, l’uomo kafkiano si vede sfuggire il lenimento di tutte le sue pene proprio nel momento fatidico il cui è in procinto di possederlo definitivamente. Il senso dell’esistenza è destinato così a rimanere ignoto come un inviolabile segreto, e la morte coglie il procuratore K. e l’agrimensore K. (stando almeno a quanto racconta Max Brod circa il modo in cui Kafka aveva in mente di far terminare “Il Castello”) senza che essi siano riusciti ad acquisire una sia pur minima certezza.
Nella impari sfida che l’uomo lancia a Dio e che Dio accetta con irridente sufficienza, Egli non esita ad avvalersi dei mezzi più infidi e sleali. Spesso e volentieri, infatti, il Cielo si mostra subdolamente conciliante e arrendevole, per non dire addirittura benevolo: nell’episodio della telefonata al Castello, per esempio, a K. che insiste nel voler presentarsi come il vecchio aiutante dell’agrimensore, l’impiegato Oswald non nega soddisfazione e gli risponde, secondandolo con voce profonda e reverente: “Sei il vecchio aiutante”. Oltre a ciò, in un capitolo successivo, K. riceve una lettera dell’ineffabile Klamm, con la quale quest’ultimo si congratula dello zelo dimostrato nei lavori di agrimensura fino ad allora eseguiti: in realtà questi lavori non sono mai stati iniziati, neppure lontanamente. K. intuisce qual è il pericolo di questa situazione all’apparenza favorevole e soddisfacente: “poteva ben accadere, se non stava costantemente in guardia, che un bel giorno, nonostante la cortesia dell’autorità e il totale adempimento di tutti i suoi doveri esageratamente lievi, egli, illuso dal favore che all’apparenza gli si dimostrava, regolasse la sua vita privata con tanta imprudenza da fallire in pieno, così che l’autorità, con la solita dolcezza e cortesia, quasi a malincuore ma in nome di un ordine pubblico a lui ignoto, fosse costretta a toglierlo di mezzo”. L’agrimensore, pur sbagliando nel credere di poter riuscire a controllare gli eventi stando continuamente in guardia, ha capito perfettamente qual è il gioco del suo avversario: l’arrendevolezza iniziale del destino ha il solo fine di blandire l’uomo, illuderlo e poi, una volta indebolite le sue capacità di reazione, schiacciarlo sotto il peso di sofferenze insostenibili. Se anche l’uomo riesce a guadagnarsi una piccola vittoria nella partita contro il destino, si può essere certi che si tratta di una vittoria sterile, di una libertà inutile. Nel “Castello” si trova un episodio molto illuminante a questo riguardo. Una sera K. si reca all’Albergo dei Signori per incontrare Klamm e, venuto a sapere dalla ragazza della mescita che Klamm sarebbe dovuto uscire con la slitta di lì a poco, si intrufola nel cortile interno per coglierlo di sorpresa. Nella lunga attesa, mentre la penombra diventa fitta tenebra, K. trova il modo di penetrare nella slitta del Castello, violando così un rigoroso tabù. Klamm però non esce dalla locanda, la slitta viene fatta rientrare nella stalla e K. rimane completamente solo a contemplare quell’assurdo trionfo: “Certo adesso era più libero che mai, poteva aspettare là nel luogo proibito quanto gli pareva e gli piaceva; si era conquistato la libertà come nessun altro avrebbe saputo, e nessuno aveva il diritto di toccarlo o di scacciarlo e nemmeno di rivolgergli la parola, ma – e questa convinzione era almeno altrettanto forte – nulla era così assurdo, così disperato come quell’indipendenza, quell’attesa, quell’invulnerabilità”.
Il Dio kafkiano non solo è ingannevole e calcolatore, ma è anche beffardo e irridente. Ho già fatto notare come Egli raccolga il guanto di sfida gettatogli da K. con un atteggiamento di canzonatoria indifferenza. Quando poi il Castello invia all’agrimensore i due aiutanti, Artur e Jeremias, capiamo presto che il suo scopo è quello di deridere gli sforzi sovrumani di K. Gli aiutanti sono infatti due burattini da commedia dell’arte, due coboldi in perenne e frenetico movimento, puerilmente importuni e goffamente pedanti. K. se li trova sempre fra i piedi, rannicchiati negli angoli delle stanze nell’atto di sorridergli ironicamente o seduti sul banco della mescita mentre fa l’amore lì sotto. Grazie ad essi, Il Castello trasforma l’epica lotta di K. in una ridicola clownerie. Quando però il Castello inizia a fare sul serio, ecco che gli aiutanti si trasformano e, da buffi pagliacci dall’aria spensieratamente infantile quali erano, diventano implacabili nemici di K., giungendo perfino a rubargli la donna.
Dio è infine indefinibile e inafferrabile. Egli non si rivela mai all’uomo, e questo gli abitanti del villaggio, allenati ad una dura ginnastica di sottomissione e di obbedienza, lo sanno bene, al punto che il desiderio di K. di poter parlare con il Conte pare loro più compassionevole che blasfemo. Quando, nonostante tutto, questa rivelazione sorprendentemente avviene non dobbiamo essere tratti in inganno: Dio può scendere fino all’uomo solo per comunicargli che non può esserci alcuna comunione tra umano e divino, solo per sancire il suo ineluttabile e definitivo distacco. All’uomo è dolorosamente preclusa la via della grazia. Nella migliore delle ipotesi, il suo destino è quello di vivere in un mondo senza Dio, non certo per il motivo che Dio non esiste (raramente Kafka si è abbandonato a una simile suggestione), ma perché Egli è infinitamente lontano, apaticamente rinchiuso nel suo impenetrabile regno e completamente insensibile alle miserie dell’umanità. In uno dei primi capitoli del “Castello”, Frieda, approfittando di un buco nella parete, fa vedere a K. il signor Klamm assiso davanti alla sua scrivania. K. non può sapere ancora che quella a cui ha assistito è una ennesima, fuorviante illusione. In realtà nessuno conosce il vero volto di Klamm. Chi come K. lo ha visto dà di lui una descrizione ogni volta diverso: “quando egli viene in paese ha un aspetto, e un secondo ne ha quando va via, un altro prima di bere la sua birra, e un altro ancora dopo averla bevuta, nella veglia cambia, e cambia di nuovo nel sonno, e quando è solo e quando parla”. Come il Proteo della mitologia, Klamm è un personaggio ineffabile e inesprimibile, simbolo tangibile della inafferrabilità del divino.
In Kafka il mondo è sovvertito, rovesciato. Il trascendente si rivela nelle forme imperfettissime della realtà finita, il sacro dimora negli ambienti più infimi e degradati. Così come le cancellerie del Tribunale de “Il processo” erano ospitate nelle opprimenti e squallide soffitte di lerci casermoni di periferia, dove l’aria è pestilenziale e le piccole finestre lasciano a malapena filtrare un po’ di luce fosca, anche l’irraggiungibile Castello è alla vista una deludente “accozzaglia di casupole senza nessuna caratteristica”. L’insieme delle case raggruppate ha un che di fatiscente e di disordinatamente affastellato, e il goffo campanile rivestito di edera, le cui merlature diroccate sembrano disegnate da una mano infantile timorosa o negligente, appare come “un tetro abitatore… che avesse sfondato il tetto e si fosse levato su per mostrarsi al mondo”. Certo è che se un visitatore fosse venuto soltanto per vederlo – pensa tra sé K. – sarebbe stato un viaggio sprecato. Kafka capovolge la nozione del divino: il divino non possiede né leggerezza e libertà, né ordine e armonia. Forse esso non è così, ma si nasconde, occulta per chissà quali arcane ragioni il suo vero aspetto agli occhi degli uomini, e l’uomo può vederlo solo in quel modo orrendo e deformato: in ogni caso, non c’è dubbio che si tratta di una ingannevole illusione.
Un aspetto molto importante del “Castello” è rappresentato dalla burocrazia, che diventa il simbolo stesso di qualcosa che trascende di gran lunga le possibilità di comprensione umane. L’assurda coerenza e la paradossale infallibilità che caratterizzano ogni sua manifestazione rappresentano per gli eroi kafkiani un ostacolo praticamente insormontabile. Si prenda come esempio l’episodio della visita di K. al sindaco del villaggio, nel corso del quale quest’ultimo rivela l’equivoco che ha condotto alla nomina di un agrimensore del quale non c’è alcun bisogno. Anche se la presunzione assoluta di infallibilità attribuita all’organizzazione del Castello è solo la goffa copertura di un immenso guazzabuglio umano, il contraddittorio tra l’agrimensore e il sindaco, così come nel “Processo” era avvenuto in occasione del colloquio tra Josef K. e il cappellano, non ha alcuna possibilità di concludersi a favore del primo. Troppo ferrea e inoppugnabile è la logica dell’assurdo che regola l’Amministrazione per non irretire anche la buona volontà di K. I suoi sforzi di confutare il meccanismo che disciplina l’apparato del Castello e di scardinarne le motivazioni si rivelano solo dei patetici proponimenti. Il sindaco può così sostenere, con totale candore, che il caso di K., anche se ha comportato una enorme mole di lavoro e l’interessamento di svariate persone, è uno dei più insignificanti, che la lettera di Klamm e le telefonate al Castello non hanno alcuna importanza ufficiale ma al tempo stesso hanno una grandissima importanza ufficiosa, che nessuno trattiene K. al paese ma neppure qualcuno lo caccia via, e così di seguito, all’infinito. Similmente, l’ostessa Gardena è in grado di affermare senza contraddirsi che l’unica possibilità per K. di avere un qualche rapporto con Klamm è il verbale del segretario Momus e, contemporaneamente, che non esiste alcuna speranza di giungere fino a Klamm, neppure per caso. In fondo a tutte le sottilissime disquisizioni di funzionari, segretari e avvocati rimane l’amara evidenza che il meccanismo dell’ingranaggio non può mai essere svelato nella sua interezza all’uomo.
Nella burocrazia kafkiana non è ammessa la possibilità dell’errore, anche laddove esso appare palesemente evidente, come nel caso della nomina dell’agrimensore. All’obiezione di K. che un errore è stato indubbiamente commesso dal Castello, il sindaco risponde che “errori non se ne commettono e, anche se ciò per eccezione accade, come nel caso suo, chi può dire alla fin fine che sia davvero un errore”. La sconcertante aporia è così risolta alla radice: errori non ce ne sono perché non possono esserci. Anche la perfezione dell’Amministrazione insistentemente vantata contrasta con il caos regnante un po’ ovunque: i documenti del sindaco sono ammucchiati disordinatamente nel granaio oppure legati come fascine e stivati nell’armadio, le pareti dello studio del funzionario Sordini scompaiono dietro pile di incartamenti che crollano ad ogni momento, e così via dicendo. Ciononostante, attraverso l’infinita e grottesca serie di equivoci e di qui pro quo in cui si dibatte l’amministrazione del Castello, è possibile leggere come in filigrana un disegno immutabile e coerente, quello del destino dell’uomo al quale è per sempre preclusa una sia pur piccola possibilità di salvezza.
Indicazioni utili
Commenti
| 4 risultati - visualizzati 1 - 4 |
Ordina
|
| 4 risultati - visualizzati 1 - 4 |