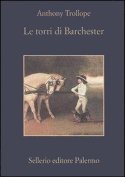Dettagli Recensione
Non la luce, ma il fuoco
“Non della luce abbiamo bisogno, ma del fuoco”.
Quando Georg Buchner muore, nel 1837, forse di tifo, forse per una meningite, ha da poco compiuto 23 anni. Una vita brevissima e fulminante, condotta all’estremo delle cose, lungo l’orizzonte sottile che separa il genio dalla follia, là dove l’anima sfarina in cenere e qualche necessità invidiosa celebra troppo presto l’eutanasia dello spirito. Di questa autore meraviglioso, ingiustamente dimenticato, eversivo, modernissimo e capace di una crudele commozione, ci restano tre drammi plastici e tremendi, scenicamente perfetti, illuminati da una luce dura e fredda e dominati da un angoscioso senso della fine: la morte di Danton, amara riflessione sulle delusioni che la rivoluzione francese ha portato con sé, il Leonce e Lena, gattopardiana e solenne rappresentazione della decomposizione della nobiltà tedesca e lo struggente Woyzeck, tragedia umanissima di un uxoricidio che scosse la società dell’epoca. Stupiscono in questo ragazzo una tanto insopportabile sensibilità e una così affilata scrittura tanto che resta da chiedersi di quale materia vivano questi personaggi, di quale oscura forza siano animate le parole e quali misteriose architetture tengano le redini delle spinte centrifughe che si muovono sotto la superficie del testo.
In uno spazio più metafisico che reale, trasfigurato dalla spirale allucinata che muove la scena, Woyzeck, un umile stalliere, vive come in una pentola a pressione, sotto un cielo “così liscio che viene voglia di piantarci un chiodo e impiccarsi”, torturato dalle beffe della moglie infedele, usato come cavia dal medico del paese, dileggiato dell’amante della stessa e sull’orlo di continue deflagrazioni. Dalla terra di questo dramma prendono forma demoni e sinistre presenze, a consumare, granello dopo granello, la clessidra della fine, epifanie ataviche e genetiche che accompagnano la discesa agli inferi di questo uomo lacerato da una tanto macerante lucidità. In questo chiarore nervoso, nell’epilettica ipersensibilità del reale, anche l’ultimo lembo di senso è stritolato dal dolore e tutto è balbettio, sussurro, frammento. Perché mai come qui il confine tra colpa e innocenza è stato così sdrucciolevole.
Woyzeck non è un personaggio semplice e riflette le contraddizioni del suo autore. Buchner è stato, tra le altre cose, studente di medicina e rivoluzionario, autore di un pamphlet social-utopista che animò una protesta duramente repressa. Lo stesso Buchner che da un lato professa la violenza come unico mezzo per raggiungere uno scopo e che nelle lettere all’amata fidanzata riesce a scrivere: “Il singolo è solo schiuma sulle onde, la sovranità del genio una commedia di burattini. Ho abituato il mio occhio al sangue, ma io non sono la lama di una ghigliottina… cos’è che in noi mente, uccide e ruba?”. E del magma pastoso di questa feroce contraddizione vive il suo Woyzeck, dilaniato dal dubbio e torturato dal labirinto fangoso della mente. Questa atroce dicotomia prende la forma di una battuta felicissima che accompagna il compiersi del dramma e anzi ne circoscrive l’akmé: “Soll ich? Muss ich?” Per due volte Woyzeck si chiede se sia giusto uccidere la moglie e qui il tedesco non è traducibile in italiano. Non è semplicemente un tentennamento, ma piuttosto la ricerca dell’intima ragione del gesto. Mussen significa dovere, un dovere soggettivo, personale, autonomo. Anche sollen significa dovere, ma è un dovere eterodiretto, esterno, dettato dalle circostanze e dalla necessità. E allora questa iterata domanda apre in realtà uno squarcio esistenziale e filosofico sul destino dell’uomo e sulle leggi dell’universo. “Sono io a volerlo o è necessario che lo faccia?”. Questo si chiede in realtà Woyzeck, in un tripudio martellante di psicosi e tragica fragilità. Perché Buchner fa proprio questo, scortica l’uomo per gettarlo sulla scena, preda degli elementi, solo e senza scampo sotto il peso del cielo. Eppure, ancora più straordinario, è che in mezzo a tanto sangue, a tanta cupa desolazione, tutto è placido in questo dramma, tutto giace in un’anomala tranquillità, in una calma miracolosa, la “pace di un campo di grano”. Perché Buchner, come il migliore Leopardi, sa che solo l’arte e la parola possono librarsi sul peso del mondo e che solo il canto della scrittura può opporre un velo di luce sul nero abisso del nulla. Perché come avrà a dire Rilke, “quest’uomo, suo malgrado, sta nell’universo, sotto l’infinito manto di stelle”.
Leggete Buchner, non lasciatevi scoraggiare dalla frammentarietà del testo, dall’espressività esasperata, lasciatevi incantare da questa arte altissima e rara, che, come la Speranza, viene dal fondo del vaso di Pandora.
Indicazioni utili
Commenti
| 6 risultati - visualizzati 1 - 6 |
Ordina
|
| 6 risultati - visualizzati 1 - 6 |