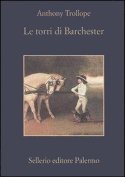Dettagli Recensione
APPUNTAMENTO FALLITO CON IL DESTINO
“La vita – ha scritto Virginia Woolf – è un alone luminoso, un involucro semitrasparente che avvolge completamente la nostra coscienza”. Della coscienza, appunto, di questo impalpabile e inafferrabile mistero quotidiano, la grande narratrice inglese ha descritto gli intimi riverberi e chiaroscuri, gli aneliti appassionati e i riflessivi ripiegamenti, dando alla sua lirica prosa le fragili sembianze della poesia. Straordinariamente recettiva, la penna della Woolf ha assorbito e registrato il fluire sconnesso e disordinato delle impressioni, dei pensieri e delle emozioni dei suoi personaggi e su questo inconsistente terreno ha edificato come per incanto una costruzione armoniosa ed equilibrata: “Gita al Faro”.
Fin dalle prime parole, fin dalla breve e lapidaria frase che, con l’annuncio dell’imminente escursione al Faro, apre in minore il romanzo (“«Sì, di certo, se domani farà bel tempo»”) veniamo introdotti nel cuore del mondo woolfiano. E’ un mondo in cui ogni impressione di gioia, di serenità e di sicurezza si rovescia in qualcosa di triste e di precario, pervaso da un’ombra di cupo fatalismo. L’iniziale affermazione (“Sì, di certo”), la quale procura al piccolo James una felicità immensa, è infatti significativamente corretta da una condizione (“se domani farà bel tempo”) che increspa, irrimediabilmente rovinandolo, il piacere dell’attesa; e un senso di occasione sciupata, di appuntamento fallito con il destino, si insinua nel romanzo, condizionandone tutto lo sviluppo futuro. L’andamento contrappuntistico è tipico di quest’opera. Termini come “oscurità e luminosità”, “ombra e splendore”, ad esempio, si alternano ritmicamente tra loro, con una intermittenza per molti versi simile a quella del fascio di luce del Faro, il quale non a caso rappresenta una delle fondamentali metafore del libro. Vi è poi il contrasto tra le singole, non amalgamabili, entità individuali: i numerosi personaggi riuniti nella villa dei Ramsay si muovono come particelle indipendenti e disaggregate, che solo raramente e per breve tempo riescono a trovare un momento di coesione, prima di disperdersi nuovamente nel vuoto. Gli stessi coniugi Ramsay, i quali esprimono la contrapposizione, abituale in Virginia Woolf, tra cervello e cuore, tra ragione e istinto, sono incapaci di comprendersi o aiutarsi, e sotto l’usurata superficie dei gesti quotidiani si comportano come due perfetti estranei. Esemplare, a questo proposito, è il dialogo che essi intrattengono nel giardino, quando si aggirano lungamente intorno agli argomenti che stanno loro a cuore, ma, senza risolversi mai (per mancanza di coraggio o eccesso di riguardo) ad affrontarli, si accontentano di conversare futilmente dei fiori e delle borse di studio dei figli; o il momento di intimità che segue la lunga cena, durante il quale la signora Ramsay capisce che il marito “desiderava qualcosa; desiderava ciò che a lei riusciva sempre tanto difficile concedergli; desiderava che lei gli dicesse che lo amava… Ma ella non poteva accontentarlo; non poteva dir certe cose”.
Molte altre significative antitesi sono disseminate nel romanzo (ad esempio, il contrasto tra aspirazioni e realizzazioni o quello tra illusione e realtà – ne parlerò più avanti -, e ancora la contrapposizione tra razionalità soggettiva e irrazionalità oggettiva), ma il fondamentale contrappunto, quello su cui si regge l’intera impalcatura di “Gita al Faro”, è quello temporale. La Woolf sembra catturare il tempo e restituircelo nelle sue implicazioni emotivamente più forti. I dieci anni che separano la prima parte dalla terza sono una tormentosa frattura che invano i protagonisti ancora in vita cercano di colmare con il ricordo. La vivida sovrapposizione, nella memoria, di passato e presente, il periodico riaffiorare di reminiscenze lontane (il sogno di Camilla, il rammarico di James provocato dalla mancata effettuazione della gita) si scontrano infatti con una realtà in cui è avvertibile (anche fisicamente: i gradini vuoti della casa) la mancanza delle persone amate, che un giorno avevano trasmesso agli altri il loro inconfondibile fluido vitale e che ora sono scomparse, per sempre. Non c’è strazio né disperazione in queste riflessioni sul passare del tempo, ma solo una contenuta commozione, un delicato struggimento. Nel passato ci si illude spesso di trovare conforto, di poter contemplare, fissandolo per sempre, il flusso inarrestabile della vita, come ama sognare la signora Ramsay (“…giudicò di poter ritornare nel mondo dei sogni, in quel luogo irreale e incantevole che era il salotto dei Mannings di vent’anni prima; e dove era possibile aggirarsi senza fretta o ansietà, perché non v’era da pensare al futuro. Ella sapeva quanto era accaduto allora a quegli amici e a lei. Era come rileggere un bel libro di cui si rammentava la fine; perché l’accaduto era di vent’anni prima e la vita, che sgorgava a fiotti perfino da quella mensa per fluire Dio sa dove, lassù era suggellata, placidamente conclusa, come un lago fra le sue rive”); ma appunto di sogni si tratta, perché in Virginia Woolf la memoria non ha la funzione consolatoria della Recherche proustiana, ma è, come scopre a sue spese Lily Briscoe, richiamando alla mente l’amata signora Ramsay, una lama che trafigge dolorosamente il cuore. “Il rimpianto vano, il desiderio struggente, come, quanto stringevano il cuore!… Sembrava così innocuo pensare a lei. Ella pareva uno spirito, un alito, qualcosa con cui giocare facilmente e senza pericolo in qualunque momento del giorno e della notte, ed ecco, all’improvviso allungava una mano per stringere a quel modo il cuore altrui. All’improvviso, i gradini vuoti all’ingresso del salotto, gl’intagli della sedia all’interno, il cucciolo scherzoso sul piazzale, tutta l’onda di bisbigli che aleggiava sul giardino divenivano curve e arabeschi volteggianti attorno a un centro d’assoluta vacuità”. Il passato, lungi dal consentire di raggiungere l’agognato equilibrio, la bramata pacificazione, svela impietosamente il disordine, il caos, la mancanza di senso della vita, ricordandoci “che ogni persona è sostanza effimera; che nulla permane, che tutto si trasmuta”. L’invocazione della persona amata che non c’è più, anziché dare sollievo, diventa così un vano tendere le braccia brancicando nel buio o un singhiozzo che ci soffoca e che non riusciamo a trattenere.
Questa complessa e affascinante elegia della memoria è tradotta in immagini elaborate e musicali, fitte di rispondenze e di suggestioni ritmiche, mediante le quali Virginia Woolf (in questo sicuramente debitrice del quasi contemporaneo Joyce) si sforza di descrivere l’ininterrotto flusso di coscienza dei suoi personaggi. La scrittrice, che pur non rinuncia a narrare in terza persona, indaga a fondo la realtà interiore di ciascuno, registrando, per mezzo di un fitto e ininterrotto monologare, l’intersecarsi di differenti piani temporali e l’alogico fluire di richiami e associazioni di idee (valga per tutti questo esempio: “…a un tratto egli s’avvide che si trattava di questo, sì di questo: ch’ell’era la più bella donna che avesse mai veduta. – Cogli occhi stellati e veli alle chiome, con ciclamini e viole – che sciocchezze gli venivano in mente? Ell’aveva almeno cinquant’anni; aveva otto figli. – Andando su prati fioriti e stringendo al seno bocciuoli recisi e agnelli smarriti, cogli occhi stellati e le chiome al vento… Le prese la borsetta”). Questa acuta e delicata esplorazione delle coscienze è modulata in tre tempi, ognuno dei quali è caratterizzato da un proprio inconfondibile ritmo: il primo è un lunghissimo piano sequenza, in cui dal rigoroso rispetto del tempo reale scaturisce, per mezzo di una raffinata tecnica di raccordi ed interconnessioni che lo moltiplica nelle coscienze dei personaggi, un effetto di dilatazione; il secondo, al contrario, condensa dieci anni di vita in poche decine di pagine ed è simile, musicalmente parlando, ad un elegiaco adagio; il terzo tempo, infine, riprende le fila del primo, però con una importante differenza: la vicenda (se di vicenda si può parlare, data la mancanza di un vero e proprio intreccio narrativo) abbandona l’unità di spazio e si sviluppa parallelamente tra il giardino della villa dove è rimasta a dipingere Lily Briscoe e il mare su cui veleggia, in direzione del Faro, l’imbarcazione del signor Ramsay.
Le tre parti del romanzo interagiscono perfettamente tra loro, e il fattore connettivo è rappresentato dalla riuscita simbiosi tra l’attività psichica dei personaggi e la realtà esterna. Più che svilupparsi su due piani distinti, il romanzo lascia che i due elementi si integrino, si sovrappongano, influenzandosi a vicenda. E’ sorprendente, ad esempio, come la Woolf segua il corso di pensieri dei personaggi senza per questo perdere mai di vista ciò che essi stanno facendo. Quando la signora Ramsay riflette sullo stato malandato della casa e nel contempo misura la lunghezza del calzerotto sulla gamba del figlio, l’effetto che si ricava non è di semplice parallelismo, ma di vera e propria contemporaneità. Ancora più significativo è il fatto che nel mondo woolfiano l’ambiente e la natura non hanno solo una funzione scenografica e decorativa, ma condizionano attivamente, spesso modificandoli, gli stati d’animo degli esseri umani. “Andavano lì regolarmente ogni sera, quasi per una necessità. Pareva che l’acqua portasse al largo, facesse navigare sull’onde pensieri stagnanti in terraferma, dando così ai loro corpi una specie di fisico sollievo… Sorridevano entrambi, sostando lì. Entrambi sentivano una comune ilarità, eccitata dalle mobili onde; eppoi dalla rapida netta corsa d’una nave, che, dopo aver stagliato una curva nella baia, sostava, fremeva, abbiosciava le vele; e allora… entrambi, al quietarsi di sì rapido moto, guardavan le dune lontane, e invece di gaiezza sentivano calar sull’animo una vaga malinconia: parte perché qualcosa aveva compimento, parte perché il remoto paesaggio sembrava dover sopravvivere per migliaia d’anni (così Lily pensava) allo spettatore, esser già in comunione con un cielo contemplante una terra in estremo riposo”.
I personaggi di “Gita al Faro” sono tutti straordinariamente permeabili all’evocativo potere delle cose, dei suoni e dei colori (al signor Ramsay, ad esempio, una determinata siepe è in grado di far scaturire una conclusione filosofica, un vaso di gerani definire i processi del suo pensiero), così che le loro emozioni nascono prevalentemente da una trasformazione dell’”oggettivo” in “soggettivo”. L’animo umano è una sensibilissima antenna puntata verso l’universo, e ogni minima irradiazione esterna (come il volo di un uccello o la vista di una nuvola) vi si rifrange in una miriade di vivide e indelebili impressioni. Esemplare è la scena in cui “il monotono sciabordio delle onde sulla spiaggia… di solito… accompagnava i pensieri della signora Ramsay con un tamburellio misurato e blando, simile a parole d’antica ninnananna mormorate dalla natura… ma altre volte, a un tratto, inopinatamente,… non aveva senso sì benigno, ma, quasi spettrale rullio di tamburi, batteva spietato il ritmo della vita,… ed ammoniva lei, i cui giorni erano dileguati in rapida successione di doveri da compiere, che tutto era effimero come l’iride”.
L’essere umano può essere definito, generalizzando ciò che la Woolf dice riferendosi alla signora Ramsay come “una spugna imbevuta di emozioni”. Il suo rapporto con le cose non è però, come potrebbe sembrare a prima vista, un fenomeno involontario o inconscio, ma è il risultato di una ben precisa, ancorché non del tutto decifrabile, tendenza, quella di “volgersi in solitudine verso le cose, le cose inanimate – alberi, torrenti, fiori -, come a forme d’espressione, col senso d’assimilarle, d’esserne inteso, di farne parte”. In questa brama di autoannullamento l’uomo esprime soprattutto il desiderio di stabilire un rapporto pacificato con la realtà e di ottenere una risposta ai quesiti esistenziali che lo assillano, come se egli intuisse che se solo fosse in grado di mettere insieme le cose come parole in una frase esse sarebbero capaci di svelare l’inafferrabile mistero della vita.
Anche la fede nelle cose, così come la fede nella memoria, è destinata però a venire presto disillusa. Virginia Woolf non lo dice chiaramente, neppure a mezze parole, ma lascia intendere che l’unico mistero che le cose custodiscono è la precarietà dell’uomo, la mancanza di senso della vita, la fuggevolezza del tempo. Il sogno che la felicità prevalga, che il bene trionfi, e la speranza di trovare nella natura una spiegazione sono qualcosa di ingannevole, sono solo i riflessi di uno specchio che ogni uomo porta dentro di sé e che deforma le sue percezioni reali. Il senso di inquietudine che si affaccia talvolta nei personaggi di “Gita al Faro” è la malinconica intuizione di questa verità negativa: “«Tutto è finito», pensò la signora Ramsay, mentre gli ospiti entravano… le sembrò che sulle cose fosse caduta un’ombra la quale, cancellandone il colore, gliele mostrasse nel loro aspetto più vero”. Quando poi lo specchio si infrange del tutto, la contemplazione delle cose, che prima sembrava promettere la salvezza, diventa intollerabile: all’uomo, tradito dalla vita, non resta forse che sperare nella morte.
I personaggi di “Gita al Faro” si sforzano in continuazione, con patetica fiducia, di aderire alla vita, ma fra loro e la realtà si frappone sempre uno scarto, una piccola, insanabile frattura: il signor Ramsay cerca la Verità ultima e indiscutibile, ma è consapevole di non essere in grado di arrivare fino in fondo (cioè alla lettera Z, lui che è giunto con immensi sforzi solo fino alla Q); la signora Ramsay si avvicina maggiormente a un armonico accordo con la realtà, ma la sua premonitrice paura di vedere distrutto da un momento all’altro il suo equilibrio (“ma non può durare” è il suo pensiero ricorrente) le impedisce di raggiungere una autentica felicità; Lily Briscoe, infine, tenta di trasferire sulla tela il mondo intorno a lei, di tradurre concretamente il sublime riflesso che le cose proiettano nel suo animo, ma lo sforzo artistico è palesemente inadeguato e solo qualche misero, imperfetto avanzo della sua visione può essere fissato per sempre nel dipinto. In un romanzo ricco di simbolismi (basti pensare al Faro, che, dopo essere stato per lungo tempo un luminoso e irraggiungibile punto di riferimento, alla fine del libro appare a James come “una torre nuda sopra una squallida roccia”), il quadro di Lily rappresenta certamente lo sforzo di estrinsecare il proprio io, il tentativo di aprirsi al mondo, in parole povere la vita umana, la quale riesce quasi sempre molto diversa da ciò che si vorrebbe essa fosse, vuoi a causa della distruttiva consapevolezza che “non si può esprimere ciò che si pensa” vuoi per il fatto che in questo sforzo di conoscenza l’uomo è necessariamente solo (Lily, ad esempio, difende strenuamente la sua intimità, pur sapendo che, in fin dei conti, da essa non riceverà in cambio che solitudine e infelicità). Se la grande rivelazione è irraggiungibile o non esiste affatto, al suo posto, nella ripetizione infinita della natura che l’uomo chiama tempo, egli trova solo brevi istanti di visione, “piccoli miracoli quotidiani, illuminazioni, fiammiferi accesi all’improvviso nel buio”. Quella della Woolf può essere definita, a mio parere, come una vera e propria poetica del momento. “Quel momento appariva estremamente fecondo. Ed ecco, la signora scavava una buchettina nella sabbia; eppoi la ricopriva, come per racchiudervi la perfezione di quel momento. Ed esso era pari a goccia argentea, che rendesse luminosa, irrorandola, l’oscurità del passato”.
Solo quegli istanti di accecante perfezione possono dare un senso alla vita, e su uno di essi (la visione che permette a Lily di terminare il quadro) si chiude il romanzo. Non bisogna però credere che la conclusione di Virginia Woolf sia del tutto serena e rassicurante. Ricordiamoci che alla fine della prima parte c’è un analogo momento di appagamento, quando la fusione tra i commensali che si sono riuniti intorno alla tavola di casa Ramsay è finalmente completa: “(La signora Ramsay) si librava, come un falco sospeso sull’ali, come bandiera sventolante, in un elemento di gioia che compenetrava ogni fibra del suo corpo soavemente, senza strepito, quasi solennemente: esso proveniva… dal marito, dai figli, dagli amici; e, levandosi in quella profonda pace…, sembrava fluttuare, senza special motivo, come un fumo, come un vapore esalante verso l’alto, e racchiudere la comitiva in un’atmosfera di sicurezza. Non occorreva dir nulla; non c’era da dir nulla. Una placida gioia era diffusa intorno, ricingeva tutti”. Eppure qualche pagina dopo c’è la triste, dolente elegia di “Passa il tempo”, in cui assistiamo all’implacabile distruzione di questa visione da parte del tempo. La vita – sembra dirci la Woolf – è una sommatoria di momenti, alcuni insignificanti, altri importanti, altri ancora addirittura decisivi, ed essi sono indubbiamente l’unico motivo per cui valga la pena di vivere; ma alla fine – e questo è forse l’unico grande, doloroso mistero dell’universo – il risultato per tutti dà sempre, sconsolatamente, zero.
Indicazioni utili
Commenti
| 6 risultati - visualizzati 1 - 6 |
Ordina
|
| 6 risultati - visualizzati 1 - 6 |