Dettagli Recensione
IL ROMANZO DOVE GLI ESTREMI SI TOCCANO
“Molto più conosce Iddio un santo idioto, che un savio peccatore” (Domenico Cavalca, “Specchio di croce”)
“Conosco solo uno psicologo che abbia vissuto nel mondo in cui il cristianesimo è possibile, in cui un Cristo potrebbe nascere in ogni momento. E questi è Dostojevskij. Egli ha indovinato Cristo” (Friedrich Wilhelm Nietzsche, “Frammenti postumi 1888-1889”)
Momento cruciale di raccolta e di assimilazione di una mole di materiale enormemente vario ed eterogeneo (vi si possono trovare, suggestivamente affiancati, Cristo e la cronaca giudiziaria russa del tempo, il “Don Chisciotte” di Cervantes e l’interpretazione dell’Apocalisse, e molti altri temi ancora), “L’idiota” è un romanzo fortemente anticipatore di quelle tendenze che, negli anni successivi, prenderanno corpo ne “I demoni” e ne “I fratelli Karamazov”, e rappresenta l’autentico centro nevralgico da cui si dipartono le coordinate filosofico-poetico-religiose di quella complessa e affascinante costruzione che è il pensiero dostojevskijano. Degli aspetti prettamente ideologici del romanzo parlerò diffusamente più avanti: qui mi preme invece sottolineare come “L’idiota” possegga tutti gli attributi necessari per essere considerato un’opera paradigmatica di quelli che sono i procedimenti narrativi tipici dell’autore, e come tale si presti ottimamente ad una analisi strutturale del testo.
Come tutte le storie di Dostojevskij, anche quella de “L’idiota” non segue uno sviluppo lineare ed armonico, ma è condotta in maniera estremamente eterogenea. Da una parte assistiamo a una accentuata arbitrarietà temporale, alla creazione di un tempo artistico parallelo a quello reale, straordinariamente elastico e modellabile a seconda delle esigenze stilistiche dell’autore. Dostojevskij è capace ad esempio di concentrare una grande quantità di avvenimenti in poche ore di una giornata, per poi saltare a piè pari interi periodi di settimane o addirittura mesi. A dimostrazione di questo personalissimo procedimento può essere presa la prima parte del romanzo: in essa il principe Myskin, appena giunto a Pietroburgo dall'estero, senza denaro e senza conoscenze, si trova a dover affrontare nell’arco di una sola giornata un numero talmente grande di avventure (dall’incontro con il generale Epancin e la sua famiglia alla movimentata festa di compleanno di Nastasja Filippovna, in cui Myskin rivela di essere entrato in possesso di una ingente eredità e dichiara solennemente di voler sposare la padrona di casa) da essere in grado di riempire con esse un intero feuilleton; per contro, la seconda parte si apre inopinatamente con un buco nero di alcuni mesi, riempito solo da tanti “sembra” e “si dice” che ci fanno sì ritrovare gli stessi personaggi di prima, ma senza la possibilità di conoscere con sicurezza ciò che essi hanno fatto e pensato in tutto quel tempo. Questo alternare momenti di estrema condensazione narrativa a improvvisi salti temporali crea un anticlimax di grandissima efficacia, che permette a Dostojevskij di “ricaricare” la tensione narrativa (attraverso la creazione di zone d’ombra piene di mistero o l’introduzione di nuovi personaggi) e mantenere sempre desto l’interesse del lettore.
Dall’altra parte, Dostojevskij sorprende e disorienta per i continui cambiamenti di direzione dell’intreccio: leggendo “L’idiota” si ha spesso l’impressione che la vicenda non sia più governata dallo scrittore e possa in qualsiasi momento prendere una piega imprevista. Si tratta però di una impressione inesatta, perché i mille rivoli che sgorgano dal denso substrato drammatico della storia e che fanno a tutta prima assomigliare “L’idiota” a un romanzo d’appendice, si ricompongono alla fine in una struttura miracolosamente equilibrata, in cui lo spunto moralistico di partenza si realizza in maniera del tutto naturale e coerente.
Lungi dall’essere espedienti puramente meccanici e artificiosi di un abile mestierante, i copiosi colpi di scena che contraddistinguono la partitura dostojevskijana appaiono come il risultato necessario della estrema complessità psicologica dei tanti personaggi che si trovano ad interagire, in maniera più o meno conflittuale, tra loro. I complessi rapporti tra i personaggi del romanzo sono forse l’ambito in cui maggiormente si impone l’unicità di Dostojevskij scrittore. Il modo in cui le figure de “L’idiota” entrano in relazione tra loro non ha infatti nulla dell’abituale dialettica che troviamo nella letteratura tradizionale. I personaggi dostojevskijani sembrano al contrario delle particelle impazzite, che cercano instancabilmente negli altri la verifica del proprio essere: essi si attirano come delle calamite, si scontrano, si respingono, si incalzano di nuovo, spinti da un disperato bisogno di aprire il loro animo. E’ sufficiente l’apparizione di un essere che polarizzi queste esigenze, come il principe, per creare dal nulla una elaborata ragnatela di reciproci rapporti, che si concretizzano dal punto di vista narrativo in affascinanti dialoghi a due, in mutue confessioni nelle quali le persone (diversamente da ciò che normalmente capita di vedere nella realtà) si affrancano completamente dalla paura di esporsi alla presunzione o alla ipocrisia di un giudizio morale.
Ma Dostojevskij non si limita a questo: egli è un alchimista che sperimenta tutte le combinazioni possibili tra gli elementi (leggi: personaggi) a sua disposizione, al fine di ricavarne le reazioni psicologiche più esasperate, e perciò più sincere. E’ per questo motivo che Dostojevskij ama spesso radunare in un solo luogo, per una circostanza qualsiasi (una festa di compleanno, un ricevimento, una riunione casuale), un gran numero di personaggi fortemente antitetici e contrastati. In queste sequenze, di cui “L’idiota” offre eccezionali esempi (la scena in casa Ivolgin, con l’arrivo di inattesi personaggi a fare da detonatore a rapporti familiari e sentimentali fino ad allora in fase per così dire magmatica, oppure il ricevimento di Nastasja Filippovna, in cui tutti si attendono da lei una decisione definitiva, o ancora l’affollato raduno nella casa di Lebedev a Pavlovsk, nella quale si trova il principe convalescente), le passioni degli uomini sono continuamente sollecitate e portate alle estreme conseguenze. E’ significativo come la maggior parte di esse si concludano con l’insorgere di stati febbrili (Ganja, Lizaveta Prokofevna, Aglaja), di accessi di epilessia (Myskin) o addirittura di follia (Nastasja Filippovna), a testimonianza di come in queste circostanze la tensione raggiunga sovente livelli insopportabili e difficilmente concepibili nella realtà normale (si pensi alla crudelissima scena in cui Nastasja Filippovna, davanti a un uditorio costernato, getta centomila rubli nelle fiamme del camino, sfidando Ganja a tirarli fuori con le mani nude).
Dostojevskij non si cura tuttavia di apparire realistico. L’episodio sopra descritto è sicuramente eccessivo e anti-realistico, ma ha una sua finalità, quella di contribuire ad assegnare al denaro (che, nei romanzi dostojevskijani, ricordiamolo, non è mai guadagnato con gli usuali strumenti della vita di tutti i giorni, tanto è vero che non risulta che qualche personaggio eserciti un lavoro concreto) una funzione mistico-simbolica, come potenza che apre spazi sconfinati di libertà e di oppressione, di affermazione e di disgregazione. Anche le atmosfere del libro sono agli antipodi della quotidianità spicciola: Dostojevskij le rovescia come guanti, le trasfigura, impregnandole di morbosa inquietudine, disseminandole di segni premonitori e angosciosi contrappunti (come nella bellissima scena che culmina nell’agguato di Rogozin, durante la quale la maturazione dell’accesso epilettico di Myskin si accompagna all’arrivo dell’uragano) e dando loro i toni cupi e irreali di un incubo notturno.
Ho accennato poc’anzi alle parossistiche scene di gruppo, così tipiche dello stile di Dostojevskij: talora esse sono delle splendide occasioni per far risaltare le virtù degli eroi dostojevskijani, ma, ad essere sinceri, il più delle volte si rivelano delle vere e proprie trappole in cui i vari Myskin, Alesa, Zosima rischiano di naufragare miseramente. Dostojevskij, infatti, non spiana mai loro la strada, così da farne risaltare facilmente la grandezza d’animo, ma, al contrario, la cosparge di situazioni imbarazzanti e penose, che rischiano di comprometterne ad ogni istante la nobiltà. L’episodio del presunto figlio di Pavliscev, prima che la truffa di Doctorenko e compagni venga smascherata, è tale da scuotere pericolosamente l’ideale di evangelica bontà incarnato dal principe (così come i dubbi religiosi di Alesa Karamazov rischiano di portare quest’ultimo sulla strada dell’ateismo). Il fatto è che Dostojevskij in ogni romanzo vuole affermare una precisa tesi morale, ma, nel far questo, paradossalmente, si preoccupa sempre, con un accanimento direi quasi masochistico, di metter sul piatto della bilancia tutti gli elementi che minacciano di contraddire questa tesi, anche a costo di rendere questi ultimi più convincenti della stessa. E’ un atteggiamento coraggioso e degno di ispirare la stima ed il rispetto più profondi a qualsiasi uomo, fosse anche l’avversario più accanito della sua ideologia, poiché Dostojevskij, con la rinuncia ai facili e ricattatori stratagemmi narrativi, rischia sempre sulla propria pelle (come si vedrà in special modo a proposito della “Spiegazione necessaria” di Ippolit), gettando nel crogiolo della verifica romanzesca i suoi valori al pari di quelli che respinge.
Siamo giunti finalmente a parlare delle idee cardine di Dostojevskij: “L’idiota”, al pari di tutti i grandi romanzi dostojevskijani, è fatto di idee, in misura largamente superiore a quanto è dato verificare in qualsiasi altra opera della letteratura moderna. Eppure qui nulla è astratto, teorico, speculativo, ma le idee si compenetrano sempre in situazioni reali (anche se, richiamando quanto detto più sopra, non necessariamente realistiche) e personaggi in carne ed ossa. Il problema di Dio, che percorre sotterraneamente, come un fiume carsico che appaia solo raramente in superficie, tutte le pagine de “L’idiota”, non ha nulla di teologico o dottrinale, ma è un problema rovente e incalzante, che condiziona gli uomini in ogni minimo frangente della loro vita, anche quando essi si sforzano di ignorarlo o di nasconderlo. Innanzi tutto, Dio, o meglio quella sua ipostasi che è il Cristo dei Vangeli, informa totalmente di sé il modo di essere del principe Myskin.
Myskin è un personaggio profondamente cristiano: in lui i precetti etici del cristianesimo non sono vuote formule teologiche, ma inderogabili norme di condotta. Se esaminiamo con attenzione la sua personalità, ci accorgiamo che la sua esistenza è una continua provocazione al mondo circostante. Egli è un semplice, indifferente alla propria condizione fino al totale oblio di sé, mentre intorno a lui tutti sono accecati dall’amor proprio e si accaniscono ferocemente nel tentativo di far trionfare la loro egoistica individualità; egli ha una fiducia cieca negli altri, anche quando appare evidente che essi ordiscono trame e complotti a sua insaputa, spesso a suo danno; è sincero fino al masochismo e al sacrificio, incapace com’è di mentire per il proprio tornaconto; la sua intelligenza non è legata alle leggi fondamentali di causalità e non contraddizione e alle regole della morale, ma è l’intelligenza del sentimento, quella che Aglaja definisce l’intelligenza primaria in contrapposizione a un’intelligenza secondaria comune alla maggior parte degli uomini. Myskin dà scandalo, ma non perché sia uno sciocco o uno sprovveduto (anche se gli altri in molte circostanze lo credono), bensì perché egli non vive secondo le norme e le convenzioni sociali, perché dalla sua esistenza sono esclusi i principi generalmente accettati dal mondo: tratta alla pari le persone a lui inferiori per età o per rango (i bambini, il domestico di casa Epancin), non capisce la necessità di affrontarsi in duello per dirimere le controversie, e tutto ciò lo fa senza sforzarsi, senza costringersi ad obbedire a tutti i costi a un comandamento o a un obbligo morale, ma in maniera del tutto naturale e spontanea. Myskin ha nel romanzo una funzione straniante, in quanto con la sua totale diversità (non a caso, egli si considera ed è considerato uno straniero) "defamiliarizza” la realtà costituita, squarciando il velo della sua falsa apparenza.
Alla luce di ciò che si è or ora detto, non stupisce che le persone più vicine al principe Myskin siano i fanciulli, poiché essi sono privi di malizia e di falso orgoglio e il loro animo non è ancora corrotto dall’esperienza né rattrappito in una ortodossia di giudizi e di impressioni. In occasione del suo soggiorno in un piccolo villaggio svizzero, l’influsso che Myskin esercita su di loro viene ipocritamente osteggiato e bollato come malsano dai gretti simboli dell’autoritarismo sociale (i genitori, il pastore, il maestro), ma sono proprio i bambini gli unici a mostrare un barlume di autentica umanità nei confronti di Marie, la povera pastorella tisica, ripudiata ed emarginata dal bigotto moralismo della piccola comunità. Myskin non si vergogna di apparire a sua volta un fanciullo e al giovane amico Kolja confida, con candido stupore: «Come siamo ancora bambini, Kolja! e.. e.. che bella cosa esser bambini!».
Myskin dovrebbe essere, nelle intenzioni dell’autore, un essere asintotico alla condizione spirituale perfetta, quella che si sostanzia nel comandamento di Cristo di amare gli uomini come se stessi. In alcuni passi del quaderno di appunti di Dostojevskij, troviamo scritto che “il supremo e ultimo sviluppo della persona deve appunto giungere a far sì che l’uomo trovi, capisca e con tutta la forza della sua natura si convinca che il supremo uso che può fare del proprio io è, in un certo senso, distruggere questo io, darlo interamente a tutti e a ciascuno anima e corpo e senza riserve… Tutta la storia sia dell’umanità, sia anche di ognuno singolarmente preso, è soltanto sviluppo, lotta, aspirazione e raggiungimento di questo fine”. Questa è la grande utopia de “L’idiota”, una utopia etica che il principe Myskin persegue con abnegazione e che vuol prendere le distanze dall’utopia politica del socialismo.
Anche ne “L’idiota” Dostojevskij non manca di attaccare duramente i nichilisti, sebbene questa polemica non costituisca, come ne “I demoni”, il motivo centrale del romanzo. La rievocazione dell’eccidio della famiglia Zemarin da una parte, e l’episodio di Burdovskij, che Doctorenko e i suoi compagni strumentalizzano in maniera ignobile, dall’altra, svelano quelli che per l’autore sono gli imperdonabili errori delle dottrine socialiste del tempo: l’intransigenza ideologica e l’esclusione del diritto di scelta (una posizione che all’incirca si riassume così: “solo noi siamo nel giusto e tutti coloro che non la pensano allo stesso modo sono nemici da combattere"), l’arbitraria manipolazione delle argomentazioni a sostegno delle proprie tesi (Doctorenko e i suoi amici ricusano sdegnosamente ogni manifestazione di gratitudine, ma poi, come intuisce Lizaveta Prokofevna, fanno leva proprio su questa per indurre Myskin a soddisfare le pretese di Burdovskij) e infine il sacrificio dell’interesse individuale a vantaggio di quello collettivo. Ma la conseguenza più aberrante cui le teorie liberali, non supportate da solide fondamenta etiche, conducono è il trionfo del diritto della forza, cioè, come si esprime Evgenij Pavlovic, del “diritto del pugno individuale e dell’arbitrio personale”, partendo dai quali è quasi inevitabile giungere al “diritto delle tigri e dei coccodrilli”. Persino un essere meschino come Lebedev se ne rende conto, quando afferma di non credere agli strumenti del progresso che dovranno assicurare la felicità del mondo, “giacché codesti carri che portano il pane all’umanità, ove all’agire manchi una base morale, possono con perfetto sangue freddo escludere dal godimento di ciò che portano una parte cospicua del genere umano”. E lo stesso principe Myskin non può non riconoscere che il diffuso pervertimento delle idee spinge molti giovani a commettere orrendi delitti nella presunzione, che potremmo definire raskolnikoviana, di avere tutto il diritto di comportarsi così, quasi che a legittimarli, rendendo il delitto “naturale” e “necessario”, fosse sufficiente una situazione di diffusa ingiustizia sociale.
La problematica religiosa de “L’idiota” non si esaurisce nella contrapposizione con le teorie socialiste e liberali, la cui fallacia, come si è appena visto, è dimostrata in maniera annichilente. In antitesi a Myskin e al suo amore cristiano, Dostojevskij ha infatti messo anche Ippolit e la sua ribellione. Con Ippolit fa scopertamente il suo ingresso la morte, la cui presenza, sotto forma di funesti presagi (come l’inquietante leit motiv del coltello) e di dolorosi ricordi, percorre il romanzo fin dalle prime pagine. Ippolit infatti è tisico e sa di dover morire in breve tempo (glielo ha rivelato uno studente universitario “materialista, ateista e nichilista”). Una penosa situazione di impotenza, di solitudine, di invidia e di orgoglio represso, lo induce a scrivere, e poi a leggere di fronte a un uditorio numeroso ed eterogeneo accorso in casa del principe per festeggiare il suo compleanno, la sua “Spiegazione necessaria”. In questo freddo eppur straziante addio alla vita, in questa confessione insieme esaltata e lucidissima, Ippolit sviluppa e porta alle estreme conseguenze una singolare filosofia materialistica dell’uomo, della natura e della religione, che lo apparenta per molti aspetti ad altri importanti personaggi dostojevskijani, come Kirillov e Ivan Karamazov.
Questa filosofia è compendiata dal terrificante sogno dello scorpione: Ippolit sente la natura come una “bestia enorme, implacabile e muta”, o meglio come una “mastodontica macchina di nuovissima costruzione” che tutto afferra, stritola e inghiotte insensatamente. Una simile concezione della natura, solo apparentemente delirante, in realtà piena di complessi risvolti psicanalitici, non porta Ippolit ad escludere automaticamente l’esistenza di Dio, sebbene egli poi proclami di non sottomettersi ad alcuna forza soprannaturale (“Non riconosco alcun giudice sopra di me”). Ippolit si sforza di negare il mistero, quel mistero che, sia pure in forma provocatoria ed angosciante, emerge anche dalla tela del “Cristo morto nel sepolcro” di Holbein il Giovane, ma la negazione, si sa, è già in qualche modo una affermazione. Difatti alla fine Dio svela a Ippolit il suo volto, che non è quello misericordioso dei Vangeli e neppure quello terribile ma giusto dell’Antico Testamento, bensì quello, spietato e crudele, di padre che provoca dolore ai suoi figli. “La vita eterna io l’ammetto e, forse, l’ho sempre ammessa. Che la coscienza si sia accesa in noi per la volontà di una forza superiore, abbia gettato uno sguardo al mondo circostante ed abbia detto: “io sono”, e che poi tutt’a un tratto quella stessa forza suprema le ordini di annientarsi, perché così è necessario lassù per qualche scopo - e anche senza spiegare per quale -, tutto questo io l’ammetto, ma ecco di nuovo l’eterna domanda: che bisogno c’è, per giunta, della mia rassegnazione? Non mi si può divorare semplicemente, senza pretendere da me delle lodi a ciò che mi divora? Possibile che lassù qualcuno si senta veramente offeso perché io non voglio pazientare quindici giorni?… Chi dunque, dopo tutto questo, mi giudicherà, e per quale colpa? Sia come volete, ma tutto ciò è assurdo e ingiusto… Ma se tutto ciò è così difficile, anzi assolutamente impossibile a capirsi, sarò forse responsabile di non essere in grado d’intendere quello che è incomprensibile?… Se fosse stato in mio potere di non nascere, certo non avrei accettato l’esistenza a condizioni tanto derisorie…”.
C’è un involontario parallelismo tra la malattia di Ippolit e la esecuzione capitale raccontata in inizio di romanzo da Myskin. Questi riconosce, con uno sdegno che è umanista prima ancora di essere cristiano, che la pena di morte è una punizione di gran lunga peggiore del delitto commesso, ma, utilizzando lo stesso metro di giudizio, si potrebbe facilmente, e in maniera quasi inoppugnabile, arrivare a sostenere la spietatezza di un Dio che condanna a morte un giovane nel fiore degli anni. E’ una crudeltà che nessuna armonia futura può legittimare. L’uomo, che è essere corporeo e limitato, non può infatti accettare una immensa ingiustizia terrena in nome di una incerta ricompensa futura. E’ assurdo d’altronde attribuire a Dio il diritto di una suscettibilità tipicamente umana e addossare contemporaneamente all’uomo l’obbligo di sottomettersi a una fede irrazionale che è al di là delle sue facoltà di comprensione. L’unica risposta che Ippolit è in grado di dare è il suicidio come estremo atto di volontà: “Non muoio già perché mi manchi la forza di sopportare questi venti giorni… La natura ha talmente limitato la mia attività col suo termine di venti giorni, che il suicidio è forse l’unico atto che io possa ancora cominciare e finire di mia volontà. E se io volessi approfittare della mia ultima possibilità di agire? La protesta, a volte, non è poca cosa…”.
Anche se il tentativo di suicidio di Ippolit finisce in farsa e sotto sotto egli stesso cerchi null’altro che il bel gesto, l’ammirazione degli altri e la consacrazione della sua speranza di essere un grand’uomo (“sognai che tutti di colpo mi avrebbero aperto le braccia per stringermi in un amplesso e mi avrebbero chiesto perdono”), la forza della sua confessione rimane intatta, contrapponendosi specularmente alla disponibilità di Myskin verso la fede. Ancora una volta a risaltare è il carattere problematico della fede, la dissociazione profonda tra sentimento religioso e razionalità. Diversamente da Kierkegaard, che nell’episodio di Abramo e Isacco vede pur sempre una fede consapevole ed elevata, coerente fino al sacrificio supremo, Dostojevskij intende la fede come qualcosa di assolutamente estraneo alla logica e alla morale, spesso addirittura coesistente con il rifiuto, rozzo e bestiale, di ogni legge umana. Il significato della fede dostojevskijana è espresso molto bene nei quattro episodi che Myskin racconta a Rogozin, dall’ateo colto ed educato che, parlando di Dio, ha l’aria “di parlare di tutt’altro”, al contadino che uccide il compagno “recitando tra sé una triste preghiera”, al soldato ubriaco che vende la sua croce per andarsela a bere in osteria (“Non voglio affrettarmi a condannare questo venditore di Cristo. – dice Myskin – Iddio sa quel che si nasconde in questi deboli cuori di ubriaconi”), fino ad arrivare all’umile donnetta col lattante, in cui si può cogliere addirittura l’essenza del cristianesimo, cioè “la nozione di Dio come nostro vero padre e della gioia di Dio davanti all’uomo come gioia del padre davanti al figliol suo: il pensiero fondamentale di Cristo”. Si può affermare, citando ancora le parole di Myskin, che “l’essenza del sentimento religioso è indipendente da qualsiasi ragionamento, da qualsiasi colpa o delitto, da qualsiasi ateismo; c’è in esso qualche cosa di indefinibile, e ci sarà sempre; qualche cosa che sempre gli atei sfioreranno appena, discorrendo sempre di tutt’altro”.
Il problematicismo che si riscontra nella fede è fors’anche la caratteristica principale di tutto il romanzo. Dostojevskij è un vero e proprio psicanalista ante litteram e analizza gli atti e i pensieri dell’uomo nella sua inesauribile molteplicità dei loro significati. Gli stessi valori di bene e male, di onestà e delitto, di virtù e vizio, di amore e odio divengono nozioni fluide e problematiche, perdendo la loro fissità dogmatica. Ciò che appare bene, a uno sguardo più attento si rivela spesso nient’altro che filisteismo morale, mentre per converso il male è a volte più umano di quel che si pensa.
Questo problematicismo lo si riconosce nella stessa personalità del protagonista, specialmente in quel suo continuo rimproverarsi di essere posseduto da “doppi pensieri” (ad esempio, avere una smodata fiducia nel prossimo e contemporaneamente una ineliminabile diffidenza), oppure nella sua convinzione di non essere in grado di esprimere i pensieri e i sentimenti che possiede nell’animo in parole che possano guidare e aiutare le persone intorno a lui. Myskin rivela, con il trascorrere del tempo, degli aspetti imprevedibili, avvalorando addirittura la tesi di una clamorosa, ma non impossibile, identità con l’antagonista Rogozin. Myskin e Rogozin sembrano l’uno il contrario dell’altro: per il primo l’amore è prevalentemente compassione, per il secondo è passionalità sfrenata; il primo ha una fede semplice e spontanea, il secondo l’ha persa da tempo e lotta furiosamente con sé stesso per riconquistarla; il primo dirige indifferentemente i propri pensieri e sentimenti verso una schiera potenzialmente infinita di soggetti, il secondo ha un’unica, maniacale, idea fissa per cui vivere: Nastasja Filippovna; il primo è spiritualità, il secondo è carnalità; e si potrebbe proseguire oltre. Apparentemente antitetici, Myskin e Rogozin sono in realtà complementari, due facce della stessa medaglia. Come afferma Ippolit in un passo del romanzo, “le estremità si toccano”, e Dostojevskij lo sottolinea a più riprese sovrapponendo i due personaggi nei principali snodi narrativi (l’arrivo in treno a Pietroburgo, l’amore per Nastasja Filippovna, la quale oscilla freneticamente tra i due, lo scambio delle croci, l’assassinio), fino a dar loro un destino comune. Psicanaliticamente, Rogozin è il doppio di Myskin: gli occhi nella folla da cui il principe si sente continuamente osservato fanno vagamente pensare al poeiano “William Wilson”, mentre il morboso e patetico abbraccio nel cuore della notte fatale sembra sancire il definitivo annullamento dell’uno nell’altro. Non è un caso che Rogozin sia all’origine dei “doppi pensieri” del principe: avendo quest’ultimo, nel corso della prima visita, sospettato Rogozin capace di ucciderlo, egli sente di dover scaricare dalle spalle del compagno (e addossare invece sulle proprie) ogni colpa e responsabilità.
L’esistenza di personaggi come Myskin e Rogozin non è che un’ulteriore, irrefutabile prova di come la personalità dell’uomo sia problematicamente complessa e al tempo stesso insufficientemente sviluppata. Se solo Myskin possedesse qualcuna delle indubbie qualità di Rogozin, probabilmente il romanzo non finirebbe in tragedia. La luttuosa conclusione de “L’idiota” non è infatti altro che la conferma del fallimento esistenziale del suo protagonista, troppo angelico per essere uomo fino in fondo. Molteplici sono invero i limiti e i difetti del principe Myskin ad una analisi non superficiale del personaggio. Egli è abulico e passivo (ma è quasi una legge di natura che quanto più è elevato il grado di un valore tanto più debole è la sua affermazione nel mondo della realtà immediata), compiange tutti senza consolare nessuno (lo ricordiamo come presenza muta e impotente di fronte ai drammi di Ippolit prima e di Rogozin poi), è incapace di dare giudizi discriminanti, distinguendo nettamente tra bene e male. Nella scena del drammatico incontro tra i due grandi, titanici, personaggi femminili del romanzo, Nastasja Filippovna e Aglaja Ivanovna, Myskin sta in mezzo a loro come una marionetta succube e priva di volontà: se finisce col respingere Aglaja e scegliere Nastasja è solo perché quest’ultima gli sviene tra le braccia, ma ovviamente non riesce poi a fare felice neppure lei. Il suo amore è grande, ma incorporeo ed esangue, è compassione più che amore carnale, è in fin dei conti non-amore, proprio perché è universale e si indirizza indistintamente a più persone senza fermarsi su una sola di esse. Al pratico e positivo Evgenij Pavlovic che gli obietta perplesso di non poter amare veramente Nastasja Filippovna, Myskin risponde: “«Oh no! io l’amo con tutta l’anima!..». «E nello stesso tempo assicuravate Aglaja Ivanovna del vostro amore?». «Oh sì, sì!». «Ma come? Vorreste dunque amarle tutt’e due?». «Oh sì, sì!»”.
La smaniosa brama di redimere e fare del bene che caratterizza il principe Myskin non è la vera via d’uscita dalla tragedia dell’uomo: in un certo senso, i veri eroi positivi del romanzo sono personaggi umili e secondari, come Evgenij Pavlovic e Vera Lebedeva, i quali sanno stare al loro posto senza aver l’ambizione di cambiare il mondo. “Non è facile trovare il paradiso in terra, - dice saggiamente il principe Sc. a Myskin – e voi ci fate proprio un po’ di assegnamento: il paradiso è una cosa difficile, principe, molto più difficile che non paia al vostro ottimo cuore”. Di questa difficoltà, Dostojevskij è pienamente consapevole, ma è lungi da lui il pensiero di trarre da questa constatazione la drastica deduzione che il cristianesimo ha fallito il suo scopo. I vari principi Myskin che si sono succeduti nel corso dei secoli non sono riusciti – è vero – ad attuare l’ideale di fratellanza universale che era l’insegnamento di Cristo, ma è altrettanto vero che questo ideale non è di questa terra e potrà affermarsi – e la sublime utopia dostojevskijana realizzarsi con pienezza – solo nel regno eterno dell’aldilà.
Indicazioni utili
Commenti
| 10 risultati - visualizzati 1 - 10 |
Ordina
|
Hai ragione sul fatto che "L'idiota" sarebbe da leggere più di una volta nella vita, anche se io provo una grande nostalgia per la lettura adolescenziale di questo libro, così importante e decisiva per la formazione culturale di una giovane mente.
| 10 risultati - visualizzati 1 - 10 |

























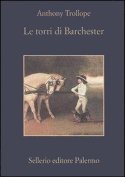





E' un libro che mi piacerebbe rileggere.