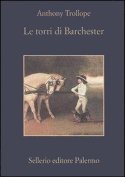Dettagli Recensione
La verità dell'arte
“Alla ricerca del tempo perduto” del francese Marcel Proust è sicuramente una di quelle opere che non ha bisogno di presentazioni: le sue quasi quattromila pagine, del resto, non passano inosservate. Ma ciò che ha reso famoso il romanzo di Proust è sicuramente la luminosità che promana dalle immagini, dalle tortuose vicende, dai colori, dalle riflessioni, dalle sofferenze, dalle nostalgie e persino dai momenti morti che punteggiano questo labirinto d’inchiostro.
Quando, più di un anno fa, iniziai a leggere quest’opera, regalatami da alcuni dei miei più cari amici, ero convinto di essere alle soglie di un cammino che mi avrebbe prima o poi condotto a un prezioso tesoro, al senso della vita, alla formula per la felicità, a un qualcosa al cui confronto la pietra filosofale ricercata dagli alchimisti e la prova dell’esistenza di Dio dei logici medievali sarebbero stati ben poca cosa. Ma dopo aver terminato questa faticosissima impresa, sento di non aver nulla fra le mani, sento soltanto un vuoto che ha preso il posto di tutti quei personaggi a cui mi ero affezionato, come la vivace Madame de Guermantes o l’acuto Swann, e che non affollano più la mia mente. Quegli ampollosi nomi francesi, sulla cui pronuncia sono sempre stato incerto, già cominciano a sgretolarsi e a piombare nell’oblio. Un piccolo universo si era schiuso, più di un anno fa, ed ora è scomparso, trascinandosi dietro stelle e desolati pianeti, di cui permangono, nel vuoto, soltanto tenui vestigia, conservate dalla memoria.
Non ho ottenuto la formula della felicità, ma almeno ho imparato a farne a meno. E questo perché la felicità, così tanto bramata, non “ha quasi che un’unica utilità; rendere possibile l’infelicità”. “Occorre – scrive Proust nell’ultimo dei sette libri che compongono l’opera magna– che nella felicità si formino legami forti e dolci, di fiducia e tenerezza, affinché la loro rottura ci susciti quella lacerazione così preziosa che si chiama infelicità. Se non fossimo stati felici, non foss’altro che a causa della speranza, le sventure sarebbero prive di crudeltà e di conseguenza resterebbero infruttuose”. Proust è, dunque, un masochista che fa propaganda della sua aberrante filosofia di ricerca del dolore? Del resto non è da tutti dedicare interamente la propria esistenza alla descrizione minuziosa di amori travagliatissimi, come quello del protagonista del romanzo con l’esuberante Albertine, che lo tradisce con delle ragazze, dominati da quel “mostro dagli occhi verdi” che prende il nome di gelosia.
In realtà Proust è semplicemente realista: l’infelicità è ciò che ci rende umani. Già Leonardo da Vinci intuì, secoli fa, che il tratto che distingue le piante dagli esseri animati è la sofferenza, che permette a questi ultimi di scampare alle minacce e che permette di elaborare strategie di auto-difesa. La sofferenza è la molla che porta l’animale, soprattutto se circondato da altri (l’istrice schopenhaueriano si ferisce accanto agli altri della sua specie) e ancor di più l’uomo, questa scimmia nuda e indifesa, ad evolversi, ad arricchirsi di esperienze, a ricercare, a plasmarsi. La sofferenza è, per Proust, all’origine dell’introspezione (soffrire è alla fine un domandare a se stessi) e, dunque, all’origine dell’arte: perché l’arte non è che il rituale attraverso cui evocare il proprio spirito, quello a cui solo l’evoluzione del dolore dà solidità, mentre gli altri, come Albertine, mutano continuamente volto, ed è addirittura l’unico modo che ci è permesso per comunicare. “Ma allora, questi elementi, tutto questo residuo reale che siamo costretti a tenere per noi stessi, che non è nemmeno possibile trasmettere conversando tra amici, tra maestro e discepolo, tra due amanti, quest’ineffabile che differenzia qualitativamente ciò che ognuno di noi ha sentito e che è costretto a lasciare alla soglia delle frasi, dove non può comunicare con gli altri se non limitandosi a dei punti esteriori comuni a tutti e senza interesse, non è forse l’arte […] che lo mette in luce, esteriorizzando nei colori dello spettro la composizione intima di quei mondi che chiamiamo gli individui, e che senza l’arte non conosceremo mai?”. Ma per giungere alla verità dell’arte, alla verità del romanzo, Marcel (il protagonista dell’opera ha lo stesso nome dell’autore) ha dovuto compiere un tormentato calvario ora lungo la strada di Guermantes, fatta di strepiti mondani, mancanza di empatia (alla fine del terzo libro i signori di Guermantes non provano alcunché di fronte alle sofferenze del loro amico Swann, in procinto di morire), snobismo e vizio, ora lungo la strada di Swann, la strada dell’amore, all’apparenza rosea, costeggiata da fiori di biancospino, ma in realtà butterata dei segni implacabili del vizio e della menzogna. Soltanto questo lungo itinerario fatto di sofferenze lo porta alla verità dell’arte, alla decisione di scrivere un romanzo: è il ricordo di questo percorso tutto umano, intriso del vermiglio del dolore, rievocato ora dalla pietra su cui inciampa prima di recarsi dai Guermantes dopo tanto tempo e ora dal rumore di una posata sul piatto, che lo spinge a scrivere.
Ho percepito nel non credente Proust una sorta di nostalgia del cattolicesimo: il primo capitolo di “Dalla parte di Swann”, il primo volume, incentrate intorno all'infanzia del protagonista, vissuta a Combray, sono quelle più vivide, più colorate (indimenticabile la descrizione delle ninfee che il piccolo Marcel ammira), sebbene l’ombra della sofferenza sia sempre presente (emblematica l’affannosa ricerca del bacio materno), hanno un perno centrale, che è la cattedrale di Combray, che svettante domina e rassicura. Nel mondo che ha fatto a meno di Dio, invece, quello della mondanità aristocratica e borghese (soltanto M. Charlus è un fervente cattolico ed è ambiguamente al tempo stesso il più vizioso di tutti e la vittima sacrificale dell’alta società), pullulano gli idoli del nome, della reputazione, delle mode, della competizione. Ma è il tempo, che tutto può e che, alla conclusione del libro, è allegorizzato dalla figura di un vescovo che si trascina con al collo la croce, a disvelare la religione fasulla imbastita meschinamente: le matinée dei nobili, i quali, una volta, a teatro, erano apparsi a Marcel come delle divinità marine, abbondano di arrivisti e borghesi camuffati, mentre i nobili stessi, consunti dall’età e i cui volti sono anticipazione della morte, hanno perso ogni densità ontologica. Il dolore e il tempo, che sono così centrali nella teologia cattolica, sono le verità che la letteratura proustiana fa riaffiorare in tutta la loro grandezza.
Indicazioni utili
Commenti
| 7 risultati - visualizzati 1 - 7 |
Ordina
|
| 7 risultati - visualizzati 1 - 7 |