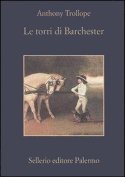Dettagli Recensione
Il doppio straniamento del formalista Šklovskij
E’ uno strano destino quello di Zoo o Lettere non d’amore di Viktor Šklovskij su internet: l’autore dichiara espressamente nel titolo ciò di cui il libro non parla, eppure la maggior parte delle recensioni (per la verità numerose) che si trovano in rete scritte da chi lo ha apprezzato, dalle più concise a quelle più analitiche, lo considerano uno dei più bei libri d’amore mai scritti, e molte si affannano (anche sulla base di indizi disseminati dall’autore nel corso del tempo) a cercare di capire se Alja, la destinataria delle lettere di cui si compone il libro, sia esistita davvero e chi fosse.
Credo che da un lato queste recensioni, questa caccia al tesoro nascosto sarebbero piaciute a Šklovskij, al suo amore per lo straniamento, ma dall’altro lo avrebbero fatto ironicamente sorridere della sua capacità di avviluppare molti lettori, grazie alle capacità evocative della sua prosa fatta di frasi brevi ed essenziali come versi, in una sorta di doppio straniamento, del quale le singole parti, annullandosi vicendevolmente come in un gioco di specchi, riportano alla semplicità ed alla evidenza della dichiarazione programmatica che è scolpita nell’introduzione alle Lettere, laddove Šklovskij scrive: E io vorrei scrivere come se non ci fosse mai stata letteratura. Scrivere, per esempio: “Stupendo è il Dnepr, quando il tempo è sereno”. Non posso: l’ironia si mangia le parole.
Šklovskij, il formalista Šklovskij, vuole, deve scrivere della cultura russa, della rivoluzione, della vita degli emigrati a Berlino, della loro nostalgia e del loro rapporto quasi edipico con la madrepatria: vuole però farlo da letterato, non da cronista. Ricorre quindi ad un topos classico della letteratura ottocentesca, quello del romanzo epistolare tra un uomo ed una donna da lui amata. Devia quindi la nostra attenzione di lettori, facendoci credere che parlare di letteratura, di emigrazione, di Russia e di rivoluzione sia il ripiego dell’innamorato cui è stato proibito, dalla donna che gli sfugge ed è visibilmente seccata dalle sue insistenze, di parlare d’amore. Senonché è lo stesso Šklovskij a dirci che parlare d’amore, riprendere i cliché della letteratura antecedente è ormai impossibile, perché l’ironia si mangerebbe le parole. L’amore del protagonista per Alja è quindi semplicemente un vestito finto, la maschera di carta nera che Šklovskij si trova in mano nel cuor della notte, che solo indossata gli permette tuttavia di scrivere della sua vita berlinese, dei tempi di cui è testimone. E così si torna al punto di partenza: le Lettere sono non d’amore perché parlano d’altro, anche se è necessario che l’opera d’arte per essere tale abbia una forma, una struttura determinate, accettate e riconoscibili.
Questa forma, nell’edizione Einaudi da me letta, è fatta da ventitré lettere, da una Epigrafe e da una Introduzione. Ciascuna Lettera ha una sua precisa fisionomia: molte sono dedicate al ritratto di alcuni dei più importanti esponenti della intelligencija russa espatriati dopo la rivoluzione; altre analizzano in generale il rapporto tra la cultura russa e quella occidentale, altre ancora sono quasi dei piccoli saggi sul rapporto tra l’uomo e le macchine, nell’epoca in cui si delinea il dominio di queste ultime e il tentativo rivoluzionario di emancipazione dell’umanità, rispetto al quale – almeno nella sua forma realizzata – Šklovskij nutre più di un dubbio, non essendo bolscevico, anzi avendo partecipato anche ad attività contro il governo dei soviet (all’epoca simpatizzava per il partito Socialista-Rivoluzionario).
Senza nulla togliere alle lettere centrate su singoli personaggi – alcune – come quelle che parlano di Chagall, di Pasternak o di Ivan Puni sono molto belle e abbozzano la loro personalità anche in relazione alle radici culturali da cui provenivano – credo che le Lettere più interessanti ed importanti in un’ottica critica siano proprio quelle di carattere più generale rispetto al clima sociale e culturale vissuto da Šklovskij ed alle sue convinzioni rispetto al ruolo dell’intellettuale in tale clima.
Da questo punto di vista credo che una delle Lettere più importanti sia la Lettera introduttiva, non a caso Diretta a tutti, a tutti, a tutti. Tema della lettera: le cose rifanno l’uomo. In essa Šklovskij dichiara il suo amore per la velocità e l’automobile, riprendendo un motivo tipicamente futurista. L’automobile tra l’altro è stato il vero motore della rivoluzione, perché ha permesso che si diffondesse rapidamente e che avesse successo. Tuttavia Šklovskij, proprio analizzando il ruolo anche simbolico che l’automobile ha poi assunto nel paese dei soviet, ci ammonisce sull’effetto che la macchina e la velocità hanno sull’uomo, perché per il solo fatto di essere disponibili devono essere giustificate, e questo trasforma l’uomo che le usa. Dice Šklovskij (così abbiamo anche un esempio della sua poesia in prosa):
L’arma fa l’uomo più coraggioso.
Il cavallo lo muta in cavalleggero.
Le cose fanno con l’uomo ciò che egli fa di esse.
La velocità richiede uno scopo.
Sono parole che denotano una posizione pienamente conscia della contraddittorietà del progresso tecnologico , quasi antitetica a quella acriticamente appiattita sulla sua esaltazione tipica del futurismo e anche dell’immaginario sovietico. Il tema del fascino che la macchina esercita sull’uomo e nel contempo del pericolo che essa rappresenta in quanto fattore di alienazione dei rapporti umani torna anche in altre Lettere, non meno affascinati di questa.
La Lettera terza ci regala una delle metafore più belle dello scrittore, che non può essere agricoltore, e coltivare in ogni stagione lo stesso appezzamento, ma è un nomade, e con la mandria e la moglie passa a nuova erba.
Bellissima e terribile è la Lettera ottava, nella quale Šklovskij si scaglia contro le futili convenzioni sociali (i pantaloni che devono avere la piega, il modo di mangiare prescritto dalle buone maniere) e, ricordando un episodio biblico e i pogrom ucraini ci ricorda come le diversità culturali siano state spesso nella storia utilizzate come causa sufficiente di orrendi massacri.
La Lettera tredicesima contiene una bellissima descrizione di Berlino, del suo anonimato agli occhi dell’espatriato russo, una città dove non c’è inverno, dove i palazzi escono da un negozio di palazzi in serie. E’ la descrizione di una struggente solitudine, che si contrappone a quelle che in altre Lettere ci fa di Pietroburgo, città dove Šklovskij viveva, ma anche a quelle di altre città tedesche, giudicate più vive, come Amburgo e Dresda.
La Lettera quindicesima è forse quella più importante, perché in essa Šklovskij ci espone compiutamente la sua concezione della letteratura e dell’arte. Leggendola si chiarisce il fondamento teorico della scuola formalista di cui Šklovskij è uno dei più autorevoli esponenti, e si chiarisce anche – nel senso che ho cercato di esprimere sopra, il significato profondo di questo libro, che provocatoriamente è proprio citato come esempio del tentativo di uscire dai limiti del romanzo ordinario congiungendo momenti singoli attraverso la storia dell’amore di un uomo per una donna. Questa concezione dell’opera d’arte come un mondo di cose che esistono in modo autonomo chiaramente entrerà presto in conflitto nella russia staliniana con i dogmi del realismo socialista ma, come lo strutturalismo del secondo dopoguerra si incaricherà di dimostrare e come già questo libro esemplifica splendidamente, possiede una carica rivoluzionaria ed eversiva che non poteva essere sopportata da qualsiasi ortodossia zdanoviana, e proprio per questo ne fu tra le principali vittime.
Il libro prosegue con altre bellissime Lettere cariche di storie, apologhi e considerazioni che riguardano gli argomenti già accennati, sino a giungere alla penultima, l’unica scritta da Alja, nella quale all’autore viene intimato di smetterla di scriverle, e all’ultima, nella quale Šklovskij inoltra al Comitato Centrale la richiesta di poter tornare in Russia. Šklovskij tornò effettivamente in URSS poco dopo, e nonostante i suoi precedenti di antibolscevico vi restò fino alla morte nel 1984.
Nello stesso periodo in cui Šklovskij era a Berlino, tra i molti emigrati russi vi era Vladimir Nabokov, che sulla sua esperienza scrisse Il dono. Un confronto tra le due opere non può a mio avviso che mettere in evidenza la grandezza intellettuale di Šklovskij rispetto al livore aristocratico di Nabokov nei confronti della nuova Russia. Come detto Šklovskij non era bolscevico, ma ciò non gli impedisce di riconoscere – pur identificandone subito i limiti congeniti (La trazione della rivoluzione è passata dice al termine di una Lettera) – la grande funzione anche simbolica che l’ottobre 1917 ha rappresentato per l’umanità intera. La sua vicenda personale non gli impedisce, a differenza di quanto accade a Nabokov, di vedere la straordinaria energia intellettuale scatenata da quell’evento e dai fatti che l’hanno preceduto e, come detto, tornerà nella sua terra a dare il proprio contributo pur in un contesto che non condivideva e dove correva sicuramente dei rischi, dimostrandosi anche in questo più grande dell’autore di Lolita. Del resto il suo formalismo ha come detto uno straordinario contenuto analitico rispetto alla funzione dell’opera d’arte, e non si risolve certo nella astratta e reazionaria arte per l’arte nabokoviana.
Un grande intellettuale, dunque, la cui complessità andrebbe approfondita come antidoto in questi tempi in cui la superficialità di giudizio regna sovrana a tutti i livelli delle relazioni umane e sociali.
Resta infine da spiegare il titolo dell’opera: gli intellettuali russi vivevano per lo più a Berlino nel quartiere dove c’è lo Zoo (Tiergarten). C’è però un sottinteso più profondo, evidenziato dalla poesia di Velemir Chlebnikov posta da Šklovskij in epigrafe all’opera: la solitudine e l’isolamento dei russi a Berlino, attorniati da una cultura in cui non si riconoscevano, era paragonabile alla condizione degli animali nello zoo cittadino.


 Opinione inserita da viducoli 18 Mag, 2016
Opinione inserita da viducoli 18 Mag, 2016