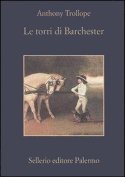Dettagli Recensione
impressioni sul castello
Il castello è l’opera più complessa e poliedrica di Franz Kafka, il suo testamento letterario. La trama essenziale (dopo un viaggio “senza fine” l’agrimensore K giunge in un villaggio troneggiato, è importante che la parola rimanga in un contesto avalutativo, da un grande castello, situato su una collina, apparentemente irraggiungibile; la sua chiamata si rivelerà un errore dell’infallibile macchina burocratica che struttura il misterioso castello, forse per questo motivo il protagonista viene accolto dalla popolazione come uno straniero da cui tenersi alla larga) è lo scheletro su cui si sviluppa una prosa stratificata dal punto di vista contenutistico, allusiva ed aperta ad un’infinità di significati (secondo Benjamin anche soggettivi) e di un teatro simbolico e filosofico su cui si muovono personaggi straordinariamente ardui. L’incipit è notevole: “Era sera tarda quando K arrivò. Il paese era sprofondato nella neve. Il colle non si vedeva, nebbie e tenebre lo circondavano, non il più debole chiarore rivelava il grande castello. K sostò a lungo sul ponte di legno che dalla strada maestra conduceva al paese e guardò su nel vuoto apparente”. Secondo un celebre schema di lettura, la struttura del romanzo si avvolge su due possibili ‘vie’ che K può scegliere di percorrere: la prima consiste nell’integrarsi nella comunità, in questo senso risulta al protagonista particolarmente utile il fidanzamento con Frieda, fino a scomparire, con la consapevolezza della perdita di ogni possibilità e speranza di entrare in contatto con il castello, nel tentativo di capire e legittimare la propria chiamata; l’altra consiste nel misurarsi direttamente con il castello, e soprattutto con i suoi funzionari. Ed il romanzo segue la battaglia inutile che K intraprende per riuscire a spezzare l’aura di densa inviolabilità che ammanta l’edificio e chi ci lavora. Ciò che tiene viva la speranza del protagonista sono alcuni messaggi inviati dal funzionario Klamm, una delle grandi autorità del castello, che tuttavia vogliono dire tutto e niente, da una parte assicurano a K che presto potrà cominciare i lavori di agrimensura, dall’altra gettano ancora più ombra sul suo incerto futuro. I personaggi che popolano la narrazione sono memorabili, su tutti aleggia il fantasma di Klamm, la personificazione delle spirali burocratiche del castello, personaggio che non compare mai (solo una volta viene osservato dallo spioncino di una porta da K, nel suo forse perenne immobilismo) ma è ovunque, su tutto il paese ed in ogni casa, arrivando a determinare le decisioni degli abitanti; eppure K non arriverà mai a parlare con lui. È certamente un personaggio allegorico, appunto allegoria, assieme al messaggero Barnabas (che ha l’ordine di recapitare a K le sue inutili lettere) dell’incomunicabilità del potere, delle parole e dell’esistenza, chiuse su se stesse ed impenetrabili; Frieda invece, oltre che fidanzata di K, precedente amante di Klamm, è un personaggio notevolmente complesso, che acquista spessore ed ambiguità mano a mano che la storia procede, rappresenta parzialmente, assieme ai due aiutanti che il castello ha messo a disposizione a K, la sordida essenza della sessualità, che è per Kafka bassa espressione dell’animalità e contaminazione dell’amore, anche se nutre per K una fedeltà snaturata e purissima, e tuttavia verso la fine abbandona il protagonista per uno dei due aiutanti; e nelle ultime pagine del romanzo, con un processo di analisi psicologica impressionante, tramite le parole dell’ingenua Pepi, Kafka insinua il dubbio circa l’onestà ed il disinteresse della sua angelica e demoniaca persona. Il vertice dell’incarnazione del tema della colpa ed inconciliabilità con il mondo è rappresentata da Amalia, sorella di Barnabas, schiacciata (ricorda a tratti, anche se il paragone è imbarazzante, Giuseppe K) dalla condanna implicita, nell’indifferenza di tutti, per una definitiva onta con cui aveva macchiato il suo nome anni addietro. Il romanzo è incompiuto, la narrazione si interrompe bruscamente, facendo precipitare nell’indeterminatezza, che appare come naturale prosecuzione di quell’inquietudine frustrata, di incolmabile distanza che separava K dal castello, che non raggiungerà “né oggi né un’altra volta”, la vicenda; forse Kafka aveva creato un’opera infinita, un’allegoria della società e dei rapporti umani (personalmente l’interpretazione teologica che vede il castello come simbolo della grazia divina non la trovo convincente) per cui non può esistere una conclusione. K è la più riuscita espressione dell’uomo kafkiano, più del famoso Samsa della Metamorfosi, oscuro e senza passato, alle prese con una lotta inutile, ogni cui sforzo è vano e si spezza dinanzi ad un divinità immobile ma non ostile, pigramente indifferente, come l’architettura che sorregge l’edificio, attorno cui persiste una specie di perpetuo inverno, il destino (o la condanna) dell’uomo contemporaneo sembrerebbe essere questa: perdersi nella propria invincibile solitudine, in attesa di un segno liberatorio (come nella parabola finale del Processo) che sbricioli la propria condizione, anche se non arriverà mai, essendo ogni cosa vivente e non avviata a sfumarsi fino a non esistere più. O forse la morte fece visita allo scrittore praghese prima che questi terminasse il suo ultimo romanzo, degna conclusione di un lungo percorso narrativo, la cui ultima parola è, come per Musil, il nulla.