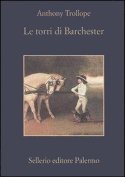Dettagli Recensione
“Io sono, io sono, io sono”
Una certa sensazione di inadeguatezza aleggia fin dalle prime pagine di questo romanzo in buona parte autobiografico, malgrado lo stile leggero e informale che lo caratterizza.
Esther, promettente studentessa della borghesia di Boston, vince insieme ad altre undici ragazze un concorso letterario indetto da una rivista di moda femminile.
Il premio è uno stage di un mese presso la redazione di New York, con la possibiltà di godere gratuitamente di tutto ciò che la megalopoli offre.
La Grande Mela è lì, invitante e caotica, e non riuscire a morderne almeno un pezzo guidando la propria esistenza nella giusta direzione significa essere dei perdenti:
“Ma io non guidavo proprio un bel niente, nemmeno me stessa”.
Nel libro emerge chiara la condizione ambigua della donna americana degli anni Cinquanta: se da un lato se ne incoraggia l'istruzione invitandola a coltivare le proprie passioni, dall'altro c'è sempre per lei la meta suprema da cui non può prescindere: sposarsi, accudire il marito, avere dei figli.
La sensibilità e l'intelligenza di Esther la portano a respingere ciò che la morale comune le impone e a prendere le distanze dal ragazzo che dovrebbe sposare, cominciando a disprezzarlo dopo un episodio che le rivela la misura della sua ipocrisia.
Il disagio lascia gradualmente il posto ad un vero e proprio malessere: è l'incertezza del futuro, il fatto di non sentirsi attraente, la sostanziale solitudine della ragazza:
“Sentivo le lacrime urgere in me, e lì lì per traboccare come l'acqua in un bicchiere troppo pieno”.
Emblematici il distacco e l'indifferenza con cui le cortesi persone dell'ambiente patinato che la circonda reagiscono al suo pianto, facendola sentire “fiacca e tradita”.
I primi allarmanti segni di alienazione mentale si manifestano poco prima del suo ritorno a casa, sotto forma di strani comportamenti descritti con logica apparente:
“...tenevo il viso immobile e quando dovevo parlare lo facevo attraverso i denti senza muovere il labbro. Veramente non vedevo perché la gente dovesse guardarmi così”.
Esther non riesce più a dormire, mangiare, leggere, ha il terrore di perdere completamente la ragione, ma ciò che le fa soprattutto desiderare di morire è il fatto di non riuscire più a scrivere, lei che sogna di diventare una poetessa.
Tutto le si confonde in testa e le diventa indifferente: “...sarei sempre rimasta là seduta sotto la medesima campana di vetro soffocando nella mia stessa aria viziata”.
La falsità di una società bacchettona e tutte le ferite del passato sembrano attaccarla sotto forma di grigiume, angoscia soffocante, sedute di elettroshock, e il lettore si ritrova dall'altra parte della barricata: quella del malato mentale oggetto di sguardi diffidenti e risatine.
Ma è il dolore di una mente brillante e alienata ciò che spicca su tutto, il bisogno di Esther di trovare un appiglio, qualcuno di cui fidarsi che le tenda una mano nel suo precipitare verso la follia.
“Io sono, io sono, io sono”, è il canto disperato del suo cuore, che la richiama alla vita tutte le volte in cui corteggia la morte.
Guarire significa avere la forza di rassegnarsi, tornare ad apprezzare le piccole gioie quotidiane, dimenticare l'attrazione che esercitano su di lei gli oggetti affilati.
La sua prosa è schietta, la sua poesia disincantata:
“Morire
E’ un’arte, come ogni altra cosa.
Io lo faccio in modo eccezionale.
Io lo faccio che sembra come inferno.
Io lo faccio che sembra reale.
Ammettete che ho la vocazione”.
Indicazioni utili
Commenti
| 6 risultati - visualizzati 1 - 6 |
Ordina
|
| 6 risultati - visualizzati 1 - 6 |