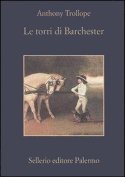Dettagli Recensione
Rivoluzione e controrivoluzione secondo Hugo
Recuperato un fondo di biblioteca, un libro da me restaurato quando ero ancora ragazzo (ovvero tanti anni fa), il Novantatrè di Victor Hugo, l’ho riletto (ne avevo qualche vaga reminiscenza, ma forse non ero riuscito a digerirlo tutto), scoprendo la passione di Hugo per questo momento della rivoluzione francese, sublime e orribile, del terrore, del regicidio, della lotta dei tre titani Robespierre, Danton, Marat: è il 1793, il 93 che dà il titolo al libro. Non so se è un bel romanzo, so che ha dei momenti di grande potenza narrativa alternati a momenti di declamazione retorica, di teatralità un po’ eccessiva e tragica. La materia romanzesca è però interrotta (parte seconda) da una puntigliosa, a tratti quasi elencativa e pedante, ma anche encomiastica, descrizione del momento storico di Parigi: un momento, appunto, di grande turbolenza, di grande tragica bellezza. La rivoluzione, secondo Hugo, è nella sua fase epica: le idee che hanno posto le basi della rinascita dell’uomo e della società, le idee di democrazia e di uguaglianza stanno scuotendo violentemente il vecchio albero del sopruso e del privilegio. Ad uccidere il re è stato il popolo di Parigi, ma alla base del terrore ci sono delle idee che stanno lavorando nell’ombra, per creare uno stato di diritto, per dichiarare l’uguaglianza di tutti gli uomini, liberandoli da tutti i vincoli che li incatenano, a cominciare dalla superstizione e dall’ignoranza.
Superstizione e ignoranza conducono, nel frattempo, le masse contadine della Vandea a ribellarsi alla Rivoluzione, facendosi guidare da coloro che da sempre le hanno sottomesse. Per cui il ‘93 non è solo il momento epico della rivoluzione, ma è anche il culmine della reazione popolare e contadina contro Parigi e il sovvertimento delle tradizioni secolari. Hugo riprende queste contraddizioni e le traduce in vicenda narrativa, attraverso delle figure simboliche. Lantenac, il marchese bretone mandato dagli inglesi a riorganizzare la rivolta contadina per preparare il terreno ad un loro sbarco sul suolo francese, rappresenta i valori dell’aristocrazia: l’eroismo solitario e sdegnoso, il culto della tradizione militare, l’inflessibilità del signore che è abituato a imporre la propria volontà con il proprio prestigio, ma anche con durezza spietata. Di fronte a lui due esponenti della Rivoluzione: Gauvain, suo nipote, ex visconte e comandante di un reparto rivoluzionario molto attivo contro i ribelli, e Cimourdain, un ex prete ed ex istitutore dello stesso Gauvain (che ama come un figlio), mandato dal Comitato di Salute Pubblica a vigilare, che il nipote conduca una guerra senza quartiere allo zio monarchico. Mentre Gauvain rappresenta i puri ideali rivoluzionari e, quindi, ritiene che la Rivoluzione debba essere superiore al vecchio mondo anche dal punto di vista dei valori umani, Cimourdain rappresenta la spietatezza del Terrore, l’inflessibilità fanatica di chi crede in un’idea, per il trionfo della quale ogni mezzo è lecito.
L’intreccio è complesso e colorito: un largo spazio è lasciato al paesaggio bretone, alle sue foreste, nelle cui viscere per secoli gli abitanti si sono nascosti per resistere agli invasori, ai diversi personaggi del popolo, come il mendicante Tellmarch, che vive tra le radici di una vecchia quercia e salva prima il marchese Lantenac e poi una sua vittima, Michelina Flechard, una povera madre fuggitiva con i suoi tre figli, fucilata insieme ai soldati da cui era stata accolta e aiutata. La Flechard è nel romanzo la rappresentante dell’umanità oppressa, vittima della guerra civile, interprete dell’amore materno, dell’innocenza dei suoi bambini. Lei riesce a smuovere, con le sue sofferte urla di madre, il cuore di pietra di Lantenac, costringendolo – per salvare i suoi bambini – a consegnarsi al nemico; provocando poi la tragedia finale: Gauvain, avendo liberato lo zio, viene ghigliottinato al suo posto e Cimourdain si suicida per aver dovuto uccidere la persona che amava di più al mondo.
Vorrei citare qui le parole di Claudio Magris, che parla, in un articolo del “Corriere della Sera” del 17 novembre 1993 , a proposito di questo romanzo, di “affresco grandioso e abnorme, con ingenua elementarita' psicologica deplorata da Flaubert e con toni melodrammatici che fanno sorridere ma testimoniano la sua grandezza, perche' solo un grande scrittore puo' cimentarsi col melodramma, con le grandi passioni e i grandi effetti, con i grandi gesti e le grandi parole, con la monumentalita' sentimentale”.
In effetti, il libro mi è parso spesso non privo di retorica e di teatralità: alcuni personaggi, nei momenti topici sembrano declamare a ruota libera le loro idee (Lantenac, Gauvain, Cimourdain) o le loro angosce (la Flechard); prevale il monologo sul dialogo e la narrazione è fluida solo a tratti. Quindi, si capiscono le rimostranze di Flaubert, ma non si può non negare che l’affresco possiede una sua forza complessiva “da grande scrittore”.