L'incanto del lotto 49
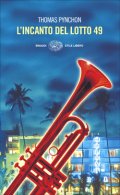
Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 3
PARANOIA ED ENTROPIA
“Comunque vada, la chiamano paranoia. Loro, la chiamano così. O senza l’aiuto dell’LSD e altri alcaloidi sei inciampata per caso nella ricchezza segreta e la densità nascosta di un sogno. […] O contro di te è stato montato un complotto, talmente caro e elaborato, […] una maniera così labirintica che deve superare i limiti dello scherzo. O tutta questa congiura te la immagini, nel qual caso, Oedipa, tu sei pazza da legare.”
Pare che Howard Hawks, dopo aver girato “Il grande sonno”, avesse candidamente confessato di averci capito poco o nulla, pur essendo il regista, dell’intricatissima storia tratta dal romanzo di Raymond Chandler. Il lettore de “L’incanto del lotto 49”, di fronte alla sua trama ingarbugliata e labirintica, si trova in una situazione del tutto analoga a quella del famoso regista, in quanto Pynchon sembra divertirsi a confondergli continuamente le idee, disseminando il romanzo di false piste (si pensi al mistero delle ossa trafugate per farne filtri per sigarette, il quale sembra fondamentale nel terzo capitolo, ed invece scompare del tutto nel prosieguo del libro) e di svolte narrative azzardate e inopinabili. Allo scrittore di Glen Clove infatti non interessa affatto la coerenza diegetica, quanto piuttosto portare avanti quello che, con lo scorrere delle pagine, diventa un vero e proprio leitmotiv, ovverossia l’inconoscibilità della realtà. L’universo pynchoniano è distorto, deformato come in un trip allucinogeno, è come una versione anamorfica del mondo che noi tutti conosciamo, e il lettore si trova disorientato di fronte a questa opera survoltata e psichedelica, in maniera non dissimile da come si sente la protagonista Oedipa quando riceve la lettera che la nomina esecutrice testamentaria del defunto Pierce Inverarity, un facoltoso uomo d’affari con cui aveva avuto una relazione anni prima, e non capisce come comportarsi, da che parte iniziare a guardare la faccenda. I tanti, imprevedibili avvenimenti che Oedipa si trova a fronteggiare nel corso del pur breve romanzo rimangono incomprensibili e non riescono mai ad apportare alcuna rivelazione, alcun incremento nella conoscenza della realtà, la quale resta oscura, indecifrabile, impossibile a vedersi nella sua nudità, così come il corpo che Oedipa cela sotto numerosissimi strati di indumenti quando decide di giocare a una sorta di gara di striptease con Metzger. Al centro della trama, dopo che altri potenziali motivi di interesse (come l’eredità di Inverarity) vengono senza alcuna motivazione accantonati da Pynchon, c’è l’enigma del Tristero, una sorta di presunta cospirazione, che attraversa secoli e continenti (dai tempi dei Thurn und Taxis in Europa fino ai più moderni Pony Express e Wells Fargo dall’altra parte dell’Oceano), legata a un servizio postale segreto, dissidente e alternativo rispetto a quello statale. Non è un caso che abbia citato in apertura “Il grande sonno”, perché Oedipa, come un detective privato, si mette a inseguire le labili tracce del complotto (alcuni strani versi in una commedia teatrale elisabettiana, il simbolo di un corno da caccia con la sordina disegnato in un bagno pubblico, un francobollo falsificato), fino a farsi completamente coinvolgere dalla cosa e dedicarle tutto il suo tempo e le sue energie. Oedipa, con il suo bizzarro ed emblematico nome, sembra essere la versione femminile del personaggio di Sofocle, ma mentre Edipo, messo di fronte all’enigma della Sfinge, riusciva brillantemente a risolverlo, la nostra protagonista fallisce clamorosamente la sua impresa. Le rivelazioni e gli indizi che si accumulano sempre più numerosi, infatti, anziché consentire di risolvere il mistero, lo infittiscono sempre di più. Non importa quante intuizioni Oedipa possa avere, quante epifanie le si possano manifestare, vi saranno sempre ulteriori strati, ulteriori livelli a coprire la verità ultima, e ogni mistero risolto aprirà solo altri sotto-misteri inesplicabili, in una frustrante catena di ermeneutica impossibilità. “L’incanto del lotto 49” diventa così una sottile satira dei romanzi gialli: mentre in questi ultimi gli indizi concorrono a svelare progressivamente il busillis, a sciogliere l’arcano, fino a un finale più o meno catartico, ne “L’incanto” ogni successivo indizio non fa che ispessire il mistero, anziché avvicinare la soluzione riporta solo al punto di partenza (come nel capitolo in cui, dopo una lunga serie di incontri rivelatori, premonizioni, congetture e pedinamenti, Oedipa si ritrova, in una sorta di loop temporale, davanti alla casa di Nefastis da cui si era accomiatata il giorno prima, come se le ultime ventiquattro ore vissute non fossero state davvero realtà, ma un’allucinazione frutto di una immaginazione psicotica). Con beffarda e preveggente lucidità Pynchon è così in grado di portare alla luce quelli che saranno, nei decenni a venire, i problemi legati agli strumenti di una comunicazione sempre più onnipresente e pervasiva, soprattutto nell’attuale era di Internet, Google e Wikipedia: ossia che a maggiori informazioni non corrisponde affatto una maggiore conoscenza.
Il mondo di Pynchon appare disgregato, frammentato, completamente in balia dell’entropia. Ad un certo punto del romanzo Oedipa si trova di fronte a una bizzarra invenzione, la macchina Nefastis, la quale permette, tramite una minuscola intelligenza nota come il “diavoletto di Maxwell”, di produrre energia dal nulla, violando così la seconda legge della termodinamica. L’invenzione si propone di mettere ordine, separando le molecole fredde da quelle calde, nel caos della realtà, ma ha bisogno, per funzionare, di un “sensitivo” capace di collegarsi telepaticamente al diavoletto. Oedipa si sottopone volontariamente a un test in grado di rivelare se lei possa essere una tale sensitiva, ma fallisce miseramente. Tale fallimento però può essere interpretato in due modi: o Oedipa non è una sensitiva o, più probabilmente, è la macchina stessa a essere niente di più che una ciarlataneria. Tutto il libro risponde in fondo proprio a questo dilemma: è Oedipa incapace di risolvere il mistero Tristero, oppure, più semplicemente, il mistero Tristero non esiste? In questa domanda si cela l’essenza stessa del romanzo e, più in generale, dell’intera letteratura postmoderna. L’eroina de “L’incanto” infatti, così come tutti gli altri anti-eroi di Pynchon, si sforza faticosamente di interpretare e dare un senso a un universo sconnesso e caotico (ad un certo punto si dice significativamente che Oedipa “voleva creare costellazioni”), senza capire, o capendolo troppo tardi, che un senso ormai non esiste più. L’entropia fatalmente prevale, come la vegetazione di una foresta vergine che invade e si impossessa delle rovine abbandonate di una civiltà estinta da tempo. Posto di fronte a questo infausto destino, l’individuo inevitabilmente si sfalda, si disintegra e diventa preda della paranoia. La paranoia circola un po’ dappertutto nelle pagine de “L’incanto”. Manny Di Presso si lamenta “Sempre qualcuno che ascolta, che spia; ti nascondono i microfoni in camera, ti intercettano le telefonate…”; il dottor Hilarius impazzisce e crede che emissari del governo israeliano vogliano ucciderlo a causa del suo passato nazista; il complesso di Miles e dei suoi amici si chiama addirittura “I paranoici”. Tutto ciò suggella in chiave parossistica e grottesca quella che, negli anni ’50 e ’60, era l’atmosfera tossica che si respirava in America, con la guerra fredda, la caccia alle streghe del senatore McCarthy e l’assassinio del presidente Kennedy. Anche Oedipa si trova a riconoscere “la logica con cui tutto si articolava perfettamente, quasi che (…) le rivelazioni si susseguissero a catena”, e si fa catturare dalla psicosi del complotto: le piste da lei seguite si intrecciano, gli indizi si ammassano esponenzialmente e ogni cosa sembra rimandare sempre e comunque (come tutti i corni da postiglione con la sordina che vede dappertutto, sotto forma di tatuaggi, spille, polsini da camicia o scarabocchi) al Tristero. Alla fine del romanzo Oedipa arriva persino a pensare di essere vittima di un gigantesco scherzo da parte di Inverarity, temendo che questi, lungi dall’essere morto, abbia assoldato attori, spiato i suoi movimenti, falsificato libri e documenti, per farle credere nell’esistenza di una cospirazione su vasta scala e prendersi in tal modo gioco di lei. Il finale de “L’incanto del lotto 49” è non a caso un finale aperto: c’è un uomo misterioso interessato all’acquisto della collezione di francobolli di Inverarity, ma non sapremo mai di chi si tratta perché il romanzo si interrompe prima, lasciando il lettore nell’amletico dubbio se Oedipa risolverà finalmente il rompicapo o, più probabilmente, si troverà di fronte a un enigma ancora più grande. In un romanzo stravagante e satirico, caratterizzato dalle consuete canzoncine pynchoniane, da imprevedibili giochi di parole e bizzarrie linguistiche (ad esempio, il nome della radio presso cui lavora Mucho, KCUF, assume, letto al contrario, un significato comicamente scurrile), dalla implausibile stramberia dei nomi dei suoi personaggi (il filatelico Genghis Cohen, lo psichiatra Hilarius, lo scienziato John Nefastis, il regista Randy Driblette), da curiose autocitazioni (il fantomatico concerto di Vivaldi per kazoo, ossessivamente cercato in “V.” dal musicologo Petard e che qui viene suonato del “Fort Wayne Settecento Ensemble”), da anacronistici episodi pseudo-storici (come quello della Guerra Civile americana in cui lo zar di Russia interviene a favore dell’Unione per sventare un attacco via mare a San Francisco da parte dei confederati, oppure quello che coinvolge la setta degli scurvamiti sotto il regno di Carlo I) e dalla feroce presa in giro delle sottoculture americane dell’epoca (dalla droga alla musica rock, dalla liberazione sessuale alle associazioni di sostegno contro le dipendenze più svariate), in un romanzo di questo tipo – dicevo – il tono del finale è paradossalmente di un pessimismo atroce. Al termine della storia infatti una Oedipa sconfortata e disillusa è costretta a riconoscere la propria sconfitta, timorosa persino di veder apparire suo malgrado davanti agli occhi nuove piste e inedite rivelazioni che possano ulteriormente disorientarla e ingolfarla. Il mistero del Tristero, irrisolto e irrisolvibile, la abbandona, come la risacca del mare con il relitto di un’imbarcazione naufragata, a una solitudine desolata e dolorosa, senza più nessuno dei suoi punti di riferimento (il marito Mucho rovinato dall’LSD, il dottor Hilarius impazzito, il regista teatrale Driblette morto suicida, l’amante Metzger scappato con una quindicenne lasciva) e con la propria vita completamente distrutta e senza scopo, in un cul-de-sac da cui, inesorabilmente, non è ormai più possibile riuscire a liberarsi per sperare di tornare alla tranquillità della routine iniziale.
Indicazioni utili
Il padre del postmodernismo.
Avete presente il concetto di brain-storming? Ecco più o meno è quello che si prova leggendo questo breve romanzo. Pur apprezzando molto il postmodernismo non avevo mai letto Pynchon e così ho deciso di iniziare dal suo romanzo più famoso, "L'incanto del lotto 49" appunto. Il libro racconta una storia molto semplice a prima vista: una giovane donna riceve una lettera da parte di un avvocato nel quale viene avvertita che un suo ex è deceduto e che le ha lasciato una parte di eredità. Logicamente però, come ben saprete se avete mai letto un romanzo postmoderno, questa trama principale è solo la punta dell'iceberg. Infatti la nostra Oedipa (anche il nome non è casuale...) cercando informazione su questa eredità verrà a scoprire di un'organizzazione lobbistica chiamata Tristero che gestisce un "metodo alternativo" (leggi "segreto") di posta parallela a quella nazionale, la cui istituzione ha origini antichissime. Nel corso del romanzo inoltre compariranno diversi personaggi dai "nomen omen" (uno su tutti, Gervis Khan...) e molte saranno le situazione ambigue, spesso ai limiti del grottesco, che ci porteranno verso una fine-non fine tipica del romanzo postmoderno. La scrittura è complessa, resa ancora più difficile dalla traduzione piena di refusi e spesso non corretta, la trama è solo apparentemente semplice, in realtà è un libro che si presta a mille interpretazioni diverse e non è di facile comprensione, e sono solo 174 pagine... Non è il postmodernismo di De Lillo, quello è più lineare, ha un inizio e una fine, non è il postmodernismo di Palahniuk, che segue sempre un solito percorso, è più quello di Foster Wallace, quasi un realismo isterico, in cui spesso ci si allontana moltissimo dalla trama principale, quasi a perdere contatto con essa, e ci si avventura in digressioni secondarie completamente estranee alla faccenda (o almeno apparentemente). Se avete letto "Oblio" di Foster Wallace avrete subito capito a cosa mi riferisco, d'altronde quest'ultimo ha ammesso diverse volte di essere stato influenzato da Pynchon. In conclusione, se vi piace il postmodernismo leggetelo ma sappiate che non è un romanzo tanto agevole, un solo consiglio: non fermatevi a pensare a ogni digressione su quale sia o non sia il significato, perché non è detto che ci sia, il postmodernismo spesso è un esercizio di stile, l'autore ci mette dentro molto della sua conoscenza su ogni campo, anche cose eccessivamente specifiche, che a volte servono, a volte appesantiscono la storia. Il postmodernismo, a mio modo di vedere, si può riassumere con la frase "La bellezza è negli occhi di chi guarda", ogni lettore può dare ai vari passaggi un suo significato, più o meno giusto, o magari non dargliene alcuno, e credo che sia proprio qui, nell'interpretazione, il bello del postmodernismo. Pynchon nè è il padre, se vi piace o vi incuriosisce lo stile in questione, leggetelo.
Indicazioni utili
Astrattismo letterario
Qual'è quella cosa su cui si regge la società antica e quella moderna, quell'unica imprescindibile prerogativa e insieme caratteristica di ogni assemblea di uomini, voglia essa chiamarsi stato, nazione o società? L'economia, la politica, la legge? No di certo, o meglio sì, in parte, ovvio!, ma tutte loro non sono tuttavia così unicamente essenziali come un'altra (e la recente storia pare anche confermarcelo): la comunicazione, il sistema di trasmissione diretto e indiretto delle informazioni. Se viene a mancare questo, vengono a mancare i rapporti tra nazioni, citta, paesi e infine uomini e non c'è più economia, politica o legge che regga. E quale migliore metodo dunque per rivoluzionare un mondo se non quello di tagliare le vie di comunicazione originali e soppiantarle con delle altre gestite e controllate dai rivoluzionari? Quale modo migliore per conquistare e mantenere il potere se non quello di controllare le informazioni? (Vedasi per esempio i regimi mono o pluri dittatoriali che ancora oggi negano al loro popolo l'accesso ai social network, o la Cina che ha introdotto un motore di ricerca "personale" per far concorrenza a Google e probabilmente filtrare certe notizie) Quale metodo migliore dunque? È presto detto: nessuno.
Ma se il sistema originale è troppo potente, troppo instaurato e affermato sul territorio da essere soppiantato così in quattro e quattr' otto, tutto ciò che possono fare i "sovversivi", gli ideatori del nuovo sistema, è quello di limitarsi ad una guerriglia, ad una guerra fredda fatta di sotterfugi, silenziosi attentati, reclutamenti segreti, e voci contradditorie seminate tra la gente, certa gente, per creare confusione o talvolta, come nel caso della "nostro" romanzo, curiosità e rabbia. E se poi qualche estraneo, qualche innocente, come nel caso della "nostra" protagonista, cade erroneamente in questa sotterranea rete eversiva, be tanto meglio: o una nuova adepta o un nuovo esempio del potere dei rivoluzionari per tutti i nemici, per tutti gli assuefatti al naturale, normale, stato delle cose, o ancora meglio, attraverso la sopraccitata metodica trasformazione dell' informazione, un nuovo martire imolato alla giusta causa, sacrificato da un sistema, quello originale, corrotto, per tentare di mettere a tacere un movimento che in questo modo non è piú soltanto la voce fuori dal coro di un manipolo di pazzi reazionari, ma la voce del popolo, l'unica e autentica voce della verità.
Non c'è come palesare una cosa per renderla dubbia, non c'è come sussurrarla per renderla autentica.
Questo è Il significato, a grandi linee, della storia a cui gira attorno L' Incanto del lotto 49; a grandi linee, poichè di per se stessa la vicenda non è per nulla chiara e lascia molti punti, o argomenti all'oscuro, tipo: perchè tirare in mezzo proprio quella donna, la protagonista? Oppure sarà stata veramente tirata in mezzo o è lei che ci si è infilata, intromessa, occupandosi di cose che non la riguardavano? E poi in fin dei conti cosa vogliono veramente questi reazionari, ammesso che esistano..., questi accaniti e quanto mai concorrenziali rivoluzionari? D'accordo vogliono rivoluzionare... ma perchè, cosa vogliono ottenere? Di cosa esattamente si lamentano? E anche ammesso che sia lecito il loro motivo, sempre che esista..., non c'era un metodo più efficace che tirare in mezzo un opera teatrale di qualche decennio prima, dei francobolli e un benedetto corno da postiglione?!
Certo è tutto figurato, è tutto un meccanismo propedeutico alla narrazione, uno stratagemma per dare il ritmo alla trama grazie ad un sarcasmo di riflesso, da teatrino dell'assurdo, come se noi, lettori, spettatori e membri della società, all'apertura del sipario ci trovassimo di fronte ad un grande specchio che non fa altro che rifletterci, storpiandoci, evidenziando i nostri difetti e la nostra illogicità e, noi, marionette nelle marionette ridessimo di gusto capendo e non capendo. (Viene spontaneo qui il paragone con uno dei primi film del cineasta che crea l'Infinite Jest del romanzo di David Foster Wallace, quello che consiste nella ripresa e riproposizione in tempo reale del pubblico in sala e questo prima si stranisce, poi illogicamente ride ed infine s'arrabbia e se ne va.)
Vero dunque, come in Infinite Jest anche ne L' Incanto del lotto 49 è tutto allegorico, ma proprio come in quello se l'allegoria è illimita e costante si rischia realmente di perdere il significato di fondo, e con esso il senso della realtà. E qui del resto certo non si lesina sull'irrealtà: l' autore apposta crea una vicenda fumosa e caotica, dove ogni propsettiva viene costantemente rivoluzionata attraverso contradditori giochi di specchi e di parole che rimandano alle incertezze della protagonista e del mondo che pare, solo pare, aprirsi di fronte ai suoi occhi; e più che raccontare la storia ce la dipinge (a tratti da vero maestro) con scorci disordinati di vissuto su un annuvolato sfondo esistenzialista e minimalista, davanti al quale noi non possiamo far altro che rimanere ad osservare beandoci dei colori e delle forme, senza tuttavia riuscire a comprendere il significato delle immagini.
Sorge dunque spontanea una domanda: in soldoni, "L' Incanto" è un bel libro oppure no? E Pynchon scrive bene oppure no?
È impossibile rispondere poichè come ogni opera d'arte che tocca profondamente chi l'osserva il giudizio non puó mai essere assoluto ma solo personale e ogni lode è lecita e giustificata quanto ogni critica. Ma se il giudizio sulla singola opera e sulla piacevolezza dello stile di Pynchon è soggettivo, una cosa oggettiva rimane, e certamente gli va riconosciuta: l'autore nel bene e nel male ha sconvolto e rivoluzionato la recente letteratura più di ogni altro suo collega e ha creato un movimento a se stante che, come per certa arte moderna che si discosta dai normali canoni di perfezione di quella classica, si pone come altro estremo della visione e comprensione umani. Pynchon ha creato la letteratura astratta, dove i soggetti narrati non sono più chiari, le vicende non più lineari, ma solo l'idea di base che si ha di esse, l'idea che viene esposta dall'autore dopo essere stata masticata, digerita e metabolizzata dalla sua fervida mente.
E come ogni movimento anche questo ha i suoi adepti, vedasi per esempio, come si diceva prima David Foster Wallace che, pur essendo la sua bibliografia ahinoi troppo scarna per poter essere portato ad esempio, a tratti pare proprio un Pynchon mondato e ripulito dall'eccessiva caoticità, o il "recentissimo" Tom McCharty col suo C (il cui titolo sembra un talmente ovvio omaggio al V del Nostro da rasentare l' inverosimile), o i critici letterari come Bloom (che consiglia addirittura di leggere L' Incanto due volte). Sì, ha i suoi adepti, ma anche suoi detrattori, coloro che criticano l'eccessività del suo stile, coloro che vorrebbero ma proprio non ce la fanno ad apprezzarlo, come per esempio il sottoscritto (lo so come esempio lascio un po' a desiderare) coloro che, pur riconoscendo l'immensa creatività e l'audacia dell'autore, non reggono allo sforzo di tirare le somme ad una vicenda che tende all'autocompiaciuta incomprensibilità in meno di 150 pagine.
Per concludere, è vero: sì legge, si evidenzia, la grandezza di Pynchon tra le righe, tra le parole e soprattutto, a mio parere, nella perfetta caratterizzazione delle atmosfere, ma i meccanismi attraverso cui si giunge a queste vette letterarie rimangono incomprenibili, così come volutamente incomprensibile è il filo logico che sottende alle sue vicende.
Genio e sregolatezza, si dice per descrivere certi grandi dell'arte e questo è anche il caso di Pynchon, ma al pari dei più grandi artisti dell'astrattismo figurato, checchè ne dicano i veri critici e i presunti esperti che si adeguano al coro delle loro risonanti voci, affrontando "un Pynchon" viene sempre umilmente da chiedersi dove veramente finisca il genio e dove comici la più totale, dissoluta, e involontaria sregolatezza.




























