Grande sertao
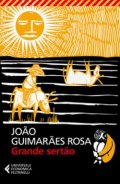
Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 3
Arrivederci amore, ciao
“M’innamorai di una palma, nell’aiuola del crepuscolo.”
Il grande sertao e’ terra arida, è terra florida. E’una pianura rovente e deserta che rigetta calore da burroni profondi come l’inferno, poi all’improvviso un fiume grandioso, le cascate cantano ed i pappagalli lo sorvolano gridando il nome dei suoi colori. Fiori sublimi di rossi e di viola, stormi di sparvieri, tartarughe e vipere e la notte lucciole a migliaia, l’erba verde un tappeto luminoso. Il sertao e’ spazio immenso senza confine, è solitudine, è tutta la certezza, è tutta l’incertezza.
Il grande sertao è per gli uomini l’attesa, e’ per tutti noi la vertigine.
“Non avevo paura. Quel che avevo era la stanchezza della speranza”.
Non concepisce il guerriero l’amore verso un altro soldato nelle regioni violente dell’entroterra brasiliano, dove fazioni di bravacci si sfidano a morte. Non può negarsi all’amore, colui che ama con l’anima.
Comanda il diavolo dove non dispone l’uomo? Vacilla alla domanda l’anziano capo. Albe di barbarie e crepuscoli di perdono, questa terra appartiene agli esseri umani, non al demonio.
Credete forse di potere camminare in terra d’Amazzonia con ai piedi sandaletti di strass? L’Amazzonia è l’umidità che occlude i pori fin quasi a soffocarti, insetti che ti riempiono di pustole e notti insonni, stivali di gomma fino al ginocchio per muovere passi su ininterrotti torrenti di fango. Poi fermo, madido di sudore, sgrani gli occhi e ti chiedi, sarà bellezza o un miracolo? Alzando lo sguardo tutto ciò che non vedi è la cima di una sequoia gigante. L’emozione, ecco colui che nella guerriglia racconta come amare con l’anima, anche negando l’amore più evidente.
Scritta negli anni Cinquanta, quest’opera di Guimaraes Rosa non parla di Amazzonia, ma è amazzonica. Faticosa, voluttuosa, indimenticabile, cavillo e poesia, ribolle parola su parola e ti si appiccica addosso come una seconda pelle di muschio vivo e brulicante di minuscole creature viventi.
Banditi e mandrie, catapecchie e fazende, incantesimo e preghiera, un’opera grandiosa nel panorama del realismo magico sudamericano. Maestosa narrazione priva di capitoli, a tratti schiaccia il lettore nella sua incapacità di ritagliarsi una pausa. Strabiliante nel finale, una volta terminato è complesso intraprendere la lettura di una qualsiasi narrativa piu’ convenzionale.
Indicazioni utili
SERTAO EPICO E SELVAGGIO
Contiene spoiler
“Vossignoria sa: sertão è dove comanda chi è forte, con le astuzie. Dio stesso, quando verrà, che venga armato!”
Quale straordinario piacere per gli occhi e per la mente è leggere Grande Sertão per la prima volta, senza conoscere del Brasile altro che il Carnevale di Rio o la spiaggia di Copacabana! E’ un po’ come guardare Ombre rosse o Sentieri selvaggi senza mai avere avuto sentore del West o della Death Valley. Si rimane letteralmente incantati di fronte a un paesaggio di selvaggia e primordiale bellezza, raccontato con affetto e nostalgia, certo, ma anche con grande sincerità, senza edulcorazioni o imbellettamenti posticci. Il sertão di Guimarães Rosa è un gigantesco ossimoro, vale a dire è tutto e il contrario di tutto: affascinante e spaventoso, pietoso e crudele, pieno di vita e solitario, pacifico e ribollente di odio. “Il sertão è confusione in una grande eccessiva calma… Tutto qui è perduto, tutto qui è trovato” (pag. 371). E’ in queste terre smisurate (“Il sertão è grande come il mondo”), tra aridi altipiani e oasi fertilissime, montagne scoscese e foreste impenetrabili, fiumi impetuosi e paludi malsane, che si aggira, con la sua banda di jagunços, il protagonista Riobaldo, in un incessante e apparentemente casuale girovagare in cui i combattimenti sono rari intermezzi di una esistenza peregrinante, monotona e disagevole, allietata solo dal cameratismo dei compagni e dall’orgoglio di una scelta di vita estrema e radicale. Il tutto è raccontato in un ininterrotto monologo di quasi cinquecento pagine, che per la sua titanica grandiosità rimanda ad altri capisaldi della letteratura contemporanea, come Il tamburo di latta o I figli della mezzanotte. In questa lunghissima rievocazione, il narratore Riobaldo, ad onta di una memoria sedicente ondivaga e lacunosa, viviseziona il suo passato come un rasoio affilatissimo (“volto al ricordo con uno specchio di lumi raddoppiati”), fino a far emergere le più minute vibrazioni interiori di ogni esperienza vissuta, quasi a voler tirar fuori da essa una qualche misteriosa e imponderabile verità. E’ così che il primo incontro di Riobaldo ragazzo con i jagunços o l’attesa notturna di un combattimento vengono descritti con una vividità impressionante, quasi che nella sua memoria fossero rimasti impressi, come accadeva al borgesiano Funes, ogni singolo minuto, ogni singolo dettaglio, ogni singolo nome e ogni singolo, apparentemente insignificante, accadimento della propria vita. Eppure, nonostante la precisione del racconto, il romanzo è pieno di periodi sconnessi in cui il protagonista si smarrisce di fronte all’impenetrabile mistero della propria anima (si vedano a mo’ di esempio le pagine 256-259): Grande Sertão è infatti paradossalmente, nonostante l’ambientazione esotica e le gesta epiche, un romanzo per così dire psicanalitico, in cui il personaggio che dice io va alla ricerca delle motivazioni dei suoi atti, in una ricerca estenuante dell’origine delle sue scelte etiche. La semplicità, la superstizione e la primitività del protagonista fanno sì che la lotta tra il bene e il male che dilaniano la sua interiorità vengano narrate quasi fossero delle storie dell’Antico Testamento, con Dio e il Diavolo che quasi si materializzano per contendersi la sua anima e un velleitario appuntamento notturno con il demonio (“Credo che non volevo esattamente nulla, di tanto che volevo solo tutto… Rimasi assente. Quello fu un grande buco nel tempo… Ubriaco di me, rovesciato all’incontrario, svuotato dei miei intimi,… stavo lì, di mia volontà, per affrontare uno slancio così smisurato. Da far arrestare i miei occhi in un’immensità di niente”) che segna una fatidica svolta esistenziale per il iagunço Riobaldo, di lì a poco destinato a diventare il capo-banda Urutù Bianco. Grande Sertão, in questo senso, è soprattutto una minuziosa confessione, in cui il narratore, di fronte a un anonimo ascoltatore (che potrebbe anche essere – perché no? - un prete), cerca di rintracciare nel passato ogni possibile ragione di innocenza per allontanare da sé l’allucinante sospetto di avere venduto la propria anima al Maligno e di avere, in un posto dove (nel libro lo si ripete spesso) “vivere è una faccenda molto pericolosa”, contribuito suo malgrado a far trionfare il male sul bene.
Ma Grande Sertão è anche, sorprendentemente, un romanzo d’amore. Anche se il sentimento amoroso parrebbe inconciliabile con l’universo di questi rudi banditi, che cavalcano tutto il giorno e bivaccano sotto le stelle, Guimarães Rosa riesce a introdurre, all’inizio quasi di soppiatto ma poi gradualmente facendone addirittura il fulcro emotivo del romanzo, l’elemento melodrammatico, nella forma del tenero rapporto di affetto tra Riobaldo e Diadorim: rapporto mai consumato, anzi costantemente negato (in quanto contrario al rigido codice virile dei jagunços), sempre in bilico sul sottile confine dell’amicizia tra compagni d’arme, eppure riconoscibilissimo in tutte le sue manifestazioni (basti pensare alle schermaglie di gelosia quando Riobaldo si innamora di Otacilia, la giovane figlia di un fazendeiro), fino al clamoroso epilogo (un vero e proprio coupe de theatre, degno di un feuilleton) in cui Diadorim, ucciso in combattimento, rivela davanti agli occhi sbigottiti di Riobaldo (“il dolore non poté più della sorpresa”) di avere un corpo di donna, per anni dissimulato accuratamente sotto i vestiti e il taglio di capelli maschili. Il rimpianto di non avere mai avuto il coraggio di confidare all’amato il proprio sentimento, di non aver saputo approfittare dei momenti di intimità per aprire il proprio cuore, i piccoli cedimenti (come il sensuale contatto di una mano nella mano) subito rinnegati e puniti con settimane di scontrosità, di silenzi o di lontananza, impregna tutto il romanzo di una tristezza, di una saudade, che contrasta con il corrusco vitalismo delle battaglie, delle cavalcate e della dura ma eccitante vita dei jagunços.
Se anche avesse un impianto letterario tradizionale, Grande Sertão sarebbe un grande romanzo. Ma Guimarães Rosa è anche uno scrittore di genio, capace di marchiare la sua opera con uno stile inconfondibile, allo stesso tempo popolaresco e raffinato, impressionista e barocco, incisivo e prolisso, ricco oltretutto di innumerevoli invenzioni linguistiche, le quali rimandano a un altro gigante della narrativa del Novecento, Carlo Emilio Gadda. I neologismi sciorinati dallo scrittore brasiliano (“sbaraondare”, “chiaracque”, “scaramucciato”, “insemprato”, “diavolarmente”, “sufflagare”, “inzupposo”, “prescioloso”, “pezzettinuccio”, “gambereggiare”, “vespare” per citarne solo alcuni tra i tanti) sono in grado di mandare in sollucchero il lettore più esigente, così come le caratteristiche giustapposizioni di termini usate per intensificare i concetti (“gli avvenuti avvenendo”, “i tuoni tuonando”, “in sì gran numero numerosa”, “buona mira ottima”, “le cose sono molte di troppo”, “fortissimo esatto”, ecc.) e soprattutto il modo originalissimo di descrivere in una parola il comportamento degli animali o di utilizzare il bestiario del sertão per rappresentare un fenomeno umano o naturale (gli uccelli che “gallineggiano”, le zanzare che “infernizzano”, il bestiame che “braveggia”, gli aironi che “aironano” e il merlo che “merleggia”, le pallottole che “colibrarono”, ecc.). L’importanza per l’economia del romanzo di quel macrocosmo particolarissimo che è il sertão la si intuisce quindi già dall’utilizzo del lessico, il quale rivela una profonda e non scontata conoscenza dell’autore dei posti di cui parla, conoscenza (e amore, aggiungerei) che si rivela anche nel loro utilizzo simbolico (le veredas, i buritìs, il manuelzinho del greto) e metaforico (si prenda ad esempio questo brano: “Diadorim – lui andava da una parte, io dall’altra, diversa; così, come, dalle paludi dei Gerais, si stacca una vereda che va a oriente e un’altra che va a ponente, ruscelletti che si separano di colpo, ma correndo, chiaramente, nell’ombra dei loro buritìs” – pagg. 444-445). Trascendendo la geografia dei luoghi, e superando gli esiti pur ragguardevoli raggiunti da altri scrittori sudamericani come Arguedas, Vargas Llosa e perfino Garcia Marquez, Guimarães Rosa ha saputo fare del sertão e della sua esuberante natura l’incontrastato protagonista di un’epopea di ineffabile e rara bellezza.
Indicazioni utili
Dentro il Sertao
Non è semplice parlare di un libro che , datato 1956, si è imposto nella letteratura brasiliana divenendone una sua pietra miliare. Non lo conoscevo e devo la sua scoperta a una vivace comunità di lettori che dopo averlo scovato tramite la partecipazione di un nutrito numero di essi ad un sondaggio teso a scovare “perle nascoste” nella letteratura mondiale, ha fatto sì che con votazione divenisse l’eletto per un successivo gruppo di lettura. Ho partecipato dunque alla mia prima lettura collettiva e devo dire che l’esperienza è stata edificante perché i contributi degli altri hanno sostenuto un leggere non sempre piacevole e spesso difficoltoso rendendomi tra l’altro maggiormente accessibili alcuni passaggi. Resistenze innumerevoli hanno siglato la lettura e primariamente una prosa arricchita di un linguaggio ricalcante la vera natura del Sertão: Brasile centrosettentrionale, lande brulle in altitudine solcate da palme, piccoli fiumi, una fauna curiosa, variopinta, onnipresente, un esercito di solitari uccelli che scandiscono i ritmi di una natura bella e selvaggia. Una terra di nessuno o forse una terra di pochi, i fortunati possessori di isolate fazende che per proteggere le loro microeconomie hanno necessità di asservire i molti sfortunati i quali, armati, fanno valere una legge, quella del più forte, in un luogo dove la legge non arriva mai. Riobaldo, ormai vecchio, sposato, sistemato e protetto dai suoi banditi è anche lui divenuto uno di essi. È divenuto appunto giacché non fu in gioventù: persa prematuramente la madre, raggiunto un padrino, sottrattosi alla sua cura, si unisce ad una delle bande che percorrono il Sertão e questo luogo immenso, difficile, ostile e accogliente al tempo stesso lo ospita, lo fagocita e lo istruisce. La sua natura però pare rifuggire dalle leggi della sua nuova casa ma in essa lui dovrà faticosamente trovare un suo ruolo, una sua ragione, una sua identità. È sua la voce narrante che si rivolge ad un ospite di passaggio “Vossignoria”, uomo di certo istruito che viaggiando per quei luoghi capirà la sua parabola esistenziale se avrà la pazienza di ascoltare lo sfogo di un uomo che vive fondamentalmente di rimpianti, in realtà di un unico grande rimpianto. Il suo narrare è una mistura di ricordi e di considerazioni di carattere più generale che vanno a toccare le grandi verità di una terra intrisa di credenze, superstizioni, attribuzioni di caratteristiche soprannaturali anche al reale più tangibile, una terra che ha necessità di interrogarsi e di capire le grandi forze antitetiche che governano la vita umana: il bene e il male e le loro incarnazioni nelle idee di dio e del diavolo. Il ritmo narrativo discontinuo, squarciato da stupendi passaggi descrittivi che offrono bellissimi quadri d’insieme dove regnano sovrane la flora e la fauna del Sertão, zigzagato da continue analessi, inframmezzato da sequenze frenetiche al sapore di piombo, regala un’esperienza di lettura unica che mima l’episodicità della stessa esistenza: tempesta e risacca. Riobaldo si dipinge in tutta la sua umanità fatta di incertezze, paure, limiti ed errori anche nei momenti più alti del proprio percorso; un uomo solo come tutti d'altronde anche se riuniti in bande, con gli stessi ”valori” da condividere, con le stesse esperienze da raccontarsi, anche le più brutali. Un uomo che pur accettando tale sistema sempre nel suo profondo lo rinnega, se ne distanzia e insieme ne viene risucchiato ancora accertandosi tra sé e sé che “la vita della gente procede per errori, come resoconto senza piedi né testa, per mancanza di buon senso e di allegria”. E se solo l’avesse avuto un po’ di buonsenso il nostro Riobaldo oggi non sarebbe lì a ricordare e contemplare l’unica vera “nebbia” della sua vita: Diadorim. Qui ci vorrebbe proprio la “misericordia di una buona pallottola” a porre fine al suo narrare- rimuginare, ancora basiti per la sua rivelazione finale, riconciliandoci infine con lui e con la sua “traversia”.




























