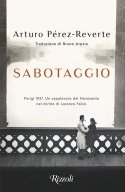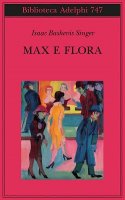Mason & Dixon

Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 2
LA STORIA SECONDO PYNCHON
“Non dovrebbe essere questa l’Età della Ragione?”
“A volte l’Invisibile apparirà tutto all’improvviso… a volte quello che vedete può non essere affatto.”
C’è una canzone di circa vent’anni fa che amo molto e che è cantata a due voci da Mark Knopfler e da James Taylor. “Sailing to Philadelphia” – questo il titolo del brano – racconta del viaggio dall’Inghilterra alla volta del Nuovo Mondo intrapreso nella seconda metà del XVIII secolo dall’astronomo Charles Mason e dall’agrimensore Jeremiah Dixon, e testimonia il ruolo rilevante ricoperto nell’immaginario collettivo anglo-americano da questi due personaggi, diventati famosi per aver tracciato la linea di demarcazione tra la Pennsylvania e il Maryland (quel confine che, oggi noto come “linea Mason-Dixon”, nel corso degli anni successivi è simbolicamente divenuto lo spartiacque tra il Nord liberista e il Sud schiavista). Ciò detto, viene naturale chiedersi, soprattutto da parte di chi conosce un poco la sua fantasmagorica e anarchicheggiante opera, cosa ci faccia Pynchon nella razionale e scientifica epoca dei Lumi, tra personaggi in giubba, parrucca e bicorno e un mondo ordinato di osservazioni celesti, misurazioni cartografiche e gradi di longitudine e latitudine. La risposta, a mio avviso, è molto semplice: Pynchon ha voluto fare, alla sua maniera – certo - ma in modo incontestabile, una vera e propria lezione di storia. Il reverendo Cherrycoke, il quale narra ai parenti riuniti, nel corso di una lunga notte d’inverno, le avventure di Mason e Dixon, avendo egli stesso partecipato anni prima alla loro spedizione, dice al riguardo una frase molto significativa: “Dovere dello Storico potrebb’essere di cercar la Verità, e nondimeno dover fare tutto ciò che è in suo potere per non svelarla”, la quale a sua volta mi richiama alla mente l’affermazione che il regista messicano Ruizpalacios fa dire alla voce narrante del film “Museo”: “Perché rovinare una bella storia con la verità?”. La storia deve essere sottratta una volta per tutte agli interessi di potere che la strumentalizzano e la piegano alle proprie ciniche e opportunistiche esigenze, ma deve essere appannaggio di chi, come i romanzieri, non hanno paura di reinventarla con la loro libera e indipendente immaginazione, e che proprio per questa attitudine sono in grado di fornire un nuovo senso e una nuova dimensione a ciò che è avvenuto in passato: quindi non arida cronologia ma affabulazione, non resoconto storiografico ma narrazione, non i fatti (“I Fatti non son che i balocchi dell’Azzeccagarbugli… Trottole e Cerchi sempre in rotazione”) bensì gli aneddoti. La verità – sostiene ancora il reverendo – “ha bisogno di essere accudita riguardosamente e amorosamente da fabulatori e contraffattori, Cantastorie ed Eccentrici d’ogni Latitudine, Maestri del Travestimento che la provvedano di Costume, Toletta e Portamento, e Scilinguagnolo abbastanza sciolto da tenerla di là dai Desideri, o anche dalle Curiosità, del Governo”. Quale stupenda dichiarazione di poetica, che dimostra come Pynchon, lungi dall’essere uno scrittore perso nelle sue solipsistiche e cervellotiche elucubrazioni mentali, come molti troppo semplicisticamente sostengono, è un autore molto politico il quale, con uno sguardo genialmente strabico, ci parla del mondo di oggi, della globalizzazione, della pericolosità dell’informazione in mano a pochi, del razzismo e della xenofobia, proprio mentre descrive le bislacche ed esotiche avventure di due gentlemen inglesi del Settecento alle prese con un mondo a loro ostile e sconosciuto. Non è tanto lo sguardo di chi, per cercar di descrivere e spiegare l’attualità del proprio Paese, si rivolge al mito originario della sua fondazione, quello della frontiera, dei pionieri, del west da colonizzare, quanto la lucida e disincantata constatazione da parte di un intellettuale da sempre ai margini del sistema che nulla in fondo è cambiato da due secoli a questa parte, e che la prevaricazione, la violenza, il sopruso, la discriminazione hanno sempre allignato in quella che forse troppo frettolosamente è stata definita la culla della democrazia. La stessa linea tracciata da Mason e Dixon, che per i nostri ignari e disinteressati eroi è uno spazio utopico, un’estensione ideale, un motore di energie e di speranze, non riesce a nascondere la sua natura di confine odioso e arbitrario (“Nulla produce Cattiva Storia in maniera più diretta, né più brutale, che il tracciare una Linea, segnatamente una Linea Retta, la veracissima Forma del Disdegno, nel bel mezzo d’un Popolo… così creando una Distinzione in esso… è il primo colpo. Tutto il resto seguirà come predestinato, fino alla Guerra e alla Devastazione”). Come nel finale de “Il pellegrino” di Chaplin, in cui uno disorientato Charlot camminava sul confine messicano, senza riuscire a decidersi tra il Nord e il Sud, tra le guardie in agguato da una parte e le sparatorie dall’altra, così Pynchon ci mostra i paradossali esiti cui può giungere una rigida e immotivata divisione (la Linea, ad esempio, ad un certo punto attraversa e taglia a metà una fattoria, la quale pertanto viene a trovarsi metà in Pennsylvania e metà nel Maryland, con la bizzarra conseguenza di essere soggetta contemporaneamente alle imposte fondiarie dell’uno e dell’altro Stato). Lo stesso sguardo iconoclasta e provocatorio è riservato anche ai personaggi illustri e ai padri fondatori di un’America alla vigilia della Guerra d’Indipendenza: da Benjamin Franklin (che si diletta a fare survoltati esperimenti con le scariche elettriche dei fulmini), a George Washington (che fuma marijuana e gioca a biliardo come un moderno figlio dei fiori), a Thomas Jefferson (che, conversando amenamente con Dixon in una taverna, chiede al nostro se può utilizzare in futuro la sua esclamazione di augurio “alla ricerca della felicità”, cosa che effettivamente farà nella sua famosa Dichiarazione di Indipendenza) e a molti altri ancora.
Coloro che amano il Pynchon più folle e psichedelico e temessero di trovarsi di fronte, in questo romanzo, a un autore in qualche modo imbrigliato dalla necessità di dover essere fedele alla storia di due personaggi realmente esistiti, con una biografia da rispettare nei suoi tratti essenziali, possono stare assolutamente tranquilli. In “Mason & Dixon”, dietro all’ingannevole fondale del secolo dei Lumi, ribolle lo stesso universo caotico, eccentrico e caleidoscopico degli altri romanzi pynchoniani. I nostri due astronomi incontrano lungo la strada cani parlanti, pitonesse, lupi (e addirittura castori) mannari, anitre meccaniche scappate dal loro inventore, golem fabbricati da fantomatiche tribù indigene e posti dove crescono ortaggi giganteschi. La fantasia di Pynchon è sfrenata più che mai, e lo sguardo asettico e scientifico di Mason e Dixon si scontra in continuazione con un irrazionalismo di fondo, che nel corso della narrazione aumenta sempre di più, dando la stura a innumerevoli situazioni umoristiche e divertenti, come se ci trovassimo di fronte a un film di Buster Keaton. Come in una matrioska, la storia principale si moltiplica in innumerevoli sotto-storie, che sfidano il senso comune in un hellzapoppin che è la quintessenza del bizzarro e dello stravagante: quella dell’Ottuplice di Gloucester, un formaggio gigante del peso di quattro tonnellate, il quale, trasportato in un enorme carro da bestiame per l’annuale festa casearia, scivola giù e, rotolando, immenso come una luna caduta sulla terra, travolge ogni cosa al suo passaggio; la leggenda del Vermo di Lambton, favola medievaleggiante di draghi e cavalieri; la storia di Hsi e Ho, astronomi di corte cinesi che, duemila anni prima di Cristo, mancano la previsione di un’eclissi di sole non per imperizia, ma perché erano ubriachi; e così via, fino ad arrivare al diavolo in persona, impelagato in una causa legale per una clausola contestata all’interno del contratto di compravendita di un’anima. Pynchon spiazza e disorienta il lettore, in quanto fa venire meno i normali riferimenti logici e spazio-temporali. Gli stessi protagonisti sono catapultati in esperienze ai limiti dell’assurdo: Mason ricorda quando nel 1752 l’Inghilterra aveva adottato il calendario gregoriano, passando in un colpo solo dal 2 al 14 settembre, ed egli si era ritrovato misteriosamente intrappolato nel 3 settembre, costretto ad aggirarsi da solo in un tempo surrealmente vuoto; e Dixon, dal canto suo, durante una spedizione nei paesi nordici, viene condotto da un misterioso personaggio, attraverso una concavità vicino al Polo Nord, all’interno della Terra, che si rivela cava e abitata da popolazioni che vivono aggrappate a testa in giù come pipistrelli. La scienza newtoniana ed euclidea viene costantemente irrisa da forze magiche e occulte (amok, magia indigena, apparizioni di fantasmi, caos ed entropia), che sembrano ironicamente alludere all’irrazionalismo e all’indeterminazione che sarebbero venuti in auge due secoli più tardi. Mason e Dixon si sentono spesso agiti da forze più grandi di loro (“come se fossimo pensionanti presso un fato d’altrui, pur trovandosi il nostro posto da tutt’altra parte”), che trascendono le loro possibilità di comprenderle, e tuttavia si lasciano trasportare passivamente da questa corrente, senza mai opporsi ad essa, per quanto strana e inconcepibile possa apparire loro, e grazie a questa forma di resilienza (comune del resto a quasi tutti i personaggi della letteratura pynchoniana) riescono a uscire indenni da tutte le disavventure, procedendo con un infantile stupore all’interno di una terra vuota, sconfinata, inimmaginabile (“chi potrebbe non ritrovarsi a credere in un Eterno Ponente?”), simile forse, per imperfetta approssimazione, ai dipinti “western” di un Thomas Moran o di un Albert Bierstadt, il cui tentativo di delimitarla e di cartografarla appare sempre più un’impresa assurda e quasi surreale, tanto l’America sembra assumere la forma di uno spazio infinito, di un “reame del dubbio” (“per un imprevedibile susseguirsi di Notti saran possesso di quest’Onda immane di Montagne coperte di Foreste, di questo sito d’antica Vendetta, e Animali Selvaggi a un passo dalla Luce del bivacco… il sole in questa sera particolare come un celeste Sigillo, riversandosi in Gloria, trasgredendo ogni Meta e Confine, colmando gli Alberi, illuminando gli Animali, i loro fianchi rivolti, inondati dalla Marea sopraggiungente, donando agli umani volti una definitezza ch’è contigua alla purificazione, sempre spronando ogni anima, ancora e ancora, verso l’Inferno dell’Eternità”). Intorno ai due protagonisti, sempre più simili a “piccoli principi” in un mondo fuor di sesto, i personaggi della spedizione assumono le fattezze di una umanità sempre più in preda alla follia (il capitano Shelby, il cinese Zhang, il cuoco Allègre, il taglialegna Stig) e alla paranoia. Nel romanzo, come del resto è tipico dell’intera opera di Pynchon, finisce per aleggiare in permanenza un’aura di cospirazione: che si tratti dei Gesuiti (che si comportano come implacabili agenti della CIA), della Compagnia delle Indie Orientali o dei Francesi, ogni passo della missione di Mason e Dixon sembra costantemente strumentalizzata e piegata al volere di forze oscure e imperscrutabili. Le stesse discussioni (siano esse filosofiche, religiose, politiche o scientifiche) avvengono sempre in implausibili taverne, avvolte dalla nebbia dei sigari e dal fumo delle candele, in cui non si sa mai se ad ascoltare sia un amichevole confidente o un nemico che – per chissà quale insondabile motivo – si cela acquattato nell’oscurità, e dove anche una semplice riunione di commissari governativi assomiglia a una sfilata di enigmatiche effigi, di inquietanti volti di cera, che scrutano con diffidenza Mason e lo fanno sentire come se fosse stato sorvegliato a sua insaputa fin dal giorno del suo sbarco in America. Il terreno in cui si muovono Mason e Dixon è sempre, in apparenza, infido e malagevole, terrorizzante ed enigmatico (Dixon, salpato dalla foce del fiume Tyne alla volta di Londra, si trova improvvisamente circondato da un’impenetrabile coltre di nebbia, e quando essa si dirada ha l’impressione di ritrovarsi inspiegabilmente già approdato sulle coste americane), ma tutto ben presto è destinato a rovesciarsi e tramutarsi in farsa stravagante e clownesca. “In verità – chiosa Pynchon - un’aura di bizzarria pervade l’intera storia […], quasi in scherzoso diniego di riconoscere che America, sotto qualche aspetto, possa esser cosa seria.”
“Mason & Dixon” è un romanzo fortemente innovativo. Pynchon adotta lo stesso stile di scrittura del Settecento, o perlomeno quello che, in un raffinato gioco di illusioni ottiche, noi lettori immaginiamo dovesse essere lo stile dell’epoca. Così, i sostantivi, come nei romanzi di Swift, vengono scritti spesso con l’iniziale maiuscola, i termini sono arcaici e desueti, i periodi ampollosi e magniloquenti, in un continuo sfoggio di mimetismo linguistico che ha del miracoloso. “Mason & Dixon” è anche un’opera di un’immensa, enciclopedica erudizione, che spazia in innumerevoli campi dello scibile, dall’astronomia alla storia americana delle origini, dalla geomanzia al deismo, dalle teorie della Terra cava alle abitudini alimentari del ‘700. Pynchon dimostra di poter scrivere su qualunque cosa nel modo in cui vuole, del tutto incurante delle aspettative del lettore, ma, nonostante ciò (o forse proprio grazie a ciò), donandogli ad ogni pagina un piacere raffinato e incomparabile. Nonostante non sia, per la sua mole (è lungo più di settecento pagine) e per la sua complessità, di facilissima lettura, “Mason & Dixon” è un libro estremamente divertente, in quanto la seriosità dei protagonisti, l’aulicismo dello stile e la stravaganza delle storie narrate creano un mix di irresistibile umorismo. Ma c’è di più: se “Mason & Dixon” è a tutti gli effetti un romanzo pynchoniano (ci sono – ovviamente – le canzoncine, ci sono il sesso e le gozzoviglie- - quanta birra bevono tutti quanti! “Mason & Dixon” è decisamente un libro ad alta gradazione alcolica – e c’è persino un marinaio, Settepance Bodine, che è fuor di ogni dubbio un antenato del Pig Bodine di “V” e de “L’arcobaleno della gravità”), esso introduce un elemento emozionale che non avevo mai riscontrato prima nelle opere dello scrittore di Glen Clove. Mason e Dixon sono due personalità diametralmente opposte (malinconico, suscettibile e misantropo il primo, socievole, scherzoso e gaudente il secondo), che hanno idee diverse su quasi tutto, bisticciano, faticano a stare insieme per lungo tempo, ma che in fondo non possono fare a meno l’uno dell’altro, come una strana coppia alla Walter Matthau e Jack Lemmon. Iniziata come una relazione esclusivamente professionale, vediamo il loro rapporto crescere poco alla volta e trasformarsi lentamente in una amicizia indissolubile, sia pure manifestata a fatica per timidezza, ritrosia e virile riserbo. Mai più avrei immaginato che Pynchon arrivasse a commuovermi con la malinconica immagine dei due uomini che, ormai invecchiati e quasi dimenticati dal mondo, passano le giornate a pescare silenziosamente l’uno accanto all’altro o a rimembrare i lontani tempi dell’avventura americana. Sebbene la coppia di protagonisti maschili sia un topos della letteratura di tutti i tempi (si pensi a Don Chisciotte e Sancho Panza, Bouvard e Pecuchet, più recentemente a Kavalier e Clay), raramente mi sono affezionato tanto come ai due eroi creati da Pynchon, capaci di illuminare con la loro esemplare e adamantina umanità un Paese ed un’epoca. Chissà che, dopo il tanto parlare che si è fatto in passato del Grande Romanzo Americano, il sogno che ogni scrittore statunitense continua imperterrito a inseguire, questo Grande Romanzo Americano sia in realtà già stato scritto alla fine dello scorso millennio, proprio da un autore che staziona ormai da tempo nei recessi più remoti e irraggiungibili della galassia della letteratura contemporanea. In fondo, leggere Pynchon – e segnatamente “Mason & Dixon” - è proprio come partire, con coraggio e anche un po’ di avventatezza, per un viaggio interstellare, senza nessun appiglio e nessun contatto con quanto si è letto prima di allora. Quando, alla fine di un “trip” di sconvolgente bellezza, ci si volta indietro, si scopre di essere ormai anni-luce lontani da dove si era partiti e forse, chissà, non si ha neppure più la voglia e l’interesse di intraprendere la via del rientro, di tornare verso i più confortevoli e rassicuranti libri cui ci si era abituati, e si vorrebbe cedere alla tentazione di rimanere sul pianeta Pynchon per tutto il resto della vita.
Indicazioni utili
Mason & Dixon
Per continuare a scroccare l’ospitalità dei parenti ed evitarsi così i rigori dell’inverno, il non certo specchiatissimo rev. Cherrycoke (l’onomastica dei personaggi è, come al solito, superlativa) racconta alla famiglia l’avventura dell’astronomo Mason e del topografo Dixon, inglesi incaricati di disegnare la linea che divide la Pennsylvania dal Maryland e che, più tardi, separerà Unione e Confederazione. Se, però, dovessimo sottoporre Pynchon alla stessa prova affrontata dal reverendo, probabilmente qualche giretto fuori al freddo finirebbe per farlo: questo ponderoso librone di oltre settecento pagine, infatti, è sì pieno di spunti brillanti e divagazioni fantasiose, ma il risultato complessivo finisce per essere inferiore a quello di altre opere dello scrittore di Glen Cove. Ad esempio, sarà anche per colpa della circostanza che tutti quanti bevono in quantità imbarazzanti, ma sono davvero troppi i momenti in cui non si capisce bene dove ci si trovi o chi stia parlando – emblematico può essere il capitolo 23 – e, inoltre, c’è qualche spunto interessante che viene abbandonato troppo presto, come il Cane Sapiente (e parlante) d’Inghilterra che dopo poche pagine ci assicura che siamo entrati di nuovo nel mondo pynchoniano, a confronto di altri tirati un po’ per le lunghe e in merito si veda l’episodio di Sant’Elena. Si tratta, in ogni caso, di imperfezioni che non spingono a rinunciare a fare il piccolo sforzo per seguire le avventure e le elucubrazioni della coppia protagonista, nonché dei millanta personaggi che li circondano. Siccome il libro è ambientato nel Settecento, lo scrittore utilizza l’inglese del tempo (o quello che potrebbe essere l’inglese del tempo, con il sovrappiù delle maiuscole per tantissimi sostantivi) e bisogna dare merito a Massimo Bocchiola di aver tradotto il tutto in stile con notevole efficacia: la musicalità della frase è spesso un valore in sé a prescindere da quel che racconta, come nel meraviglioso incipit, e la resa riesce a essere all’altezza. Il malinconico Mason, che incontra con frequenza il fantasma della moglie deceduta, e l’effervescente Dixon incrociano le loro vite su di una nave diretta in Sudafrica dove i due si recano per studiare il transito di Venere, battibeccano sovente e senza risparmiarsi cattiverie, ma finiscono per attrarsi come tutti gli opposti: attorno a loro si muovono innumerevoli figure, ora di fantasia ora reali (gli sballi elettrici di Franklin, la ganja di Washington, Jefferson che prende a prestito una chiacchiera di Dixon per la ricerca della felicità), che vivono ogni sorta di avventura accennando o proclamando teorie che non si capisce mai se abbiano un fondamento storico o siano state inventare lì per lì (non che abbia poi qualche importanza stabilirlo, perché suona comunque bene questo discettare di geomanzia, terra cava, deismo, rapimenti alieni e molto altro). Non possono mancare, ovviamente le situazioni e i momenti – spesso racconti nel racconto - difficili da dimenticare: le donne ninfomani di casa Vroom che concupiscono tutte Mason, la parabola del cuoco Armand e l’anatra meccanica che lo segue ovunque, il giardino dei vegetali giganti e il formaggio di analoghe dimensioni che rotola spiaccicando ogni cosa sul suo cammino, il rapimento di Eliza e la sua fuga dal Canada in compagnia di uno fuso mica male come il cinese Zhang, la rivisitazione del verme di Lambton, lo svedese Stig e la sua inquietante ascia, il piccolo popolo che vive all’interno della Terra dalle parti del Polo Nord, per non parlare dei gesuiti visti come una sorta di Spectre. Dove lo scrittore ritorna all’improvviso serio è quando guarda alla storia della nascita del suo Paese, con i miti fondativi messi a confronto con la brutalità nei confronti degli schiavi e degli indiani in aggiunta alla considerazione del fatto che tracciare un confine tirando semplicemente una linea (o, forse, tracciare un confine e basta) sarà, prima o poi, foriero di disgrazie tra coloro che vivono da una parte e quelli che stanno dall’altra.