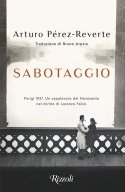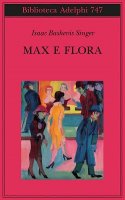Il castello bianco

Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
IL SOSIA TURCO
Quello del doppio è da sempre uno dei temi più sfruttati dalla letteratura mondiale, soprattutto dell’Ottocento: limitandoci ai classici più famosi, si possono citare “Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hyde” di Stevenson, “Il sosia” di Dostojevskij e “William Wilson” di Poe. Orhan Pamuk, ne “Il castello bianco”, oltre ai normali ingredienti insiti nel genere (lo sdoppiamento della personalità, la labilità dell’io), vi aggiunge una prospettiva insolita, quella del rapporto tra Oriente e Occidente. Nel rapporto tra il giovane veneziano catturato dai Turchi e il notabile ottomano di cui è divenuto schiavo viene infatti adombrato l’incontro-scontro tra due civiltà, ognuna con la sua cultura, la sua scienza e le sue tradizioni. Più che l’antagonismo tra i due (che pure esiste, nelle varie sfumature dell’invidia, della gelosia, della diffidenza e dell’avversione vera e propria), emerge dalla pluridecennale convivenza tra i due uomini, coetanei e simili nell’aspetto tanto da sembrare gemelli, una reciproca curiosità, che diventa ben presto morbosa ossessione di conoscere quello che è contenuto nella mente dell’altro. Il Maestro e il narratore (intercambiabili anche nella vita pubblica, astrologo di corte il primo e apprezzato consigliere del Sultano il secondo) condividono fortune e fallimenti, passioni scientifiche e filosofiche, e perfino i minuti fatti del loro passato, in una sorta di transfert psicanalitico che li porta ad essere una “strana” coppia dai confini individuali sempre più sfumati, non solo nei confronti degli estranei, ma anche di loro stessi. La fuga del narratore in un’isola solitaria durante la peste che affligge la capitale è l’anticipo di quella sostituzione, tacitamente concordata durante la fallimentare spedizione militare in Polonia, per mezzo della quale il Maestro fugge dall’accampamento per raggiungere l’Italia nelle vesti del narratore, e quest’ultimo prende il posto del Maestro, ognuno dei due calandosi definitivamente nell’esistenza dell’altro e realizzando in tal modo una completa simbiosi.
Lo stile di Pamuk è volutamente datato (sulla falsariga di un Potocki, tanto per fare un esempio) e assai poco moderno. Ciò crea un effetto sicuramente straniante: ambientazione seicentesca, stile ottocentesco, tematica contemporanea. A ciò si aggiunge un andamento del romanzo che, attraverso i molteplici mutamenti reciproci che avvengono nel rapporto tra i due protagonisti e tra questi e il Padiscià (prima è il Maestro ad essere nelle sue grazie, successivamente è il suo schiavo ad essere chiamato a corte in virtù del suo sapere, e così via in una sorta di monotono andirivieni con destinazione il palazzo del Sultano, a cui seguono lunghi e snervanti periodi di tediosa attesa), diventa col tempo sempre più ambiguo e psicologicamente aggrovigliato (le domande “perché io sono io” o “chi è chi?” sono il leit motiv dominante). Alla fine ci accorgiamo che, non avendo mai messo in dubbio le affermazioni del narratore (come sarebbe del resto avvenuto con qualsiasi romanzo dell’Ottocento), ci siamo dimenticati della figura dell’autore. E siccome “Il castello bianco” si propone dichiaratamente come un racconto partorito da una mente incline alle divagazioni fantastiche (si vedano i racconti pieni di sogni o di animali immaginari allestiti per il Sultano), nelle ultime pagine sorge il dubbio, e l’espressione di Evliya Celebi (il primo fantomatico lettore del manoscritto) ce ne dà un’ulteriore riprova, che tutto quanto abbiamo letto fino ad allora non sia mai avvenuto ma sia solo una fantasia. Più di ogni altra cosa, è proprio questa vertigine (in cui si adombra il senso ultimo di ogni creazione artistica) che il lettore si porta dietro al termine di questo elegante, fascinoso ma, ad essere sinceri, anche un po’ ostico gioco di scatole cinesi.