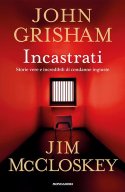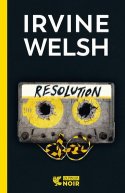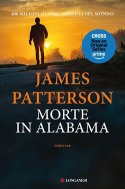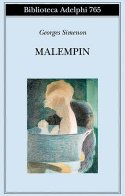La locanda del Gatto nero

Editore
Recensione della Redazione QLibri
Elementare Kindaichi, elementare
Marzo 1947, il Giappone dopo la disfatta bellica sta lentamente tornando alla normalità. Nelle città satelliti di Tokio però, cominciano a sorgere quartieri malfamati. Tra stradine strette e buie e antichi templi testimoni di un passato più ordinato, spuntano come funghi case di appuntamenti e taverne di dubbia moralità. Proprio in una di esse, la Locanda del Gatto Nero, è rinvenuto un cadavere di donna, malamente sepolto nel cortiletto sul retro dell’edificio. Il corpo, completamente nudo, è in stato di avanzata decomposizione. Soprattutto il viso è irriconoscibile, orrendamente corroso e divorato dai vermi, al punto da rendere impossibile ogni identificazione. La locanda, sino a pochi giorni prima, era gestita da Itojima Daigo e dalla consorte Oshige. Costoro, però, l’hanno ceduta a fine febbraio e ora è in ristrutturazione. Dunque, di chi è quel corpo? I vecchi proprietari sembrano scomparsi nel nulla, ma, stranamente, anche nelle settimane precedenti alla vendita Oshige era praticamente irreperibile, ufficialmente malata, ma celata alla vista pure delle tre inservienti che lavoravano nella locanda. La polizia comincia a temere che il corpo rinvenuto sia quello di Kuwano Ayuko, amante del proprietario, che sarebbe stata uccisa da Oshige in un impeto di gelosia. Quest’ultima, poi, si sarebbe celata al pubblico nel timore di tradirsi. Pochi giorni dopo, però, con un ribaltamento repentino di valutazione, gli inquirenti giungono all’ipotesi che la vittima sia la stessa Oshige mentre, ora, sia Ayuko a spacciarsi per la defunta.
Solo lo strampalato detective privato Kindaichi K?suke, assoldato da Kazama Shunroku, ex amante di Oshige, riuscirà a sciogliere il mistero con un colpo di scena finale.
In questo secondo romanzo che vede come abile risolutore del caso il detective Kindaichi, Yokomizo tenta di affrontare, dopo l’enigma della camera chiusa, un altro classico della letteratura poliziesca: il mistero del cadavere senza volto. Lo scrittore giapponese, come spiega lui stesso nelle premesse, si cimenta col tema tentando una strada innovativa. Quasi si fosse imposto il compito di risolvere un’equazione matematica particolarmente complessa e voglia evitare la soluzione classica, quella nella quale l’omicida si fa passare per vittima, si inventa un piano diabolico che fa attuare al suo assassino.
L’aspetto più negativo del romanzo consiste proprio nell’approccio utilizzato: il rigido meccanicismo del racconto e l’asettica esposizione di un’ipotesi da laboratorio, più che la drammatizzazione di un evento appassionante, lo rendono freddo e poco coinvolgente. Come già nel precedente romanzo (Il detective Kindaichi) anche qui lo svolgimento è tutto teso unicamente a intessere una credibile ipotesi criminosa che smentisca e scardini l’approccio tradizionale. Non una parola è sprecata per una ricostruzione che cali il lettore sulla scena ove si svolge l’azione. Tutto è finalizzato a voler solo dimostrare “scientificamente” che il gioco omicida-vittima possa essere declinato in modi diversi da quelli già utilizzati in passato nella letteratura di genere.
La prima parte del libro, quindi, è dedicata unicamente a fornire gli elementi di indagine senza consentire alcuna partecipazione emotiva del lettore. La narrazione non indulge nella descrizione dei personaggi o delle loro emozioni. I contesti sono descritti solo in funzione dell’enigma che si vuole proporre. Per altro, anche in questo compito l’A. vìola uno dei principi fondamentali del giallo classico: fornire a chi legge tutte le notizie utili in modo da consentirgli, se ne è capace, di anticipare la soluzione finale. Al contrario molti particolari sono tenuti celati e rivelati da Kindaichi non prima della lunghissima spiegazione finale. È lo stesso Yokomizo che, per giustificarsi, ammette che in questa tipologia di enigmi il narratore deve celare la verità all’ascoltatore per avere la possibilità di sconfiggerlo. Opinione rispettabile anche se non necessariamente condivisibile.
Una volta intessuta la trama la seconda parte del romanzo è integralmente destinata alla elaborata spiegazione di come sia concepibile il macchinosissimo (e decisamente artificioso) stratagemma utilizzato dall'omicida. Insomma la costruzione della storia è tutta molto cerebrale e sembra intenzionata soprattutto a mostrare come l’allievo (giapponese) abbia imparato la lezione dai maestri e modelli (occidentali) e abbia saputo superarli in inventiva e fantasiosità. Ritengo che sia un po’ poco perché l’opera risulti completa in ogni sua componente.
Come per il libro che l’ha preceduto, anche in questo, quindi, è il contenitore, inteso come quel soffuso profumo orientale che trasuda dalle righe della narrazione, ad attrarre e dar piacere al lettore, più del contenuto, cioè dell’intreccio poliziesco in sé. Fanno sorridere le reazioni improvvise ed esagerate dei protagonisti a ogni evento inatteso, ma ricordano tanto quegli stupori e quegli scatti bruschi a cui ci hanno abituato la cinematografia e, ancor di più, gli “anime”, nipponici e suscitano simpatia. Le atmosfere, appena accennate, perché date per note al lettore nipponico, sono piacevoli ed esotiche. Quindi, nonostante tutto, si fa presto a calarsi in un Giappone che ormai non è più e assaporarne gli aromi.
In definitiva si tratta di un libro abbastanza gradevole. Tuttavia il lettore smaliziato viene messo sull’avviso: se tutti i romanzi di Yokomizo si dovessero risolvere in una specie di diligente compitino nel quale il romanziere tenta soltanto di riprodurre i temi classici del poliziesco occidentale elaborandoli in salsa wasabi, l’aroma di loto e mandorli in fiore non sarà più sufficiente in futuro a tener vivo l’interesse di chi li legge dall’altra parte del globo.