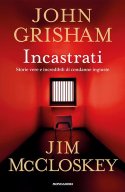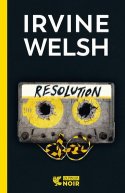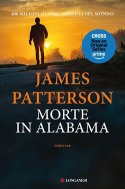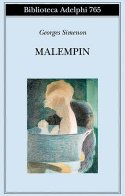Il detective Kindaichi
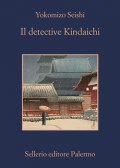
Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
Lo Sherlock Holmes del Kabuki
Novembre 1937, villaggio di Yamanodani nella prefettura di Okayama, Impero Giapponese. Gli Ichiyanagi sono una facoltosa famiglia della provincia nipponica, la più ricca del villaggio. Finalmente Kenz?, ormai quarantenne, figlio primogenito ed erede del nome del casato, ha deciso di sposarsi con Katsuko, una giovane insegnante presso una scuola femminile nella città di Okayama. La famiglia di lui, prima restia a consentire quel matrimonio con una ragazza di classe inferiore, alla fine ha ceduto e tutto è pronto per la cerimonia, che sarà intima, ma si svolgerà regolarmente secondo i rituali familiari.
Quella stessa notte, mentre i pochi ospiti presenti nella residenza smaltiscono nel sonno le abbondanti libagioni della festa di nozze, un urlo squarcia il silenzio della casa. Tutti i membri della famiglia accorrono nella dèpendance, ove gli sposi stanno trascorrendo la loro prima notte e, dopo aver scassinato una delle imposte per entrare, scoprono con orrore i cadaveri degli sposi che giacciono in un lago di sangue, atrocemente squarciati. Fuori, piantata per terra, una spada insanguinata. Chi ha commesso quel terribile delitto, visto che la casa era chiusa dall’interno? E perché tutti, dopo le urla delle vittime, hanno udito distintamente le note del koto che la sposa aveva suonato proprio in occasione del matrimonio? La polizia orienta immediatamente i suoi sospetti verso un misterioso individuo con sole tre dita alla mano destra e una lunga cicatrice sulla guancia, malamente nascosta da una maschera. Costui è stato visto in paese solo tre giorni prima del matrimonio e avrebbe recapitato un misterioso biglietto per Kenz? il quale, lettolo, sarebbe impallidito. Le sue impronte digitali, insanguinate, sono ovunque nella stanza. Chi è costui? E quali sono stati i suoi moventi?
Lo strampalato detective Kindaichi K?suke, chiamato a indagare da Kubo Ginz?, zio della sposa, non è convinto della versione ufficiale e, collaborando con gli inquirenti, riuscirà a scoprire il vero assassino, lasciando tutti esterrefatti.
Ogni volta che mi accosto a un romanzo giapponese provo una sensazione di inadeguatezza per il timore di non comprendere appieno una mentalità così diversa da quella occidentale e, di conseguenza, di fraintendere il senso delle situazioni descritte. “Il detective Kindaichi” non ha fatto eccezione: nonostante lo schema generale voglia ricalcare i ben noti modelli anglosassoni del poliziesco classico, l’influsso della cultura nipponica condiziona pesantemente la narrazione e il suo fluire, al punto d'avermi lasciato interdetto sull'impressione finale conseguita.
Va precisato che l’A., quasi sconosciuto in Italia, è stato uno dei giallisti nipponici più acclamati in patria. Per parte sua fu sempre affascinato dagli enigmi della camera chiusa, genere inaugurato dal famosissimo racconto di Poe “I delitti della Rue Morgue” e che ha visto cimentarsi, nel complicato gioco di raccontare un delitto avvenuto in circostanze apparentemente impossibili (cioè dentro una stanza chiusa dall'interno), tutti i più grandi giallisti, da Conan Doyle, alla Christie, da van Dyne a Wallace e, soprattutto, a Dickson Carr per il quale Yokomizo Seishi aveva una sconfinata ammirazione.
Proprio per emulare il suo nume ispiratore, l’A. si confrontò spesso con storie, ambientate nel suo Giappone, che giocano sul mistero della camera chiusa.
Questo romanzo, in particolare, vede per la prima volta come protagonista il detective Kindaichi, un giovane, all’apparenza sciatto, poco appariscente e addirittura balbuziente, ma oltremodo geniale che diverrà uno dei personaggi simbolo dei polizieschi giapponesi nel dopoguerra.
Narratore di questa storia è lo stesso Yokomizo, che afferma di ricostruire la clamorosa, truce vicenda sulla base delle testimonianze raccolte tra i pochi testimoni rimasti. Questa impostazione, purtroppo, rende il racconto meno coinvolgente, poiché si percepisce una certa freddezza, un certo distacco del cronista rispetto ai fatti riferiti. Inoltre ho trovato i protagonisti, con la sola eccezione (forse) di Kindaichi, assai poco definiti e curati. Come personaggi del teatro kabuki, la loro scarsa caratterizzazione ne fa spesso solo dei porgitori di battute, senza che sia possibile decifrarne le emozioni se non quando ci vengono espressamente segnalate dall’A. stesso.
Tuttavia non credo che questi possano essere considerati veri difetti dell’opera e non piuttosto caratteristiche proprie dell’animo e della cultura tradizionale giapponese e, quindi, componenti essenziali della narrativa di quel Paese, che ritiene necessario mantenere sempre un certo distacco emotivo dagli avvenimenti.
In ogni caso è evidente che tutto l’intreccio narrativo è predisposto al solo scopo di illustrare l’abile meccanismo con il quale si è reso possibile il duplice omicidio nella stanza sigillata. Non esistono vicende parallele, non digressioni o riflessioni su argomenti di ordine generale. Tutto è funzionale a fornire gli elementi che compongono l’enigma. La spiegazione finale, poi, occupa quasi tutta la seconda parte del libro, spalmata su ben quattro dei capitoli conclusivi. Non dirò nulla, ovviamente, del rompicapo giallistico o della sua soluzione che sono la sola ragione del romanzo. Non posso esimermi dall’osservare, però, come l’intera costruzione sia sicuramente geniale e ricca di inventiva, ma eccessivamente macchinosa e cerebrale. Arzigogolata e, forse, un po’ astrusa. Mi domando quante volte, nel mondo reale, quel meccanismo inventato dall’assassino del romanzo avrebbe funzionato perfettamente in ogni singolo passaggio, senza incepparsi e mandare tutto all’aria. Insomma, divertente è l’idea, ma troppo cerebrale e assai poco pratica, concretamente.
Detto questo, mi sembra doveroso segnalare come l’aspetto più affascinante del romanzo sia l’ambientazione nel Giappone degli anni trenta: un Paese in mezzo al guado della storia. Una società che non è più quella feudale e medievale che abbiamo imparato a conoscere attraverso i meravigliosi film di Kurosawa, ma che è egualmente lontana dal frenetico e ipertecnologico Paese odierno. La gente è ancora impregnata del retaggio fornitole dalle sue millenarie tradizioni, ma si muove in un contesto che vorrebbe modernizzarsi. Yokomizo, pur non dilungandosi nelle descrizioni d’ambiente (che dà per scontato), riesce ugualmente a farci assaporare il profumo di quelle antiche dimore di bambù, ove gli ambienti, separati solo da porte scorrevoli, vengono descritti per il numero dei tatami da cui sono costituiti, i tempi sono scanditi dai precisi riti della tradizione e coloro che si vestono con abiti occidentali sono visti come eccentriche divagazioni. Il fatto stesso che l’enigma abbia come elemento caratterizzante il melanconico suono del koto, l’arpa giapponese che accompagna il teatro tradizionale, conferisce un’aura di mistero e incanto a tutta la storia. E il lettore, mentre scorre le pagine del libro, difficilmente riesce a scrollarsi dalla mente quel lento “plin plin” di accompagnamento ai soffusi passi dei protagonisti sulle stuoie intrecciate, ai loro ragionamenti attorno a un tavolo da tè.
In conclusione, il romanzo merita sicuramente la lettura, non tanto e non solo per l’enigma investigativo, quanto, piuttosto, per potersi immergere in quest’epoca, odorosa di loto, di sake, di sete fruscianti e di antiche tradizioni.